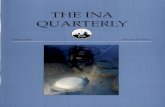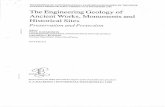E. Govi, G. Sassatelli, Ceramica attica e stele felsinee, in “Hesperìa” 18, 2004, pp. 227-265.
Transcript of E. Govi, G. Sassatelli, Ceramica attica e stele felsinee, in “Hesperìa” 18, 2004, pp. 227-265.
,-------------- Hesperia -------------,
comitato consultivo
"'HESPERIA,18
D. BRlQUEL (paris), A.C. CASSIO (Roma), M. GRAS (Paris),M.L. LAZZARINI (Roma), M. LOMBARDO (Lecce), A. MELE (Napoli)
D. Musn (Roma)
STUDI SULLA GRECITÀ D'OCCIDENTEa cura di LORENZO BRACCESI
I Greci in Adriatico, 2coordinamento scientifico di
LORENZO BRACCESI e MARIO LUNI
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
ELISABET'!'A GOVI - GIUSEPPE SASSATELLI
CERAMICA ATTICA E STELE FELSINEE;'
Il rapporta tra la ceramica attica e le stelc di Bologna è stato sottolineato a più riprese, già a partite dalla prima cdizionc di questi monumenti', nella quale P. Ducati, limitandosi ad enumerare clementi di confronta, pet alcuni motivi ornamentali e pet alcunischemi iconografici afferma una diretta derivazione dal repertorio cerarnico greeo 1,
Tale dipendenza è riconosciuta, ma solo sul piano formale, anche dal Grenier 3, il qualeconsidera il patrimonio figurativo dei vasi attici soltanto uno dei modelli cui si ispira laproduzione scultorea bolognese: ad esso infatti rimanderebbero la resa disegnativa delrilievo e illinguaggio formale, ma il contenuto ideologico c la composizione generaledelle scenc sarebbcro riconducibili ad un ambito etrusco e in particolare all'esperienzadella pittura tombale etrusco-meridionale, per cui le stele Ielsinee sono considerate la riprova di un forte legame culturale tra l'Etruria tirrenica el'area padana.
Tali osservazioni sono state riprese in seguito da G.A. Mansuelli, al quale si deve ilprimo tentativo di considerare in modo organico il problema della formazione degliscalpellini felsinei 4. Egli ricallega la comparsa a Balogna nella seconda metà del VIsec. a.C. di una mentalità figurativa, quasi del tutto assente nelle fasi precedenti, allamassiccia importazione dei vasi greci ed in particolare riconduce la nascita delle tecniche espressive degli scultori bolognesi ail'esperienza pittorica vascolare.. TI bassissimorilievo e il trattamento disegnativo della superficie, basato sull'adozione della linea dicontorno e di tratti incisi per i particolari interni, oltre che sul contrasta cromatico trail fondo neutro e le figure in origine senza dubbio dipinte, sono adottati ad imitazionedella tecnica pittorica tipica dei vasi attici. L'ascendente ceramico è poi postulato perla divisione in registri della superficie e pel' l'ordine gerarchico assegnato alle scene fi-
'l, Le fore delle stcle sono state cortesemcntc Iornirc dal Musee Civico Archcologico di Bologna cui vail ringraziamento degli aurori anche pet la disponibilità mostrata nel favorire la presente ricerca. l disegni ele rabclle sono di E. Govi.
1 P. Ducx'n, te pietrefunerarie felsinec, «MonAL» XX, ]911, 357-728; 11)., Nuooc stclc[uncraric fclsinee, «MonAL» XXXIX, 1943,373-466.
2 DUCATI, Le pictre funerarie feZsint'e,305-307, 317 "318,321, 324, 340, 351 (per i singoli scherni iconegrafici dcsunti dalla ceramica attica);511-513 (per le comici}.
.\ A. GRENIER, Bolognevi!lanovienne et etrusque, Paris 1912,432-458.4 G.A. M'\.NSUELLI, Problemi artistici dell'Etruria podana, in Catfvlostra, tâostra deli'Etruria pt/dalla e
della città di Spina, Balogna 1960, 17"24, ripreso successivamente in C. MORlGI GOVI, Persistenze oricntalnzanti nelle stele[elsmec, «SE» XXXVIII, 1970,67-74.
gurate in essi comprcse. Se la nascita di un linguaggio figurative è sicuramente ricondotta da Mansuelli all'influsso esercitato dalla cerarnica attica, più complessa invece è
considerata la formazione culturale degli scultori bolognesi, nel cui repertorie ÎC0I10
grafico si combinano persistenze di tradizione villanoviana, terni desunti dal patrimonio figurative etrusco di area tirrcnica e motivi di origine greca, nel segno di un forteconservatorismo e di un altrettanto Evidente eclettismo.
In anni più recenti studi di carattere iconologico hanno nuovamente posto l'attenzione sull'influsso esercitato dal rcpertorio figurativo attico 11e11a secha di alcunitemi raffigurati sulle stele, nelle quali a partire dalla mctà del V secolo si affermanoschemi iconografici ispirati alla ceramica attica ' c scene ricollegabili a concezioni escatologiche trasmesse dal monda greco 6. Immagini di demoni psicopompi in aspettoefebico, di Caronte con connotati silenici 7 e di figure abnormi di sileni, assimilati a de-
Si vedene ad esempio Jo schema del combatrimento ira guerrieri il cui modello sono le scène di mo"nomachic COSl frequentî sulla ccramica attica (G. SASSATELLI, Le stcicfclsinee con "ceùomacbie", in AttiCaU,Popoli e [aaes culturali ceùicbe il nord c il sud delle Alpi da! V al l secolo a.C, (Milanc 1980), Milano 1983,168) e quelle del rapimento del defunto da parte del demone, ispirato all'iconografia assai ricorrente sui vasianici del ratte pet fini erotici mcsso in auo dai sileni (G. SASS1\TELI.I, Una nuova stele felsmea, in Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Modene 1984, 111; L. CERCH1AI,Daimoncs e 'Caronie sullc stclcfelsinec, in AttiCon Caronte. Un oboloper l'Aldilà, «pp» L, 1995, 376 ss.).
6 G. SASSATELLI, Problemi cronologici delle stcle felsinee alla luce dei nspenioi corredi tombals, in AttiCon Seconda Congrcsso Internauonale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, 948.
- SASSATELLI, in Culturefigurative c materiautra Emilia c Marche, 110 ss.; CEHCHJAJ, in AttiCon Caronle. Un obolo pcr l'Aldilà, 392-394. Dibattuto il problcrna relative all'arrivo e all'area di trasmissionc dei terniescarologici in Etruria. L'ipotesi di una diretta provenicnza del mondo greco in area padane, da cui in particolare il tema di Carontc sarebbe giunto in Etruria tirrenica (SASSATELLI, in Culture figurative c materiali traEmilia c Marcbe, 118; ID., in CatMostra, CiviltJ degli Etruschi, Milano 1985,297 n. 11.15), formulera sullabase di una priorità cronologica delle stele felsinee con Caronte rispctto aIle attestazioni tirreniche alloranote, è stata messa in forte dubbio dalla recente scoperta della tomba dipinra tarquiniese dei Demoni ALzurri della seconda metà del V secolo (M. C,'\TALD! DINI, Tomba dei Demoni Azzurri, in Pittura etrusca alMuseo di Villa Giulia (a cura di M.A.Rizzo) , Roma 1989, 151-153), che ha imposto di riconsiderare il prob1cma dell'arrivo del tema in Etruria ed ha aperto nuove strade relative aJl'interpretazione del viaggio deldefunto verso l'Aldilà (M. RENDELI, .J1nagoghe, in «Prospettiva» 83-84, luglio-ottobre 1996, 10-29; F. RONCALLI, Iconographie funéraire et topo<~rapbie de l'au-delà en Etrurie, in AttiColl, Les Élruxques. Lex plus relt~
gieux de,· hotJlmes (Paris 1992), Paris 199ï, 37-54; F. RONCAI,LI, Spazio reale e luogo simbolico: alutlle soluzioni nell'arte funeraria etrusca, in «Acta Hyperborea», 8, 2001, 249-272). A tale scoperta si è poi aggiunto ilrecente esame di a1cune testimoniamc epigrafiche e figurative di ambito etrusco-meridionale databili tra lafine del VI e la metà dd V sec. a.c. che, dubitativamente ricondotte all'introduzione in Etruria delle figuredi demoni e di Caronte, farebbero pensare ad una direzione contraria del fenomeno di diffusione di unanuova religiosità dlcnizzante, impastasi nei centri meridionali già al volgere dell'età arcaica (H. D'AGOSTINO,Dili J}alazzo alla tomba, in B. D'AGOSTINO - L. CERCIllA!, JImare la IJwrte l'amore, Roma 1999, 12; G. COLONNA, JI dokanon, il culto dei DiOJ"curi e gli aspetti ellenizzanti della religione dei morti nef!'Etruria tardo-arcaica, in Scritli di antichità in memoria di Sandra Stucchi, «Studi miscdlanei» 29, 1991-1992, 183-184; G. Co"LONNA, Divinité-> peu connues du panthéon étrusque, in AttiColl, Le., plus religieux des hommes (Paris 1992),Paris 1997, 170-172). Al di là della priorità di assunzione, con agni probabilità da assegnare aIle metropolietrusco-meridionali, sembra comungue plausibile l'ipotesi di un apporto diretto del tema, a di particolariredazioni iconografiche di Caronte, dal mon do greco ai centri dell'Etruria padana, soggetti durante il V secolo a forti sollecitazioni culturali e ideologiche da parte dei partners commerciali greci. Neè una riprova ladiversità deUe soluzioni iconografiche adottate contemporaneamente nei due ambiti dell'Etruria e la mag-
giare vicinanza della versione ctrusco-pad<ll1<l del Carome con remo rispetto alla tradizione greca (RoNCALLI,in «Acta H yperborea» 8, 2001, 253).
~ A. MASTI\OCJN0UE, Giganti silenici in Grecia e in Etruria, in AttiCon Dionysos. Mita e fnislero (Comacchio 1989), Ferrara 1991, 2n ss. La diffusione sulle stele felsinee delle figure di sileni potrebbe trovareorigine nelle immagini di sileni e di cartei dionisiaci che ricorrono, sia pure di rado, nel repertorio della pittura parietale funeraria di Tarquinia (G. COLONNA, Rz/lenioni sul dionisismo in Etruria, in AttiCon Dionysos. Milo e mÙtero (Comacchio 1989), Ferrara 1991, 118).
9 MANSUELLI, in CatMostra, .Mmlra dell'Elruria Padana, 23; CERClIIAI, in AttiCon Camnte. Un obolopel" l'Aldilà, 377; 1. CERCIIIAl, La rappresenlazione di Teseo sulle stele fe/sinet, in AttiCol1, Le mythe grecdans l'Ilalie antique. Fonction et image (Roma 1996), Roma 1999,353; S. BRUNI, Ulla pietra "scema". COlllri"huto allo sludio della .'lllluaria elrusca di elà arcaica dell'elà .lt'ltentrionale, in ln memoria di Enrico Paribeni,Roma 1998,73 nota 34, ove a proposito del personaggio raffigurato sulla stc1e o. 135 si ipotizza possa esserel'immagine di un saccrdote che impugna une skerpanon.
la CERGIIi\I, in AttiCon Le tnylhe grec, 353; una posizione piÙ cauta è sostenuta da G. Sassarelli, nel·l' Inrervcnto alla discussione in AttiColl, Le mylhe grec, 372-373.
11 L'analisi delle stele sicuramente riconducibili ai corrcdi di pcrtinenza ha consentito di ricostruirc unagriglia cronologica che comprende l'intera produzione scultorea e che puà essere assunta come punto di riferimento anche pel' gli esemplari non in contesta (SASSATELLI, in AttiCon Seconda COllgresm Inlernazionale).
12 Si\SSATELLl, lntervento alla discussione in AttiColl, Le mythe grec, 373.
229Ci-:lÜ\fvllC\ ATne."'. E STELE FELSINEE
moni che alludono all'Oltretomba e al potere civilizzatorc di Dioniso K, indiziano il diffondersi di nuovc Ideologie funerarie e mutano il panorama figurative delle stele, inprecedenza ancorato a temi quali il banchetto, la danza e la raffigurazione del defuntosecondo un sistema codificato che riflette le categorie sociali 9.
Luca Cerchiai arriva a riconoscere "nella città delle immagini" delineata nella ceramica attiea a figure rosse il principale modello di riferimenro, rifunzionalizzato insenso funerario, del repertorio iconografico adottato sui segnacoli di Bologna, pro ponendc in tal modo una chiave di lettura degli schemi figurativi su di essi adottati 10.
Nell' ambito di tale filone di indagine, che tende ad assegnare alla ceramica attieaLIn ruolo preponderante nella formazione e nello sviluppo dellinguaggio figurativo edel pensiero locale, con questo contributo si è inteso esaminare un aspetto marginaleche, in quanto tale, puo portare un contributo modesto, ma più oggettivo a qucstocornplesso problcma. Si è voluto analizzare l'eventuale apporto del patrimonio iconografico attico al ricco repertorio delle decorazioni "accessorie" delle stele, costituite dacornici, da listelli che separano le scene, e dagli clementi fitomorfi che decorano i registri minori in alternativa ai consueti animali marini e mostruosi. Tale decorazione, infatti, essendo apparentemente priva di condizionamenti di carattere culturale e ideologico risulta più libera e quindi di fatta più soggetta alla diffusione di gusti e di motiviartistici. Lo studio ha preso le masse da una analisi tipologica dei motivi ornamentaliimpiegati. Pur nella generale difficoltà di definire con prccisionc l'inquadramento cronologieo delle stele, qualora non siano note le associazioni con i corredi tombali di appartenenza, si è tentato di considerare diacronicamente I'adozione dei diversi -elementiciecorativi, attribuendo una datazione alle stcle esaminate sulla base del profila e delledimensioni, della selczionc dei temi iconografici presenti negli spazi figurari 11 e, soloin ultima analisi, dei caratteri srilistici che, come è noto, consentono valutazioni meerte ed in studi passati hanno generato pericolosi fraintendimenti cronologici 12.
EUSAJ:lETTA GOVT - GlUSEPPE SASSATELLl228
gurate in essi comprese. Se la nascita di un linguaggio figurative è sicuramcnte ricondott~ da Mansuelli all,'influsso esercitato dalla ceramica attica, più complessa invece ècon~lder~ta la f?rmaZlOne culturale degli scultori bolognesi, nel cui repertorio iconog~afl~o SI ~ornb1l1ano persistenze di tradizione villanoviana, temi desunti dal parrimomo figurative etrusc,o di arca tirrenica e rnotivi di origine greca, nel segno di un forteconservatonsmo e dl un altrettanto evidente eclettisrno.
In anni più rcccnti studi di carattere iconologico hanna nuovamente posta l' attenzione sull'influsso esercitato dal repertorie figurative attico nella secha di alcuniterni raffigurati sulle stele, nelle quali a partire dalla metà deI V secolo si affermanascherni iconografici ispirati alla ceramica attica ' e scene ricollcgabili a concezioni escatolo!?iche .trasmesse dal mondo greco '. Ïmmagini di demoni psicopompi in aspcttoefebico, dl Caronte con connotati silenici 1 e di figure abnormi di sileni, assimilati a de-
, Si vedano ad csempio 10 schema del combattimento tra gucrrieri il cui modello sono le scene di monomachie cosi frcquenri sulla ccramica artica (G. SASSAJ'ELLI, Le stclc felsinee con "ceùomacbie" in AttiCollPopoli e facies cultur~li celticbe a nord c a sud delle Alpi dal 11al l secolo a.C. (Milano 1980), Milano 1983:168) e quello del rapimenro del defunte da parte del demene, ispirato all'iconoarafia assai ricorrente sui vasiattici ,del ratto p~r fini ctotici messe in arro dai sileni (G. SJ\SSAITLU, Una nuo;a stele felsinea, in Culture figuraftve e ma!erwft tra Emilia ~ Marche. Studi in mcmoria di Mario Zuffa, Modene 1984, 111; L. CERCHIAI,DalJJ~~n~s c Caronte sulle steic felsinee, in AttiCon Caronte. Un obolo pel' l'Aldilà, «pp» L, 1995,376 ss.l.
Cr. SASSi\TELLI, Problemi cronologici delle stele felsinee alla luce dei rispcttioi corredi lombali, in AttiCon Seconda Congrcsso lntemasionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, 948.
SASSATEI.LI, in Culture figurative e maleriali tra Emilia e Marche, 110 ss.; CERCHIAI, in AttiCon Caronle. Un obolo per /'Aldilà, 392-394. Dibattuto il problema relativo all'arrivo e all'area di trasmissione dei temiescatol?gici in ~t~uri8. T:ipotesi di una diretta provenienza dal mondo greco iu area padana, da cui in particola.re li tema dl Caronte s~~rebbe giunto in Etruria tirrenica (SASSATEU.l, in Culture figurative e materiali traEmtlxa e Marche, 118; ID., III CatMostra, Civiltà degli Etruschi, Milano 1985,297 n. 11.15), formulata sullabase di una priorità cronologica delle stele felsinec con Caronte rispetto alle attcstazioni tirreniche alloranote, è stata mcssa in forte dubbio dalla recente scoperta della tomba dipinra tarquiniese dei Demoni Azzurri del~a s.econ,c!a ?letà del V secolo (M, CATALDI DJNI, Tomha dei Demotzi Azzurri, in Pittura etrusm alMuseo dl -v,zl/~ (,zulta (a cUl:a di M.~. Rizzo), Roma 1989, 151-1.53),che ha imposto di riconsiderare il problema deU arm:o d~l, tema ln Etruna ed ha apcrto nuove strade relative all'interpretazione del viaggio deldefunto verso l Aldila (M. R.ENDELI, Anagoghe, in «Prospettiva>~ 83-84, luglio-ottobre 1996, 10-29; F. RONC~L1) lc~nographie fim.éraire et top~graphie de rau-delà en Etrurie, in AttiColl, Les Étrusques. Les plus religteux des hommes (Pans 1992), Pans 1997,37-54: F. RONCALLI, Spazio reale e luogo simbolico: aleune mlttzioni nell)arteJu~erariaetrusca, in «Acta Hyperhorea», 8, 2001, 249-2ï2). A talc scoperta si è poi aggiunto ilrecente esamc dl alcune tcstimoniame epigrafiche e figurative di ambito etrusco-meridionale databili l'ra lafi~1e del V.le l~ metà de! V sec. a.c. che, dubitativamente ricondotte all'introduzione in Etruria delle figuredi demoOi e di Carante, farebbero pensare ad una direzione contraria del fenomeno di diffusione di unanuova re!igiosità ellenizzante, impostasi nei centri meridionali già al volgere dell'età arcaica œ. j)'ACOSTlNO,DaI palazzo alla tomba, in B. D'AGOSTINO -. L. CmCHIi\I, Tl tHare la marie l'amore, Roma 1999, 12; G. CoLONNA, Il dokanon, il culto det Dioseuri e glx aspettl ellenizzanti della religione dei morti neltEtruria tardo-armica, in Saittt di alttichità in mel1loria di Sandro Stucchi, «Studi miscellanei» 29, 1991-1992, 183-184; G. Co"LUNN1\, Dxvlllité- peu connues du panlhéon étrusque, in AttiColJ, Les plus religieux des hommes (Paris 1992)Paris 1997, ~7.0-17~). Al di là della priorità di assumione, con ogni probabilità da assegnare aile metropoIletrus~o-I~~1"l(honalt:sem~ra comunque plausibile l'îpotesi di un apporto diretto del tema, 0 di panicolariredazl0m l.conogl:afl~he.d1 Caran.te, dal mondo greco ai ccntri dell'El'ruria padana, soggetti dmante il V sec?lo a.f?rtl solleclta~lOl~l,culturah.~ideologiche da parte dei partners commerciali greci. Ne è una riprova ladlverslta delle SOlUZI011l lconograhche adottate contemporaneamente nci due ambiti dell'Etruria e la mag-
giorc vicinanza della versionc etrusco-padana del Carante con remo rispetto alla tradizione greca (RONCALLI, in «Acta Hyperborea» 8, 2001, 253).
8 A. M.i\.STROCINQUE, Giganti sileniei in Grecia e in Etruritl, inAttiCon Dionysos. Mita e mistero (Comacchio 1989), Ferrara 1991,277 ss. La diffusione sulle stele fdsinee delle figure di sileni potrebbe trovareorigine nelle immagini di sileni e di cortei dionisiaci che ricorrono, sia pure di rada, nel rcpertorio della pittura parietale funeraria di Tarquinia (G. COI.ONNA, Rijlessioni sul dionisismo in Etruria, in AttiCon Diony"sos. Mita e mistero (Comacchio 1989), Fenara 1991, 118).
'! MANSUELU, in CatMostra, Moslra dell'E'truria Padana, 23; Cr:mCIIIAI, in AttiCon Caronte. Un oboloper l'Aldilà, 377; 1. CERCIIIAI, La rappresentazione di Teseo sulle stele felsÙm:, in AttiColl, Le mythe grecdans l'Italie antique. Fonction et imt/ge (Roma 1996), Roma 1999, 353; S. BKUN1, Una pietra "scemaJ). Contributo allo studio dellt/ statut/n'a etrusca di eLà areaica del!' elà settentrioflale, in In memona di E'nnco Parthem,Roma 1998,73 nota 34, ove a proposito del personaggio raffigurato sulla stele n. 135 si ipotizza possa esserel'immagine di un sacerdote che impugna uno sl~erpaflon.
III CERCHIAI, in AttiCon Le mythe grec, 353; una posizione piÙ cauta è sostenuta da G. Sassatelli, nell'întervento alla discussione in AttiCoil, Le mythe grec, 372-373.
11 L'analisi delle stele sicuramcntc riconducibili ai conedi di pertinenza ha consentito di ricostruire unagriglia cranologica che comprende J'intera produzione scultorea e che pua essere assunta come punta di riferimento anche pel' gli esemplari non in contesta {SASSATELLI, in AttiCon Secondo Congresso Internilzionalel.
12 SI\SSATELLI, lntervento alla discussione in AttiColl, Le mylhe grec, 373.
229CERAMICA ATTlCi\ Je: S'J'ELE FELSINEE
moni che alludono all'Oltretomba e al potere civilizzatore di Dioniso '" indiziano il diffondersi di nuove ideologie funerarie e mutano il panorama figurative delle stele, inprecedenza ancorato a terni quali il banchetto, la danza e la raffigurazione del defuntosecondo un sistema codificato che riflette le categorie sociali 9.
Luca Ccrchiai arriva a rieonoscere "nella città delle immagini" delineata nella ceramica attica a figure rosse il principale modello di rifcrirnenro, rifunzionalizzato insense funerario, del repertorio iconografico adottato sui segnacoli di Bologna, proponendo in tal modo una chiave di lettura degli schemi figurativi su di essi adotrati 10.
Nell'ambito di tale filone di indagine, che tende ad assegnare alla ceramica atticaun ruolo preponderante nella formazione e nello sviluppo dellinguaggio figurative edel pensiero locale, con questo contributo si è inteso esaminare un aspetto marginaleche, in guanto tale, pue portare un contributo modesto, ma più oggettivc a questocomplesso problema. Si è voluto analizzare l'eventuale apporto del patrimonio iconografico attico al ricco repertorio delle decorazioni "accessorie" delle stele, costituite dacornici, da listelli che separano le scene, c dagli clementi fitomorfi che decorano i registri rninori in alternativa ai consucti animali marini e mostruosi. Tale decorazione, infarri, essendo apparcntcmcntc priva di condizionamenti di carattere culturale c ideologico risulta più libera e quindi di fatto più saggetta alla ditfusione di gusti e di motiviartistici. 1,0 studio ha preso le mosse da una analisi tipologica dei motivi ornamentaliimpicgati. Pur nella generale difficoltà di definire con precisione l'inguadramento cronologieo delle stele, qualora non siano note le associazioni con i corredi tombali di appartenenza, si è tentato di considerare diacronicamente l'adozione dei diversi clementidecorativi, attribuendo una datazione alle stele esarninate sulla base del profilo e delledimensioni, della se1ezione dei terni iconografici prescnti ncgli spazi figurati 11 c, soloin ultima analisi, dei caratteri stilistici che, come è noto, consentono valutazioni incerte ed in studi passati hanno generato pericolosi fraintendimenti cronologid 12.
EUSABLTTA GOVI - GIUSEPPE SASSilTELLl228
L.' DUCATI, Le pierre [unrraric felsinee, 125-131. Altri due cippi sferici, ara pcrduri, furono rinvenutincl 1889 nel sepolcreto dei Giardini Margherita (SASSATELLl, AttiCon Seconda Congresso Inlernazionale,9.30-931 nn. 4-5).
14 DUCATI, Le pietre funerarie felsinee, 146-149; G. SASSATELU, Topografia e "sistcmarione momanentale" delle necropoù felsince, in AttiCon La formazione della dt/à preromana in Emilia Romagna (BalognaMarzabatto 1985), Imola 1988,226-227; S. BRUNJ, L'altere arcaico dei tempio di Fiesole, «ArclrClass» XLVI,1994,70; ID.,in In memoria di Enrico Paribeni,71.
]) A questo gruppo di segnacoli eniconici forse andrebbero aggiunti anche gli esemplari nn. 8 e 60 delDucati con fascia incisa l'uno e triplice cordone a rilievo I'altro, che scguono il borda arcuato del segnacolo,ma resta incerta il significaro di talc decorazione nella quele si porrebbe forsc riconoscere l'immagine di unaporta ad arco. Se COS1 fosse, salirebbero a tre i segnacoli felsinei decoran con questo motivo, in realtà resoassai diversamenre nell'unica stele che sicuramenn- esibisce al centra una grande porta rettangolare (DucxTl, Le pietre funerarie felsinee, 286-287, n. 1.32),del rutto simile a quelle dipime sulle pareti delle tombe tarquiniesi (per il significaro dell'immagine della porta nel quadro del sistema decorativo adottata nelle pitturefuncrarie si veda M. TORELLI, "Limina Aoemi". Realtâ e rappresenlazione nelia pi/tt/ra tarquiniese arcaica, inIl rango, il rito c l'immagine. Alle ongini della rappresentazione storica romana, Milana 1997, 122-150. Delnitro imprcbabile invece illegame con il motive della porta nclla stele n. 10.3,di forma arcuata, aniconica econ fascia delimitata da duc cordoni posta sulla spessore del segnacolo.
1(, Le stcle dccoratc su entrambi i lati sono solo 3.3.
Va tuttavia rilevato che nella tarda stele 10 dei Giardini Margherita la celebre scena della oave risulta priva di comice, regolarmente presente invece sull'altro lata della stele. In questa casa pero la comp1cssità della scena potrebbe aver indono a rinunciare aUfi consueta fascia decorata sul bordo della stele.
18 DUCATl, Le pietre funerarie felsinee, 497 -51.3.
i9 Sei di gueste stele hanno anche l'altro lato decorato e incorniciaro da un motivo ad onde correnti.
Il corpus dei segnacoli funerari felsinei comprende 210 esemplari, tra i quali si annoverano 10 cippi sferiei su base quadrangolare 13, 3 sculture a tutto rondo conformate aIcone 14, 17 stele aniconiche e semplici ciottoloni ovoidali 15 e 180 stele, decorate a bassorilievo su un lara 0 su entrambi [6, Dall'analisi della decorazione accessoria vanna espunri 20 esemplari conservatÎ solo in piccoli frammenti riconducibili aIle scene inscrite neiregistri e 18 stele prive di corniee e decorate con un unico motiva iconografico, preleribilmente costituito da una grande palmetta 0 dalla singola figura di guerriero e di panneggiato appoggiato ad un bastone. T ra le stele prive di corniee alcune appartengonocon certezza ai prirni decenni del V sec. a.C., suggerendo forse di considerare precipuodella produzione arcaica l'uso di uno specchio iconografico non incorniciato JI.
Tutte le rimanenti 142 stele presentanouna cornice che delimita il campo figurato.Nella editio princeps del Ducati le decorazioni comprese entro le cornici sono descrittesommariamente seguendo una tripartizione tipologica (decorazione geometrica, spiralead onda e decorazione firomorfa) lS. Ad un più attento csame le cornici possono essereciistinte in quatrro grandi gruppi, tre dei quali con alcune varianti interne sul piano tipologico. Il primo gruppo è costituito da 37 stele dotate di una comice Iiscia di larghezza variabile, talvolta conformata a spesso cordone, che compare per 10 più suesemplari di forma rcttangolare superiormente arcuata 0 dal profile a ferro di cavalloancora tozzo (Fig. 1) ed è quasi unicamente associata a decorazioni uniche (la palmetta- il cavaliere - il panneggiato -l'oplita) che occupano l'intcro spazio figurato " (Fig. 2).L'adozione della comice liscia sembra caratterizzare I'esordio della produzione sculto-
230 EUSAH.ETTiI. GOVI - GHJSEllPE SASSATELLlCERAlvllCA A"J'I'lCA E STELE PELSINEE
~{)~ •~ "~ •~
~ •d • •
1~ "'" •T -'" •
~ -<, •\""-" ~ •\è>"" ---c?i •
~~ • •='" • •
\~" • •~ "'" • • • • •
~.d •,d •~ •
wg, =d ••1L1
<: .:» • • • •----L
0 ((j \ ill crCJ ((1 jJ-
Fig. 1. Rapporta tipo di comice e forma della srclc.
231
211 Ricnrrano in questo gruppo stele darabili in base ai dati di scavc tra ]a fine del VI c gli inizi del V sec.a.C. (stèle n. 187) e al seconde quarto del V sec. a.C. (stèle nn. 60, 132, 135, 181), per le quali si veda SASSA
TEUJ, in AttiCon Seconde Congrcsso Intemauonale, 933 n. 10, 936 n. 19, 935 n. 16, 933 n. 12, 937 n. 21.21 Stde 200 (SASS1\TELU, in AttiCon Seconde Congrcsso Iraemazionalc, 939 n. 27) H, I (C. MORlGT Go
VI-G. SASSATELLl, Il sepolcreto ctrusco de! Polisporliuo di Bologna: nuoue stele funerane, «(Jcnus» I, 1993,109-114), stelc di S. Michele in Bcsco-Iato B (SASSATELLI, in Culture figurative e materiaù Ira Emilia e Marcbcï, 126 c 173B (DUCATI, Le picsre[unerarie [elsinee, 422 e 445-446) tutte della seconda metà del sccolo.
22 MORlGT GOVI-SASSATELU, «Ocnus» T, 1993, 119 stele F, inquadrata cronologicamente attorno allametà del V secolo. Une datazione più alta è assegnata alla stele da S. BRUNI, in «ArchClass» XLVI, 1994,67-68 nota 36, che sottolinea la presenza nel repertorie vascolare attico già dei primi anni del V secolo dellacarena di palmette oblique e contrapposre, inserita nel Iistello della srcle F. Va tuttavia tenuto in considerazione l'use assai prolungato che di questo motivo si fa nella cerarnica artica e la sua adoaione anche su alrrcstele felsinee sicuramente darabili agli ultimi decenni del V secolo, tra le quali la nota srele deI "navarca" inquadrabile cronologicamente sulla base del corrcdo funcrario cui la stele cra associata (SASSXITLU, in AtriCon Seconda Congresso lntcrnaaionaie, 941 n. 30), li motive della carena di palmette oblique e conrrapposnnon sembra dunque sufficieme pcr rielzare ai primi dccenni del secolo la stcle P, dal memento che ricnrrain un repertorie decorative che, oltre ad essere molto diffuso, resta inveriato pet l'intero V secclo.
233
•
•
•
•
•
•
•
•
•
~
•
•
••
•
• •
••
•
• •• •
• •• •
• •
•
.
•
•
1
1
1
•
•....•
•
•
•
••
! !
1·
i· •,
: ·1
1
.1 •!
·1·• • •
CERMvUCA ATTlCA E S'rELE l'ELSINEE
•
Fig, 2, Rapporte tipo di comice e terni raffigurati sulle stèle.
EUSABFl'TA GOVI - GIUSEPPE SASSATELLI232
rea felsinea 20, Va detto ruttavia che tale usa si prolunga nella fase tarda, seppure conrare attestazioni su stele a ferro di cavallo ma anche di forma circolare 21 (Fig. 3).
Il seconda gruppo di cornici cornprende una decorazione geometrico-lineare incisa, generalmcnte de1imitata da due Iistclli lisci, attestata su 48 steIe c solitamente cestituita da una fascia di triangoli alterni campiti a tratteggio (38 esemplari) (Fig. 4), piùdi rado da un motivo a spina di pesee (6 csernplari), da un reticolo di losanghe (2esemplari) e da un semplice tratteggio obliqua (2 escmplaril. Le cornici che rientranoin questa famiglia sono le più nurnerose dopa quelle decoratecon onde correnti e si riscontrano quasi esclusivamente su stele di piccole dimension! con profila a ferro di cavallo (Fig. 1). Di Donna su queste stele ricorre una figura unica a tutto campo che ta1volta è cornpresa tra una lunetta e un registre inferiore, entrarnbi decorati con rnotivivegetali 0 zoomorfi. 1 terni più frequenti sono la singola figura stante, maschile 0 fernminile, la palmetta e I'incontro tra un demene e il defunto (Fig. 2). L'usa di cornicigeornetriche ha probabilmcnte un arco cronologico molto ampio, ma cararterizza laproduzione più tarda e standardizzata delle stele, che negli ultimi deccnni dei V secoloin genere mostrano dimensioni molto ridorte ed una cornice assai larga (Fig, 3),
li terzo gruppo individuato, costituito da cornici con onde correnti documentatesu 67 ste1e, comprcnde al suo interno sette varianti, quantificabili con difficoltà tenutocanto dello stato frarnmentario delle stele, le cui cornici spesso non possono csscre valutate nel dettaglia. In tutte, le onde si dipartono dalla base della srele con andamentoopposto fino ad incontrarsi sulla sommità della superficie arcuata. Al tipo più semplice, con onde prive di ulteriori elementi ornarnentali e di limitata attestazione. si preferiscano di gran lunga le cornici delimitate alla base con una fogli» d'edcra rivolta versol'alto e arricchitc sulla somrnità con una palmetta (16 arrestazioni) (Fig, 5), piir di radacon una foglia d'edera (4 attestazioni) (Fig. 6), con un fiore di loto stilizzato (2 attestazioni), con un triangolo (3 attestazioni) 0 con una fascia di palmette e fiori di 101'0 alternati che costiruisce pero un unicum 22, Sono infine abbastanza nurnerose le stele do-
2i Stele C del Pohsporrivo datera agli inizi del IV sec. a.c. (MORlGl GOV1-SASSATElLl, «Ocnus» I, 1993,117-118).
14 G. SASSATELLl, in AttiCon Seconde Congresso Intemauonale, 946.25 Le stele decorate sullo spessore sono Il (Ducvn, Le pictre[unerariefelsinec, 507 -508), 9 delle quali
mostrano Û rralcio d'edcra dal tronco ondulato. Hanno un'unica attesrazione il rrelcio di vite e le singole foglie d'edera.
26 DUCATI, Le pietre funerarie je/sillet', 35, Pel' questa srele si porrebbero richiemare a confronte, siaper il tema raffigurato che pcr I'adozione delle metope, le srcle a soggetto dionisiaco del distreuo flesolano(F. MAGl, Stele e dppi fiesolani, in «SE» VI, 1932, tavv. VII 3, IX 2, X, XI 1-2, XII 1-2), per il guale è starorccenrcmente sottolineato l'importante ruolo di mediazionc nella diffusione verso Bologne c I'area padanedelle esperienze scultoree elaborate a Pisa c a Volterra (BRUNI, in «ArchCJass» XLVI, 1994,79).
tate di cornici neUe guali il motiva della spirale ad onda si alterna ad una sîngola fogliad'edcra (8 esernplari). In un solo casa poi la comice ad onde correnti presenta sullasommità una coppia di quadrupedi affrontati ". Gli esemplari che rientrano in questocospicuo gruppo mostrano quasi unicarnente la canonica forma a ferro di cavallo suddivisa in più registri, che si afferma attorno alla metà del V secolo e contraddistinguela fase matura della produzione scultorea di Boiogna" (Fig. 1). Le stèle con comice adonda si distribuiscono tra il 470 a.C. e gli inizi del IV secolo, ma alcune varianti, cornele onde culminanti sulla sornmità della stèle in una singola faglia d'edera 0 in un triangala e le onde alternate alle foglie d'edera, sono introdotte soltanto negli ultimi decenni del V secolc (Fig. 3).
Il quarto gruppo di cornici, costituito da appena 19 esemplari, comprende decorazioni fitomorfe, assimilabili a corone i cui rami solitamente si incontrano sulla sommitàdella stele. I tipi più frequenri sono il tralcio di mirto a di alloro (6 esemplari) (Fig. 7), iltralcio di vite (5 esemplari), il rama d'edera dal tronco ondulato (4 esemplari), mentre lacatena di singole foglie d'edera cuonformi 0 di vite ha una attestazione limitata rispettivarnente a due e ad un solo csemplare, 1 motivi vegetali sono gli unici a comparire anche negli spessori delle stele che solo di rado sono decorati 25. Generalmcnte associatealla forma a ferro di cavallo, ad eccezione del tra1cio di vite esclusivamente presente sustele dal profila circolarc (Fig. 1), queste cornici sono realizzate nella seconda metà delV secolo ed alcune varianri, come il tralcio di vite e le singole foglie di vite, sono documentate soltanto negli ultimi deccnni deI secolo (Fig. 3). Va infine menzionato un casoisolato di comice apparentemenre costiruito da Ullafascia suddivisa in metope figurateche segue il borda della stele n. 37, purtroppo conservata solo in un piccolo frammento.Vi si riconoscono due metope, in una delle quali è raffigurato un banchetrante semisdraiato su una kline. La srele era decorata con almeno due registri, separati da un listel10, ma i motivi figurati purtroppo non sono riconoscibili 26,
Se si esamina più in dettaglio il rapporta tra il ripa di comice, la forma della stelced i motivi iconografici realizzati nel campo figurato, emergono alcune tendenze cherimangono invariate attraverso il tempo e che chiariscono I'csistcnza di sistemî piuttosto radicati nella sintassi decorative delle srcle (Fig. 2). La figura a tutto campo 0 comunque compresa tra una lunetta e un registra inferiore, presente su stele centinate 0
a ferro di cavallo dal profilo poco slanciato, è sempre associata a cornici lisce 0 deco-
234 EU5t\HETTi\. Govr - GIUSEPPE SASSATELLlCERAMICA ATTICA E STELE FELSINEE
~'--
~{){)~
d
"" ~.
L
l~...--"
.,J 1
~.
'\r'h'-' ~.
~- -
.-J 1
\~"- .,.d
~..';,. ..J1
.
~ ,
\~,
~
l,
L---L CL·
1
1
L 1
-: ...J 1~
1
0 '0 0 0 0 0 0
0 r -s» ~ -e- N 'i''0 -e- ~ ~ ~ ~
Fig. 3. Cronolcgia delle comici adottate sulle stele.
235
rate da motivi geometrico-lineari. A1cune figure poi, come la grande palmetta, la donna stante e il cavaliere, ricorrono unicamente con un solo tipo, 0 al massimo con duetipi,. di corniee (liscia e con triangoli alterni). Questa associazione è costante e nonsembra dipendere né dalla capacità dello scalpellino né dalla monumcntalità della stele e solo in parte è conncssa a fattori di orcline cronologico. Tenuta in debito conto ladiffiéoltà di attribuire aile stele una datazione precisa c circostanziata al quarto di secalo, è possibile osservare che la schema specifiee con singola figura incorniciata dauna fascia di triangoli alterni compare su esemplari inquadrabili a partite dalla metàcirca del V secolo e caratterizza la fase matura della produzionc. Inoltre csso ricorrcanche sulla faccia secondaria di stele tarde, sul cui lato principale sono raffigurati ternicolti, ricollegabili alla mitologia greca, distribuiti su più registri e corredati da cornicicon onde correnti. Esemplificativo è il caso della stele n. 12 del sepolcreto dei Giardini Margherita, databile tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., che si configuracorne una delle più rnonurncntali pel' la prcsenza sulla spessore di una ricca serie dirnetope figurate con scene mitologiche. Sulla faccia principale la stele è decorata conuna comice di onde alternate a foglie d'edera e, procedendo dall' alto verso il basso,con le immagini di un delfino, deI viaggio della dcfunta su biga alata e dell'Aiace suicida; sull'altra faccia il rnotivo della donna stante rivolta verso sinistra, avvolta in unrnantello e affiancata da due grandi foglie d'edera, è incorniciato da una larga fascia di
237
Fig. 7. Stele n. ï3 dal scpolcrcto Arnoaldi.
CERAMICA ATTICA E STELE FELSINEL
Fig. 6. Stele n. 19.5dal scpolcreto della Certosa.
triangoli alterni ". La persistenza di tali scherni cornpositiv~, oltre a~ evidenziare l' esistenza ne] repertorio iconografico di un forte conservatonsrno,. ~~o forse avvalorarel'ipotesi, intuita dal Mansuelli e sviluppata di recente dal Cerchiai ' , seconde la gualetali irnmagini rientrano in un sisterna di rappresentazione dello status sociale del defunto connotato in base alla categoria di appartenenza (l'oplita, il cavaliere, il pann.eggiato 'con bastone, la domina), un sisterna evidentemente codificat? non .solo nell'immagine ma anche nella decorazione accessoria. 1 terni più complessi ~he SI aff~rrn~no apartire dalla meta del V secolo, quali il viaggio su carro 29, le figure dl demoni e dl Ca-
T' Sulla stele si veda da ultimo A. Mt\GGIANI, Modello etico 0 antenat.o erolc~< Sul m?llv? ~l Alace JUiCl~da nelle stclc fclsinee, «SE» LXIII, 1999, 149-165 con nuova Iettura delle immagmr c dell'iscrizione.
]$ Si veda la nota 9. ."~ n tema è gencralmenre inteso come l'allusione al pass~ggi~) dei def~unto verso l'A~dilà, ~C:VCnt: espli
cirato ulteriormenre dalla prcscnza di cavalli alati e di dernoni psicoporot» (SASSt\.TELLl, ~ AttlCon .S~cond(j
Congresso lrucrnazionale, 948 con ipotcsi di un'antericrità cronologica .d.el tema. 111 Etrun.a p~dana nspettoall'arca tirrenica, dovuta al ccntatto diretto con il monda greco, dalla cui ideologia funeraria dlpende:e?be).Una visione differente e orientata verso una lettura del tema in chiavc sociale è suggerita da ~".Ccrchiai chevi riconosce i paradigmi dell'universo mascbilc (la sfileta rrionfale su carro) c di guel~o~e~m1n~e (la ~ro~es
sione nuziale) secondo un sistema codificato di immagini articolate in base aIle classi dl cta c al genen (CERCHIAI, in AttiCon Le mythe grec, 353; ID., in AttiCon Caronte. Un obolo pa f'Aldilà, .377). Si rraua comun-
Fig. 5. Stele 0.130 del sepolcreto De Luca.
EUSABETTA GOVl - GIUSEPPE SASSATELU236
Fig. 4. Stele n. 80 dal sepolcrcto Amoaldi.
239
stele nn. 2, 1Oa,33,37,41, 160, F
stèle n. 169a
srele n. 10a
srelc n. 169a
ste]e nn , 144, 160
src]c n. 169b
srele n. 21
stele nn. 2, 43 spcssore, 169b, 182"~
siele no. l4, 15, 16, 17, 40, 42a, 44a, 54, 95, 164.
168, H
srele n. 63
CEllAi'I,uCA ATTICA E ST'LLE 1;ELSINEE
-~
TlP07
TlPO 8
TIP09
TIPO 10
TIP06
TlPO 5
TIPO 4
TIPO 3
TIPO 2
TIPO 1
r Schema delle decorazioni realizzate nei lisrclli che separano Î rcgistri delle stele.rïg.8. '- L
EUSABETfA GOVI - GIUSEPPE SASSATELLl238
que Ji un tema che sulle steie si carica Ji una valenza sicuramenre fuueraria essendo associaro ad immaginidi csseri ultramonJani.
JO Si vedano le note 7 c 8..JI G. SASSX[EU.I, Rapprescntasioni di giocbi atletici in monumenu funerari di area padana, in AttiCon
Spectacles sportifs et scéniques dans le monde Éirusco-Italiquc, (Rome 1991), Rome 1993,45-67.)2 G. SASSATELU, La situazioncin Euuria padana, in AttiCon Crise et transformation des sociétés arcbai
ques de l'Italie antique au \!,'siécleav. I-C (Rome 1987), Rome 1990, 80-83.JJ Sl\SSATELLI, in Culture figurative c materiau tra Emilia e Marche, 114"115. Un esempic Hluminante di
studio di un complesso iconografico fondato ami turto sull'anaiisi oggettiva della strutrura cornpositiva edella decorazione accessoria è quello delle pirrure pesrane, che ha chiariro I'esistenza di botteghe disnnte ri,spondenti alle diverse esigenze della cornmitrenza (A. PONl1MNDOLFO-A. ROUVERET, Le tombe dipinte diPaestum, Modene 1992,449-4(8).
H In alcune stèle il Iistellc liscio è occupato da un'iscrizione incisa (stele nn. L5,25, 42, 47,106) 0 scolpita (stele n.10). Per tutte si veda SASSATELLI, in AttiCon La formarioncdella cittàpreromane, 236-246.
)j Sulla quale si veda da ultimo A. IvL\GCL'INI, Agoni funebri "bellemleois nomois' pa Vel Kaiknas,«Genlis» 5, 1997, 123,135.
ronte", i giochi funebri " cd i cortei magistratuali", sono invece incorniciati di norrnadal motiva ad onda e dalle corone vcgetali che, come si è visto, ricorrono unicarnentesulle stele con più registri della seconda metà dei V secolo. In alcuni casi poi la ripetitivitâ degli schcmi cornpositivi, qualora sia anche associata a forri affinità sul piano stilistico pet la verità di non facile riconoscirnento, potrebbe fare ipotizzarc la provenienza di singoli gruppi di stele da una medesima bottega e forse I'analisi di questo particolare aspetto della produzione felsinea, mai tentato per la oggettiva difficoltà di sottoporre il corpus delle stele ad una sicura seriazione cronologica e stilisrice, deve prenclere le mosse proprio dalla decorazione accessoria, verosimilmonte la prima ad esscreeseguita dalla scalpellino ",
Passando ora ad esarninare i listclli che separano i registri (Fig. 8), si puo osservareanzi tutto come questo elemento solo di racio sia preso in considerazione nel generaleschema compositivo della stele. Sono infatti decisamente dominanti i Iistelli lisci ", attestad su 45 stele, molte delle quali mostrano terni colti, grande cura formale ed un riccoapparato ornamcntale realizzato nella cornice, nella lunetta e nell'ultimo registre in bassa. È dunque probabile che la preferenza verso un Iistcllo priva di decorazione dipendadalla sottigliezza della superficie a disposizione e forse anche dall'esigenza di non appesantire ulteriormente 10 spazio iconografico. Il ricorso a listelli lisci caratterizza l'interaproduzione delle stele, senza che si possa registrare un momento di maggiore adozione.I motivi ornamentali adottati in alternativa alla fascia priva di decorazione rientrano nelle tre grandi categorie individuate nell'analisi delle cornici, Ritroviamo cosi i motivi geometriei, in assoluto i più frequenti (tipi 2-5), quelli fitomorfi (tipi 7-8) e le onde eorrenti(tipo 6). I triangoli alterni campiti a tratteggio sono il tipo di decorazione maggiormenteutilizzato nei listelli, ma ha una certa anestazione anche la carene di palmette oblique econtrapposte (tipo 10), un motivo assentc nelle cornici ed introdotto unicamente nei listclli, cos}come quello delle singole foglie d'edera disposte su un rama ad "5" e affiancatc da piccole foglie a goceia (tipo 9). Entrambi i tipi sono prescnti sulla nota stele 10del "navarca" Vel Kazkna ". L'usa di listelli decorati si diffonde nella seconda metà dei
241
ULTIMO REGISTRO
srclc 11n, 48, 64?
stc]c 1111. 48, 64?
TIP06
srelen.47
TIro 4
stelen.73
TIro 3
TIP02
srele n. 173
'rIPO 1
'rIPO 5
srek n. 173
TIP08
TTP07
stele n. 79
TIPO 9
stele n. 168
CERAivlICA ATTICA E STELE FELSINEF
LUNETTA
srelc nn. 47,48,49,64,79,94, 106, J 61, 173. 195,S. Michele
TIPO 1
TlP02 ~~/J~~\I/~
/ , J
stc]c nn. 63, 86, 8V
TIPO 4
TIP03
ste]e n. 84
TIP05
stèle n. 168
TlP07
ste]e n. 68
stelenn.17,83?
srele n. 15
1 . ll'ulri 0 r -gistro in basse delle stele.Fig. 9. Schema delle decorazioni rcalizzate nella unetta supenore e ne llll e .
EUSll.BETTA GOVI - GWSEPPE SASSATELLI240
V sec. a.C. e sembra esclusiva delle ste1e più monumentali e particolarmenn- curate sulpiano iconografico e stilistico, come le note stele nn, 2, 10, 16, 160, 164, 168, il cui legame con una committenza "speciale", investira di alte cariche politiche e sociali ali'inter.no della comunità, è stato opportunamente sottolineato ". I listelli decorati sono assodari a cornici con onde correnti, spesso confluenti in una palrnetta sommitale, a conferma dell'inguadramento cronologico suggerito, che d'altra parte corrispondc a queljodella diffusione di stele a ferro di cavallo divise in più registri,
Resta infine da esaminare il repertorio ornamentale accessorio impiegato nei registri minori (Fig. 9). All'inremo delle lunette, poste sulla sommità, predominano i motivi di carattere vegetale (20 attestazioni), ma sono abbastanza numerose le stele chemostrano in questa sede animali in lotta, più spesso il serpente e I'ippocampo, 0 figureibride quaIi la Scilla". Il tipo maggiormente documentato è costituito dalla coppia difogIie d'edern (ripo 1), particoIarmente atto a riempire 10 spazio ristretto del registrosuperiore. In alternativa sono reahzzate palmette (tipi 2-6), dispos te su volute dallequali si dipartono due foglie a composte in gruppi di due 0 trc palmette contrappostee variamente legate tra loro, sempre con un ovvio sviluppo in orizzontale. Ha un'isolata attestazionc l'alberello di edera (tipo 7), presente su un piccolo frammento di stele,la cui cornice è decorata con la catena di singolc foglie d'edern cuoriforrni.
Sono solranro dicci le stele che esibiscono un motivo fitomorfo nell'ulrimo registroin basso, generalmente occuparo da una scena Iigurata 0 da un essere marino 0 ctonio.Tra i nove tipi individuari ricorrono la coppia di foglie d'edera (tipi 1-2), come si è visto presente anche nella lunetta, la doppia voluta, associata anche aile foglie d'edern(tipi 3-4), la singola palmetta impostata su volute da cui si sviluppano foglie (tipi 6-7),la catena di palmette alternate a fiori di loto {tipo 8) e due rami di edera fronteggiati(tipo 9). Le cornici di questc stele sono decorate con onde correnti. spesso arricchitcsulla sommità da una palmetta, 0 con motivi vegetali 0 con triangoJi a1terni incisi, e piùdella metà mostra un motivo fitomorfo anche nel registre superiore. Il ricorso a quesroschema compositivo, nel quale abbondano clementi vegetali, è esclusivo della produzione della seconda meta del V secolo c, in particolare, delle stele più curare sul pianoformale e stilistico, sulle quali tale decorazione accessoria sovcnte è associata a terninobili ed anche alla presenza di un'iscrizione ".
Dopo aver individuato nel corpus delle stele un ampio numero di elementi decorativi, inquadrabili tipologicarnente e cronologicamente, se ne è voluto esaminarel'ambito di ispirazione e la ditfusione in Etruria e nel mondo greco, con particolare riguardo alla ceramica attica, allo scopo di individuarne il modello di riferimento c di
;(, SASSAI'ELU, in AttiCon Crise el tramforlllatio!J des societes orcbaïqucs, 80-83.
li M. 1300SEN, EtruskÙche Meeresmiscbiocsen UntenuchulIgen ZU Typologie und Bedeutung, Roma1986,141-1421111.14-16,146_147 on. 32, 34,150 nn. 46-48 (pel' l'ippaca1l1po); 16-17 nn. 1-5 (per la Scilla).
J~ È il casa delle stele nn. 15,47,161 con isctizione, pel' le quali si veda SASSATEJ.LI, in AttiCon Laforrtwzione della dt/à preromane, 236-246.
•
Fig., 10,. Specchio arcaico con comice a triangoli alrcrni (da J. '1 P" '-. "N I\YER- I{OKOP, Die gravierten ctruseiscben
Gnffspiegel arcbaiscben Stils,Heidelberg 1967, taf 47,2).
J~ l_ .: MA~ER.-PR~)K:)P, Die G~avie~ten .etrttskis~hen Griffspiege! arcbaiscben Stih, Heidelberg 1967,
~O~ 10/1,.
ove SIsott?~ea la ~as:a diffuslone mEtruna dd motivo impiegato sin dalla fase più antica per decorme (lVerSe dassl dl matenah, tra le quali j bronzi e le stde fdsinee.
243CERA1\HCA ATTICA E STELE FELSINEE
",' il motive è pero già presente tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.c. come dimostrano due vasierrusco-corinzi attribuiti al pirtore dei Caduti (J. G. S:t.YLAGYJ, Ceramica etrusco-corimia [ignrata, Firenze1992,243-252, tav. CIX) e un calice di bucchero proveniente forse da Tarquinia (F. SCIACCA, in CatMostraPrincipietruschi tra Mediterraneo edEuropa, Venezia 2000, 208 n. 229).
-11 il motiva è presente anche nclla Tomba dellaPulcella, dove incornicia il Ioculo, e in tombe deI V secolo di Blere (Crotta dipinta) e di Grotte S. Stefano (tomba dipinta) (S. S"lYINGRABER, Catalaga ragionatodella pittura etrusca. Milano 1985, 340 n. 103,265 n. 1,283 n. 29).
-12 J.G. SZIL,\GYI, Ceramica etrusco-corimia figurata, parte Il 590/580-550 ü.c., Firenze 1998, 435 11. 3,tav. CLXXIl d.
-1i T. DOHR.N, Die sdnoanfigurigen etrusleiscben Va.œn ans der noeitcn Ilà"lfte des secbsten [abrunderts,Berlin 1937,26 e 145 n. 57, tav. 2.
-1-1 M. MARIELLI, La ccramica degli Etruscbi. La pittura oascolarc, Novara 1987,311 n. DO; B. GINGE,Ceramicbe etruscbe afigure nere, «MMAT» XII, Roma 1987,58-59 n. 26, tav. XLV.
.jj M. C\PI'ELLFTTl, MUJ"t'o Claudio Faina di Orvieto. Ceramica euusca figurata, Pcrugia 1992, 112 n. 35;M. Martelli, Pesta euusca, in Kotinos. Festscbrift [ùr Erika Simon, Mainz 1992, 342 con confronti individuatinell'ambito della "Pattern Class" del Gruppo di Orvieto, nella qualc lespirali e le oncle correntî ricorronocon frequenza.
specifica iconografia del defunte, raffigurato secondo un sistema codificato, articolatosulla base dello status sociale e della classe di età. La Iortuna di questo ornato, assaisemplice e di facile esccuzione, è quindi uno degli elementi che consente di riconoscerein una larga parte della produzione scultorea della seconda metà dei V sec. a.C. un generale impoverimento del repertorie figurativo oltre che un certo scadimento stilistico,a fronte di esernplari di elevato livello artistico che spiccano ultcriormcntc per le misuredecisamcntc maggiori, per l'adozione di terni colti e di una decorazione accessoria ricca,connotandosi come esclusivi di un gruppo sociale elevato. Nella seconda metà del V secole si registra pertanto un divario sempre maggiore nella produzione delle stele, moltoeterogenee sul piano stilistico-formale e dei contenuti, un divario che probabilmente riflette un cambiamento sociale ed economico della comunità. organizzata ora secondouna struttura "cittadina", non più ancorata a valori di antica tradizione arisrocratica evincolata al ruolo rivestito dall'individuo all'interno della società.
Il secondo tipo di comice maggiormente documentato sulle stèle, eioè le onde correnti, utilizzate anche per i listelli, ha una vastissima diffusione nell' arte etrusca a partiredall'arcaismo 40. Il motivo delle onde marine, rcso con una Iinca ondulata continua sullaquale si schicrano paratatticamente i delfini, infarti è presente nella pittura parietale giàdagli ultimi decenni del VI secolo (Tombe delle Leonesse e della Caccia e della Pesca).La redazione stilizzata delle onde correnti, adottata anche sulle stele felsinee, fa la suacomparsa nella pittura tarquiniese qualche decennio più tardi, cioè nella prima rnetà delV secolo (Tombe del Triclinio e dei Letto funèbre], e si impone poi corne fregio superiote dello zoccolo, sovente associato a delfini guizzanti, specie durantc la fase ellenistica 41. Nella tarda produzione ceramica etrusco-corinzia il motivo compare, seppure inuna redazione stilizzata, sulla spalla di un'anfora dei pittore delle Teste di Lupo cheopera a Tarquinia tra il59ü e il57ü a.C. 42. Nella ceramica etrusca a f.n. esso rientra nelrepertorio del Gruppo de La Tolfa 43, del Pittore di Micali e della sua scuola 44 e soprattutto in quello delle botteghe tarde" (Fig. 11). Nella dccorazionc architettonica il fregio
EUSABETTA GOVI - GruSEPPE SASSATELLI242
v~utare quindi la rea~e p01~tata, del:'influsso che i vas! attici esercirano sugli scalpellinidl Bologn~. ~ ~uesta indagine e pm strettamente correIato il tentativo di analizzare l'cventuale slgmfIcato che la dec.orazio~e accessoria riveste nell'ambito della composizione generale della stele c della ideojogia funeraria.
. Tut~ i.motivi geomerrico-lineari rientrano in un repertorio decorative etrusco di antrca tradlzlO~e., I? p~rticolare il tipo di ornato geometrico più frequentemente utilizzatos~lle. stel~, croe 1 tr~angoli ~;;rn~ campin a tratteggio, durante la fasc tardo arcaica eclassica ncorre sugli spccchi (FIg. 10), sia nella comice che nei listelli delimitanti I'es~rgo,. In an~logla con l'uso che di tale rnotivo si fa sulle sculture funerarie felsinee. Ladiffusionc dl questo ~~po.di comice, come si è visto, caratterizza la produzione più tardadelle stele, sempre pm piccole nelle dimensioni, ed ha una stretta correlazione con una
Figh"
J L Anfora et~llsca a f.n. attribuim ad un scguece del pittore di Micali 500-480 C (d Brmc c etruscbc a figure nere, Roma 198ï, tav. XLV), ' a. . a . GINGE, Ccra-
245CERAtVI1CA ATTICA E STELE FELSINEE
con onde correnti ha frequenti atresrazioni sin dagli inizi del V secolo 46, COSI come nellaproduzione metallurgica 47, nell' ambito della quale compare sui coperchi delle ciste prenestine più antiche 48, ma soprattutto sugli specchi arcaici e della prima metà del V secola, che ancora una volta offrono il confronta più stringente con le stele felsinee non soloper la comune adozione di scherni cornpositivi generati dan'adattamento del fregio aduna superficie circolare 0 ovoïdale, ma anche pet la analoga se1ezione di ornati accessoriassociati aile onde correnti. Sugli specchi infatti la comice di onde correnti, oltre ad essere trattata come sulle steIe facendo convergere verso l'alto le due fasce direttc in sensoopposto, è arricchita alla base e all'estrcrnità superiore del disco con una foglia d'edera~') (Fig. 12), con una palmctta" (Fig. 13), con un fiore di loto 'JI , a con una sorta ditriangolo 'i2. Il motivo rientra dunque nel più cornunc repertorio figurativo etrusco cd inaren padana si afferma durante il V secolo oltre che sulle stele funerarie anche su clementi di arredo architettonico, come i parapetti da pozzo fittili di Marzabotto-"·'.
~(, Notissimi gli acroreri da Palerii e da Gabii, datati agli inizi del V secolo, nei quali onde correnti sonoposte alla base delle grandi volute che comprendono gli altorilievi (Catlvlostra Civiltà degli [}truschi, Milano1985, 267 10.l1 e l0.12) e altrettenro celebre quelle da Caere con Eos c Kcphalos impostato su onde marine (A, ANDRÉN, Architectural tcrracottas from ctrusco-ùolic temples, Lund-Leipzig 1939-1940, 36-37 II.16,tac. 11 e Catêdostra Die \Veli der Etrusleer, Berlin 1988, 170, B 6.1.18). Il rnotivo ricorre anche sulle lastre dirivestimenro del tempio A di Pyrgi inquadrabili nella prima metà dei V sccolo, pcr le quali sono citarc aconfronro aime da Olimpia c da Corcira con serie di spirali dipinte (F. Mrtrs, Pyrgi, "NSA" 1970, II Suppl.1,14.5 fig. 96). Nella produzione di IV-III sec. a.CiIe onde continue compaiono con una certa frequenza allabase delle lame erchitettoniche (ANDRÉN, Architecturalterracouas, nn. 252-253, 264, 548).
~; Il fregio ad onde correnti è presente ad cscmpio sul]e lamine in bronao con scene di battaglia da Bomarzo (M. COMSTOCK-C. Vm!\;1UJLE, Crcele Etruscan and Roman Bronzes in the Fine Arts Boston, Boston 1971,469-70), sul notissimo lampadario di Cortona, sul quale cornpaionc anche i delfini guizzanti (P. BRUSCHETTJ.ll Iompadario di Cortona, in «AnnAcCortona» n.s. X, 178) c su un 'oinochoe di forma VI dalla r. 13 della necrcpcli di S. Cerbone di Populonia, datata alla seconda metà del.V secolo (A. ROMUALDI, in CatMostra Unodonnadi rangoa Populonia, Firenze 1998). Il motive, significativamente presente anche sul coperchic del cinerario con banchertantc all'Ermitage di San Pietroburgo (M. Ü{ISTeWANI, Tbromi degli Etruscbi, Novara 1985,29.) n. 117), nel IV-III secolo ricnrrcrà ne! più comune repertorio degli amati sie nella toreutica che nell'oreficeria (si veda ad es. NI. CmsTofANI-M. Mi\I{TELLI, L'oro degli Etruscbi, Novara 1983, 318, n. 281).
~~ La fascia di oncle correnti di norma orna il borde e l'ancllo centrale del copcrchio delle ciste delgruppo A, la cui produzionc ha inizio attorno a1460 a.C. (G. BORDENI\Cl-IE BAl'Ti\GLl/\, Le cisteprencstine I)1, Roma 1979, nn. l, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIX, XXIV; G. BüRDENACIIE BATTAGLIA"A. El\HLIOZZI, Leciste prencstine T, 2, Roma 1990, nn. 1, XXII; per la cronologia del gruppo: M. i\!IENICHETTI, "Çuoius FormaYirtutei Parisuma fuit ..." Ciste prenestine e culrura di Roma mcdio-rcpubblicana, (Archacologia Pcrusina12), Roma 1995, 15-16).
,I~ CSE Bundesrepubliè Deutschland4, n. 4, dateto tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.c. Si vedanca coofronto le stcle nn. 16, 160, 168, 195 con analoga soluzionc.
'II CSE Great Britoin 2, 1, n. 1, dataro al primo classicisme: G. PFlsTER-RoESGEN, Die etmsleiscben Spicgeldes 5.[abrbundertsv. Chr. (Archâologische Studien 2), Bem-Prankfurt 197.5,S 13, datato al 460-450 a.C.La presenza di una palmette sulla sommità della cornice ad onde correnu è la variante più comunc sulle stele felsinee (si vedano a titolo cscmplificativo lesrclenn. 130, 136, 188).
j1 CSE Denmark 1, n . .3 datato attorno al 460 a.C, per il quale si confronti la stele n.76 ..oz CSE USA. l, n, 26 datato al.500-460 a.c. Si confrontino le stele nn. 106 e 47,48, E con rriangoli ar
ricchiti di incisioni interne.j) G. SASSATELLI, in CatMostra Civiùâ degli Etruscbi, Milano 1985, 160"161 n. 6. 3.'5, dataro alla prima
EUSAI:lETIA GOVI - GiUSEPPE S/\.SSAfELLI244
247CLm..MvllC1\ 1\T11C1\ E STELE l'ELSINEE
toatrica (J. BOAHDIVIAN, Earl}' Greel: Vase Painting, London 1998, figg. 102.1, 127,210; P. JACOBSTII1\L, Ornamcnte Griecbiscber Vase, Berlin 1927,48).
56 J. BOARDMAN, Vasiateniesi afigure nere, Milano 1990, fig. 86 (pirtore di Amasis)..\' J. BOAKDMAN, AibenianRed Figure Vases. The ArehaiePeriod, London 1975, fig. 144 (pirtore di Ber
lino); ID., Atbenian Red Figure Vases. The Ciassical Period, London 1989, figg. 326 (pittore di Pronomosl,371 (piano da pesee), 374 (pirtore di Toya): Catlvlosrra La ceramica auicafiguratanellc Marche, Castelferretti 1991,26 n. 4, 28 n. 5; M. B. MOORE, Anie Red-Pigured and White-Ground Pouery (The Athenian AgoraXXX), Princeton 1997, n. 623. Massiccic l'usa di questo ornato nella produzione ceramica magno"greca (A.D. THI':NDALL, Red Figure VasesofSouth Italy and Sicily,New York-London 1989, 172, 197,206,235).
5H Una srcle funeraria forse di produzione artica, datata rra il 575 e 525 a.c., esibisce sulla sommità,conservata solo in una piccola poraione, una voluta incisa che ha suggerito una ricostruzione con una fasciadi onde correnti, sulla quale pero non vi sono clementi di conferma ed anzi risulta molto più prcbabile lapresenza in questo punto della stele di un'originaria palmena e di qualchc altro motiva decorative (M. B.COl'vlSTOCK"C. C. VERMEULE, Sculpturein stone. The Greele, Roman and Euuscan Collection of the l\lfuseum ofFineArh, Boston 1976, 10-11 n. 16).
Fig. 13. Specchio con comice ad onde corrcnti, datato al primo classicismo (da CSE Great Britain 2, 1,n. la).
a f.n. 56 e a f.r. 57, nella qua]e riveste un valore puramente esornativo ed è destinato adelimitare le scene figurate oppure, nella produzione tarda, a decorare vesti 0 oggetti". In nessun casa il motiva sembra avere una conncssione diretta con il mare, costante invece nel mondo etrusco dove è esplicitata, specie nella pittura parietale e suglispecchi, dalla prcscnza frequente di delfini che saltano tra le onde. Studi recenti, basati su approfondite analisi iconologiche e filologiche, hanna chiarito come la ricorrenza
EUSABETT/I. GOVl - GrUSEPPE SASSATELLJ246
, ~'ori~in,~ di talc or:;ato, mai indagara nel, dettaglio, è stat~ ricondotta da qualchestl~dl~SO ~ll area greca .' clave trova la redazione più antica ". Una serie continua dispirali 0 dl vere e proprre onde correnti compare sporadicamente nella ceramica artica
Fig. 12. Specchio ercaico con comice ad onde corrcnn (da CSEBundcsrepublieDeutscbland 4, n. qal.
~1etj.d~ V sec. ai\ A. M. r:UR.i\i\JTE-L GERVJ\SINI, Marzahotto, in CatMostra La formazione de/la città inmll~a .omagna, 0 ogna 1:8/, 321~325, datata alla prima merà deI IV sccolo, ma ricondotto entra il rima
trentenmo del V secolo da S. BRUNI 111 «ArchClass»XLVI 1994 68 nora 36 In -nt bi . . "IP .• . cl de c ,." . . .. .' , ~ . en l'am 11 parapettl 1 mou\ 0 a 140n c ~orrcntl c assocrato al dclfini guizzanti.
La Schwarz, nello studio dedicato alla Pattern Class del Crupp cl' O· . . . 1 cl. " .. dl' . J .T 0 1 IVleto, nntraccra ne mon 0g:eco l prototl~l c rnouvo che entra a far parte del repertorie più comune della ccramica a f n di reduztonc ctrusca (S. SCH\'I?!\RZ, The Pattern Clan Vases of the "Gruppo di Gnncto" ir. the US" t . " ,f .C Il t' (",1 . l . . . " '" .. j ~a ,lOna· .Jvluseum,0 ec IOn, cllnll)SOnlan nstuunon, Washington D.C. «SE» XLVII 19-/9 -/3) L M J' k .
. al bi di '. . ' ". a aycr- ro op suggerrsceun an, ?g~ am Ho l lspl~az~onc ~er spl~gare la diffusione in Etruria, specificamente sugli spccchi arcaicit~ f;e~lO a~ ond~ correnn, gl~111to 111 It~ha ~ttraverso la mediazione della ceramica laconica e artica (MAYER~
ROK21, Dit graoierten etrusleiscben Gnffspiegel, 109"110).
Esso compare infani sulla ceramica gcornetrica di produzione beotica, argiva s: sulla ceramica pro-
sv B. D'AGOSTINO, Le Sirene, il tuffatorc c le porte dell'Ade, in B. n'AGOSTINo-L. CEHUHi\l, Il mare lamorte l'amore, Roma 1999, .53-60; ID., Oinops pontas. 1l mare come aùerità nclla pcrcaione arcaica, ibidem,81-88; L. CERCIHAI, Sulle Tombe de! Tuffatore c della Cama e della Pesca. Proposta di Ieuura iconologica, ibidon, 61-71,
611 Si pensi ad es. allampadario di Cortona, sul quale una cornplessa sequenza di immagini allude allediverse dimension! dei mondo terrcno e ultraterreno, 0 alla starua-cinerario a San Pictroburgo (per enrram.bi si veda la nota 48).
6] Resta da chiarire ad csempio il significaro che tale omuto ha sugli specchi, dcve è largamcnre utilizzato sie came comice, sia came ricmpirivo dell'esergo. Una diretta derivazione dal repertorio della pitturatombale è del tutto probable e d'altrn parte è stara più volte asserira Ia dipendenza, 0 comunque 10 srrcttoIegame, dur-ante l'arceismo, degli incison dall'csperienza della grande pîttUIa (G. A MANSUFLLI, Gli specchifigurati etruschi, «SE» XIX, 1946,73-87; I. E. j'vI. Em.uND, Flora! and fauna! motifs on etruscan mirron, inAA.VV.,A Guide to Etruscan Mirrors, Tallahassee 1982, 138; S. BRUNI, Di un J!110VO specchio etrHlCQ e delleofficine tarquiniesi di età tardoarcaica,in «Rassegna di Archeologia» 9, 1990,390-393). Il riferimento al mareperà potrebbe in moIti casi non essere COS] esplicîto, avendo assunto il motivo ad onde carrenti un sempliccvalore decorativo (D. REBUFFAT-E!\.lMi\t\lUEL, Le miroir étrusque d'apres la Collection du Cabinet des Médailles, Rome 1973, 43.5-436).
{'2 SCII\'l/,iillL, in «SE» XLVII, 1979, tav. XXVI, 22-23 (piattîl, ta\'. XXVII, 1-4 (calici).
sulle pareti tombali di tale Îconografia marina, e ancor di più della secna de] tuffo nelmare, sia da ricondurre all'allusione in essa implicira ad uri'esperienza di totale altcrità, paragonabile nell'immaginario etrusco (e greco), da una parte, a quel1a vissuta nelsimposio durante il consuma del vina, i cui effetti conducono ad una condizione "soprarazionale", dall'altra, al passaggio verso la morte, intesa quindi metaforicamentecome un'immersione in una diversa dimensione". Sembra aliora molto probabile cheanche sulle ste1e felsinee, clave oltre turto esseri marini c delfini sovente decorano lunette e registri inferiori, il fregio con onde correnti paresse evocare una particolarepercezione della morte. Lavalenzafuneraria, implicita nell'iconografia delle onde correnti ed entrata a far parte dell'immaginario etrusco già nel tarde arcaismo, pue scnzadubbio averne favorito I'adozionc ed il successo nella produzione scuItorea di Bologna, come su altre categorie di oggettidestinate ad un contesto tombale 60. Va comungue tenuta in considerazione l'iporesi molto verosimile che nel corso del tempo abbiaprevalso l'aspetto puramente decorativo di questo motivo, come sembrerebbe denotare la sua ampia diffusione in quasi tutte le ciassi di materiali di produzione etrusca,non necessariamente correlate all'ambito funerario 61.
Tra le varianti individuate all'interno del vasto gruppo di stele che esibisce la cornice con onde correnti. quella costituira dall'alternanza tra on da e singola foglia d'edera sembra configurarsi come un'innovazione autonoma degli scalpellini bolognesi allabase della quale vi è la semplice combinazionr- di duc distinti motivi in uso, anche setale ornato compare già in una fase più antica nella cerarnica etrusca a f.n. 62 (Fig. 14).
Se dunque per i motivi maggiormente diffusi nelle cornici delle stele, geometriei ead onde correnri, è possibile individuare i modelli stilistici cd ideologici nelmondo etruseo, ed in particolare nell'esperienza della grande pjttura funerarin e della bronzisticatra loro strettamente corrclate, diverso c più complesso è il quadro offcrto dalla famigliadelle cornici vegetali, dai Iisrclli e dai registri minori, decorati dai rnotivi fitomorfi.
249CERAlvllCi\ i\'J'llCA E STELE FELSINtE
La serie continua di singole foglie d'edern cuoriformi è attestata sul finire del VIsec. a.C. in Etruria meridionale, da cui si trasmette verso nord, entrando.a far partedeI repertorio oruamentale dei cippi di area etrusoco-sett~ntr.i~nale, .che sI:urament.ecostituiscono il modcllo per gli artigiani bolognesi 6). Se quindi Il motivo puo essere ri-
Fis 14 Calice etrusco a f.n. della Pattern Class del Gruppo di Orvieto (da S. Schwarz, ~he .Patlenl C~anVc~:es of the "Gruppo di Onneto" in the u..')': National Mm'eulll Collection) Smitbsonian Institution, Washmgton nc, in "SE" XLVn, 1979, tav. XXVIl).
{,\ Olrrc ai tre esemplari documentati a Balogna (stclc nn. 68, 190 e cippe Arnoaldi: G. SASSi'd:ELLI,
.. . 1 \' 1 SE XLVn 1977 120-121 n 9· S BRUNI-F.-SI·.Vf',-L'Etruria padana e i! commrrcto dei marrm ne scco 0, «o.r;» .. ':'. . '.' . '.' ..IUNI Prob!emi .ft/lie presenze e1rusche net!a Toscana nord"occidenta!e: 1 datl delle ne~ropo!l dl~/:,a, ln Att!:Cm;v Aspetti della culiura di \lo/term etrusca Ira l'e/à de! ferro 0' l'età .ellentstlcl1 CAttI.del XIX Conv.~gn.o.chStudi Etruschi cd Ttalici, Volterra 1985), Firenze 1997,583), va :11cnzl~nata l~ stel~ dl ,V secolo .con .ISCflZIO:
ne rinvcnuta a Tombarelle (Crespel1ano) c dccorat8 con una sene contmua d~ fog1Je d.cdcra ul1lt.e tra lor? edesinenti in una palmetta posta sulla sommità. La stdc mostra al ~entrc:, un disco ragglato c .nel nc!uadro 111-.
f · , . 1· ff t· t· 1(' SSS·S·A·]·E] L] ilncora fUI mf/Jortl tra Etruntl padana e Italia setttlltnonale.enore uue anJm81 a l'on a 1 .T.'.' '.'"" , . . . . C)
qualche esemplifiàlziolle, in AttiCon Ch Etruschi a !lord dei Po (NIantova 1986), Mantova 198;1,67 -69 .
EUSAI3ETTA GOV1 " GTUSEPPE SASSil.TELLT248
sulle pareti tombali di tale iconografia marina, e ancor di più della scena del tuffo nelmare, sia da ricondurre all'allusione in essa implicita ad un'espcrienza di totale alterità, paragonabile nell'immaginario etrusco (e greco), da una parte, a quella vissuta ne]simposio durante il consuma del vino, i cui effetti conducono ad una condizione "soprarazionale", dall'altra, al passaggio verso la morte, intesa quindi metaforicamentecome un'immersione in una divers a dirncnsionc ". Sembra allora molto probabile cheanche sulle stele felsinee, clave oltre tutto esseri marini e delfini sovente decorano lunette e registri inferiori, il fregio con onde correnti potesse evocare una particolarepercezione della morte. La valenza funcraria, implicita nell'iconografia delle onde correnti ed entrata a far parte dell'immaginario etrusco già nel tardo arcaismo, pue senzadubbio averne favorîto l'adozione ed il successo nella produzione scultorea di Bologna, come su aItre categorîe di oggettidestinate ad un contesta tombale 60. Va comunque tenuta in considerazione l'ipotesi molto verosimile che nel corso del tempo abbiaprevalso l'aspetto puramente decorativo di questo motivo, come sembrerebbe denotare la sua ampia diffusione in quasi tutte le classi di mareriali di produzione etrusca,non necessariamente correlate all'ambiro mncrario".
Tra le varianti individuate all'interno del vasto gruppo di stele che esibisce la cornice con onde correnti, queUa costituita dall'altcrnanza tra onda e singola foglia d'edera sembra configurarsi come un'innovazione autonoma degli scalpellini bolognesi allabase della guale vi è la semplice combinazione di due distinti motivi in usa, anche setale ornato compare già in una fase più antica nella ceramica etrusca a f.n. 62 (Fig. 14).
Se dunque per i rnotivi maggiormente diffusi nelle cornici delle stele, geometrici ead onde correnti, è possibile individuare i modelli stilistici ed ideologici nel monde etruseo, ed in particolare nell' esperienza della grande pittura funeraria e della bronzisticatra loro strettamente correlate, diverso e più complesso è il quadro offerte dalla famigliadelle cornici vegetali, dai listelli e dai registri minori, decorati dai motivi fitomorfi.
Fig. 14. Calice etrusco a Ln. della Pattern Class del Gruppo di Orvieto (da S. Schwarz, T'he Pauem ClassVases of the "Gruppo di Orvieto"in the US NationalMuseum Collection, Smitbsonian lnstuution, Washington tic, in "SE" XLVII, 1979, tav. XXVlI).
249CER",lvllC1\ 1\T'1'J(A E STELE FELSJNEEEUS/I..I:\ETTA GOVI - GIUSEPPE SASSATELLl248
j') B. D'AGOSTINO, Le Sircnc, ii tuffatore e le porte dell/Ade, in B. I)'AGOSTINO-L. CERCHIA1, Il maye lamorte l'amore, Roma 1999, .53-60; ID., Oinops pontas. Il mare come oùerùâ nella percczionearcaica, ibidem,81-88; L CERCHIAI, Sulle Tombe dei Tuffatore e della Cama e della Pesca. Proposta di lettura iconologica, ibidem, 61-7l.
6ù Si pensi ad es. al Iampadario di Cortona, sul quale una complessa sequenza cli immagini allude ailediverse dimensioni del manda terreno e ultraterreno, 0 alla statua-cinerario a San Pierroburgo (per entrambi si veda la nota 48).
61 Resta da chiarire ad esempio il significaro che tale ornato ha sugli specchi, doce è largamente urilizzatc sie come comice, sia come riempitivo dell'esergo. Una dirette derivazione del repertorie della pitturatombale è del tuno probabilc c d'altra parte è stara più volte asscrita la dipcndcnza, 0 comunque 10 strcrtoIegame, durante I'arcaismo, degli incisori dall'csperienza della grande pittura (G. A. MANSlJELLl, Gli speccbifigurati etruscbi, «SE» XIX, 1946,73"87; 1. E. M. EULUND, Floral and faunal motifs on etruscan mirrors. inAA.VV., A Guide ta Etruscan Afirrors, Tallahassee 1982, 1.38; S. BRUNI, Di un nuovo spcccbio ctrusco e delleofficinetarquiniesidi elà tardoarcaica, in «Rassegna di Archeologia» 9, 1990,390-393). Il riferimento al marepero potrebbe in moiti casi non essere cosl esplicito, avendo assunto il motivo ad onde correnti un semplicevalore dccorativo (D.REBUFFAT"El\IMANUEL, Le rniroir étrusque diapres ia Collection du Cahinetdes Médailles,Rome 1973, 435-436).
62 SCIl\Y'ARZ, in «SE» XLVII, 1979, tav. XXVI, 22,23 (piattil, tav. XXVII, lA (calici).
La serie continua di singole faglie d'edern cuoriformi è attestata sul finire del VIsec. a.C. in Etruria meridionale, da cui si trasmette verso nord, entrando a far partedel repertorio ornamentale dei cippi di arca etrusco-settentrionale, che sicuramentccostituiscono il modello pcr gli artigiani bolcgncsi'". Se quindi il motiva puo essere ri-
&\ Oltre ai trc cscmplari documentati a Bologne (stèle nn. 68, 190 e cippo Arnoaldi: G. SASSATELLI,L'Etruria padano e il commercio dei marmi nol V secolo, «SE» XLVII, 1977, 120-121 n. 9; S. BRUNI-F.S[\.'ERINI, Proh!emisulle presence etruscbc nella Toscana nord-occidentale: i dati delie necropoli di PÙa, in AttiConv Aspetti della cuttura di Volterra etrusca fra l'età dei ferro e t età ellcnistica (Atti del XIX Con vegno diStudi Etruschi cd Iralici, Volterra 1985), Firenze 1997,583), va mcnzionata la stele di V secolo con iscrizione rinvenuta a Tombarelle (Crespellano) e decorata con una serie continua di foglic d'edera unite tra loro eJesinenti in una palmetta posta sulla sommità. La stdc mostra al centra un disco raggiato e nel riquaJro inferiore due animali affrontati (G. SASSATELU, Ancora sui rapporti tt'a Et/"uritl padana e !ti/lia seuen/rionale:quaicheesemplzjicazione, in AttiCon Cii EtrtHChi a nord de! Po (Manrova 1986), Mantova 1989, 67-69).
Fig. 15. Particolare della ghirlenda di fogiic d'edera riprodorta su un cippo di marmo da Volterra (da G. SNiSl1
TELL!, Ancortl sui marmi in Etruria ne! vsecolo: confronti vo!terrani, in "SE" XLVII, 1979, tav. XXXV b).
251
l1
1
1
lIAI
CERAMTCA AllIe/\. E STELE FELSINEE
Fig. 16. Specchio arcaico con comice a tralcio d'edera (da CSEBunâesrepublile Deutschland4, n.12 a).
quentemente adottato come comice sugli specchi (,6 (Fig. 16) ed è diffusamente utilizzato anche in altre produzioni etrusche, quali la ceramica a f.n. 61, la grande pittura pa-
EUSAB.ETTA GOVJ - GIUSEPPE SASSI\TELLl250
condotto ad una matrice etrusco-meridionale, è tuttavia I'arrivo in area felsinca di monumenti di marmo (Fig. 15) e di artigiani dall'Etruria settentrionale a gcnerare il fenomena di irnitazione ". Inoltre sono proprio i cippi volterrani e pisani a chiarire il signifieato che lornato di carattere vegetale doveva rivestire sulle stele felsinee, sulle qualiil fregio sviluppato nclla corniee riproduceva vere e proprie ghirlande, con valenza funeraria, nella realtà infilate nei cippi 0 poggiate sopra i segnacoli tombali 65.
Il tralcio d'edera con tronco ondulato e foglie cuoriformi è uno dei motivi più fre-
6-1 M. BONMvIICI, Nuoui ItlOnUinenti di marmo da/!'Etruria scuentrionale, in «ArchClass» XLIII, 1991,805-806, con clenco delle anestazioni deI motivo nclle distinre classi di materiali di produzionc etrusca. Pergli spccchi si veda inoltre PrrsTER"RoESGEN, Die.etruslascbcn Spiege!, S 3,10,17, tutti darari a1460-450 a.C.Nd tarda V e duranre il IV secclo rirroviamo questo ornuro nella bronzisrica (K SC.HUl'vlM:HER, Beschrei"bung der Sammlung tlllüker Bron,zen, Karlsruhe 1890, 116 n. 616 e 117 n. 620) e nella decorazione archirertonka (ANDRÉN, Architecturalterracouas, rav. 75, Il.I n. 254).
61 Ne sono un chiara csempio le ghirlande di foglie d'edera realisticamente raffigurate su un cippo volterrano (G. S;\SSATELLI, «SE» XLVII, 1977, 110-112 n. 3, tav. XXXV b), gui riprodono alla fig. 15, e sulcraterc della tomba delle Leonesse, giustemcnte ricordaro dalla Bonamio tra le attestazioni più entiche delmotiva in ambito etrusco-meridionale (BONAMICI, «Archt.Iass» XLIII, 1991,805). A Bologna il motivo è
presente anche sul cippo di marmo da! sepclcreto Arnoaldi, menzionato alla nota 63,
66 .l'vIAYElZ-PROKOP, Die graoiencn etrusleiscben CrtjfJjJÙ:ge!, 112; R.EBUFl'i\T-Er\'lM~~lŒ~,.Lemiroir ~tr~squc, 454-4.59; U. FISCHER-GRAF, Spiegeluxrstàtten in Vulci, Berlin 198~, 86-87,. ove SI Jl1dr:ld~a propn.o. ln
questo tipc di comice il carattere peculiarc della produzione vulcente dl.sp,ecchl. Per soluzioni c~)mpos1t1ve
analoghe a quelle realizzate sulle stele felsinee si confrontino la specchio "' ~SE Bu~deJre?u?ltkD~uts~h
land 1, n. 2 della seconda metà cid V secolo e la coeva stele n.100, con temunaatone dei tralci ci edera ln Ptecoli corimbi sommitali.
67 Rami d'edera ondulati rienrrano nella più comunc dccorazione eccessoria dei vasi e sovente sono introdctti nelle scene principali come ricmpitivi: per le idrie ceretane J. M. HElvlELRl.lK, The Caeret(/J~ H.vdrÙl~"
Main 8.R 1984,168-169 con prorotipi riconosciuti nella produzione ceramica greca; per la cerarmca ponuca P. DUCATI, PontiscbcVasen, Berlin 1932,24 n. 3, rav. 7; per il Gruppo de La Tolfa, nel quale perla veritàil motivo ha una limirata atrestazione cd una resa più naturalistica P, Boccr, Alcuni vasi inedits de! Musee dl
rietalc " e la scultura in pietra di ambito settentrionale", Se, come si è visto, dall'csperienza scultorea rnaturata al di là degli Appennini è derivato l'usa di elementi vegetalisulle stele felsinee, ad imitazione di ghirlande funerarie, la resa stilistica dei rralci d'edera introdotti nelle cornici e realizzati sugli spessori sembra rimandare più da vicinoalla ceramica attica della seconda mctà del V sccolo, nella quale questo motiva ha Ulla
iarghissirna diffusione, sebbene sia spesso associato ai corirnbi, assenti invece sulle stele iO, Allo stesso ambito di ispirazione probabilmente si riferiscono il tralcio di alloro 0
di mirto, il tralcio di vite e le sÎngole foglie di vite. Il primo è assai ben documentatonel patrimonio figurativo etrusco 71, ricorrendo ad esempio nell'ambito della sculturaetrusca settentrionale 72, in quello della ceramica a f.n. Tl e degli specchi 74. Tuttavia èforsc la frequenza del tralcio di alloro 0 di mirto sulla ccrarnica artica a fr. della seconda metà del V secolo a fornire 10 spunto per I'adozionc di tale motivo sulle stele ", Sicuramente ad un modello cerarnico attico e ad un repertorie figurativo di caratteredionisiaco si rifanno infine il tralcio di vite e le carene delle singole foglie di vite 76, noncosi diffuse nel repertorio etrusco 77 e significativamente presenti unicamente su stele
Firenze,in «SE>~ XXiX, 1961, 91-92, tavv. XXVl-~"'{\Tll; per il pinore di Micali, A. ClIERICI, Ceramica etruJ'ca della CollezionePoggialidi Firenze, Roma 1988, tav. LXXIX.
6K Nelle Tombe del Triclinio, del Letto funèbre e della Scrofa nerf] complicari tralci d'edcra con corirnbi decorano il tirnpano e le cornici che delimitano le scenc (STI-:tNGMBFR, Catalogo ragionato dellapiuuraeirusca,nn. 82, 108, 121L
6'! G. CL\iVIPOLTHlNJ, 1 cippifunerari della bassae media voldera, «Prospeniva», 21,1980,74-82; BONAMICI, «ArchClass» XLIII, 1991,806.807.
711 Si vedano a titolo puramente esemplificativo MOORE, Auic Red-Figured and White-Ground Pottery,nn. 2?7-288, 1190-1191; A. LF7.ZI-HAFTER,Der Scbtooalou-Malcr, Mainz 1976, tav. 35a.
il R. PAi'dPANINI, Le pianle ncll'onc decoratioa deg/i Etruschi, «SE» IV, 1930,309.31:5; TD.,Altri soggeuifitomorfi nell'arte decorauea ctrusca, «SE» V, 19.31,422.
n M. BONAMICI, If marmo lunense in epoca preromana. in AttiSeminario If marmo nella civiltà romana.La produuone e il commercio, CalTara, 1989,91 con rimando al rcpertorio delle ceramiche greco-orientali,attiche ed etrusche della seconda metà del VI seeolo.
'Ji L. Hl\NNESTAD, The ParisPainter, Copenhagen 1974, tav. 8 n. 11 e tav. 15 n, 26.'1 MAYER-PROKOP, Die gravier/en etru,kischen Gn/fr;piege!, 112-113; REBUJ+'AT"E!\lMANUEL, Le rtlirair
étrusque,451-452.
7j Si vedano a tilolo esemplificativo il largo usa che il gruppo di Polignoto fa di traIei di ailoro a dimirto per decorarc la fascia sottostante J'orla dei crateri (S. B. MATHESON, Po!ygnotosand Vase Painting inC!asJica!Alhens, Madison 1995, 18 tav. 10,55 tav. 41, 134 tavv. 118-119) e a1cuni degli esemplari deI piuoredi Pemesilea, tra i quali la nota coppa da Spina (CatMostra Spina. Storia di una ciltâ tra Etruschi e Greci,Ferrara 1993, 80, fig. 57). L'arbusto inoltre è di norma rappresentato sl-ùlc glaukes e sugli skyphoi con civetta (A. W. JOHNSTON, A note on ow! skyphoi, «AJA» 59,1955). Mo1teplici poi sono i crateri mici a f.r. conquesto motivo che sono stati rinvenuti nelle tombe felsince, pel' alcuni dei quali si veda E. GOVI, Le ceramiche attiche a vemiœ neradi Bo!ogna, Imola 1999,figg. 32, 48, 66.
}(', Si confrunti per la stcle n. 92 il piatto anico a Cr. rinvenuto a Spina con fregio di foglie di vite sull'orlo (CatMostra Spina, 168 fig. 142, cat. 383).
,-; Sugli speechi il motivo è presente sporadicamenre ed è correlato alla sccna principale di carattcredionisiaco (CSE u.s.A. 2, n. 13). Un cratere etrusco a Cr., databile agli l-ùtimideccnni del V secolo, esibisccun ricco traIeio di vite che ineornieia la figura di Dioniso accompagnato da satiri (J. D. BEA!.LEY, EtruscanVase Painting, Oxford 1947, 29l.
7H B. KI'.I":SFfl, Rebe und E/eu, in Cati''vIostm KUllst der Scba!e (Antikensammlungen München J990),München 1992, 325-33.'5.
79 TI motivo compare su lUla lekythos di Amasis (D. v. BonIMER, The Amasis Painter a'nd his w~rld,
New York-London 1985, 176 n. 43), ma è presente anche nella ceramica etrusca a f.n. (P. DUCATI, PontlscheVasen, Berlin 1932,22; L. I-IANNESTAD, The Jollowers of the Paris Painter, Copenhagen 1976, tav. L3 n. 4:SCH\\;7ARZ, «SE» XLVll, 1979,72 fig. 2e) e sugli specchi arcaiei (CŒ France 1, III, n, 20; CSE Deutsche De-mokratische Republik I, 11. 45; CSE u.s.A. 2, n. 5). _
80 A titolo esemplifiealivo si vcelano BOARDMAN, ilthenian Red Figure Vases. The archaie period, tigg196,261; ID., Alhenian Red Figure Vases. The danica! period, figg. 1,8,15, 126, 153, 181, 184,219); M.PMNGE, Der NiobidenMa!er und xeine \Verkstatt, Frankfurt am Main 1989,45, tab. VI 1; J. lI. OAKLF'r,The Phia!e Painter, Maim 1990, 106. 11 motivo è comunque presente sin dal tarJo areaismo nel repertoriofigurativo etrusco, per il quale si vedano ANDRÉN, Architectural terracottas, tav. 74 n. 251; MAYER-PROKOP.Die gravierten etruskischen Cri/Jr;piege!, 110-111; CSE France 1,III, n. 15.
Hl OAKLI':Y, The Phiale Painter, 107; MATHESON, Polygnolos, tavv. 13,54,55,60,65.82 Si veda la nota 5.s.\ JACOB5TIIAL, Omamenle, 104 a"b (fig. 20); B. PHILlI'I'AKI, The Attic Slamnoi, Oxford 1967, tav. .'51, 2.
253CEl\i\M1C\ AT'TTCA E STELE FELSTNEE
dal profilo circolare degli ultimi decenni deI V secolo, dccoratc tutte, eccetto una, conla scena deI viaggio su carro verso l'aldilà.
In conclusione I'adozione, per la verità piuttosto limitata, di cornici fitomorfc suisegnacoli felsinei si giustifica da un punto di vista ideologico con l'implici.to.val~re funerario c: dionisiaco delle ghirlande che essi riproducono, e da un punto dl VIstaiconegrafico con la frequente ricorrenza sulla ceramicn artica dell'associazione tra scene~Üonisiache e tralci di vite e rami di edera ·/S.
Tra i motivi fitomorfi inrrodotti nei listelli che separano le scene (Fig. 8), le singolefoglie d'edern impostate verticalmente su un ramo ad "5" (tipo 9), documentate esclusivamcnte sulla nota ste1e 10 dei Giardini Margherita, hanno un'attcstazionc limitatasia neI repertorie ceramico greco che in quello figurativo etrusco, cui sembrano rifarsi". Il fregio di palmette oblique, contrapposte e unite da volute (tipo 10) rivela inveceun'indubbia dipendenza dalla ceramica attica a f.r., nella quale il motivo è largamenteimpiegato pcr delimitare la scena principale, specie sui crateri 80 (Fig. 17). Un analogoasccndente ceramico pue essere ipotizzato pel' alcuni dei motivi _fitomorfi introdortinelle lunette e nell'ultimo registre in basso (Fig. 9). In particolare la fascia di palmettealtematc a fiori di loto, presente solo sulla stele 168 (tipo 8 dell'ultimo registre}, costituisce una delle bordure più frequenti sui vasi attici a fr. dove trova redazioni leggermente diverse tra loro 8' (Fig. 18). D'altra parte che 10 scalpellino di questa stele si siaispirato al patrimonio figurativo della ceramica attica è deI tutto confermato, olrrc chedal tipo di scene reaIizzate neI registra principale 1\2, anche dalla presenza nella lunettadi tre palmette collegate da volute (tipo 4), per le quaIi possono essere citate a confronto analoghe soluzioni adottate dai ceramisti attici spccic per arricchire la zona sottostante le anse K.J. Dalle svariate e complesse combinazioni di palmette, di volute e difoglie sperimentate sui vasi attici a f.r. deIIa seconda meta deI V. secolo con ogni probabilità hanno attinto anche gIi artigiani felsinei che hanno realizzato le altre decorazioni con palmette, dcstinatc ad occupare i registri minori (tipi 2,3,5,6 delle lunette e
EUSABETTA GOVI " GIUSEPPE SASSATELLl252
Fig. 17. Crarere attico a f. r. attribuito a Polygnotos (da S.B. iVv"T1-IESON, Polygnotos and Vase Painting inClassical Atbcns, Madison 1995, p. 73J.
255CERAi\UCA ArnCA L SIhl.F. FELSTNEE
Fig. 18. Stele o. 168 dal sepolcrero della Ccrtosa.
IlAl., Gmamente, 80, a; A. LE/:/:I-IIAI'TER, Der Eretria-Naler, Maioz 198R, 177 fig. 58; CVA Firenze Muser;Archeologico III, tav. 11.3,.3). Infine per il tipo "Zh" si confrcntino i vasi in Catlvlostra Spina, 111, fig. 92-93c in MOORE, The Athenian Agora, tav. ll8, 1253.
~j BOARDM.'1N, Athenian Red Figure Vases. The classical period, figg. 81, 167, 196; jACOBSTlIAl, Omamente, tavv. 51 a-b, 74 a
Sb J.H. OAKlEY, The AchillesPointer, Mainz 1997, o. 70.
vi pittorici: piuttosto risulta del tutto evidente, da una parte, la difficoltà di riprodurrele sinuose volute e le forme più complesse, dall'altra, il tentativo di variare il modello,di adattarlo agli spazi ristretti e di sviluppare in orizzontale motivi ideati per riempirela vasta zona sottostante le anse dei vasi. Ne risultano motivi che non trovano confronti puntuali nella ceramica attica, dalla quale comunque dipendono, e che sembranol'effetto di una combinazione di diversi elementi, a volte ripresi dal repertorio di tradizione etrusca. Il tipo 6 delle lunette ad esempio si ispira alla fascia che spesso decoral'orlo dei crateri a f.r. della seconda metà del V secolo " e che a volte associa alla coppia di palmette contrapposte singole foglie d'edern cuoriformi 86, ma la divers a compo-
EUSr\J:lETTA GUVl - GIUSEPPE SASSATELLl254
tipi 5, 6, 7 dell'ulrimo registra in basso) e la scmmità delle cornici con onde correnti 84
(Fig. 19). Tuttavia difficilmente si osserva una fedele trasposizione sulla pietra di moti-
.. ,,~.j ~:ra gli '":" tipi di p~m~tta. associati al~a cor~ice ad onde correnti (fig. 19) solo gli ultirni quanro,trpt e-h) s~n~ slcu~amentc aspiran alla ccranuca emca della seconda rnetà dei V secolo cd in particolareall~ de.coraz~ol1l destinate aile zone sotrostanri le anse, menrre i tipi "Za-d" rientrano nel più comune rcperreno figurative ctrusco. Per il ripe "en si vedano Moosz, The I1thenian Agora, tav. 67 n. 617; J. H. OAKI.EY,The Achilles Pointer, Mainz 1997, tav. 31 B; A LEZZI-HArTER., Der Scbmoalou. Maler, Mainz 1976, tavv..3~d-g, 35a,?5 b. La stessa palrnetta si rirrova anche sulla nota srcle figurata di Marzabotto, proprio in posizrone sommitale, come sugli escrnplari Ielsinei (CatMostra Spina, 163 fig. 138). Va inoltre tenuta in considerazione la presenza di una palmcrta del tutto simile come coronamenro di alcune srcle fiesolane, quali lanota stele Peruzzi dell'Anrclla (Magi, Stelc c cippifiesolani, tav. X), che sicuramcnte hanno influenzaro laproduzione felsinea. Per il tipo "f" con due foglie laterali si confronrino i vasi in PHIl.lPPAKI, The Auic Stamnot, t.av. ?1,2.e in G. ~I,' F:'illRlNl j N~mana: oasi attici da collezioni, Roma 1984, tav. XL, b. il tipo "g" concoppra dl foglie larerali e pruttosro diffuse sulla ccramica artica degli ultimi deccnni del V secolo (JACOBST-
25ïCEKt\i\HCA ATTICA E STELE l'ELS1NEI',
. f artribuiro el pittore di Danac (da P. jacobsthal, Omamente Griccbiscbcr Vase,Fig. 20. Stamnos atuco a r.r. H H " i
Berlin 1927, tav. 104 bl.
cl
srele nn. 136, 1ïD. 182b
sre]c n. 15
'~, ,stèle n. 138
srdcn.168b
h
stèle lm. Bob, 134. 145.188,200, Via dei tvHile
stèle 1111.1(,4<1,44
EUSABETTA GOVl - GiUSEPPE SASS;\TELLl
~/ ,
stèle n11. 2, 1l2, 82, 91, %,BOa. 182a
stèle n. l(iO
256
Pig. 19. Schema delle palmette realizzare sulla sommirà delle stele, a coronamento delle cornici ad onde correnti.
sizionc degli clementi genera un motiva nuovo, seconda un gusto che ritroviamo inepoca precedente nella cerarnica etrusca a f.11. Si, Analogamente il tipo 7 delle lunettesi avvicina agli arbusti di cdera posti sotta le anse delle cappe di Makron 88, ma richiama da vicino anche l'alberello del timpano della Tomba del Triclinio cil frcgio su] soffitto della Tomba del Letto funebre di Tarquinia.
Infine le due foglie d'edcra contrapposte (tipi 1 e 2), in assoluto il riempitivo piùFrequente sulle stele, e la coppia di volute affiancate (tipo 3 dcll'ultimo registre) nontrovano riscontro altrove IN e sembrano un'innovazionc locale, gcnerata da elementipropri del repertorio dcgli scalpellini felsinei e particolarmente adatti a riempire unasuperficie ristretta.
In conclusione nell' ambito della decorazione fitomorfa adottata nei registri e neiIistclli risultano ispirate con certezza alla ceramica artica soltanto le carene di palmetteoblique contrapposte 0 alternate ai fiori di loto e le cornposizioni di due 0 tre palmette. Se a queste limitate attestazioni si aggiungono alcune delle singole palmette postesulla sommità delle cornici, realizzate pero solo su una decina di stele, e alcune dellecornici vegetali, che come si è visto si ispirano più facilmente al repertorio ceramicogreco, il quadro generale della decorazione accessoria induce a sminuire notevolmente
g, M.A. RILzU, La ceramografia etrasca tardo-arcaica, in CatMostra Un artista etrusco c ti mo monde. IIPit/on' di Mica!i, Roma, 1988, fig. 52; AA..Vv., La Collezione Casuccini Ceramica attica etrusca c falisca,Roma 1996, 121 n. 5.
Hi: N. KUN1SH, Makron, Mainz 1997,69 n. 356,70 n. 509.
sv Il tipo 3 potrebbe pero richiamarc un motiva simile realizzaro su un'anfora pontica (DUCAT!, Pontiscbc Vasen, 16 a) e su un cippo da Sesto Fiorentino datato rra la seconda metê del VI c i primi deI V sec.a.c., sul quale ha una redazione più scmplificam (G. DE l'VIARIN1S, Sesto Fiorentino (Firenze) Vil/a "La Castellina", in Scevi c Scopene «SE» LVIII, (1992l 1993,612-613 n. 42b, tav. (IX al.
l'apporte della ceramica attica alla formazione degl~ ~calpellini fe~sine~ e su~ge~isce
piuttosto di ricercare la fonte di ispirazionc .n.ella t~adlzlOne de~~ratlva dl amb1t~ etruseo, assimilata, fatta propria e spesso modlftcat.a ID ~o~o ot1?l11ale: Oc~orr.e .l11.01~resottolineare come i motivi desunti dal rieeo patnmoruo figurative dei vast attici Sl trovino spcssc associati tra 101'0 su una stessa stcle (la n. 1?8 già c!t~ta e le stele ~n ..1.0, .15,63 84 160) ed in definitive il numero degli esemplan che esibiscono ornati di muta-, ,
Fig. 21. Olpe attica a f.r. artribuita al pittore di Schuwalow (da A. LE7.ZI-HA~TER, Der Scbmoalou- Maler,Mainz 19ï6, tav.65 b).
zione cerarnica si riduce ulteriormente e si limita alle stele più monumentali e coite,esclusive della classe sociale più elevata. (E.G.)
Le osservazioni conclusive formulate fine a questo punta possono essere ulteriormente corroborate da una serie di considerazioni relative a quegli esemplari nei qualirisulta più marcato ed evidente l'influsso della cerarnografia artica.
Come già è stato osservato risulta infatti molto significative - e pel' certi versi anche sorprendente c inaspettato - il sostanziale ridimensionamento del]' apporta arrecato dalla ceramica artica alla formazione degli elementi decorativi "minori" presentisulle stele felsinee. È risultato chiaro infatti che i motivi più frequenti nella decorazione delle cornici 0 dei listelli, come ad esempio i triangoli alterni campiti a tratteggio 0
le onde correnti (quest'ultimo con indubbi valori simbolici per la sua allusione all'acqua c al mare) trovano la loro principale fonte di ispirazione nel mondo etrusco diarea tirrenica e sembrano indicare una sostanziale ritrosia dcll'ambiente felsineo nell'adottare motivi e schemi desunti dalla ceramica attica, con una scelta che risulta ancora più significativa se rapportata ad un ambito che è grande consumatore di ceramiche attichc importate lungo l'intero arco del V secolo. E anche nei casi in cui si riscontra una maggiore attenzione verso il patrimonio decorative della ceramica attica e unaconseguente maggiore assimilazione di alcuni di quésti motivi, cio avviene, il più dellevolte, con modalità e meccanismi che, da un Iato, ,sottolineano la relativa rarità del fenomeno, dall'altro, evidenziano come tale assimilazione si inserisca in modo del tuttomarginale e sempre con qualche innovazione allinterno di una tradizione artigianale edecorativa fortemente etruschizzata; oppure si associ ad altri elementi di carattere tematico e figurativo che ne sottolineano ulteriormente la lore apcrtura verso il mondoellcnico e quindi di fatto la loro sostanziale estraneità rispetto alla tradizione etruscalocale. E proprio su questi due aspetti credo sia possibile aggiungere qualche ulterioreconsiderazione. In primo luogo si puo constatare infatti che anche quando si assiste all'accoglimento di motivi desunti dalla tradizione decorativa della ceramica attica, daun lato, questi sono comunque abbastanza rati e isolati, dall' altro si presentano comeclementi singoli che si inseriscono facilmente in schemi ben radicati nella locale tradizione etrusca senza modificarla più di tanto, ma assumendo al contrario la caratteristica di piccoli inserti in una trama che cornplessivamente mantiene le sue connotazionioriginarie. Questo è molto chiaro per alcuni motivi vegetali, come ad esempic il tralciodi allaro a di mirto, il tralcia di vite e il tralcia di singale faglie di vite, pcr i quali è palese il richiamo aile corone vegetali che nella realtà rivestivano sia le stele che i cippi,seconde la migliore tradizione etrusca, pur arricchcndola in questo casa di un ulteriore significato simbolico che aggiunge al valore funerario un rimando al mondo dionisiaco. L'aspctto c le caratteristiche di inserti piccoli e marginali all'interno di una tradizione decorativa locale sono ancora più cvidenti per i morivi decorativi collocati neiregistri minori posti alle due estremità delle stele, in alto e in basse. In questi casi latendenza degli scalpellini di Felsina a mantencre un solido legame con la tradizionedecorativa locale e nello stesso tempo a inserire qualche elemento nuovo desunto dalleceramiche attiche importate è facilitato dalla sostanziale marginalità di questi insertidccorativi, costituiti da palmette alternate a fiori di loto (tipo 8 dell'ultimo registro),
259CEKr\MfCA ATTICA E STLLL l'ELSINEEEUSABETTA (;OV1 - GLUSEPI-'~ SASSATELLi258
Fig. 22. Anfora artica a fr. del pirtore dei Niobidi (da P. ]ACOB51HAl, Cmamcnte Gnccbiscber Vase Berlin192ï, tav. 82 al,
')il SASSAl'FLJ.I, in AttiCon La Formaaione della città, 243-245.
261CERA!vI1CA ATTICA E STELE FELSTNEE
da palmette collegate da volute (tipo 4 della lunetta) e da palmette isalate e Ji Jiversaripe (tipo 5 della lunetta, tipi 6 e 7 dcll'ultimo registra), oltre che da combinazionimolto variegate di palmette, volute e foglie (tipi 2, 3 e 6 della [unetta), tutti motivi che50110 largamente utilizzati come riempitivi dai ceramisti attici, specie a partite dallamctà del V secolo. Olrre che nei registri minari tali inserti si trovano anche alla sornmità delle cornici costituite da onde correnti, cosi tipicamente etrusche, nelle quali siinseriscono agevolmente senza alterarne il disegno complessivo, oltrc che il significato.In tutti questi casi è abbastanza evidente da parte degli scalpellini felsinei un usa relativamente libere di motivi "importati", utilizzati di fatto come riempitivi e come talispesso variamcntc combinati Ua di loro fino ad esiti che finiscono con l'essere un'autentica innovazione locale (si vedano ad esempio i tipi 1-2-3 delle lunette) sia pure rea[izzata utilizzando e riunendo stimoli e impulsi che vengono da fuori. E allora forsenon è un casa che tali motivi siano spesso ripetuti, intreceiati e variamente combinatisulla mcdcsima stele, fatto quest'ultimo ancora una volta assai signifieativo se si considera che le stclc con uno 0 più di questi inserti "atticizzanti", sono complessivamentepoche, comunque non più di una decina e che in moiti casi tali inserti sono associati aterni figurativi largamente ispirati al mondo ellenico sia sul piano iconografico che suquello formale. Si realizza cosi, almeno in questi casi, una significativa coerenza tratemi 0 iconografie ispirate al mondo greco e motivi decorativi desunti dalle ceramicheattiche importate. Molto chiara al riguarda il casa della stele n. 168 (Fig. 18) dove sullato con il defunto preIevato da un demene alato e nudo, dai tratti largamente ispiratial mondo ellenico, si trovano sia in alto che in basso palmette oblique di un tipo c conuna disposizione che sono molto vieini ai motivi ornamentali della ceramica attica edin particolare dei crateri. Qualcosa di simile si verifica anche nelle steJe n. 48, n. 79 en.84.
Da ultimo va sottolineato che complessivamente le stele con l'inserimento di questi motivi Jecorativi ispirati alla ceramica attica non solo sono poche, ma sono ancheintrinsecamente importanti 0 perché accolgono terni figurati complessi, come adescmpio quello del viaggio su carra (stele 11.63,11.83, n. 86 e n. 164),0 perché si riferiscono a individui socialmente rilevanti come ad esempio si verifica per la stele n.15 ilcui titolare è un membro della famiglia dei Kazkna che aveva un proprio reeinto sepolcrale nella necropoli dei Giardini Margherita, dove tra l'altro trovava posto anche lanota stele n. 10 (Fig. 24) con raffigurazioni molto complesse e il cui titolare Ve! Kaikna aveva ricoperto importanti cariche politiche e militari (ma su questo tornero trapoco) Yo.
L'impressione che i pochi elernenti decorativi ispirati alle ceramiche attiche si trovino su segnacoli speciali, cornunque riferibili a individui socialmcntc e politicamenteimportanti della città di Felsina, trova una importante conferma nella ricorrenza suquesti stessi segnacoli dell'unico vero motivo assolutamente estraneo alla tradizionedecorative locale e totalmente ispirato alla ceramica attica. Mi riferisco alle singole fo-
EUSABETTA GOV] - GlUSFYl'E SASSil.TELLl260
glie d'edera, impostare verticalmente su di un rama a "S" ttipo 9 di fig. 8), per altrod.ocu~1entate una s~la volta e guarda casa proprio sulla stele n. 10, e soprattutto al fregio di palmette oblique contrapposte e unite da volute (tipo 10 di fig. 8), presente sualcune stele che vale la pena di esarninare più nel dettaglio. Si tratta infatti delle srelen.2 (Fig. 23), n. 10 (Fig. 24), n. 33, n. 37, n. 41, n. 160 (Fig. 25) e della stele F deI Polis~ortlvo, tutte assolutamente speciali all'interno di questa classe di segnacoli. Alcunedl esse (stele nn. 33, 37, 41,160 e stele F del Polisportivo), pur essendo molto frammentane, co?servano ccmunque qualche dettaglio che consente di isolarle dal restadella produzione, A parte la stele n. 23 con figura di cavaliere che per quanto importante. costttursce un el~ment~ d.ecoratlvû abbastanza Frequente (resta comunque l'incogmta delle altre ratfigurazioni), nella stele n. 37 oltre ad un felino accovacciato trov~a~o ,un .banchettante disposto in modo del tutto inusuale sulla corniee esterna suddivisa III riquadri: sia il banchettante che la sua strana collocazione eonsentona quanta
263CERA1'vllCA ATTICiI. L STLLL J;ELSINEF
Fig. 24. Stclc ri, 10 del sepolcrero dei Ciardini Margherita.
mena di eonsiderare questa stele un unicum rispetto al resta della produzione. Dellastele n. 41 resta solo un piccolissimo frammenro, per di più con la superficie talmentedeteriorata che i pochi elementi superstiti della decorazione si intravcdono appena.Anche della stele F del Polisportivo 9J resta solo un piccolissimo frammento, ne1 qualetuttavia è ben visibile un felino alato (sfinge?) accovacciato che lascia comunquc intravedere una dccorazionc figurata non di routine. Molto significativa in questa stele lacompresenza di due motivi largamente ispirati alla ceramiea artica: oItre allistello orizzontale con palmette oblique contrappostc e unite da volute va segnalata sulla cornieeuna serie di palmette unite da volute che sostituiscono in alto le spirali di un motivoad on da eorrente. Meglio eonservate e come tali assai più chiare e apprezzabili da que-
~l Si veda lanota 22.
EUSABETTA GOVl- GlUS EPPE SASS/I.TELLl
Fig. 23. Stek n. 2 dal scpolcrero dei Giardini Margherita.
262
92 MAC;G1ANI, IN «OCNUS» 5,1997.
sto punto di vista sono le stele n. 160, n. 2 en. 10. Nel registre principale della stele n.160 è raffigurata una triga di cavalli alati, verosimilmente riferibile al viaggio del defunto sul carro, in una iconografia molto solenne e del tutto speciale, comunque riserv.ata a defunti di rango, visto che il viaggio su carro trainato da più di due cavalli alati51 trova solo su altredue stele che sono guarda caso, la n. 2 (triga) e la n. 10 (quadriga).Su que~tl ~ue ultlilll. es~mplarr ,ha tra l'altro richiamato l'attenzionc A. Maggiani conuna sene dl ossC;VaZlOnl molto importanti che si inseriscono perfettamente nel discorsa qui proposto ". Si t~atta infatti di due segnacoli assolutamente straordinari nel panorama delle stele felsmce, non solo perché uno di essi reca un'iscrizione, eccezionalmente realizzata a rilievo, che consente di ricollegarla alla famiglia dei Kailena, ma an-
265CU..A,MICA ATTlCA E STELE FELSINEE
che perché entrambe si caratterizzano pcr una decorazione molto complessa e rieca dimessaggi di grande significaro. Alla solennîtà del viaggio del defunto su trige 0 su quadrîga di cavalli alati, una sorta di projeaio 0 apoteosi accompagnata dal suono del lituo (stele n. 10) 0 deI corno (stele n. 2), si aggiunge una complessa raffigurazione deigiochi in onore del defunte pcr la quale disponiamo ora di una raffinata lettura daparte dello stesso Maggiani. Le trombe diritte, relativamentc rare nell'Erruria, vengeno ricondotte all'uso "greco" di dare il segnale di inizio delle gare 0 anche il segnaleche precedeva la proclamazione del vincitorc; il cratcrc, presente solo nella stele n. 10,oltre che al prcmio della gara, potrebbe alludere al contenitore delle sortes da estrarreper l'accoppiamento degli atleti; i portaton di scettro, presenti su entrambi i segnacoli,più che un generico riferimento ad un eventuale ruolo pubblico del defunto sarebberogli araldi che esibiscono 10 scettro dell' organizzarore dei giochi funebri che di volta involta cambiava (e questo spiegherebbe la diversitâ delle inscgne che compaiono sulledue stèle}, trattandosi comunque di giochi privati anche se svolti in un conteste cittadino comunque più allargato rispetto alla gens che li organizzava .. Tutti questi elemcnti (araldi, trombettieri, vasa per il sorteggio) oltre a designare uno scenario unico nellaiconografia dei giochi sia di area padana sia di area tirrenica, collocandolo al di fuoridella tradizione più genuinamente etrusca, consentono di riconoscervi la precisa sceltaideologica di porre in scena degli agoni "alla greca", il cui model1o ispiratore va sicuramente cercato in qualcuno dei grandi appuntamenti panellenid che la Grecia potevavantare. E tra questi, come giustamente ha suggerito A. Maggiani, un ruolo decisivopotrebbero averlo avuto proprio i giochi panarenaici, la cui celebrazione avveniva inquella stessa Atene dalla quale giungcvano a Spina e a Bologna una grande quantità diccramiche figurate. E allora forse non è senza significato che il Ilel Kailena della stelen. 10, sicuramente un navarca di Felsinn impegnato a Spina e sull'Adriatieo, e il defunto della stele n. 2, anonimo, ma sicuramente importante, oltre ad adottare il complesso apparato dei giochi panellenici, forse in virtù della loro frequentazione di Spinac della comunità greca che vi abitava, abbiano anche accolto, per la decorazione accessoria dei loro segnacoli, motivi di chiara impronta ellenica, come le palmette oblique eintrecciate. Se ne deduce una non casualità di questo accoglimento e di questa adesione che proprio per il contesta esplicitamente ellcnizzanrc in cui è inseriro, volute daidefunti del tutto speciali cui i segnacoli si riferiscono, ci confermano che la Felsina delV secoJo, nonostante le profonde sollecitazioni che le derivavano dalmondo greco,preferiva riallacciarsi non solo nelia scelta dei terni e nella creazione delle iconografie,ma anche nella decorazione accessoria dei suoi segnacoli funerari alla più genuina tradizione locale e tirrenica (G.S.).
EUSABETTA Govr - GIUSEPPE SASSlI.TELLl
Fig. 25. Srelc 11. 160 del sepolcreto della Certosa.
264


























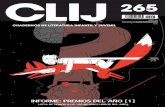




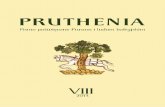


![•“Longinos en el Poema de Mio Cid: espejos, identidades e ideología”, Olivar 10 (2007), pp. 265-276. [ISSN 1515-1115]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320dacbc5de3ed8a70deb60/longinos-en-el-poema-de-mio-cid-espejos-identidades-e-ideologia-olivar.jpg)