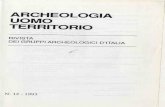Sulla cronologia delle stele felsinee. Qualche novità dal sepolcreto De Luca, in Artisti,...
Transcript of Sulla cronologia delle stele felsinee. Qualche novità dal sepolcreto De Luca, in Artisti,...
ARTISTI, COMMITTENTI E FRUITORI IN ETRURIA TRA VIII E V SECOLO A.C.
Atti del XXI Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria
a cura di Giuseppe M. Della Fina
estratto
ISBN 978-88-7140-574-2
© Roma 2014 - Edizioni Quasar di Severino Tognon srlvia Ajaccio 41-43 - 00198 Romatel. 0685358444, fax 0685833591www.edizioniquasar.it
Finito di stampare nel mese di novembre 2014
estratto
A N N A L ID E L L A F O N D A Z I O N E
P E R I L M U S E O « C L A U D I O F A I N A »
VOLUME XXI
ORVIETONELLA SEDE DELLA FONDAZIONE
EDIZIONI QUASAR2014
estratto
La grande attenzione riservata al corpus delle stele felsinee nel-l’am bito di questo convegno1 oltre ad aver costituito una preziosa op-portunità di confronto, è stata l’occasione per sottoporre all’attenzione degli studiosi alcuni dei più recenti traguardi raggiunti nell’analisi di questa classe di monumenti da parte della Cattedra di Etruscologia di Bologna, come noto, da tempo impegnata su questo fronte attraver-so una lunga e consolidata tradizione di studi2.
In tale ottica è maturata la stimolante possibilità di presentare in questa sede alcuni elementi di novità frutto di un più ampio studio dedicato ad uno dei principali nuclei funerari della Bologna etrusca di fase Certosa, noto tradizionalmente come sepolcreto De Luca3.
1 Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Prof.ssa E. Govi. e al Prof. G. Sassatelli per la fiducia accordatami offrendomi la possibilità di presentare questo lavoro, per i preziosi suggerimenti ricevuti e, non da ultimo, per avermi da tem-po reso partecipe di uno studio così ricco di stimoli come quello sulla Bologna etrusca di fase Certosa. Ringrazio inoltre G. M. Della Fina e tutto il comitato scientifico del convegno per aver accolto con grande disponibilità il presente contributo. Infine un doveroso riconoscimento va alla Direttrice e al personale del Museo Civico Archeologico di Bologna per la collaborazione fornitami e per l’autorizzazione a riprodurre le imma-gini delle stele utilizzate.
2 Si vedano i contributi di E. Govi e G. Sassatelli in questo stesso volume, cui si rimanda per un’esaustiva rassegna dei lavori dedicati alla classe.
3 La ricerca condotta nell’ambito di una tesi di Dottorato svolta presso l’Uni-versità di Padova (XXIII Ciclo), sotto la guida di E. Govi e G. Sassatelli, si inserisce in un più esteso progetto a cui da molti anni e con grande impegno lavora la cattedra di Etruscologia di Bologna, d’intesa con il Museo Civico Archeologico, finalizzato alla ricostruzione dei molteplici aspetti che dovettero caratterizzare Felsina ed il suo ter-ritorio tra VI e V secolo a.C. In particolare, data la natura prevalentemente funeraria dei rinvenimenti e la straordinaria ricchezza della documentazione recuperata, uno dei campi d’indagine privilegiato è proprio quello rivolto all’analisi sistematica, finalizzata
GIULIA MORPURGO
SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE. QUALCHE NOVITÀ DAL SEPOLCRETO DE LUCA
estratto
244 GIULIA MORPURGO
Come infatti si avrà modo di illustrare, il recupero e l’analisi si-stematica dell’originale documentazione di scavo hanno consentito, tra le altre cose, di ottenere qualche importante risultato anche in merito alla conoscenza dei segnacoli messi in luce in questo specifico settore funerario4.
Tali novità, non solo hanno contribuito ad una definizione sem-pre più puntuale dei caratteri propri del contesto in esame, ma hanno altresì permesso di integrare ed aggiornare significativamente il qua-dro noto, in particolar modo in relazione al tema, così ricco di impli-cazioni, del rapporto tra segnacolo e originario contesto di pertinenza.
La scoperta del sepolcreto De Luca si inserisce nell’ambito di quella vivace e fortunata stagione di scavi che tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento fece di Bologna una delle capi-tali internazionali dell’archeologia5. Le indagini, condotte da Antonio Zannoni tra il 1875 e il 1876 nei terreni allora di proprietà del Mar-chese Francesco De Luca6, consentirono di mettere in luce centoundi-ci sepolture che andavano a disporsi in maniera organica nell’area dei sepolcreti occidentali dove, come noto, a partire dall’epoca villanovia-na, si sviluppò uno dei principali poli funerari della Bologna etrusca7 (Fig. 1).
Ciò nonostante, lo stato fortemente lacunoso della documenta-zione d’archivio e la frammentarietà di molti dei materiali ad esso pertinenti, tutti attualmente conservati presso il Museo Civico Arche-
all’edizione scientifica, dei singoli lotti funerari di fase Certosa messi in luce a Bologna tra la seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900 (sulle caratteristiche di questo progetto e, più in generale, sulle principali linee di ricerca portate avanti negli ultimi anni dall’équipe coordinata da G. Sassatelli ed E. Govi, si veda ora GoVi 2009a con riferimenti).
4 DuCAti 1911, cc. 422-431.5 Per una ricostruzione delle principali vicende che caratterizzarono quegli
eventi si rimanda ai diversi contributi presenti in BolognA 1984.6 Secondo una tradizione antiquaria, la denominazione dei singoli lotti sepol-
crali riferibili alla Bologna di fase etrusca, trae per lo più origine dal nome dei proprie-tari dei poderi teatro delle diverse scoperte.
7 L’area interessata dalle indagini, limitata alla porzione nord-orientale del fondo De Luca, distava m 1150 dalla porta S. Isaia, m 240 dal Cimitero comunale della Certosa, ed era delimitata a sud dalla strada S. Isaia, a nord dal canale di Reno, a est dal Rio Meloncello e a ovest dalla strada nuova della Certosa. Tale sepolcreto si sviluppava quindi nell’area compresa tra il sepolcreti felsinei Battistini ad ovest, rispetto al quale era contiguo e Arnoaldi ad est più distante e marcatamente separa-to dal corso del Rio Meloncello, lungo la direttrice segnata dallo sviluppo dell’antica strada sepolcrale. Con “sepolcreto De Luca” si è soliti designare anche un altro nucleo funerario costituito da 175 tombe la maggior parte delle quali databili tra villanovia-no ed orientalizzante, le restanti ad epoca gallica e romana, messe in luce sempre da Antonio Zannoni in un altro punto della necropoli occidentale, privo di alcun rapporto topografico con il contesto in esame (Fig. 1).
estratto
245SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
ologico di Bologna, hanno per molto tempo disincentivato uno studio complessivo su tale contesto che, con qualche rara eccezione8, risulta a tutt’oggi sostanzialmente inedito.
Mossi dall’esigenza di colmare questa importante lacuna e guida-ti da una metodologia d’analisi ben consolidata9, si è dunque avviato un esame di tutto il materiale disponibile finalizzato ad una ricompo-sizione quanto più accurata possibile dei molteplici aspetti che dovet-tero caratterizzare questo nucleo sepolcrale10.
Stadio iniziale del percorso ermeneutico e componente fonda-mentale del lavoro si è rivelata, come anticipato, la raccolta della documentazione di scavo elaborata all’epoca delle scoperte. Accanto al recupero delle fonti già note, conservate presso il Museo Civico Ar-cheologico di Bologna11, la ricerca è stata estesa ad alcuni importanti archivi in cui risultavano custoditi non soltanto documenti relativi alle indagini archeologiche effettuate a Bologna nel corso dell’Otto-cento12, ma anche carte manoscritte un tempo appartenute ai princi-pali protagonisti di quelle scoperte13. Gli esiti positivi e molto spesso
8 Fatti salvi alcuni studi dedicati a singole classi di materiale, spesso impor-tanti dal punto di vista documentario, ma superati sul piano interpretativo (si veda ad esempio, per la ceramica attica, Brizio 1888 e Pellegrini 1912), le uniche notizie edite sul sepolcreto in generale sono costituite da alcune preliminari comunicazioni, dal contenuto scarno e del tutto generico, databili all’epoca dei ritrovamenti (ZAnnoni 1876; GozzADini 1876). Una breve sintesi sulle caratteristiche generali del sepolcreto è in GoVi 1999, pp. 18-20, opera dedicata allo studio delle ceramiche attiche a vernice nera provenienti dalle necropoli bolognesi in cui si forniscono informazioni anche in merito a cinque corredi del nucleo De Luca.
9 Come anticipato infatti, tale lavoro si pone nel solco già tracciato da una lunga ed importante tradizione di studi che lo hanno preceduto: al sepolcreto Arnoaldi, di recente pubblicazione (mACellAri 2002), si sono affiancati nel tempo gli studi sul sepolcreto della Certosa, oggetto del Dottorato di E. Govi (GoVi 1998a) e quello sul sepolcreto dei Giardini Margherita condotto da F. Guidi (GuiDi 2005a). Tutti questi lavori hanno costituito un imprescindibile punto di riferimento non solo dal punto di vista metodologico, ma anche sul piano dei contenuti. Fondamentale da questo punto di vista in particolare l’analisi compiuta da E. Govi in relazione al sepolcreto della Cer-tosa, il nucleo funerario più ampio e sicuramente meglio documentato della Bologna felsinea (per un quadro di sintesi si veda GoVi 1998b e EAD. 1999, pp. 13-18).
10 Per una preliminare rassegna dei risultati ottenuti ed un breve inquadra-mento delle caratteristiche generali del sepolcreto si rimanda a MorPurgo c.s.
11 AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, cassetto 7. Tra i documenti conser-vati grande importanza riveste senza dubbio il Giornale di Scavo redatto con cadenza settimanale da Antonio Zannoni anche se purtroppo dal contenuto spesso piuttosto ge-nerico. Le tombe, di cui viene sempre specificato il tipo di rituale funerario praticatovi, vengono presentate a gruppi e non sono numerate in una sequenza generale. Rare sono le indicazioni relative alle caratteristiche strutturali della sepoltura e, dei corredi, vie-ne spesso fornito un elenco circoscritto agli oggetti ritenuti maggiormente significativi.
12 Accurati controlli, dall’esito più o meno fortunato, sono stati effettuati pres-so l’Archivio Gozzadini, custodito nella Biblioteca dell’Archiginnasio, presso l’Archivio Storico Comunale di Bologna e l’Archivio Centrale di Stato a Roma.
13 Di grande utilità in questo senso lo spoglio effettuato presso l’Archivio Pigo-rini di Padova, dove è stato possibile rintracciare preziose informazioni sul sepolcreto
estratto
246 GIULIA MORPURGO
insperati di tale operazione hanno infatti consentito di integrare si-gnificativamente il quadro documentario disponibile, fornendo una ingente serie di nuovi elementi rivelatisi, a vario titolo, di estremo interesse ai fini della conoscenza del contesto.
Tra i risultati di maggiore rilievo va senza dubbio menzionato il ritrovamento, presso l’Archivio del Museo Civico Archeologico di Bologna, dell’originale planimetria generale del sepolcreto, un docu-mento di straordinario valore sulla cui esistenza la precedente tradi-zione di studi aveva sempre dubitato14.
La pianta, elaborata da Antonio Zannoni presumibilmente all’e-poca delle scoperte, non solo ha rappresentato una fonte d’informa-zione preziosissima per una ricostruzione dell’assetto topografico del sepolcreto15, ma, grazie al raffinato livello di dettaglio molto spesso raggiunto nella riproduzione delle diverse componenti, si è rivelata anche di fondamentale supporto nel delicato tentativo di ricomposi-zione filologica dei singoli corredi funerari.
Accanto alla planimetria generale, si segnala inoltre il recupero di una notevole quantità di appunti manoscritti e schizzi, nella mag-gior parte dei casi opera dello Zannoni, riferibili a singole tombe o gruppi di sepolture messe in luce sempre all’interno di questo settore.
Elemento che accomuna questa cospicua ed alquanto eterogenea documentazione è la particolare attenzione riservata dallo scavatore proprio nei confronti dei segnacoli funerari di cui molto spesso ven-gono fornite minuziose descrizioni, quando non fedeli riproduzioni grafiche, della forma e dell’apparato figurativo, circostanza che ha favorito lo studio di questa componente, dischiudendo possibilità dav-vero inattese.
Come noto, la conoscenza di questi monumenti è legata alla fi-gura di Pericle Ducati che nel 1911 editò un catalogo completo delle
contenute negli scambi epistolari che Luigi Pigorini intrattenne con i protagonisti di quelle scoperte. Altrettanto fondamentale infine il censimento condotto presso la Bi-blioteca Comunale di Forlì all’interno dell’Archivio Piancastelli dove, probabilmente in virtù delle sue origini faentine, si conservano appunti e disegni elaborati da Antonio Zannoni (BcFo, Raccolte Piancastelli, Sez. Carte Romagna, Busta 519). Si tratta infatti di un fondo creato da Carlo Piancastelli (1867-1938) grande collezionista e studioso romagnolo il quale nel tempo riunì, tra le altre cose, libri, manoscritti, stampe, dipinti, monete, francobolli, fotografie e altri materiali che a vario titolo e, più o meno diretta-mente, riguardavano la Romagna.
14 Proprio la supposta perdita di questa componente, riducendo in maniera drastica le possibilità di indagine, ha da sempre rappresentato uno dei principali de-terrenti verso lo studio di tale complesso.
15 Tale fortunato recupero ha inoltre stimolato la realizzazione di una nuova planimetria generale della necropoli occidentale di fase Certosa presentata in occasio-ne di un recente convegno (GoVi 2009a) e primo importante passo verso l’ambizioso progetto che mira all’elaborazione di un GIS dei sepolcreti felsinei in cui raccogliere e sistematizzare l’immensa mole di dati disponibili.
estratto
247SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
“pietre funerarie felsinee” restituite fino a quel momento dagli scavi cittadini16. In tale opera, per molti aspetti ancora un punto di rife-rimento imprescindibile nello studio della classe, i semata ricondot-ti al sepolcreto De Luca sono ventotto, tutti attualmente conservati ed esposti presso il Museo Civico Archeologico di Bologna17 e tra cui si annoverano una scultura a tutto tondo riproducente un leone, un cippo sferico su base quadrangolare e ventisei segnacoli riferibili più propriamente al gruppo delle cosiddette stele felsinee.
Lo studio della documentazione grafica e manoscritta ha inoltre consentito di ricostruire la presenza, all’epoca delle scoperte, di alme-no un ventinovesimo monumento18, nello specifico, stando a quanto riferisce lo Zannoni, una stele recuperata ancora praticamente intat-ta in corrispondenza della tomba n. 20 e decorata a bassorilievo con l’immagine di un cavallo. Non essendo tali caratteristiche riconduci-bili a nessuno dei segnacoli attualmente conservati19 risulta verosi-mile l’ipotesi che la stele in oggetto, per ragioni attualmente difficili da precisare, sia andata perduta in una fase precedente all’arrivo del lotto di materiali De Luca presso il Museo Civico Archeologico di Bo-logna.
Rapportando dunque il numero dei segnacoli con quello delle se-polture ne risulta che all’interno del predio De Luca le tombe indicate esternamente da stele, sculture a tutto tondo o cippi scolpiti erano cir-ca il 26% secondo modalità che ben si inquadrano in quel fenomeno,
16 Il Catalogo (DuCAti 1911), a cui ancora si fa riferimento per la numerazione dei segnacoli, comprende 201 esemplari e venne successivamente aggiornato, sempre per merito del Ducati (ID. 1943), con l’edizione delle sei stele messe in luce nel 1925 nell’area dello stadio comunale. Il corpus è stato in seguito integrato ulteriormente da alcuni ritrovamenti di carattere prevalentemente sporadico: due stele furono recupe-rate durante le indagini condotte all’interno del predio Arnoaldi nel primo dopoguerra (MACellAri 2002 con riferimenti precedenti); a scavi di emergenza è legato il rinveni-mento della cosiddetta stele di S. Michele in Bosco (SAssAtelli 1984) e delle tre stele ancora dall’area Polisportivo (Morigi GoVi - SAssAtelli 1993); in tempi recentissimi si è poi aggiunto l’eccezionale rinvenimento da via Saffi (per cui si veda ora Desantis in questo stesso volume) per un totale di 214 monumenti tra cui si annoverano 196 stele, 10 cippi sferici, 3 sculture e 5 semplici ciottoli aniconici. Nel gruppo possono infine essere inseriti tre segnacoli che, sebbene provengano non dall’area urbana, ma dal territorio circostante, risultano pienamente partecipi dei caratteri più tipici della produzione scultorea felsinea. Si tratta nello specifico delle stele da località Tombarelle (SAssAtelli 1989a con ulteriori rimandi), di quella dalla tomba 26 di Casalecchio di Reno (OrtAlli 2002) e di quella dalla tomba 2 della Galassina di Castelvetro (PizzirAni 2009a).
17 DuCAti 1911, cc. 422-431, nn. 128-155.18 Non è da escludersi che i segnacoli in origine fossero in numero ancora mag-
giore data l’oggettiva impossibilità in alcuni casi di ricondurre generici riferimenti al recupero di frammenti di stele con quelli tutt’ora conservati.
19 Due sono in realtà i segnacoli pertinenti al sepolcreto De Luca caratterizzati da questa iconografia (stele n. 130B e n. 134), ma si tratta di esemplari riferibili con tutta sicurezza ad altri contesti.
estratto
248 GIULIA MORPURGO
già messo in evidenza da studi condotti in passato20, che prevedeva una progressiva diminuzione nella monumentalizzazione delle aree funerarie mano a mano che ci si allontanava dall’antico centro urba-no21.
Accanto all’uso certamente esclusivo di tali monumenti22, in as-soluto una delle espressioni più alte del livello culturale ed artistico raggiunto da Felsina nel V secolo a.C., è stato possibile attestare, uni-camente a livello documentario, la diffusa presenza di altre tipologie di elementi atti a svolgere il ruolo di indicatore esterno delle singole sepolture23. Frequente è infatti il riferimento al recupero di semplici ciottoli aniconici o rozze sfaldature in arenaria che dovevano costitui-re le categorie di semata più diffuse all’interno delle necropoli, unita-mente ad elementi lignei di cui non si conserva più traccia.
Come anticipato però, l’aspetto certamente più interessante a cui l’analisi condotta ha consentito di approdare, risulta essere quello della contestualizzazione dei segnacoli scolpiti al relativo corredo di pertinenza.
Dei ventotto monumenti inseriti nel catalogo del Ducati e riferi-bili al sepolcreto De Luca, sedici sono quelli per cui, attraverso una minuziosa ed attenta collazione delle fonti recuperate, è stato possi-bile avanzare una proposta di associazione con l’originario contesto, circostanza che ha indubbiamente favorito un’analisi delle molteplici e complesse variabili che dovettero regolare il rapporto stele - tomba.
È stato innanzitutto possibile formulare qualche interessante riflessione di carattere topografico in merito alla distribuzione che i segnacoli monumentali dovevano avere all’interno del sepolcreto (Fig. 2).
Diversamente da quanto documentato in altre zone della necro-poli occidentale ed in particolar modo presso il sepolcreto della Certo-sa infatti, in tale settore essi non paiono concentrarsi esclusivamen-te nelle immediate vicinanze di quella strada sepolcrale che dovette condizionare fortemente le dinamiche di sviluppo dell’intera area
20 SAssAtelli 1988, in particolare p. 233. La percentuale tiene conto anche del segnacolo non recuperato, ma si tratta di un dato che sostanzialmente non modifica quanto ricostruito nel contributo citato (per cui si veda anche la nota seguente).
21 Tale aspetto risultava particolarmente perspicuo nel settore funerario oc-cidentale dove, sulla base dei dati ricavabili dal catalogo del Ducati, è stato possibile ricostruire come le sepolture indicate fuori terra da stele o da elementi scolpiti erano il 42% nel sepolcreto Arnoaldi, il 25% nel sepolcreto De Luca, il 14-18% nei sepolcreti Aureli e Battistini ed appena il 10% nel sepolcreto della Certosa, in una sequenza to-pografica che coincide perfettamente con il progressivo allontanamento dalla città.
22 In generale solo il 20% delle sepolture databili a fase Certosa appare con-traddistinto da segnacoli monumentali indizio del carattere elitario.
23 Tali oggetti infatti, in virtù del loro scarso valore, è raro venissero conservati.
estratto
249SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
funeraria24, ma si distribuiscono in maniera piuttosto omogenea in tutte le zone del sepolcreto interessando anche le tombe più distanti dall’asse viario25. Tale circostanza, se da un lato costituisce un’ulte-riore riprova della diffusa ricchezza che doveva connotare le sepolture di questo settore, dall’altro non sembra compromettere la precipua funzione assegnata a tali segnacoli ovvero quella di comunicare un messaggio a tutti coloro che da quella strada transitavano. Se infatti si considera che l’estensione massima di tale lotto funerario non dove-va superare, stando alle indicazioni riportate in pianta dallo Zannoni, la trentina di metri in senso nord-sud, appare evidente come anche i monumenti più lontani risultassero chiaramente visibili agevolati in questo anche dal naturale pendio del terreno che, come è stato ricostruito, contribuiva con un effetto chiaramente scenografico alla monumentalizzazione esterna delle necropoli bolognesi26.
Aspetto però certamente ancora più significativo di questo lavoro di ricomposizione è che dodici di queste sedici sepolture sono risultate databili sulla base dei materiali di corredo ed hanno dunque fornito un valido contributo al più ambio dibattito sulla cronologia da asse-gnare a questi monumenti.
Come noto infatti, quello del rapporto tra stele e corredo e dunque il problema della datazione dei singoli manufatti, costituisce da sem-pre uno degli aspetti più delicati e complessi della ricerca, frequen-temente pregiudicato dalle circostanze di ritrovamento dei segnacoli in giacitura secondaria, spesso accatastati uno sull’altro all’interno di fosse sepolcrali, a seguito di episodi di violazione o a lavori agricoli moderni27.
Già il Ducati, nella sezione dedicata all’analisi generale del cor-pus, posta a seguito del catalogo, si domandava “…in quale succes-sione cronologica possiamo noi distribuire questi segnacoli funebri?”, postulando la necessità di dare risposta a tale quesito preliminar-mente attraverso “…l’esame del materiale ritrovato nelle diverse tom-
24 SAssAtelli 1988, pp. 221-224. Ciò nonostante non mancano anche qui casi assolutamente emblematici costituiti da sepolture in cui tutti gli elementi, dimensio-ne, struttura, corredo, presenza del segnacolo monumentale e anche localizzazione in prossimità del percorso stradale, concorrono organicamente nel sottolineare la grande volontà di autorappresentazione dei titolari dei sepolcri, certamente individui che in vita erano appartenuti ai ranghi più elevati della comunità civica bolognese.
25 Una analoga situazione è stata registrata anche nel secondo gruppo di se-polcri del predio Arnoaldi per cui si veda MACellAri 2002, p. 41.
26 SAssAtelli 1988, pp. 212-213.27 Questa circostanza verificatasi di frequente, in particolar modo nel sepolcre-
to Arnoaldi, può trovare una sua logica giustificazione tenendo conto del fatto che tali segnacoli si trovavano ad un livello superiore rispetto al piano della fossa sepolcrale ed erano dunque più facilmente soggetti a danneggiamenti e/o rimozioni più o meno consapevoli.
estratto
250 GIULIA MORPURGO
be sormontate dalle pietre” e, solo in seconda istanza, mediante “…il confronto stilistico, tettonico, ed il confronto di contenuto, tra pietre approssimativamente databili e pietre per cui manca ogni base di da-tazione28”.
Se dunque i presupposti metodologici dello studioso apparivano guidati da criteri filologicamente inoppugnabili, i risultati a cui egli fu in grado di approdare appaiono sicuramente più incerti e di fatto costituiscono la parte forse più fragile del suo catalogo che, per molti altri aspetti, resta ancora un valido punto di riferimento.
Sebbene, a giudizio del Ducati, fossero allora soltanto tredici le stele ancora riconducibili al relativo contesto29, egli giunse a formu-lare una proposta di inquadramento cronologico per tutti gli esem-plari30 del catalogo con alcune evidenti forzature legate al fatto, mal-grado le premesse, di avere privilegiato elementi di tipo iconografico e stilistico.
Come già efficacemente dimostrato31, la limitata attendibilità di queste ricostruzioni emerge distintamente osservando le tabelle cro-nologiche conclusive in cui le centosessantasei stele prese in consi-derazione risultano distribuite all’interno di cinque gruppi, ciascuno dei quali occupante un trentennio, dal 510 al 360 a.C. Stando infatti alla suddivisione proposta dal Ducati, la produzione di tali manufatti risulterebbe caratterizzata da un progressivo e costante incremento nel corso del tempo che porterebbe paradossalmente a collocarne l’a-pice, con oltre un terzo degli esemplari datati, nella prima metà del IV secolo a.C., periodo in cui molteplici sono ormai gli elementi che in maniera organica e coerente mostrano una Bologna esposta ai primi segni di quella crisi che di lì a poco coinvolgerà tutta l’Etruria padana.
Sebbene, nonostante le evidenti e pesanti ricadute sul piano del-la ricostruzione storica, l’arbitrario ricorso a criteri di tipo esclusiva-mente stilistico e tematico per risolvere questioni di cronologia non sia mancato anche in studi successivi a quello del Ducati32, le ricerche condotte da G. Sassatelli verso la fine degli anni Ottanta permisero di approdare ad una rigorosa impostazione del problema33. All’interno di un contributo che, avendo segnato profondamente l’approccio esegeti-co nei confronti della classe, ancora oggi costituisce uno dei capisaldi
28 DuCAti 1911, c. 461.29 DuCAti 1911, cc. 462-465 (stele nn. 43, 61, 76, 79, 80, 81, 103, 156, 181, 182,
183, 192, 200).30 Dei 201 monumenti catalogati, ne restarono fuori dalle valutazioni 35 a cau-
sa del cattivo stato di conservazione.31 SAssAtelli 1989b.32 Si veda ad esempio StAry-RimPAu 1988, pp. 73-88. Su questo specifico argo-
mento importanti osservazioni in SAssAtelli 1999. 33 SAssAtelli 1989b.
estratto
251SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
della critica, lo studioso mise in risalto l’esigenza di arrivare ad una definizione cronologica dei singoli monumenti fondata su criteri pie-namente oggettivi.
Partendo dal presupposto che in un ambiente sostanzialmente “periferico” come quello etrusco-padano valutazioni di ordine stilisti-co corrono il rischio di essere compromesse dall’obiettiva difficoltà di distinguere “realizzazioni veramente ‘arcaiche’ da probabili ritardi nell’aggiornamento formale e, in qualche caso, anche da incerte capa-cità espressive”, operò per la prima volta un serio tentativo di ricon-testualizzazione dei segnacoli subordinato prioritariamente proprio all’esigenza di puntualizzarne la cronologia.
Trentasei le stele e i cippi che lo studioso allora riuscì a datare sulla base dei dati offerti dai relativi corredi di pertinenza, risultato che, per quanto circoscritto dal punto di vista quantitativo, rese co-munque possibili alcune importanti considerazioni di carattere gene-rale. L’estrema coerenza del quadro messo in luce consentì infatti di fissare una serie di capisaldi cronologici in grado di riflettere alcuni dei tratti salienti che dovettero contraddistinguere l’evoluzione tipo-logico-formale interna alla classe, base oggettiva a cui poter ancorare in seguito valutazioni di altra natura34.
Per quanto riguarda nello specifico il sepolcreto De Luca, poten-dosi avvalere esclusivamente delle informazioni contenute nel Gior-nale di Scavo, i segnacoli presi in esame dallo studioso furono tre35, numero che le ricerche più recenti hanno consentito di integrare in maniera piuttosto significativa offrendo, tra le altre cose, un prezioso terreno di verifica di molte delle linee di tendenza messe in luce in precedenza.
Come già anticipato infatti, i monumenti del sepolcreto De Luca per cui è stato possibile formulare una proposta di datazione sulla
34 Al di là dei limiti di carattere più generale legati, come già messo in eviden-za, ad un’errata impostazione del problema, confrontando nel dettaglio le tabelle del Ducati con i risultati raggiunti da Sassatelli, accanto a diversi punti di sintonia, non si possono non registrare altrettanto frequenti sfasature con inevitabili conseguenze sul piano della ricostruzione storica. A titolo puramente esemplificativo cito il caso di alcuni cippi sferici datati dal Ducati nella prima metà del IV (DuCAti 1911, c. 715, nn. 101-102) e riferibili invece sulla base del contesto alla fine del VI - inizi V secolo a.C. (SAssAtelli 1989b, pp. 929-930; MACellAri 2002, p. 162) a riprova del fatto che l’uso di tali segnacoli risulta riferibile, con estrema coerenza, alle fasi iniziali della produzione scultorea felsinea. Significativo anche il caso della stele n. 182, un monumento davvero eccezionale e ricco d’implicazioni per le caratteristiche dell’apparato figurativo, datata dal Ducati tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. (DuCAti 1911, c. 715), mentre da Sassatelli attorno alla metà del V secolo a.C. (SAssAtelli 1989b, p. 935), cronologia che può ora trovare ulteriore conferma nella “nuova” stele di via Saffi, per molti aspetti gemella alla 182 e databile, sulla base del contesto, tra 460 e 450 a.C.
35 Si vedano le indicazioni alla nota seguente.
estratto
252 GIULIA MORPURGO
base del contesto, sono attualmente dodici tra cui si devono distingue-re una scultura configurata a leone e undici stele36.
Occorre innanzitutto rimarcare come, in ben nove casi, si tratti di segnacoli inquadrabili cronologicamente, in maniera più o meno pun-tuale, nell’ambito del secondo quarto del V secolo a.C., circostanza che ha favorito specialmente valutazioni relative alle fasi iniziali e forma-tive di questo eccezionale fenomeno produttivo37. Si tratta di un aspetto che già Pericle Ducati aveva sottolineato38 e che risulta estremamente coerente con il quadro più generale delineato per l’intero sepolcreto.
L’analisi dei corredi ha infatti consentito di ricostruire uno sfrut-tamento per scopi funerari di tale settore dalla fine del VI alla fine del V - inizi del IV secolo a.C., con una netta predominanza di tombe databili al momento più antico ed in particolar modo al secondo quar-to del V secolo a.C., periodo a cui sono riconducibili oltre la metà dei sepolcri per cui è stato possibile avanzare una proposta di inquadra-mento cronologico e che si configura dunque come quello in assoluto di maggiore sviluppo del sepolcreto39. Appare a questo proposito inte-ressante sottolineare come proprio in questa fase si possa collocare il momento di massima fioritura dell’intero sistema economico messo a punto dagli Etruschi in area padana40, reso ben evidente, tra le altre cose, dai vertiginosi picchi raggiunti ora nei grafici relativi alla diffu-sione della ceramica attica41, riflesso della più compiuta affermazione di un’élite urbana che dal commercio traeva la sua grande ricchezza.
L’osservazione dei segnacoli De Luca databili sulla base del con-testo consente di evidenziare una serie di elementi che si inseriscono in maniera molto coerente all’interno del quadro delineato in occasio-ne di precedenti studi42.
36 I segnacoli, per cui si vedano le relative schede di catalogo in appendice, sono i numeri: 128, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 143, 150, 153, 154. Quelli già presenti in SAssAtelli 1989b erano i nn. 132, 135 e 138. Rispetto a questo contributo però, le nuove indagini hanno consentito di ricondurre la stele n. 135 al sepolcro 9 e non al 15 come precedentemente proposto, circostanza che tuttavia non ne ha modificato l’inquadramento cronologico (cfr. in particolare la scheda n. 4).
37 Come già evidenziato in letteratura quello delle stele è un fenomeno relati-vamente tardo che tocca il suo apice solo nella seconda metà del V secolo a.C. (SAssA-telli 1989b).
38 DuCAti 1911, c. 716.39 Decisamente meno attestata invece la seconda metà del V secolo a.C. in
sintonia con quanto messo in evidenza anche in Certosa (GoVi 1999, pp. 13-17), sepol-creto con cui frequenti sono i punti di contatto. Per una riflessione più generale sulla scansione cronologica dei corredi di fase felsinea si rimanda a GoVi 2009a, pp. 73-74.
40 GoVi 2005, pp. 284-285.41 Per la ceramica attica figurata BoArDmAn 1979, p. 36, fig. 5, ripreso poi in
MArtelli 1985, p 179, fig. 14. Per le produzioni a vernice nera GoVi 1999, in particolare pp. 171-173, fig. 83.
42 SAssAtelli 1989b, GoVi - sAssAtelli 2004 e si veda ora anche il contributo di E. Govi all’interno di questo volume.
estratto
253SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Come già messo in luce infatti, gli esordi dell’esperienza sculto-rea felsinea risultano connotati da tratti di grande sperimentazione, testimoniati, anche in questo caso, dall’adozione sincronica di tipolo-gie formali differenti quali, ad esempio, il leone funerario (n. 128), la stele di forma centinata (n. 135) o più tozza e circolare (nn. 132-133), con esiti anche del tutto eccezionali come quello della monumentale stele n. 137, dal profilo rettangolare e con iscrizione su rotaia, che non sembrano avere seguito. Si tratta poi di monumenti che a livello sia morfologico, che tematico43, palesano quel debito nei confronti dell’E-truria tirrenica riconosciuto come peculiare delle fasi iniziali della produzione.
Pienamente confermati appaiono inoltre non solo una predile-zione nei confronti del campo figurato unico44, ma anche il valore in passato assegnato alle cornici lisce quale indizio di seriorità45: tutte le stele De Luca dotate di cornice e databili a queste fasi iniziali risulta-no infatti caratterizzate in tal senso46.
Le associazioni proposte hanno poi consentito di collocare in una fase più recente ed in particolare nel terzo quarto del V secolo a.C. sol-tanto tre dei segnacoli De Luca47. Tuttavia, anche questa documenta-zione, per quanto circoscritta, presenta caratteri di profonda sintonia con le linee di tendenza più generali messe a punto per l’intera classe che, solo in un momento più avanzato, collocano l’adozione di icono-grafie maggiormente complesse, esito delle forti sollecitazioni cultu-rali e ideologiche da parte dei partners commerciali greci e riflesso
43 Particolarmente esemplificativa in questo senso l’immagine della porta che decora la stele n. 132 (cfr. in Appendice scheda n. 2).
44 Dei nove monumenti databili nella prima metà del V secolo a.C., escludendo ovviamente la scultura conformata a leone, nessuno risulta caratterizzato dalla parti-zione in registri.
45 Si tratta di un aspetto già richiamato dal Ducati (DuCAti 1911, c. 486), ma che solo studi più recenti hanno messo a fuoco in maniera organica e sistematica (GoVi-SAssAtelli 2004, pp. 230-231). Va in ogni caso precisato che, in qualche raro caso, l’uso della cornice liscia sembra prolungarsi anche nella fase più tarda come tra l’altro attestano le stesse stele De Luca 130 e 139 databili probabilmente nel terzo quarto del V secolo a.C.
46 Appare non privo di interesse mettere in evidenza come, più in generale, prendendo in considerazione anche gli esemplari non databili, il quadro restituito dal sepolcreto De Luca in merito alle cornici è il seguente: dei ventotto segnacoli conservati, se si escludono quelli privi di cornice (nn. 128-129, 153-155) o troppo frammentari (nn. 144, 147-149) o in cui la cornice viene destinata a contenere l’iscrizione (n. 137), restano analizzabili diciotto casi, che salgono a ventuno considerando che tre esemplari risultano decorati su entrambi i lati. Di questi ventuno, ben quindici risultano caratterizzati da una cornice di tipo liscio andando a costituire poco meno della metà delle attestazioni totali di tale tipologia (37 le cornici lisce documentabili all’interno di tutto il corpus per cui si veda Ibidem, pp. 230-231); in soli sei casi è invece attestato l’uso della cornice con motivo ad onde correnti, tipologia tra le più ricorrenti all’interno della classe.
47 Si tratta nello specifico delle stele nn. 138, 130 e 139 (cfr. in Appendice ri-spettivamente le schede nn. 10, 11, 12).
estratto
254 GIULIA MORPURGO
del progressivo diffondersi di nuove concezioni funerarie48. Ne sono in particolare testimonianza la stele n. 138 in cui il viaggio su carro del defunto viene eccezionalmente scortato dai Dioscuri raffigurati nel registro sottostante49 o la stele n. 130 con la raffigurazione dello scon-tro tra il defunto ed un mostro in cui, secondo le letture più recenti, può forse essere visto un ambiguo riferimento alla tappa del viaggio nel distretto infernale che comporta il superamento di prove50.
Quest’ultimo segnacolo, in assoluto una delle stele più note dell’intero corpus proprio per la singolarità della decorazione figurata che lo ha da sempre messo al centro dell’interesse della critica51, me-rita un breve approfondimento.
Si tratta infatti di un monumento che, a partire dall’opera del Ducati52, ma ancora in studi recenti53, in virtù di presunti tratti ar-caicizzanti della decorazione figurata, è stato considerato uno degli esemplari più antichi del corpus e datato tra la fine del VI e gli inizi del V secolo, cronologia che, come anticipato, stando ai dati recuperati dall’originale documentazione di scavo, potrebbe essere ora rivista e abbassata al terzo quarto del V secolo a.C.54.
Sebbene, come illustrato, le circostanze del ritrovamento in que-sto caso specifico non possano purtroppo considerarsi pienamente di-rimenti, tale ipotesi sembra trovare conforto in una serie di elementi di carattere tematico, iconografico e formale messi in risalto attra-verso lo studio sistematico a cui è stato di recente sottoposto l’intero corpus55.
Una datazione al terzo quarto del V secolo a.C. consentirebbe innanzitutto di avvicinare l’esemplare in questione alla stele n. 188
48 Anche per questi aspetti si rimanda al contributo di E. Govi in questo volu-me con ulteriori riferimenti.
49 Sul segnacolo e sulle differenti proposte di lettura della componente ico-nografica si rimanda alle indicazioni segnalate in Appendice nella relativa scheda di catalogo (n. 10). Si veda inoltre il contributo di G. Sassatelli in questo stesso volume.
50 BonAmiCi 2006, p. 531, nota 70.51 Per una rassegna delle problematiche sottese all’esegesi del monumento si
rimanda a SAssAtelli - GoVi 2009, p. 85 con riferimenti.52 DuCAti 1911, cc. 715 inserisce la stele nel I gruppo della sua classificazione
proponendone una datazione al periodo compreso tra il 510 e il 480 a.C.53 Così in SACChetti 2011, pp. 267-273 dove per giustificare una datazione tra
la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., tra le altre cose, si chiamano in causa possibili legami con il repertorio figurativo delle stele orientalizzanti, esperienza artistica che, come ormai chiarito dagli studi (SAssAtelli 1989b), nulla ha da condividere, se non l’uso della locale pietra arenaria, con la successiva produzione scultorea felsinea.
54 La medesima cronologia viene proposta in BonAmiCi 2006, p. 531, nota 70 sulla base, probabilmente, di valutazioni di ordine stilistico che però non vengono espli-citate. Lo stesso criterio viene adottato da L. Cerchiai che pensa piuttosto ad una data-zione attorno alla metà del V secolo a.C. (CerChiAi 1999, p. 361).
55 E. Govi in questo volume.
estratto
255SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
del catalogo Ducati56 a cui da sempre viene associata per identità di tematiche57 e che sulla base del relativo corredo di pertinenza è stato possibile datare negli ultimi decenni del V secolo a.C.58 (Fig. 3a).
Nel terzo quarto del V secolo a.C. viene inquadrata cronologica-mente anche la stele n. 91 che doveva costituire, secondo le ricostru-zioni più recenti, il segnacolo della tomba 110 del sepolcreto Arnoal-di59. Nonostante l’estrema lacunosità del monumento risulta ancora possibile scorgervi, in corrispondenza del secondo registro partendo dall’alto, la raffigurazione di un duello che vedeva impegnati un cava-liere, di cui non rimane traccia ed un fante, armato di clipeo e protetto da un elmo dall’alto cimiero, che presenta tratti stilistici talmente simili al guerriero della stele n. 130, da suggerire una possibile reda-zione di entrambi i segnacoli da parte di una stessa mano (Fig. 3b).
Infine, l’analisi strutturale condotta sull’intero corpus delle stele felsinee consente di sottolineare come gli schemi adottati dallo scal-pellino bolognese nella resa sia del guerriero del lato A, che del ca-valiere del lato B, possano trovare confronto proprio in monumenti databili sempre nell’ambito del terzo quarto del V secolo a.C.60.
Se dunque gli elementi appena richiamati appaiono orientare in maniera piuttosto coerente verso una cronologia recenziore61, ciò che in ogni caso si ritiene potersi escludere assolutamente è una datazio-ne della stele n. 130, così come proposto anche in contributi recenti62, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. A questo periodo infatti, allo stato attuale delle conoscenze, risulta riferibile solamente la stele n. 18763 (Fig. 4), segnacolo che, sotto molteplici punti di vista, si allon-
56 DuCAti 1911, cc. 453, 546-549.57 La stele, di forma circolare è decorata su di un lato soltanto a registro unico
con il motivo del cavaliere in lotta con un mostro anguipede identificabile con Tifone che, per l’assoluta omologia formale e stilistica con quello raffigurato nel lato A della stele 130 (Fig. 16), viene da sempre ricondotto all’uso di un medesimo cartone preparatorio.
58 SAssAtelli 1989b, pp. 942-943.59 MACellAri 2002, pp. 226-233.60 Il tipo del guerriero nudo, variamente armato, con gambe divaricate e busto
che tende leggermente a ritirarsi quasi in atteggiamento di difesa che caratterizza la figurazione del lato A, lo si ritrova ad esempio, seppur con una resa molto difforme dal punto di vista qualitativo, nella nota stele 168A databile agli anni tra 440 e 420 a.C.; analogamente, lo schema del cavaliere in attacco con un braccio alzato all’indietro e l’altro proteso verso il cavallo ricorre sempre nel duello della stele 168 e in quello della stele 42A, databile ancora nell’ambito del terzo quarto del V secolo a.C.
61 Tale ipotesi risulterebbe inoltre pienamente in sintonia con l’idea di una strutturazione del viaggio oltremondano articolato per tappe cui, come anticipato, an-che questa scena potrebbe essere riferita e che in ambito etrusco tirrenico proprio a partire dagli anni attorno alla metà del V secolo a.C. sembra restituire le testimonian-ze più compiute (BonAmiCi 2005; EAD. 2006).
62 Si veda nota 54.63 Si escludono da queste valutazioni i cippi sferici su base cilindrica o qua-
drangolare, segnacoli caratteristici proprio di queste fasi più antiche, ma riconducibili
estratto
256 GIULIA MORPURGO
tana dai caratteri più tipici della produzione felsinea, la quale dovette trovare la sua piena formulazione presumibilmente solo a partire dal secondo quarto del V secolo a.C., in parallelo alla più compiuta affer-mazione di un’élite propriamente urbana64.
Un altro aspetto che la documentazione restituita dal sepolcreto De Luca consente di mettere in evidenza è quello, prendendo a pre-stito un termine della tradizione ottocentesca, delle cosiddette “stele lisce65”, ovvero quei segnacoli la cui forma appare l’esito certo di una lavorazione, ma privi di alcuna componente figurata: si tratta in par-ticolare delle stele nn. 15066, 153, 154 e 155 del catalogo Ducati67.
Tre di questi esemplari, sulla base delle associazioni proposte68, risultano databili nel secondo quarto del V secolo a.C., circostanza che, trovando conferma anche in altri contesti69, sembra definire in maniera piuttosto coerente quella delle stele aniconiche come una manifestazione tipica, per non dire esclusiva, delle fasi iniziali della produzione scultorea felsinea.
Proprio la presenza di questi segnacoli in cui l’unico elemento sottoponibile ad esegesi risulta essere la forma e che Ducati più ba-nalmente riconduceva ad uno stadio ancora incompleto di lavorazio-ne70, sembra oggi poter confortare l’idea che anche dietro questa possa celarsi un significato intrinseco specifico, evidentemente sufficiente a richiamare pregnanti contenuti ideologici.
Appare dunque a questo proposito interessante chiamare in cau-sa una recente ipotesi71 secondo cui, in particolar modo per i primi esemplari caratterizzati da un profilo poco rastremato verso il basso, sarebbe forse possibile riconoscervi un’allusione al passaggio verso la
in maniera coerente ad una matrice culturale d’ambito etrusco-tirrenico (SAssAtelli 1989b, pp. 944-945).
64 SAssAtelli - GoVi 2009.65 Si tratta della definizione solitamente adottata dallo Zannoni per designare
questa particolare categoria di segnacolo.66 Quest’esemplare si distingue in parte per la presenza, su di un lato, di un’in-
cisione che sembra circoscrivere lo spazio di una cornice, anche questa priva di decora-zione.
67 DuCAti 1911, cc. 430-431.68 Si vedano nell’Appendice a questo contributo le relative schede di catalogo.69 Al secondo quarto del V secolo a.C. risultano databili con tutta probabilità le
stele n. 166 (di forma centinata) e n. 167 (circolare) rinvenute nel sepolcreto della Cer-tosa e la n. 60 (superiormente arcuata e con cornice a triplice cordonatura) dal sepol-creto Arnoaldi; da questo stesso nucleo proviene anche la stele n. 103, di forma sempre superiormente arcuata e databile poco dopo la metà del V secolo a.C. Nella prima metà del V secolo a.C. può inoltre essere inquadrato l’esemplare aniconico con profilo a “ferro di cavallo” che fungeva da segnacolo della tomba 15 del piccolo sepolcreto etrusco della Galassina di Castelvetro in provincia di Modena (PizzirAni 2009a, pp. 121-123).
70 DuCAti 1911, cc. 467-469. 71 Su questo tema si veda E. Govi, in sAssAtelli - goVi 2009, p. 90, EAD. 2010,
p. 43 e Govi in questo stesso volume, tutti con ulteriori riferimenti.
estratto
257SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
morte, al transito attraverso un varco72 che dà accesso ad un ambito funebre73.
Tale lettura infatti sembrerebbe poter trarre ulteriore sostanza dall’analisi degli elementi che caratterizzavano il corredo della tomba 13 uno di quei contesti del sepolcreto De Luca segnalati all’esterno proprio da una stele aniconica74 (Fig. 14).
Si tratta infatti di una sepoltura, un’inumazione in fossa sicura-mente riferibile ad una donna per la presenza di una conocchia75, che nella selezione delle sue componenti restituisce un quadro di estrema coerenza, riflesso dell’alto grado di consapevolezza messo in atto da parte del titolare della tomba che rende lecito ipotizzare come anche la scelta del segnacolo non sia dipesa da fattori di ordine economico, ma dalla volontà dell’individuo di costruire un preciso messaggio dal pregnante valore evocativo76.
Tra gli elementi del corredo spicca per l’eccezionalità della deco-razione figurata il cratere attico a colonnette77 (Fig. 5), nucleo focale del set vascolare78, deposto, in conformità ad una prassi consolidata nel rituale funerario felsineo, presso il lato sinistro della fossa all’al-tezza del cranio della defunta.
Il lato principale del vaso, ricondotto dal Beazley all’opera del pittore di Alkimachos79, risulta infatti caratterizzato dalla rappresen-tazione di una giovane donna semivelata, ornata da orecchini e alto diadema, la quale, mentre con una mano tiene il proprio abito, ten-de l’altra ad una figura maschile connotata inequivocabilmente come Hermes. Questi, raffigurato di prospetto, ma con il volto girato verso di lei, prendendola per il polso la conduce verso destra dove, ad at-
72 Al secondo quarto del V secolo a.C. si data la stele n. 132 (Fig. 7), provenien-te proprio dal sepolcreto De Luca e caratterizzata dalla raffigurazione di un portale di tipo dorico, in cui dunque il tema del transito risulta essere reso in maniera assoluta-mente esplicita.
73 Come messo in luce da E. Govi (per cui si veda il contributo in questo vo-lume) tali rimandi potevano non essere necessariamente univoci come sembrerebbe suggerire l’interessante lettura proposta in occasione proprio di questo convegno da F. Roncalli in relazione agli esemplari contraddistinti da profilo circolare (si veda il contributo).
74 Al di là della puntuale validità dell’associazione proposta (cfr. Appendice, scheda n. 9), non sussistono dubbi in merito al fatto che questa tomba fosse in antico segnalata da un monumento privo di alcuna decorazione figurata.
75 Altri indizi, come vedremo, sostanziano significativamente tale ipotesi.76 Si tratta di un aspetto già riconosciuto per l’ambito etrusco-padano ed in
particolare bolognese che gli studi degli ultimi anni stanno contribuendo a mette a fuoco in maniera sempre più puntuale (GoVi 2009a; EAD. 2009b; PizzirAni 2011; Mor-Purgo c.s.). Su questo tema si veda inoltre il contributo di G. Sassatelli all’interno di questo volume.
77 Brizio 1888, c. 4; Pellegrini 1912, p. 93, n. 236. 78 Per la composizione del corredo si rimanda in Appendice alla scheda n. 11.79 ArV2: 532,44; ADD2: 254.
estratto
258 GIULIA MORPURGO
tenderla, è una donna anziana identificabile con Ecate per l’attributo delle torce che regge in entrambe le mani. Segue la coppia, muoven-dosi nella stessa direzione, un satiro barbato recante sulla testa una cassetta riccamente decorata.
Lo schema iconografico adoperato e a cui il ceramografo pare es-sersi attenuto in maniera fedele, non lascia dubbi nell’interpretare tale raffigurazione come un’agoghè di tipo nuziale80; tuttavia alcuni elementi, ed in particolar modo la presenza di Ecate, consentono di ubicare tale futura unione nel mondo degli inferi, in un gioco voluta-mente ambiguo che, come spesso accade, vede compenetrarsi la sfera matrimoniale con quella funeraria81.
Particolarmente emblematico a questo proposito, il gesto della mano sul polso, chèir epì karpoù, segno rituale che sancisce la pre-sa di possesso della sposa da parte dell’uomo82 e che, per estensione, proprio come accade nel cratere oggetto di quest’analisi, caratterizza Hermes nella sua funzione psicopompa, quando il dio si accinge a condurre il suo protetto nell’Aldilà83.
Apparentemente meno perspicua l’identificazione della protago-nista della scena, soggetta infatti a soluzioni differenti da parte de-gli studiosi che si sono a più riprese interessati a questo vaso84, ma va tuttavia messo in evidenza come ad un primo livello di analisi, essa possa risultare non così strettamente necessaria. Al di là infatti del puntuale riconoscimento della donna guidata da Hermes, quello che sembra costituire il fulcro semantico della scena raffigurata è il concetto della transizione, del passaggio, un passaggio che, coerente-mente al messaggio intrinseco ipotizzato per la stele aniconica, viene collocato in una dimensione ctnoia85.
80 Si veda, a titolo esemplificativo, un’oinochoe a f.r. con generica scena di noz-ze dal Museo Archeologico di Firenze (BA 205957).
81 Nota e ampiamente dibattuta da parte della critica l’omologia semantica che intercorre tra il matrimonio e la morte, entrambi determinanti un passaggio di stato (Rhem 1994; OAkley 2008).
82 BérArD 1984; LissArrAgue 1990, p. 189.83 G. Siebert, in LIMC, s.v. Hermes, pp. 336-337. Come messo in risalto dalla
critica, il medesimo segno iconico risulta non a caso connotare di frequente i demoni psicopompi presenti sulle stele felsinee (E. Govi in questo volume con riferimenti).
84 Già il Brizio, per primo, ricondusse correttamente la scena all’ambito matri-moniale suggerendo di leggervi la raffigurazione delle nozze tra Arianna e Dioniso alla presenza di Semele (Brizio 1888, c. 4); altri studiosi in seguito hanno ipotizzato invece si potesse trattare dello sposalizio tra Hermes e la figlia del re Driope (ARV2: 532.44; Metzger 1965, p. 12, n. 1), mentre a partire dal Pellegrini (Pellegrini 1912, p. 93, n. 236) si è fatta strada l’ipotesi, maggiormente avvalorata in seguito dalla critica (Minto 1919; BérArD 1974 con ulteriori riferimenti), che nell’anonima sposa vada riconosciuta Kore nell’atto di essere condotta verso Ade alla presenza di Ecate. In merito a questa lettura si vedano alcune considerazioni esposte in seguito.
85 Assume un rilievo del tutto particolare in questo senso la figura del satiro presente sul cratere che, in via assolutamente eccezionale, svolge la funzione di portatore
estratto
259SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Appare a questo proposito particolarmente significativo richia-mare una delle ipotesi più recenti86 secondo cui, un immaginario spe-cificatamente femminile all’interno del corpus non solo risulta essere piuttosto limitato e soprattutto circoscritto al tardo V secolo, ma an-che una volta strutturatosi esso trova la sua espressione più compiu-ta ed originale proprio nel passaggio di status che interviene con la morte87.
La profonda coerenza ideologica che, stando agli aspetti appena messi in luce, sembrerebbe pervadere il corredo della defunta sepolta nella tomba 13 del sepolcreto De Luca, emerge ancora più significa-tivamente dall’analisi di altri elementi che, tra le altre cose, consen-tono di recuperare ancora una volta l’immagine presente sul cratere valorizzando la possibile identificazione della figura femminile con la dea Kore, già postulata, come abbiamo visto, per la presenza di Ecate e dell’Hermes psicopompo88.
Un allusivo riferimento a Kore-Persephone è infatti da rintrac-ciare anche nel candelabro in bronzo deposto all’interno della tomba, caratterizzato da una cimasa configurata a galletto, emblema della luce che vince le tenebre, ma anche attributo specifico di questa di-vinità89.
La presenza, certo non casuale, di questi oggetti dischiude dunque un ulteriore livello di esegesi che consente forse di ipotizzare l’adesione della titolare della tomba a culti di derivazione eleusina che nel corso del V secolo, come già ampiamente illustrato dalla critica90, dovettero trovare divulgazione anche in ambito etrusco-padano nel quadro più generale di credenze escatologiche di matrice dionisiaca91.
della cassetta nuziale solitamente rivestita da un’ancella o un erote. Secondo un’ipotesi di Chiara Pizzirani (PizzirAni 2008) infatti, proprio la presenza del satiro, unitamente alla scena di komos dipinta sul lato B, sarebbe funzionale a chiarire l’identità del compagno a cui la sposa è destinata, un compagno che è allo stesso tempo Dioniso e Ade, consentendo di collocare questo passaggio verso l’Aldilà in una dimensione dionisiaca (per un’analisi dei documenti iconografici che anche in Etruria padana consentono di riconoscere un’a-nalogia tra Dioniso e Ade si rimanda a EAD. 2010a con ulteriori riferimenti). La scelta di includere nella raffigurazione questa figura potrebbe inoltre non essere accidentale “in un vaso venduto nella città etrusca in cui la funzione psicopompa del satiro costituisce uno dei fondamenti della demonologia dei segnacoli funerari” (EAD. 2008).
86 E. Govi in questo volume.87 Suggestivo il fatto che almeno cinque delle otto stele aniconiche, tutte in-
quadrabili come già esplicitato nelle fasi iniziali della produzione, risultino riferibili con sicurezza ad individui di sesso femminile.
88 Si vedano i rimandi alla nota 84.89 SurVinou-InWooD 1978, p. 108 con ulteriori riferimenti.90 Su questo tema si rimanda in particolare a GoVi 2009b, EAD. 2010 e al con-
tributo della stessa all’interno di questo volume.91 Cfr. MAsArACChiA 1993, p. 175: “Eleusi, culti dionisiaci, orfismo, rappresen-
tano tre correnti, tre percorsi che si lasciano identificare, ma nella pratica corrente si intrecciano, si mescolano, si confondono”.
estratto
260 GIULIA MORPURGO
Se le ipotesi formulate colgono nel segno avremmo dunque un al-tro significativo esempio della capacità messa in atto da parte di alcuni componenti della comunità felsinea di costruire un messaggio seman-ticamente coerente operando una selezione iconografica che sapiente-mente integra oggetti d’importazione attica, con materiali etruschi.
Un messaggio che, come in questo caso, spesso può sottendere differenti prospettive esegetiche che si compenetrano e sostanziano reciprocamente: da un lato la raffigurazione della scena nuziale che, unitamente al segnacolo funerario, evocano lo status di passaggio al-lusivo ad una dimensione funeraria, dall’altro la presenza di parti-colari segni iconici di marca eleusina funzionali ad esprimere in ma-niera più o meno celata la possibile adesione del defunto ad un credo religioso di natura salvifica92.
Lo stesso sepolcreto De Luca non ha mancato di restituire al-tre significative testimonianze di coerente condivisione ideologica tra monumenti funerari e vasi attici inseriti nel corredo, altro importante traguardo raggiunto grazie al lavoro di ricomposizione filologica pre-sentato in questo contributo93.
Senza dubbio eccezionale a questo proposito il caso della tomba 109 cui, stando alle ipotesi più recenti, potrebbe essere riferita la ste-le n. 137 del catalogo Ducati94 (Fig. 8).
Si tratta infatti di una sepoltura sotto tutti gli aspetti straor-dinaria e in cui diversi elementi concorrono in maniera organica e coerente nel riflettere il ruolo di assoluto prestigio ricoperto in vita dal defunto.
Non certo casuale si configura innanzitutto la posizione della tomba a ridosso della strada extraurbana che, come già evidenziato, attraversava le necropoli occidentali catalizzando alcuni dei contesti più ricchi della Bologna di V secolo, ma caratteri di grande rilievo ri-sultando rintracciabili anche a livello del rito funerario e della strut-tura tombale adottati.
Stando infatti alle indicazioni recuperate analizzando la docu-mentazione di scavo originale, è stato possibile ricostruire come si trattasse di una sepoltura a cremazione in grande fossa95 di forma
92 Cfr. Bottini 1992, p. 38: “l’anima del mystes, subito dopo la morte, è avviata dunque ad un destino favorevole di assimilazione divina che deve aver luogo nel regno di Persefone, cioè di Kore nelle vesti della sposa di Hade signore degli inferi”.
93 Su questo tema in generale si rimanda al contributo di G. Sassatelli in que-sto volume. Per un’analisi di dettaglio del caso rappresentato dalla tomba 100 De Luca segnalata all’esterno dalla stele Ducati 138 si veda MorPurgo c.s.
94 Si veda in Appendice la rispettiva scheda n. 3.95 Studi precedenti hanno già messo in evidenza il valore di esclusività celan-
tesi dietro all’adozione del rito funerario della cremazione in fossa in cui forti sono i rimandi ad un’antica tradizione di stampo aristocratico (GoVi 2005, p. 283).
estratto
261SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
rettangolare le cui dimensioni (m 3,30 x 3,5096) trovano rari confronti all’interno del sepolcreto De Luca e più in generale, nelle necropoli bolognesi di fase Certosa97.
Il rinvenimento nell’area del sepolcro di consistenti quantità di blocchi di travertino, anche sagomati, ha consentito inoltre di ipotiz-zare come questo fosse in antico provvisto di una struttura di tipo monumentale di cui non si è purtroppo in grado di specificare le ca-ratteristiche, ma per cui può forse essere utile richiamare la tomba a sarcofago costruito messa in luce nel sepolcreto dei Giardini Mar-gherita98. Ciò che però certamente assicurava alla sepoltura grande visibilità all’esterno, accentuando un effetto fortemente scenografico, era la presenza del segnacolo funerario, un monumento che, come già messo in luce99, per aspetti tipologici, dimensionali100 e tematici, si configura come un vero e proprio unicum all’interno del panorama scultoreo felsineo101 (Fig. 8). Nonostante lo stato gravemente lacuno-so del monumento un tentativo di ricostruzione del campo figurato è stato effettuato in passato da parte di G. Sassatelli secondo il quale la raffigurazione andrebbe ricondotta nell’alveo delle speciali onorifi-cenze tributate al defunto102, un individuo che, come esplicitato dall’i-scrizione che incisa sulla larga cornice rilevata che correva lungo il bordo della stele, aveva ricoperto in vita la carica di zilath103.
A testimoniare l’estrema coerenza messa in atto nella costruzio-ne del complesso funerario si pone infine l’analisi degli elementi di corredo in cui, in maniera raffinata e sapiente, si torna ad insistere
96 Assolutamente eccezionale anche il livello di profondità a cui fu intercettato il fondo della fossa che doveva superare i sei metri rispetto al piano di campagna.
97 Per le necropoli bolognesi in generale si rinvia a GoVi 2009a. Per quanto riguarda più specificatamente il sepolcreto De Luca appare interessante mettere in evidenza come le poche tombe caratterizzate da dimensioni così ragguardevoli (nn. 109, 101, 103) risultano significativamente disporsi all’interno di uno stesso settore della necropoli suggerendo forse la possibilità di riconoscere anche in corrispondenza di questo nucleo la presenza di gruppi di sepolture molto coerenti sul piano culturale e pertinenti ad individui ai vertici della città.
98 SAssAtelli 1988, pp. 230-231.99 G. Sassatelli in questo volume con ulteriori riferimenti.100 È stato ipotizzato che la stele dovesse in origine raggiungere una larghezza
di circa m 1,70 e una altezza di m 1,50 (SAssAtelli 1988, p. 255).101 L’associazione della stele al sepolcro n. 109 consente di proporne una data-
zione al secondo quarto del V secolo a.C. concordemente con quanto già ipotizzato in passato sulla base di valutazioni epigrafiche, tipologiche e stilistiche (SAssAtelli 1985, pp. 254-255).
102 Di recente è stata prospettata l’ipotesi che l’immagine possa essere sottopo-sta a nuova esegesi partendo dal presupposto che nel personaggio con lituo e copricapo a calotta con larga tesa possa riconoscersi il dio Turms (Govi in SAssAtelli - GoVi 2009, p. 85, nota 70 e Govi in questo stesso volume).
103 Per un’analisi degli aspetti epigrafici si rimanda a Rix 1981-1982 e SAssA-telli 1985.
estratto
262 GIULIA MORPURGO
sul ruolo di garante che dovette rivestire in vita il defunto all’interno della comunità civica bolognese. Nella tomba fu infatti deposto un ricco e variegato set di ceramiche attiche in cui, come messo in luce da studi recenti, unico protagonista della selezione iconografica risulta essere Dioniso, questa volta inteso nella rara accezione di divinità po-liade delle Antesterie e di vincitore dei Giganti e portatore dell’ordine civico104.
Infine, le novità emerse dall’analisi del sepolcreto De Luca, han-no stimolato una più generale revisione del quadro offerto in passato in merito al rapporto stele - corredo - cronologia105.
Tale aggiornamento (Fig. 18), accanto ai dati derivanti da De Luca, ha potuto contare su una serie di acquisizioni più o meno re-centi frutto del rinnovato interesse cui negli ultimi anni, come già an-ticipato, sono state sottoposte le necropoli bolognesi di fase Certosa106.
Rispetto alle ricerche condotte da G. Sassatelli, tale studio si è infatti potuto avvalere dell’edizione definitiva del sepolcreto Arnoaldi che, se da un lato ha in parte corretto le associazioni tra stele e con-testi, senza tuttavia modificare le datazioni assegnate in preceden-za, dall’altro ha consentito di aggiungere qualche nuovo elemento107; alcune piccole modifiche derivano inoltre dall’indagine sistematica effettuata in tempi recenti sulla documentazione pertinente al sepol-creto dei Giardini Margherita108.
Sono stati poi compresi all’interno del nuovo elenco alcuni impor-tanti ritrovamenti frutto delle indagini condotte negli ultimi anni dal-la Soprintendenza Archeologica a Bologna e nel territorio circostante: si tratta nello specifico della stele proveniente da via Saffi109 e di quel-la rinvenuta in corrispondenza di un piccolo sepolcreto messo in luce a Casalecchio di Reno110 che, per le proprie caratteristiche, risulta
104 PizzirAni 2009b e EAD. 2010b. Ad entrambi questi contributi si rimanda per un’analisi puntuale delle ceramiche attiche ed esegesi delle iconografie.
105 SAssAtelli 1989b.106 Confronta i riferimenti a nota 9.107 Si veda la tabella alla fig. 18108 La ricostruzione della necropoli, seconda per numero di tombe solo al nucleo
della Certosa, risulta fortemente penalizzata dallo stato estremamente caotico e lacu-noso in cui versa la documentazione superstite. Tuttavia rispetto a SAssAtelli 1989b le nuove ricerche hanno consentito di riferire la stele 17 alla tomba 64 e non più alla tomba 54, associazione che non ne modifica la datazione verso la fine del V secolo a.C. Purtroppo invece sembra dover essere espunta dall’elenco dei segnacoli databili sulla base del con-testo la stele n. 10, dal momento che il cratere attico in origine associatovi non sembra in realtà essere pertinente. Devo tali informazioni alla cortese disponibilità di F. Guidi, che ringrazio, titolare dello studio sul sepolcreto dei Giardini Margherita (GuiDi 2005a. Per una preliminare rassegna dei risultati raggiunti si veda GuiDi 2005b).
109 Desantis in questo volume.110 OrtAlli 2002.
estratto
263SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
pienamente partecipe dell’esperienza scultorea felsinea contribuendo anche a riflettere il pieno inserimento del vicino comprensorio rurale nell’orbita culturale bolognese111.
L’integrazione di queste componenti ha dunque favorito l’elabo-razione di un nuovo elenco che, come in parte già messo in luce, ar-ricchisce notevolmente il quadro delineato in precedenza portando il numero dei segnacoli databili sulla base del relativo corredo da 36 a 62. Tali importanti risultati hanno così stimolato ed agevolato la pos-sibilità di valutare in una dimensione diacronica i molteplici aspetti che, come valorizzato a più riprese dalla critica, risultano connotare questa produzione112.
Per quanto risulti innegabile come la conoscenza dei contesti fu-nerari bolognesi necessiti di percorsi ermeneutici complessi e non di rado tortuosi, l’assoluta coerenza del quadro ricomposto, ulteriormen-te validata, come già osservato, anche dalle acquisizioni più recenti relative al sepolcreto De Luca, crediamo possa costituire una confer-ma indiretta alle ipotesi formulate.
Confortati già dall’estrema linearità del percorso delineato in merito all’evoluzione tipologico-formale della classe113, ciò che attual-mente appare significativo sottolineare è la profonda coerenza riscon-trabile anche a livello tematico e figurativo. Le analisi più recenti infatti, supportate da strumenti esegetici assolutamente innovativi, stanno contribuendo a chiarire in maniera sempre più puntuale ca-ratteristiche e modalità del progressivo strutturarsi dell’immaginario presente sulle stele felsinee, evidenziando aspetti che trovano ancora una volta precisi riscontri, anche a livello cronologico, con quanto co-nosciuto per l’ambito greco ed etrusco-tirrenico114.
La griglia cronologica predisposta e fondata su criteri oggettivi, può essere così assunta come riferimento per tentare una sistema-tizzazione anche degli esemplari non in contesto attuata attraverso un’analisi serrata dell’intero corpus in grado di mettere in risalto l’e-ventuale presenza di affinità formali e capace di valorizzare, in via subordinata, aspetti di ordine tematico e stilistico.
111 Per le medesime ragioni si è scelto di inserire nel nuovo elenco anche la stele aniconica pertinente alla tomba 15 del sepolcreto della Galassina di Castelvetro contesto messo in luce nell’ottocento ma solo di recente oggetto di un edizione puntuale e sistematica (PizzirAni 2009a).
112 Si veda il contributo di E. Govi in questo volume.113 SAssAtelli 1989b. Per ulteriori affinamenti, anche in merito a tali aspetti,
si rimanda al contributo di E. Govi in questo volume.114 E. Govi in questo volume.
estratto
264 GIULIA MORPURGO
Appendice
Catalogo dei segnacoli De Luca databili da contesto115
1. Scultura funeraria (Fig. 6)Ducati n. 128116. H. della base 0,23; lungh. della base 0,67; h. dell’anima-
le fino al collo 0,95. Priva della testa. Scultura a tutto tondo a forma di leone accovacciato in riposo, su base parallelepipeda. Ampia criniera resa a piccoli cerchielli incisi. La coda, ripiegata dietro la gamba destra posteriore, segue il contorno della coscia; le unghie sono distese.
Tomba 101.
…in uno di questi, di combusto, pochi frammenti di vasi a figure rosse ma due fram-menti di leoni in macigno ed alcuni solidi di travertino sagomati.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dal 20 al 24 dicembre 1875)
Consentono di approdare a tale ricostruzione le indicazioni fornite da A. Zannoni sia nel GdS che nella planimetria generale. La scultura, confron-tabile con esemplari analoghi rinvenuti nei sepolcreti dei Giardini Marghe-rita117 e Arnoaldi118, stando a quanto riferisce l’archeologo doveva fare parte di un monumento più articolato e complesso le cui caratteristiche restano purtroppo difficili da precisare119.
Corredo: la tomba, per molti aspetti dai caratteri in origine senza dubbio eccezionali, risultò al momento della scoperta purtroppo in gran parte già saccheggiata.
Le informazioni desumibili dal GdS, come spesso accade per il sepolcreto De Luca, sono troppo generiche per consentire un’individuazione puntuale
115 I segnacoli per cui si è arrivati a formulare una proposta di associazione con il relativo corredo tombale vengono presentati in una sequenza cronologica. Di ciascun monumento si forniscono indicazioni relative alle caratteristiche tecniche, allo stato di conservazione e, quando presente, all’apparato decorativo. Seguono una disamina delle informazioni che hanno permesso di approdare all’ipotesi ricostruttiva ed una breve rassegna degli oggetti che componevano il corredo.
116 Brizio 1885, p. 204; Brizio 1890, p. 138; DuCAti 1911, cc. 422, 496, Fig. 12, n. 128; BroWn 1960, pp. 138-139, tav. XLIX, a, 1-2; Hus 1961, p. 94, nn. 2-4 e p. 330; SAssAtelli 1988, pp. 226-227; StAry-RimPAu 1988, p. 224.
117 DuCAti 1911, c. 365, n. 4.118 DuCAti 1911, c. 460, n. 201; MACellAri 2002, p. 128 (rispetto a questo ritro-
vamento si veda però la nota seguente).119 ZAnnoni 1876-1884, p. 36 e ID. 1876, pp. 142-44, successivamente ripreso in
DuCAti 1911, c. 497. In merito a questo particolare aspetto si veda più recentemente SAssAtelli 1988, pp. 226-227. Stando alle indicazioni recuperate al momento dello sca-vo i frammenti pertinenti a leoni funerari dovevano essere almeno due, uno dei quali andò probabilmente perduto. Appare però a questo proposito significativo mettere in evidenza come qualche margine di dubbio sussista in relazione alla provenienza del frammento attualmente ricondotto al sepolcreto Arnoaldi (SAssAtelli 1988, p. 226, nota 70; MACellAri 2002, p. 128) dal momento che il Ducati, inserendolo all’interno del proprio catalogo fornisce l’indicazione “provenienza non accertata, ma forse De Lucca” (DuCAti 1911, c. 460, n. 201).
estratto
265SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
dei materiali. Ciò nonostante, grazie all’integrazione degli elementi dispo-nibili, è stato comunque possibile riferire al contesto un cup-skyphos a f.r. ricondotto dal Pellegrini e dal Beazley all’opera di Douris120, una coppetta su piede attica a v.n.121, una piccola base di forma parallelepipeda in avo-rio122, un anello in verga di bronzo a sezione circolare ed un chiodo di ferro. Pertinenti alla tomba, secondo quanto riferito da Cappellini123, ma non più rintracciabili, un unguentario in alabastro, tre conchiglie e tre sassolini da interpretarsi dubitativamente come parte di un set di pedine da gioco.
Cronologia: attorno al 470 a.C.
2. Stele figurata (Fig. 7)Ducati n. 132124. H. max. 1,43; largh. max: 1,08. Ricomposta da diversi
frammenti e lacunosa. Decorata su di un lato soltanto a registro unico: gran-de porta di tipo “dorico” con architrave rettilineo sporgente ai lati. Cornice liscia a doppio cordone.
Tomba 57.
Frugato il 4° sepolcro, però si raccolsero frammenti di grande cratere a figure rosse ed una stele con su scolpita una porta.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 25 alli 30 ottobre 1875).
La descrizione presente nel regesto di scavo dello Zannoni non lascia dubbi in merito all’identificazione del segnacolo di questa tomba, l’unico dell’intero corpus ad essere caratterizzato dalla raffigurazione di una porta.
Corredo: per la tomba, già violata in passato, il GdS registra soltanto il recupero di alcuni «frammenti di grande cratere a figure rosse» che, per la presenza del contrassegno cartaceo con indicazione di provenienza, possono essere agevolmente identificati con il cratere a colonnette n. 263 del catalogo di G. Pellegrini125.
Cronologia: 480-460 a.C.
120 Brizio 1888, c. 26; Pellegrini 1912, p. 213, n. 470, Fig. 133. Entrambi gli autori concordano nel riferire lo skyphos al sepolcro De Luca 101. Per l’attribuzione ARV2: 445.253.
121 “Stemmed dish” tipo “Concav lip”. Si confronta con il n. 989 dell’Agora XII (SPArkes, TAlCott 1970, p. 305, Tav. 35) datato intorno al 470 a.C.
122 CAPPellini 1877, p. 442, fig. 3.123 CAPPellini 1877, p. 442.124 Brizio 1885, p. 207; DuCAti 1911, cc. 423-424, 635-636, fig. 65, n. 142; StAry-
RimPAu 1988, pp. 226; SAssAtelli 1989b, p. 935, tav. III, b; SAssAtelli - GoVi 2009, p. 90 e nota 91; SACChetti 2011, pp. 266-267.
125 Pellegrini 1912, p. 106, fig. 63, n. 263; Brizio 1888, c. 40, lettera H. Non attribuito. Ricondotto dal Pellegrini allo “stile grande-severo” (480-460 a.C.).
estratto
266 GIULIA MORPURGO
3. Stele figurata (Fig. 8)Ducati n. 137126. Largamente frammentaria e solo parzialmente ricom-
ponibile. Un tentativo di ricostruzione del campo figurato è stato effettuato in
passato da parte di G. Sassatelli127. Stando a questa proposta la scena raffi-gurata consisterebbe in una sorta di corteo con tre personaggi che procedo-no verso destra (probabilmente due uomini e una donna) e vanno a rendere omaggio ad una quarta figura in cui andrebbe identificato il defunto, l’Arnth Petlana che in vita, secondo quanto riportato dall’iscrizione, rivestì l’impor-tante carica di supremo magistrato a Felsina.
Sulla larga cornice rilevata che correva lungo il bordo esterno della stele è infatti incisa da destra verso sinistra l’iscrizione: [mi] suqi petlnas arnqial venulsl zilu tu [- - -]acn[- - -]s ran[- - -].
Tomba 109.
Nell’ultimo finalmente [107], prima frugato, non si rinvenne che l’ansa di un grande cratere; però nell’area di questo sepolcro, ed in quella adiacente, si raccolsero frammenti d’iscrizioni appartenuti a stele figurate…(GozzADini 1876, p. 8.)
L’ultimo dei sepolcri [107] era privato di fittili se non per l’ansa di un grande cratere; però in tale sepolcro e nell’area adiacente si ebbero molti frammenti che si riconoscono appartenere a tre stele figurate…(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, Riassunto degli Scavi eseguiti nel mese di gennaio)
Nel quarto sepolcro [107] alcuni frammenti di stela figurata e scritta a caratteri etru-schi, di questi si manderà la trascrizione non appena ricomposti o raccolti altri fram-menti com’è sperabile.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dal 17 al 22 gennaio 1876)
Si diede opera alla regolarizzazione delle trincee ed a nuove ricerche che diedero tre sepolcri. Uno è di combusto [109] e soprastavano alcuni solidi di travertino sagomati, ed entro erano un grande cratere ed un’anfora a figure rosse. All’angolo sud-ovest due frammenti di stela scritta in etrusco i quali si collegano agli altri accennati nel rapporto anteriore.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dal 24 al 29 gennaio 1876)
Si continuò la regolarizzazione del terreno scavato anteriormente…ad alquanti metri si raccolse altro frammento di stela figurata con caratteri etruschi il quale si collega con il 4° e il 5° dei frammenti ricordati nei giornali anteriori.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 1876)
126 DuCAti 1911, cc. 425-427, 712-713, fig. 87; GozzADini 1876, p. 8; CII, III Sup-pl. 12; CII, App. 19-20; Rix 1981-82, pp. 281-286; SAssAtelli 1985, pp. 254-255, n. 9.17; SAssAtelli 1988, pp. 247-255, Figg. 26-28; StAry-RimPAu 1988, pp. 227-228; ColonnA 1999, p. 446, fig. 3, a; MACellAri 2002, p. 105, Tav. 67.
127 SAssAtelli 1988, p. 250-252.
estratto
267SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Come già messo in luce in passato128 la stele n. 137 fu protagonista di una travagliata vicenda di scavo che ne ha compromesso lo stato di conserva-zione complicandone le prospettive esegetiche.
Il monumento fu infatti recuperato spezzato in diversi frammenti i quali risultarono sparpagliati a livello più o meno del piano di campagna in cor-rispondenza nel settore sud-orientale del sepolcreto De Luca, a seguito di episodi di violazione frequentemente attestati nelle necropoli bolognesi. Noto è come addirittura uno di questi frammenti venne alla luce durante gli scavi condotti da A. Zannoni nel predio Arnoaldi, all’interno del terzo gruppo di sepolcri, ovvero quello collocato nel settore più occidentale a ridosso del rio Meloncello e dunque attiguo al terreno De Luca129.
Una disamina puntuale delle informazioni contenute principalmente nel Giornale di Scavo e nella planimetria generale del sepolcreto (Fig. 8a) aveva consentito di circoscrivere in un primo momento l’area di ritrovamento alla zona compresa tra le tombe 107 e 109, tra loro parallele e attigue al per-corso stradale extraurbano.
Di grande utilità, in questo senso, si è rivelato il recupero di materiale d’archivio del tutto inedito all’interno del Fondo Piancastelli di Forlì, tra cui vi era uno schizzo di dettaglio relativo al sepolcro n. 109 realizzato da A. Zannoni130 (Fig. 8b). Tra le varie informazioni contenute all’interno del docu-mento particolarmente importanti i riferimenti che hanno consentito di rico-struire come un numero elevato di frammenti pertinenti alla stele fu messo in luce all’interno di questa fossa sepolcrale. Tale circostanza, unitamente al quadro di estrema coerenza a cui tale attribuzione consente di approdare131, rende assolutamente lecito ipotizzare che nella stele n. 137 vada riconosciuto il segnacolo della tomba 109.
Corredo: la tomba, sotto tutti gli aspetti dai caratteri assolutamente ec-cezionali, ha restituito uno skyphos132 a f.n. vicino al pittore di Teseo133, un cratere a calice a f.r. del Pittore di Blenhaim134, un’oinochoe a f.r. del Pittore di Altamura135, una kylix a f.r. del pittore di Pentesilea136, uno skyphos a f.r.137 ed un’anforetta in ceramica grigia di produzione locale. Ricondotti alla tomba, ma non più rintracciabili, «un’anfora a figure rosse», «due tazze ver-
128 SAssAtelli 1985; ID. 1988, pp. 247-255.129 MACellAri 2002, p. 105 con riferimenti precedenti.130 BcFo, Fondo Piancastelli, Carte Romagna, Busta 519.293r.131 Si veda infra.132 Brizio 1888, c. 30, tav. I, 4; Pellegrini 1912, p. 40, n. 130, Fig. 23.133 HAsPels 1936, p. 253.15.134 Brizio 1888, c. 30; Pellegrini 1912, pp. 130-132, n. 286, Fig. 76; ArV2: 598.3;
ADD2: 265.135 Brizio 1888, c. 29; Pellegrini 1912, pp. 169-170, n. 338, Fig. 102; ArV2:
595.65; ADD2: 265.136 Brizio 1888, c. 28; Pellegrini 1912, pp. 185-186, n. 375; ARV2: 881.30.137 Brizio 1888, c. 29; Pellegrini 1912, p. 216, n. 493. Non attribuito. Si con-
fronta in maniera puntuale, per forma e iconografia, con uno skyphos conservato a Parigi e attribuito dal Beazley al Pittore del Louvre CA 1849 (ARV2: 979.5), artista già presente a Bologna con altri due esemplari rinvenuti rispettivamente nella tomba 15 De Luca e nella tomba 295 della Certosa.
estratto
268 GIULIA MORPURGO
niciate nere con piede e senza manico138», «spillone di bronzo», «sommità di candeliere in piombo», «unguentario di alabastro», «perla di vetro azzurro» ed «aes rude».
Cronologia: 460 - 450 a.C.
4. Stele figurata (Fig. 9)Ducati n. 135139. H. 1,29; largh. 0,48. Ricomposta da diversi frammenti
e leggermente scheggiata in alcuni punti. Decorata su di un lato soltanto a registro unico: personaggio maschile con copricapo e mantello, reso di profilo e gradiente verso destra; nella mano destra tiene un bastone con estremità ricurva, la sinistra è alzata in gesto di saluto. Cornice liscia.
Tomba 9.
Nell’ultima tomba, pur frugata, molti frammenti di kelebe e di altri vasetti figurati a rosso, tre dadi parallelepipedi di marmo e ciottoletti; a metri 1,20 dal fondo una grande stela figurata: il defunto che incede con bacalo nella destra.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 13 alli 18 settembre 1875).
La stele, in passato associata alla tomba 15, stando agli elementi mes-si in luce, va ricondotta al sepolcro n. 9140. Non sembrano lasciare dubbi in tal senso non solo la descrizione presente nel GdS, ma anche lo schizzo del contesto realizzato da A. Zannoni nella planimetria generale in cui risulta possibile distinguere una riproduzione schematica del segnacolo, recuperato a m 1,20 dal fondo della fossa.
Corredo: tomba già violata. Dei materiali menzionati piuttosto generi-camente nel GdS è stato possibile riconoscere esclusivamente sette pedine in calcare bianco e granito corrispondenti ai cosiddetti «ciottoletti». Associabi-li al contesto sulla base dei contrassegni cartacei ottocenteschi sono inoltre un’oinochoe attica a v.n.141, una fibula in bronzo142 ed un grosso chiodo di ferro con rivestimento e capocchia sferica in lamina di bronzo.
Cronologia: 460 - 450 a.C.
138 Brizio 1888, c. 29.139 DuCAti 1911, cc. 424-425, 484, Fig. 8; StAry-RimPAu 1988, pp. 225; SAssA-
telli 1989, p. 933-934, Tav. II b (erroneamente associata alla tomba 15); Bruni 1998, p. 73, nota 34.
140 Si veda nota 37.141 Pellegrini 1912, p. 225, n. 582. Si tratta di un’oinochoe a bocca trilobata
Beazley forma I, tipologia documentata a Bologna anche dagli esemplari Pell.580 (Cer-tosa, tomba 56 in GoVi 1999, pp. 83-84, n. 54, Tavv. VIII, XXVI) e Pell.581 (Arnoaldi, tomba 146 in GoVi 1999, p. 84, n. 55, Tavv. VIII, XXVI) entrambi inquadrabili cronolo-gicamente intorno alla metà del V secolo a.C.
142 Frammentaria ma inquadrabile nel tipo E della Terzan diffuso tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C.
estratto
269SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
5. Stele figurata (Fig. 10)Ducati n. 133143. H. 0,72; largh. max. 0,64. Ricomposta da diversi fram-
menti e lacunosa. Decorata su di un lato soltanto a registro unico: sei spirali ad onde grandi e dirette verso l’alto, tre a sinistra e tre a destra; in mezzo a queste si eleva una pianta che pare dividersi in due ramificazioni. Ognuna di queste due ramificazioni è a forma rettangolare allungata e dentro ha un ramo con foglioline fitte, opposte simmetricamente e sottili. In mezzo è inse-rita una palmetta con due coppie di foglie opposte ai lati ed una più grossa e lunga, al centro. Stretta cornice liscia.
Tomba 19.
Nell’uno, frugato, frammenti di stele e due tazzette.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 20 alli 25 settembre 1875)
Il disegno di dettaglio realizzato nella planimetria generale ha consenti-to di riconoscere quale segnacolo pertinente al sepolcro n. 19, cui lo Zannoni fa un limitatissimo cenno nel GdS, la stele n. 133 del catalogo Ducati. Tale associazione risulta confortata dal recupero, presso l’Archivio Piancastelli di Forlì, di uno schizzo, riferibile a questa tomba e contenente una fedelissi-ma riproduzione del monumento figurato144. Alcuni appunti posti a margine del disegno sempre dallo Zannoni, hanno inoltre permesso di documentare il ritrovamento nell’area della tomba di “altri frammenti [di stele] con pie-di di cavallo” che si propone di identificare con la stele n. 141 del catalogo Ducati145, l’unica tra quelle conservate appartenenti al sepolcreto De Luca, caratterizzata dalla raffigurazione, largamente frammentaria, di un cavallo.
L’attenzione particolare riservata dallo Zannoni alla stele n. 133, unita-mente al livello di conservazione, non sembra lasciare dubbi nell’identificare questo come il segnacolo della tomba 19.
É probabile invece che la stele n. 141 fungesse da segnacolo ad una delle tombe collocate nelle vicinanze del sepolcro n. 19, anche se risulta impossibile riferirla ad uno in particolare.
Corredo: già pesantemente saccheggiato al momento della scoperta, nel GdS si segnala soltanto il recupero di “due tazzette”, riconoscibili anche nella riproduzione della tomba realizzata all’interno della planimetria generale. Poiché il termine di “tazzetta” viene spesso utilizzata da Zannoni per indicare il kantharos, forma vascolare che sembra trovare anche una certa somiglian-za con quanto disegnato nello schizzo, si propone di identificare almeno uno di questi due vasi con il kantharos di tipo Saint Valentin Pell.562146, l’unico, tra quelli conservati e pertinenti al sepolcreto De Luca, privo di indicazione di provenienza. L’uso di deporre una coppia di kantharoi del tipo Saint Va-lentin è attestato all’interno del sepolcreto De Luca anche nella tomba 103,
143 DuCAti 1911, cc. 424, 517-518, Fig. 19; StAry-RimPAu 1988, p. 226.144 BcFo, Fondo Piancastelli, Carte Romagna, Busta 519.309.145 DuCAti 1911, cc. 428-429; StAry-RimPAu 1988, p. 229.146 Gruppo A della classificazione elaborata da Howard e Johnson databile al
secondo quarto del V secolo a.C. (HoWArD, Johnson 1954).
estratto
270 GIULIA MORPURGO
ricca sepoltura femminile inquadrabile cronologicamente sempre nel secondo quarto del V secolo a.C.
Grazie alla presenza del contrassegno cartaceo è inoltre riferibile a que-sto contesto un piedino di mobile in bronzo.
Cronologia: se corretta, la pertinenza del kantharos S. Valentin, consen-tirebbe di proporre una datazione del contesto al secondo quarto del V secolo a.C.
6. Stele figurata (Fig. 11)Ducati n. 143147. H. max. 50; largh. max. 33. Ricomposta da tre fram-
menti, ma largamente lacunosa.Decorata su di un lato soltanto a registro unico: grande palmetta realiz-
zata a bassissimo rilievo caratterizzata ipoteticamente da sette foglie. Stretta cornice liscia.
Tomba 71.
…nel quinto con vasi a figure rosse, tre stele ad ornato…(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dall’8 al 13 novembre 1875)
Nonostante le scarne indicazioni presenti nel GdS si propone di rico-noscere, quale segnacolo della tomba 71, la stele n. 143 del catalogo Ducati. La definizione di stele “ad ornato” viene infatti solitamente adottata dallo Zannoni per indicare la rappresentazione di una palmetta a tutto campo148, motivo decorativo piuttosto frequente nel repertorio delle stele felsinee e che risulta appunto caratterizzare il segnacolo in esame. A conforto di questa ipo-tesi si segnala inoltre come della stele n. 143 si conservino solo tre frammen-ti, circostanza che sembrerebbe poter giustificare il riferimento dello Zannoni al recupero di “tre stele ad ornato”.
Corredo: dei «vasi a figure rosse» genericamente citati nel regesto di sca-vo è stato possibile riferire al contesto, per la presenza delle relative etichette cartacee con indicazione di provenienza149, un cratere a colonnette a f.r. del Pittore di Londra E 489150 e due kylikes a f.r. attribuite dal Beazley rispetti-vamente al Pittore di Bologna 417151 ed al Pittore del Louvre G 456152.
Cronologia: 460-450 a.C.
147 DuCAti 1911, c. 429; StAry-RimPAu 1988, p. 230.148 Si veda, a titolo puramente esemplificativo, MACellAri 2002, p. 112.149 Associazione confermata anche dal Brizio e dal Pellegrini nei rispettivi ca-
taloghi (si vedano i riferimenti alle note seguenti).150 Brizio 1888, c. 19; Pellegrini 1912, pp. 82-83, n. 213; ARV2: 546.6.151 Brizio 1888, c. 18; Pellegrini 1912, p. 189, n. 388; ARV2: 910.58.152 Brizio 1888, c. 18; Pellegrini 1912, p. 197, n. 411; ARV2: 825.18.
estratto
271SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
7. Stele aniconica (Fig. 12)Ducati n. 154153. H. max. 0,47; largh. max. 0,36. Frammentaria nella
porzione inferiore. Forma a ferro di cavallo, priva di alcuna decorazione.Tomba 49.
Erano nella 2a tomba due stele, una liscia altra con ornato e pochi frammenti di vasi figurati a rosso e verniciati.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 18 alli 23 ottobre 1875)
Come descritto nel GdS i monumenti funerari recuperati durante lo sca-vo della tomba 49 furono due, uno “liscio” ed altro “con ornato”. Lo schizzo realizzato da Zannoni nella planimetria generale consente di identificarli ri-spettivamente con le stele n. 154 e n. 134 del catalogo Ducati. Inoltre, alcune notazioni di tipo stratigrafico poste a margine del disegno suggeriscono di riconoscere quale originario segnacolo di questo sepolcro la stele n. 154. Men-tre infatti questa fu recuperata a m 0,30 dal fondo della fossa, l’altra giaceva sul piano di campagna dell’epoca ed è quindi probabile che quello non fosse il suo contesto di giacitura primaria.
Corredo: lo scarno resoconto di scavo menziona il ritrovamento di vasi a figure rosse e a v.n. I Cataloghi del Brizio154 e del Pellegrini155, confermati dal contrassegno cartaceo, associano a questo sepolcro una pelike a f.r. del Pittore di Amphitrite156. Sempre sulla base delle indicazioni riportate sulle etichette ottocentesche è stato possibile ricondurre alla tomba anche 3 piedini ed alcu-ne fibule in bronzo, un frammento di conocchia e dei chiodini.
Cronologia: secondo quarto del V secolo a.C.
8. Stele aniconica (Fig. 13)Ducati n. 153157. H. max. 72; largh. max. 58. Integra, leggermente scheg-
giata. Forma a ferro di cavallo poco rastremata verso il fondo. Spessore carat-terizzato da fitte incisioni lineari e parallele.
Priva di decorazione su entrambi i lati.Tomba 51.Sulla base del disegno realizzato nella planimetria generale si propone
di riferire a tale contesto la stele n. 153 del catalogo Ducati. Si tratta infatti dell’unica stele, tra quelle aniconiche, che presenta ancora il caratteristico zoccolo parallelepipedo così come lo schizzo dello Zannoni sembra mettere in evidenza. Che si tratti di una stele liscia, priva cioè di alcun elemento decorativo, lo inducono a sostenere non solo le caratteristiche dello schizzo di dettaglio, ma anche l’assenza di qualsiasi riferimento in merito ad un even-tuale raffigurazione.
153 DuCAti 1911, cc. 430, 496, fig. 12.154 Brizio 1888, c. 16.155 Pellegrini 1912, p. 56, Fig. 34, n. 166.156 ARV2: 833.44.157 DuCAti 1911, c. 430.
estratto
272 GIULIA MORPURGO
Corredo: riconducibili al corredo, per la presenza dei contrassegni carta-cei e per le indicazioni riportate nei cataloghi del Brizio e del Pellegrini, un cup-skyphos a f.n. del Lancut Group158 ed uno stamnos a f.r. del Pittore di Agrigento159.
Cronologia: secondo quarto del V secolo a.C.
9. Stele aniconica (Fig. 14)Ducati n. 150160. H. max. 69,5; largh. max. 32; largh. min. 41. Integra. Priva di decorazione, ma, su di un lato larga cornice leggermente rileva-
ta. Spessore caratterizzato da fitte incisioni lineari e parallele.Tomba 13.
Soprastava al quarto una stele liscia ed al piè di essa quasi tutta una kelebe a figure rosse: sul fondo avanzi di uno scheletro, quattro balsamari, tre d’alabastro, altro di vetro smaltato ed un elegantissimo piatto a doppio ordine di figure nere in campo rosso.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 13 alli 18 settembre 1875)
Si propone, in via ipotetica, di identificare, quale segnacolo della tomba 13, la stele n. 150 del catalogo Ducati. Sebbene infatti lo schizzo presente nella planimetria sembri in parte allontanarsi dalle caratteristiche genera-li del monumento, non si può non rilevare la perfetta corrispondenza tra il disegno dello Zannoni, in cui sembra volersi mettere in risalto anche lo spes-sore della stele, e l’incisione che separa la cornice esterna del segnacolo dallo specchio interno privo di alcuna decorazione. Si tratta inoltre dell’unica stele aniconica tra quelle non già riferite ad altri contesti, ad essere conservata integralmente.
Corredo: dei materiali elencati dallo Zannoni si sono potuti riconoscere un piatto attico a f.n. del Pittore di Haimon161 ed un cratere a colonnette a f.r. del Pittore di Alkimachos162; associabili inoltre al contesto per la presenza del relativo contrassegno cartaceo una cimasa di candelabro configurata a galletto, frammenti di conocchia e dei piedini di mobile in bronzo riconoscibili anche nello schizzo della tomba.
Cronologia: secondo quarto del V secolo a.C.
10. Stele figurata (Fig. 15)Ducati n. 138163. H. 1,70; largh. 1,70. Ricomposta da diversi frammenti
e ampiamente lacunosa.
158 Brizio 1888, c. 16; Pellegrini 1912, pp. 41-42, n. 137; ARV2: 576.4.159 Brizio 1888, c. 17; Pellegrini 1912, p. 63, n. 177; ARV2: 577.53, 1659.160 DuCAti 1911, c. 430.161 ZAnnoni 1876, p. 43; ZAnnoni 1876-1884, p. 36; Brizio 1888, cc. 37-38, lette-
ra E; Pellegrini 1912, p. 43, Fig. 24, n. 149; HAsPels 1936, p. 245, n. 84.162 Brizio 1888, c. 4; Pellegrini 1912, p. 93, n. 236; ADD2: 254.163 DuCAti 1911, cc. 427-428; 537-538; 693, Fig. 84.
estratto
273SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Decorata su di un lato soltanto su tre registri: La figurazione è delimi-tata da una cornice con spirali ad onda dirette verso l’alto e una palmetta in cima. Il campo è suddiviso in tre registri. In alto, due sfingi affrontate164. Al centro, viaggio del defunto su triga. Il registro inferiore presenta due cava-lieri diretti verso destra, nello stesso senso del carro, che impugnano con la mano destra un pungolo; in corrispondenza delle spalle, in un punto della stele in cui lo stato di conservazione del monumento non consente una lettura chiara, si riconosce un attributo, dal quale dipende l’esegesi degli studiosi che si sono occupati dell’immagine. Ducati, interpretando questo elemento come delle ali, ha individuato nella scena una corsa di cavalieri che procedono su cavalli alati. G. Sassatelli165, seguito in tale lettura da G. Colonna166, pensa piuttosto che ad essere alati siano i due cavalieri che dunque, in qualità di divinità psicopompe, andrebbero identificati nei Dioscuri. Di diversa opinio-ne R. Bonaudo167 la quale identificando l’attributo presente sulle spalle dei cavalieri non come ali, ma come i lembi di un mantello svolazzante inteso ad esprimere la velocità della corsa, propone di riconoscervi la raffigurazione di un’apobasis.
Tomba 100.All’identificazione del segnacolo n. 138 era già approdato G. Sassatelli
valorizzando il riferimento dello Zannoni al recupero di una “grande stela figurata” e procedendo per esclusione all’interno del gruppo di segnacoli ri-feriti al sepolcreto De Luca, ipotesi convalidata anche dalle ricostruzioni più recenti.
Diede l’altro sepolcro un ampio cratere a doppio ordine di rappresentazioni di figure rosse, simili altri vasetti minori, un aryballo di bronzo, due fibule in bronzo con tracce di copertura in foglio d’oro; una grande stela figurata.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dal 20 al 24 dicembre 1875)
Corredo: la ricostruzione presenta qualche problema dal momento che, come di consueto, l’elenco dei materiali fornito dal GdS è troppo generico per consentire l’individuazione di tutti gli oggetti. Nell’inventario del Museo, ad esempio, le fibule sono attribuite alla tomba 101, ma vanno sicuramente as-sociate alla tomba che conteneva il cratere. Sono inoltre attribuiti alla stessa tomba, ma su questo resta un margine di incertezza, alcuni vasi a vernice nera oggi non più rintracciabili168, ma che potrebbero identificarsi con i “va-setti minori” di cui parla Zannoni nel resoconto di scavo; la loro identifica-
164 La presenza delle sfingi n posizione araldica, secondo Morigi GoVi 1970, rivelerebbe l’attaccamento ad un motivo orientalizzante, pur essendo il monumento collocabile stilisticamente in piena età classica.
165 SAssAtelli 1993, pp. 49-51, Fig. 1.166 ColonnA 1996, p. 180.167 BonAuDo 2002-2003.168 Si tratterebbe nello specifico di una kylix e di due coppette edite in Pelle-
grini 1912, p. 227, n. 659 e p. 229, nn. 742-743. Per quanto riguarda nello specifico questi ultimi due esemplari, i dati tecnici e la descrizione fornita dal Pellegrini, consen-tirebbero di proporre un’identificazione con il tipo “Shallow wall and convex-concave profile”, ciotola che dovette godere di grande popolarità negli empori dell’alto medi e
estratto
274 GIULIA MORPURGO
zione non è però del tutto sicura e sarebbe comunque poco rilevante per la datazione della tomba la cui cronologia ci è data dal cratere a calice attico a f.r. ricondotto dal Beazley all’opera del Pittore della Phiale169.
Cronologia: 450-440 a.C.
11. Stele figurata (Fig. 16)Ducati n. 130170. H. max. 0,94; largh. 0,80. Ricomposta e con qualche
piccola lacuna.Decorata su entrambi i lati. Lato A: campo figurato diviso in due registri
da un cordone liscio a rilievo e di forma irregolare che non congiunge com-pletamente le due parti. Nel registro inferiore sono due piccole foglie d’edera su steli ricurvi. In quello superiore, a destra vi è una figura di guerriero, con elmo crestato il quale, diretto verso sinistra, ha nella mano destra un piccolo scudo, e nell’altra, ripiegata, una corta spada. Contro di lui si erige a sinistra una figura mostruosa, umana nella testa e nel torso e con lunga coda intrec-ciata e distesa171. Cornice con motivo delle onde correnti terminanti in cima con una palmetta.
Lato B: a tutto campo è rappresentato, col corpo di prospetto, un cava-liere imberbe diretto verso sinistra. Il braccio destro è alzato all’indietro, il sinistro curvo sulla cervice equina. Sottile cornice liscia.
Tomba 50.
L’ultimo dei sepolcri serbava lo scheletro appiedi del quale uno specchio di bronzo, a sinistra un cratere a figure rosse, al cranio due grandi orecchini d’oro. A meso della trincea stava una grande stela figurata a ciascuna faccia: nell’una un cavaliere, nell’al-tra un fante combattente con un mostro.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 18 alli 23 ottobre 1875)
Le indicazioni recuperate nel Giornale di Scavo e nella planimetria ge-nerale consento di avanzare questa ipotesi ricostruttiva, tuttavia non senza qualche margine di incertezza dato dal fatto che il monumento non fu recu-perato esattamente in corrispondenza del sepolcro n. 50, ma nell’area imme-diatamente a nord172.
medio Adriatico e che a Bologna risulta già attestata in una tomba del sepolcreto Arno-aldi databile nella seconda metà del V secolo a.C. (GoVi 1999, pp. 142-143).
169 Brizio 1888, c. 25; Pellegrini 1912, p. 139, n. 298, fig. 80. Per l’attribuzione ARV2: 1018.62.
170 Dennis 1883, p. 532; ZAnnoni 1876-1884, p. 298, Tav. CXV, 2 (lato A); MAr-thA 1889, p. 373; DuCAti 1911, c. 423, 575, Fig. 42, Tav. III; MAnsuelli 1956-57, p. 15, Fig. 10; BolognA 1960, p. 210, Tav. 25; StAry-RimPAu 1988, p. 225; CerChiAi 1999, p. 361; BonAmiCi 2006, p. 531, nota 70; SAssAtelli - GoVi 2009, p. 85, Tav. XVIIIc; SAC-Chetti 2011, pp. 267-268.
171 Per l’esegesi della scena si vedano i riferimenti alla nota 51.172 Per una rassegna degli elementi che tuttavia sembrano poter confortare tale
proposta si rimanda alle riflessioni contenute nel testo.
estratto
275SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Corredo: cratere a campana attico a f.r.173, kantharos tipo S. Valentin, coppetta attica a v.n., “orecchini d’oro”, specchio di bronzo, fibula tipo Cer-tosa, alabastron in alabastro, frammenti pertinenti ad una o più conocchie.
Cronologia: terzo quarto del V secolo a.C. (440-430 a.C.)
12. Stele figurata (Fig. 17)Ducati n. 139174. Ricomposta da alcuni frammenti e con ampie lacune
nel campo figurato; superficie piuttosto corrosa.Decorata su di un lato soltanto a registro unico: risultano ancora leggi-
bili le gambe nude di un personaggio maschile gradiente verso destra; supe-riormente si intravede lo scudo circolare in cui è infilato il braccio sinistro. Cornice liscia.
Tomba 1.
Soprastava al primo sepolcro una stela: nell’una faccia un guerriero che imbraccia con la sinistra lo scudo e tiene la destra nell’elsa del gladio. Collo scheletro, sconvolto però, un vasetto figurato ed altro bruno.(AMCB, Carte Zannoni, Scavi De Luca, GdS, Settimana dalli 30 agosto alli 4 settembre 1875)
La descrizione fornita da Zannoni nel GdS consente di identificare nella stele n. 139 il segnacolo di questo sepolcro. Nonostante le ampie lacune ed il precario stato di conservazione del campo figurato, risulta infatti ancora pos-sibile scorgervi le tracce della porzione inferiore di una figura chiaramente maschile e dello scudo che questa impugnava con il braccio sinistro alzato, elementi che coincidono perfettamente con quanto riferito dallo Zannoni.
Corredo: del corredo, già parzialmente violato, si conserva solamente un kantharos attico a f.r.175, associato a questo sepolcro sia da E. Brizio176 che G. Pellegrini177 ed ancora provvisto del contrassegno cartaceo ottocentesco con la relativa indicazione di provenienza. Corrisponde molto probabilmen-te al “vasetto figurato” citato nel Giornale di Scavo. Non più rintracciabile risulta invece il “vasetto bruno”, definizione con cui lo Zannoni è solito fare riferimento all’anforetta in ceramica grigia di produzione locale.
Cronologia: terzo quarto del V secolo a.C.
173 Pittore del gruppo di Polignoto (ARV2: 1055.62).174 DuCAti 1911, c. 428.175 Non attribuito. Per l’inquadramento cronologico si rimanda ad un gruppo
di kantharoi attici a f.r. riconducibili alla cerchia del Washing Painter molto simili al nostro per morfologia ed apparato decorativo. In particolare si confronti il kantharos di Monaco n. 215087 attribuito dal Beazley (ARV2: 1338.50) al Pittore di Hasselmann, artista già presente in Etruria padana ed in particolare a Spina con diversi esemplari.
176 Brizio 1888, c. 2. 177 Pellegrini 1912, p. 222, n. 565, Fig. 138.
estratto
276 GIULIA MORPURGO
REFERENZE BIBLIOGRAFICHE
ADD2 = CArPenter 1989ArV = beAzley 1942ArV2 = beAzley 1963beAzley 1942 = J.D. BeAzley, Attic red-figure vase-painters, Oxford.beAzley 1963 = J.D. BeAzley, Attic red-figure vase-painters, Oxford.BérArD 1974 = C. BerArD, Anodoi: essai sur l’imagerie des passages ch-
thoniens, Rome.BérArD 1986 = C. BerArD, La condizione delle donne. Dal matrimonio
ai funerali, in La città delle immagini. Religione e società nella Grecia antica (Catalogo della Mostra, Salerno 1984), Losanne, pp. 79-95.
BoArDmAn 1979 = J. BoArDmAn, The Athenian Pottery Trade. The Clas-sical period, in Expedition XXI, 4, pp. 33-39.
BolognA 1960 = Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina, Bo-logna.
BolognA 1984 = Dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della Mostra, Bologna 1984-1985), Bologna.
bonAmiCi 2005 = M. BonAmiCi, Scene di viaggio all’aldilà nella ceramo-grafia chiusina, in Pittura parietale, pittura vascolare: ricerche in corso tra Etruria e Campania (Atti della Giornata di studio, Santa Maria Capua Vete-re 2003), Napoli, pp. 33-44.
bonAmiCi 2006 = M. BonAmiCi, Dalla alla vita alla morte tra Vanth e Turms Aitas, in Aei mnestos. Miscellanea di Studi per Mauro Cristofani, Fi-renze, pp. 522-538.
bonAuDo 2002-2003 = R. BonAuDo, Trasmissioni iconografiche e costru-zioni immaginarie. Riformulazione di modelli attici su alcune stele felsinee, in AnnAStorAnt 9-10, pp. 103-113.
Bottini 1992 = A. Bottini, L’archeologia della salvezza, Milano.brizio 1885 = E. Brizio, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Pa-
tria per le Province di Romagna, ser. 3, III, (1885), pp. 184, 194, 199 (stele 134, stele 135), 201 (stele 138), 204 (stele 138), 205, 207 (stele 132), 210.
brizio 1888 = E. Brizio, Vasi greci dipinti dal Museo Civico di Bologna (Raccolta De Luca), in Museo Italiano di Antichità Classica II, cc. 2-40.
brizio 1890 = E. Brizio, Bologna. Nuove scoperte nella necropoli felsinea, 2°. Sepolcri etruschi nel Giardino Margherita, in NSc, pp. 89-106.
BroWn 1960 = W.L. BroWn, The Etruscan lion, Oxford.Bruni 1998 = S. Bruni, Una “pietra scema”. Contributo allo studio della
statuaria etrusca di età arcaica dell’Etruria settentrionale, in In memoria di Enrico Paribeni, I, Roma, pp. 67-82.
CAPPellini 1877 = G. CAPPellini, L’ivoire, les coquilles et autres maté-riaux utilisés par les anciens habitants de Felsina, in AttiConv Congrès inter-national d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques, Budapest.
CArPenter 1989 = T.H. CArPenter, Beazley Addenda. Additional refe-rences to ABV, ARV2 and Paralipomena, Oxford.
CerChiAi 1999 = L. CerChiAi, La rappresentazione di Teseo sulle stele felsinee, in F.-H. MAssA PAirAult (a cura di), Le mythe grec dans l’Italie antique. Function et image (Atti del Colloquio, Roma 1996), Roma, pp. 353-365.
ColonnA 1996 = G. ColonnA, Il dokanon, il culto dei Dioscuri e gli aspet-ti ellenizzanti della religione dei morti nell’Etruria tardo-arcaica, in Scritti di antichità in memoria di Sandro Stucchi, Studi miscellanei 29, pp. 165-184.
estratto
277SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
ColonnA 1999 = G. ColonnA, Epigrafi etrusche e latine, in Atti dell’XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma, 18-24 settembre 1997, Roma, pp. 435-447.
Dennis 1883 = G. Dennis, The cities and cemeteries of Etruria, London.DuCAti 1911 = P. DuCAti, Le pietre funerarie felsinee, in MonAnt XX, cc.
357-728.DuCAti 1943 = P. DuCAti, Nuove stele funerarie felsinee, MonAnt XXXIX,
cc. 373-446.GoVi 1998a = E. GoVi, Il sepolcreto etrusco della Certosa di Bologna:
rituale funerario e articolazione sociale, Dottorato di ricerca in Archeologia: città e produzione artistica (mondo greco, etrusco-italico, romano), Ciclo X, Università degli Studi di Padova.
goVi 1998b = e. GoVi, Il sepolcreto etrusco della Certosa, in La Certosa di Bologna. Immortalità della memoria, Bologna, pp. 82-89.
GoVi 1999 = E. GoVi, Le ceramiche attiche a vernice nera di Bologna, Bologna-Imola.
GoVi 2005 = E. GoVi, Le necropoli, in Storia di Bologna 1. Bologna nell’antichità, Bologna, pp. 264-281.
GoVi 2009a = E. GoVi, L’archeologia della morte a Bologna. Spunti di riflessione e prospettive di ricerca, in Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia. In-dagini sulle necropoli (Atti dell’Incontro di Studio, Fisciano 2009), Paestum, pp. 21-35.
goVi 2009b = E. GoVi, Aspetti oscuri del rituale funerario nelle stele fel-sinee, in S. Bruni (a cura di), Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale, Pisa-Roma, pp. 833-840.
GoVi 2010 = E. GoVi, Le stele di Bologna di V secolo: modelli iconografici tra Grecia ed Etruria, in Meetings between Cultures in the Ancient Mediter-ranean (XVII International Congress of Classical Archaeology, Rome 2008), Bollettino di Archeologia on line, Volume speciale, Roma.
goVi 2011 = E. GoVi, Rinascere dopo la morte. Una scena enigmatica sul-la stele n. 2 del sepolcreto Tamburini di Bologna, in Tra Protostoria e Storia. Studi in onore di Loredana Capuis, Roma, pp. 195-207.
goVi - sAssAtelli 2004 = E. GoVi - G. SAssAtelli, Ceramica attica e stele felsinee, in I Greci in Adriatico, 2 (Hesperìa 18), pp. 227-265.
GozzADini 1876 = G. GozzADini, Bologna, in NSc, p. 8.guiDi 2005a = F. GuiDi, Il sepolcreto etrusco dei Giardini Margherita,
Dottorato di ricerca in Archeologia, Ciclo XVII, Università degli Studi di Pa-dova.
guiDi 2005b = F. GuiDi, 1876-1986. Un secolo di archeologia bolognese. La necropoli etrusca dei Giardini Margherita: un primo bilancio critico, in Il Carrobbio: rivista di studi bolognesi XXXI, pp. 259-280.
HAsPels 1936 = C.H.E. HAsPels, Attic black-figured lekythoi, Paris.HoWArD, Johnson 1954 = S. HoWArD - E.P. Jhonson, The S. Valentin
class, in AJA 58, pp. 191-207.Hus 1961 = A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque ar-
chaïque, Paris.LIMC = Lexicon Iconographicum Mitologiae Classicae.LissArrAgue 1990 = F. LissArrAgue, Uno sguardo ateniese, in Storia
delle donne in Occidente. L’antichità, Bari, pp. 179-240.mACellAri 2002 = R. MACellAri, Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoal-
di di Bologna, 550-350 a.C., Bologna.
estratto
278 GIULIA MORPURGO
MAnsuelli 1956-57 = G.A. MAnsuelli, Una stele felsinea di tradizione villanoviana, in RIASA V-VI, pp. 5-28.
MArtelli 1985 = M. MArtelli, I luoghi e i prodotti dello scambio, in Civiltà degli Etruschi (Catalogo della Mostra, Firenze 1985), Milano, pp. 175-181.
MArthA 1889 = J. MArthA, L’art etrusque, Paris.MAsArACChiA 1993 = A. MAsArACChiA, Orfeo e gli ‘orfici’ in Platone, in
Orfeo e l’Orfismo (Atti del Seminario Internazionale, Roma-Perugia 1985-1991), Roma, pp. 173-197.
Metzger 1965 = H. Metzger, Recherches sur l’imagerie athénienne, Paris.
Minto 1919 = A. Minto, Corteo nuziale in un frammento di tazza attica, in Ausonia 9, pp. 65-75.
Morigi GoVi 1970 = C. Morigi GoVi, Persistenze orientalizzanti nelle ste-le felsinee, in StEtr XXXVIII, pp. 67-89.
Morigi GoVi - SAssAtelli 1993 = C. Morigi GoVi - G. SAssAtelli, Il se-polcreto etrusco del Polisportivo di Bologna: nuove stele funerarie, in Ocnus I, pp. 103-124.
morPurgo c.s. = G. MorPurgo, Circe e i porci su un cratere a calice dalla tomba 100 del sepolcreto etrusco De Luca di Bologna, in Hesperìa. Studi sulla grecità d’occidente, c.s.
oAkley 2008 = J.H. OAkley, Women in Athenian ritual and funerary art, in Worshipping women. Ritual and reality in classical Athens, New York, pp. 335-341.
ortAlli 2002 = J. OrtAlli, La rivoluzione felsinea. Nuove prospettive dagli scavi di Casalecchio di Reno, in Padusa 38, pp. 57-90.
Pellegrini 1912 = G. Pellegrini, Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, Bologna.
PizzirAni 2008 = C. PizzirAni, Il dionisismo in Etruria padana, Dotto-rato di Ricerca in Scienze Archeologiche, Ciclo XX, Università degli Studi di Padova.
PizzirAni 2009a = C. PizzirAni, Il sepolcreto etrusco della Galassina di Castelvetro (Modena), Bologna.
PizzirAni 2009b = C. PizzirAni, Iconografia dionisiaca e contesti tombali tra Felsina e Spina, in AttiConv Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia. Indagini sulle necropoli (Fisciano 2009), Paestum, pp. 37-49.
PizzirAni 2010a = C. PizzirAni, Identità iconografiche tra Dioniso e Ade in Etruria, in Hesperìa, 26. Studi sulla grecità di Occidente, Roma, pp. 47-69.
PizzirAni 2010b = C. PizzirAni, Cerimonie religiose attiche ed Etruschi di area padana, in Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean (XVII International Congress of Classical Archaeology, Rome 2008), Bolletti-no di Archeologia on line, Volume speciale.
PizzirAni 2011 = C. PizzirAni, Un mystes dionisiaco nel sepolcreto felsi-neo Tamburini, in Tra protostoria e storia. Studi in onore di Loredana Ca-puis, Padova.
Rhem 1994 = R. Rehm, Marriage to Death: The Conflation of Wedding and Funeral Rituals in Greek Tragedy, Princeton.
Rix 1981-82 = H. rix, Una nuova ricostruzione della stele Ducati 137 e la questione di magistrati etruschi a Felsina-Bologna, in Emilia preromana, 9-10, 1981-1982, pp. 281-286.
sACChetti 2011 = F. SACChetti, Charu(n) et “les autres”: le cas des stèles étrusques de Bologne, in RA 2, pp. 263-308.
estratto
279SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
SAssAtelli 1983 = G. SAssAtelli, Le stele felsinee con celtomachie, in Popoli e facies culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi dal V al I secolo a.C. (Atti del Colloquio Internazionale, Milano 1980), Milano, pp. 167-178.
SAssAtelli 1984 = G. SAssAtelli, Una nuova stele felsinea, in Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Rimini, pp. 107-137.
SAssAtelli 1985 = G. SAssAtelli, Stele funeraria, in Civiltà degli Etru-schi (Catalogo della Mostra, Firenze 1985), Milano, pp. 254-255.
SAssAtelli 1988 = G. SAssAtelli, Topografia e “sistemazione monumen-tale” delle necropoli felsinee, in La formazione della città preromana in Emi-lia Romagna (Atti del Convegno, Bologna 1985), Bologna, pp. 197-259.
SAssAtelli 1989a = G. SAssAtelli, Ancora sui rapporti tra Etruria Pada-na e Italia settentrionale: qualche esemplificazione, in Gli Etruschi a nord del Po (Atti del Convegno, Mantova 1986), Mantova, pp. 49-81.
SAssAtelli 1989b = G. SAssAtelli, Problemi cronologici delle stele felsi-nee alla luce dei rispettivi corredi tombali, in Secondo Congresso Internazio-nale Etrusco (Atti del Convegno, Firenze 1985), Roma, pp. 927-949.
SAssAtelli 1993 = G. SAssAtelli, Rappresentazioni di giochi atletici in monumenti funerari di area padana, in Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusquo-italique (Actes de la table ronde, Rome 1991), Rome, pp. 45-67.
SAssAtelli 1999 = G. SAssAtelli, Discussione, in Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image (Actes du Colloque Internationale organisé par l’Ecole Française de Rome, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Na-poli, UMR 126 du CNRS, Roma 1996), Roma, pp. 371-378.
sAssAtelli 2009 = G. SAssAtelli, Riflessioni sulla “stele della nave” di Bologna, in Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale, Pisa-Roma, pp. 833-840.
sAssAtelli - goVi 2009 = G. SAssAtelli - E. GoVi, Ideologia funeraria e celebrazione del defunto nelle stele etrusche di Bologna, in StEtr LXXIII, pp. 67-92.
SPArkes, TAlCott 1970 = B.A. Sparkes - L. Talcott, Black and plain pottery of thr 6th, 5th and 4th centuries B.C., The Athenian Agora XII, 1-2, Princeton.
StAry-RimPAu 1988 = J.S. StAry-RimPAu, Die Bologneser Stelen des 7. bis 4. Jh. v.Chr., Marburg.
sourVinou-InWooD 1978 = C. sourVinou-InWooD, Persephone and Aphrodite at Locri: a model for personality definitions in Greek Religion, in JHS 8, pp. 101-121.
zAnnoni 1876 = A. ZAnnoni, Scoperte archeologiche di Felsina, in BdI, pp. 42-44.
zAnnoni 1876-1884 = A. ZAnnoni, Gli scavi della Certosa, Bologna.
estratto
280 GIULIA MORPURGO
Fig. 1 - Pianta della Bologna di fase Certosa con dettaglio dei nuclei funerari messi in luce nel settore occidentale.
Fig. 2 - Planime-tria schematica del se polcreto De Luca. In eviden-za le tombe a cui è stato possibile ricondurre l’ori-ginario segnacolo di pertinenza in-dicato con il nu-mero del catalogo Ducati (in grigio le sepolture data-bili; a righe quelle non databili).
estratto
281SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Fig. 3 - Stele n. 188 (a) e n. 91 (b).
Fig. 4 - Stele n. 187.
estratto
282 GIULIA MORPURGO
Fig. 5 - Cratere attico a f.r. dalla tomba 13 del sepolcreto De Luca (Museo Civico Archeologico di Bologna).
Fig. 6 - Leone n. 128 e schizzo di dettaglio della tomba n. 101 De Luca.
estratto
283SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Fig. 7 - Stele n. 132.
Fig. 8 - Stele n. 137 e schizzi di dettaglio relativi alla tomba 109 De Luca.
estratto
284 GIULIA MORPURGO
Fig. 9 - Stele n. 135 e schizzo di dettaglio re-lativo alla tomba 9 De Luca.
Fig. 10 - Stele n. 133 e schizzo di dettaglio relativo alla tomba 19 De Luca.
estratto
285SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Fig. 11 - Stele n. 143 e schizzo di dettaglio relativo alla tomba 71 De Luca.
Fig. 12 - Stele n. 154 e schizzo di dettaglio relativo alla tomba 49 De Luca.
Fig. 13 - Stele n. 153 e schizzo di dettaglio relativo alla tomba 51 De Luca.
Fig. 14 - Stele n. 150 e schizzo di det-taglio relativo alla tomba 13 De Luca.
estratto
286 GIULIA MORPURGO
Fig. 15 - Stele n. 138. Fig. 17 - Stele n. 139.
Fig. 16 - Stele n. 130 e schizzo di dettaglio relativo alla tomba 50 De Luca.
estratto
287SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Fig. 18 - Tabella con elenco dei segnacoli databili sulla base del relativo con-testo di pertinenza.
Tipologia CatalogoDucati
Provenienza Cronologia
Cippo sferico 5 Giardini Margherita - 1876, “Tomba dello Sgabello”
Fine del VI sec. a.C.
Cippo sferico 101 Arnoaldi, tomba 80 Fine del VI sec. a.C.Cippo sferico 102 Arnoaldi, tomba 79 Fine del VI sec. a.C.Cippo sferico NC Giardini Margherita -
1889, tomba 9Fine del VI sec. a.C.
Cippo sferico NC Giardini Margherita - 1889, tomba 17
Fine del VI - inizi del V sec. a.C.
Stele figurata 187 Certosa, tomba 319-320 510-480 a.C.Cippo sferico *72 Arnoaldi, tomba 98 Entro il primo quarto del
V sec. a.C.Cippo sferico 157 Certosa, tomba 6 480-460 a.C.Stele figurata 132 De Luca, tomba 57 480-460 a.C.Stele figurata NC Casalecchio di Reno,
tomba 26480-460 a.C.
Cippo sferico 193 Certosa, tomba 415 480-450 a.C.Stele figurata 181 Certosa, tomba 215 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele figurata *133 De Luca, tomba 19 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele aniconica *150 De Luca, tomba 13 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele aniconica *153 De Luca, tomba 51 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele aniconica *154 De Luca, tomba 49 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele aniconica 166 Certosa, tomba 53 Secondo quarto del V
sec. a.C.Stele aniconica 167 Certosa, tomba 73 Secondo quarto del V
sec. a.C.Scultura *128 De Luca, tomba 101 Attorno al 470 a.C.Stele figurata *135 De Luca, tomba 9 460-450 a.C.Stele figurata *137 De Luca, tomba 109 460-450 a.C.Stele figurata *143 De Luca, tomba 71 460-450 a.C.Stele figurata 183 Certosa, tomba 253 460-450 a.C.Stele figurata NC Via Saffi, tomba 11 460-450 a.C.Stele figurata 62 Arnoaldi, tomba 133 Attorno alla metà del V
sec. a.C.Stele figurata 104 Arnoaldi, tomba 76 Attorno alla metà del V
sec. a.C.Cippo sferico 6 Giardini Margherita -
1876, “Tomba Grande”Attorno alla metà del V sec. a.C.
estratto
288 GIULIA MORPURGO
Tipologia CatalogoDucati
Provenienza Cronologia
Stele figurata *159 Cerosa, tomba 16 Attorno alla metà del V sec. a.C.
Stele figurata 182 Certosa, tomba 218 Attorno alla metà del V sec. a.C.
Stele figurata *46 Arnoaldi, tomba 118 Attorno alla metà del V sec. a.C.
Stele figurata *71 Arnoaldi, tomba 144 Attorno alla metà del V sec. a.C.
Stele aniconica 171 Certosa, tomba 149 Prima metà del V sec. a.C.
Stele figurata 163 Certosa, tomba 32 Prima metà del V sec. a.C.
Stele aniconica NC Galassina, tomba 15 Prima metà del V sec. a.C.
Stele figurata *161 Certosa, tomba 21 Prima metà del V sec. a.C.
Stele figurata *69 Arnoaldi, tomba 149 Decenni centrali del V sec. a.C.
Stele aniconica 60 Arnoaldi, tomba 130 Secondo o, meno proba-bilmente, terzo quarto del V sec. a.C.
Cippo sferico 165 Certosa, tomba 43 o, meno probabilmente, 33
Tomba 43: 450-440 a.C. Tomba 33: prima metà del V sec. a.C.
Stele figurata *168 Certosa, tomba 89 Seconda metà del V sec. a.C.
Stele aniconica 103 Arnoaldi, tomba 88 Poco dopo la metà del V sec. a.C.
Stele figurata 138 De Luca, tomba 100 450-440 a.C.Stele figurata 156 Battistini, tomba IV 450-440 a.C.Stele figurata *42 Arnoaldi, tomba 114 Terzo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata *63 Arnoaldi, tomba 146 Terzo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata *91 Arnoaldi, tomba 110 Terzo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata 200 Tomba di Via dei Mille Terzo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata *61 Arnoaldi, tomba 151 o
152Poco dopo la metà del V sec. a.C. (151) o inizi del quarto venticinquennio del V sec. a.C. (152)
Stele figurata *68 Arnoaldi, tomba 151 o 152
Poco dopo la metà del V sec. a.C. (151) o inizi del quarto venticinquennio del V sec. a.C. (152)
Stele figurata *130 De Luca, tomba 50 440-430 a.C.
estratto
289SULLA CRONOLOGIA DELLE STELE FELSINEE
Tipologia CatalogoDucati
Provenienza Cronologia
Stele figurata *139 De Luca, tomba 1 Terzo quarto del V sec. a.C.
Stele figurata 3 Tamburini, tomba 4 440-420 a.C.Stele figurata 164 Certosa, tomba 37 440-420 a.C.Stele figurata *53 Arnoaldi, tomba 121 Attorno al 420 a.C.Stele figurata *113 Arnoaldi, tomba 6 Entro l’ultimo quarto del
V sec. a.C.Stele figurata 89 Battistini, tomba VI Ultimi decenni del V sec.
a.C.Stele figurata 158 Certosa, tomba 14 Ultimo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata 188 Certosa, tomba 338 Ultimo quarto del V sec.
a.C.Stele figurata 17 Giardini Margherita -
1876, tomba 64Fine del V secolo a.C.
Stele figurata 64 Arnoaldi, tomba 137 Attorno al 400 a.C. o su-bito dopo
Stele figurata *114 Arnoaldi, tomba 145 Primo decennio del IV sec. a.C.
Stele figurata *85 Arnoaldi, tomba 116 Inizi del IV sec. a.C.Stele figurata 43 Arnoaldi, tomba 125 Inizi del IV secolo a.C.
* Nuove associazioni rispetto a SAssAtelli 1989; NC: non classificato nei ca-taloghi del Ducati.
estratto