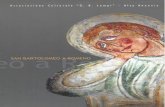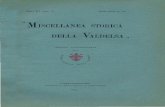IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
«Allontanarsi dall'antico». Novità e cambiamento nell'antica Roma («Storica» 12, 2006)
Transcript of «Allontanarsi dall'antico». Novità e cambiamento nell'antica Roma («Storica» 12, 2006)
«Allontanarsi dall’antico».Novità e cambiamento nell’antica Roma
di Elisa Romano
1. «Quanto è antico il nuovo?»
Nel 192 a.C. furono istituiti a Roma i Ludi Megalenses,spettacoli teatrali in onore della Magna Mater, divinitàorientale il cui culto era stato accolto da pochi anni; per laprima volta in questa occasione, per decisione degli organiz-zatori, ai senatori furono riservati posti separati rispetto alresto del pubblico. L’innovazione, come apprendiamo dalresoconto di Livio1, suscitò molte polemiche, «come succedeper tutte le novità» (sicut omnis novitas solet): la nuova rego-la, che modificava all’improvviso e senza motivo una con-suetudine lunga più di cinquecento anni, fu giudicata damolti un atto di arbitrio e di arroganza (nova superba libi-do), tanto che Scipione Africano, console in carica, si pentìdi averla sostenuta. Livio conclude il suo racconto con unaconsiderazione di carattere universale: «non può ricevereapprovazione ciò che si allontana dall’antico» (adeo nihilmotum ex antiquo probabile est). In questa affermazionesembra condensarsi, esprimendosi lapidariamente nei toni enello stile di un enunciato gnomico, un atteggiamento men-tale comunemente riconosciuto come dominante presso iromani, e più in generale nel mondo antico: la diffidenzaverso le novità, il rifiuto di ogni cambiamento in presenza diuna tradizione consolidata, la tendenza a mantenere l’ordineesistente, considerato immodificabile finché non fosse pro-vata l’utilità di una innovazione.
La sentenziosa densità e il valore quasi proverbiale diqueste parole di Livio colpirono Michel de Montaigne, cheall’interno delle pagine dedicate alla consuetudine e
1 Ab urbe condita, 34, 54, 3-8.«Sto
rica
», n
.34
all’opportunità di «non cambiare facilmente una leggericevuta»2 le citò a conforto della propria manifestazione di«disgusto per la novità»3, come una sorta di glossadell’affermazione secondo cui «anche il miglior pretesto perun’innovazione è molto pericoloso»: «mais le meilleurpretexte de nouvelleté est tres-dangereux: adeo nihil motumex antiquo probabile est»4.
La riflessione di Montaigne ci offre una testimonianzaesplicita di un atteggiamento che attraversa, ricomparendo apiù riprese, il pensiero antico e medievale fino alle soglie dellamodernità, e che può essere definito, in breve, come condan-na della novità in quanto espressione di scontentezza ed eser-cizio di arbitrio, che aprirebbe le porte ad agitatori di popoloe a sovversivi5: condanna a cui si accompagna l’invito a esserecircospetti6 o, senz’altro, l’esortazione a «non far novità»7, ein genere la diffidenza nei confronti dei cambiamenti costitu-zionali e legislativi8. Questo atteggiamento si ritrova non sol-tanto nella tradizione del pensiero politico, ma anche nellateoria giuridica, medievale e poi umanistica, in cui, attraversolo strumento dell’esegesi ai Digesta, aveva preso corpo il te-
8 Primo piano
2 M. de Montaigne, Les Essais, a cura di P. Villey, Paris 1988 (1° ed. 1965), I,pp. 108 sgg. (= cap. XXIII: «De la coustume et de ne changer aisément une loyreceüe»).
3 Ivi, p. 119: «Je suis desgousté de la nouvelleté, quelque visage qu’elle por-te, et ay raison, car j’en ay veu des effets tres-dommageables».
4 Ivi, p. 120.5 Sui malcontenti che si legano facilmente a quelli «che desiderano innova-
re» e sul fatto che chi vive di «mala contentezza» si rende sempre disponibilealla novità si ricordi N. Machiavelli, Principe, IV; e soprattutto Discorsi, III, 21:«gli uomini sono sempre desiderosi di cose nuove; in tanto che così desideranoil più delle volte novità quegli che stanno bene, come quegli che stanno male:perché [...] gli uomini si stuccano del bene, e nel male si affliggono. Fa, adun-que, questo desiderio aprire le porte a ciascuno che in una provincia si fa capodi innovazione». Sulla «mala contentezza» cfr. G. Borrelli, Non far novità. Alleradici della cultura italiana della conservazione politica, Napoli 2000, in parti-colare pp. 15 sgg.
6 F. Guicciardini, Ricordi, 152: «abbiate grandissima circumspezione innan-zi entriate in imprese o faccende nuove».
7 L’espressione (in Della Ragion di Stato di Botero) dà il titolo al citato stu-dio di Borrelli.
8 Cfr. per esempio Machiavelli, Principe, VI, 17-18: «Debbesi considerare co-me è non cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire né più pericolosa amaneggiare che farsi capo di introdurre nuovi ordini. Perché lo introductore haper nimico tutti quegli che delli ordini vecchi fanno bene, e ha tiepidi defensoritutti quegli che delli ordini nuovi farebbero bene: la quale tepidezza nasce parteper paura delli adversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredu-lità degli uomini, e quali non credono in verità le cose nuove, se non ne vegganonata una ferma sperienza»; J. Bodin, Les six livres de la République, VI, 4: «lesnouveaux Princes cherchent les nouveautés: cela se peut dire de quelques uns,qui pour faire congnoistre leur puissance font des loix à propos et sans propos».
ma della novità come fonte di discordia, fino alla sovrapposi-zione fra la sfera del novum e quella dell’iniquum9.
Le radici di questa linea di pensiero sono facilmente indi-viduabili nel passo del secondo libro della Politica in cuiAristotele, all’interno dell’analisi dei vari modelli di costitu-zione, realizzati o soltanto teorizzati, affronta la questione«se, quando, come e per quali motivi convenga mutare la co-stituzione vigente». Il contenuto di questa digressione meto-dologica può essere così sinteticamente esposto:
anche per le città, come per tutte le arti e attività, potrebbe sembra-re un vantaggio mutare le leggi tradizionali (to kinéin tous patríousnomous) in presenza di una legge migliore; la medicina, per esem-pio, ha tratto vantaggio dall’aver praticato cambiamenti rispetto al-la tradizione (kinethéisa parà ta patria). Lo stesso principio do-vrebbe valere per la politica, che è anch’essa una téchne, ed è veroche in alcuni casi leggi e consuetudini antiche sono rozze e incivilie che, in generale, si cerca non quel che è tradizionale (patrion), maquel che è bene. Da tali considerazioni risulta chiaro che a volte al-cune leggi vanno cambiate (kinetói eisìn). Se si esamina però laquestione da un altro punto di vista, il cambiamento sembra ri-chiedere molta cautela. Infatti, nei casi in cui il miglioramento sa-rebbe piccolo, è preferibile tollerare qualche difetto, perché il van-taggio apportato dal mutamento non compenserebbe il dannoprodotto abituando gli uomini a disobbedire ai governanti e adabrogare con leggerezza le norme. Non si possono assumere comemodello le tecniche, poiché non è la stessa cosa cambiare (kinéin)una tecnica e una legge: la legge non ha altra forza per imporsi chela tradizione, e perché questa si crei occorre molto tempo, per cuimutare con facilità le leggi vigenti con nuove leggi (metaballein eisnomous kainoùs) significa indebolirne la forza10.
La riflessione aristotelica si inseriva in un ampio dibattitoche aveva già registrato opinioni contrarie al mutamento del-le leggi, dalla rigidità pitagorica contro ogni innovazione(kainotomia)11 alla categorica affermazione del Platone delleLeggi: «per uno stato non vi è danno maggiore dei cambia-menti, e fra questi i più gravi, quelli che richiedono la mag-giore circospezione, sono i cambiamenti relativi a costumi etradizioni»12. Una posizione, quella cui era approdato l’ulti-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 9
9 Cfr. C. Zendri, Novitates pariunt discordias. A proposito della nozione dinovum nella tradizione giuridica fra medio evo ed età moderna, in «Laboratoi-re Italien», 6, 2005, pp. 37-54.
10 Aristotele, Politica, 1268b-1269a.11 Cfr. Aristosseno in Giamblico, Vita Pitagorica, 176. Le testimonianze re-
lative al dibattito in questione sono raccolte e discusse da G. Camassa, I Grecidavanti al problema del mutamento, in «Quaderni di storia», 57, 2003, pp. 147-72 (una versione ampliata costituisce il capitolo Mutamento, in Id., La lonta-nanza dei Greci, Roma 2004, pp. 77-109).
12 Cfr. Platone, Leggi, 797d-798d.
mo Platone, molto lontana dall’idea, espressa per esempionel Politico, della possibilità per il legislatore di promulgareleggi migliori di quelle date, «così come per il medico di sta-bilire cure nuove rispetto a quelle già prescritte»13. È proprioda questa assimilazione della politica a una téchne edall’equiparazione dell’uomo politico al medico che il passoaristotelico prima ricordato prende le distanze. Ma nel mo-mento stesso in cui se ne allontana Aristotele riafferma la va-lidità del paradigma delle téchnai come campo di sperimen-tazione del cambiamento (kínesis) e della novità (kainòn):fuori dallo spazio della politica, in altri ambiti, in altre atti-vità legate ad altre forme di sapere (prima fra tutte, la medici-na) l’innovazione produce effetti positivi e va praticata. Lavastità e la ricchezza di questo scenario sembrano tuttavia es-sersi perdute in quella tradizione, che è stata e continua a es-sere riconosciuta senz’altro come aristotelica, e che nell’in-novazione individua, senza eccezioni né distinzioni, un og-getto di diffidenza e di rifiuto.
Nell’affermarsi di tale tradizione ha avuto probabilmenteun ruolo determinante la fortuna di un altro luogo classicodella teorizzazione politica aristotelica, quello relativo aimutamenti costituzionali nel quinto libro della Politica. Ilmutamento degli ordinamenti politici non esaurisce la pro-blematica del cambiamento, che investe anzi tutte le attivitàumane, come sottolineava lo stesso Aristotele nel passo ri-cordato in precedenza; ma la trattazione del quinto librodella Politica sembra avere influito in modo decisivo sullesuccessive rappresentazioni del mutamento, nella cultura an-tica e in parte anche in quella moderna, determinando unatendenza a ridurre la sfera del cambiamento e della novità al-la sfera delle istituzioni e delle leggi della politica. Non sol-tanto; ma per un altro aspetto questo luogo aristotelico hagrande rilievo nella storia della cultura del cambiamento edella novità. La domanda posta all’inizio della trattazione,«per quali cause le costituzioni cambiano (metabállousin)?»viene infatti specificata con una successiva formulazione:«qual è l’origine delle ribellioni (staseis)?»14. Mutamento e ri-bellione, metabolè e stasis, appaiono dunque strettamente
10 Primo piano
13 Platone, Politico, 295e sgg.14 Sulla stasis, corrispondente al concetto di internal war nella moderna
scienza della politica, e sulla sua connessione con la metabolè costituzionalenella teoria dello Stato e nella storiografia politica cfr. H.-J. Gehrke, Stasis.Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den Griechischen Staaten des 5. und4. Jahrhunderts v. Chr., München 1985.
connessi fin dalla definizione del tema trattato: «l’originedelle staseis è di due tipi, perciò anche le metabolái hannodue possibili cause, l’attacco alla costituzione per cambiarlain un’altra o il tentativo di mantenerla cercandone il control-lo». I due fenomeni continuano ad essere esplicitamente ac-costati nel seguito del discorso:
poiché studiamo da dove derivano le ribellioni (staseis) e i muta-menti di costituzione (metabolái), bisogna dapprima stabilirne ingenerale le origini e le cause […] bisogna stabilire quali sono le di-sposizioni di chi si ribella, per quali fini, e in terzo luogo, quali sonole origini dei disordini politici (politikái tarachái) e delle ribellioni.
Nel quinto libro della Politica appare cioè fissato il lessi-co del mutamento politico, con una stretta associazione frastasis e metabolè destinata a una lunga fortuna.
In questa idea del cambiamento come rivolgimento nega-tivo e della novità come elemento di disordine, formulata ri-guardo ai mutamenti costituzionali, non si esauriva l’interopunto di vista di Aristotele, il cui sguardo, come abbiamovisto, abbracciava il più ampio orizzonte dell’innovazione inogni attività umana. Tuttavia essa finì per imporsi e per esse-re riconosciuta come dominante non solo rispetto ad altreriflessioni aristoteliche (per esempio, quelle già ricordate delsecondo libro della Politica), ma anche rispetto ad altri puntidi vista espressi all’interno del dibattito su novità e cambia-mento in Grecia15. La tradizione così formatasi, e che ancoraai nostri occhi coincide con il quadro complessivo degli at-teggiamenti degli antichi, può essere riassunto in pochi con-tenuti essenziali: è sempre preferibile mantenere l’ordine esi-stente; i cambiamenti sono pericolosi perché produconosquilibrio e contengono germi di distruzione; la consuetudi-ne, ciò che è vecchio e convalidato dal tempo, è da antepor-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 11
15 La varietà di posizioni sul mutamento politico è splendidamente rappre-sentata nelle coppie antilogiche costruite da Tucidide (1, 71, 2-3 e 1, 84; 3, 37, 2-4 e 3, 45, 3; 6, 14 e 6, 18, 7: rispettivamente, i corinzi vs. il re spartano Archida-mo, Cleone vs. Diodoto, Nicia vs. Alcibiade), su cui cfr. l’analisi di Camassa, IGreci cit.; ed è ben testimoniata anche in ambiti extra-politici, per esempio nellaletteratura medica, dove gli effetti del cambiamento sull’organismo umano divi-devano gli esponenti della scuola ippocratica non meno di quanto dividessero iteorici della politica. Al vero e proprio elogio del mutamento nell’autore diArie acque luoghi (16; 23), che enuncia una teoria della metabolè all’interno diun quadro antropologico che contrappone società sedentarie a società dinami-che, fa da contrappeso, per esempio, il consiglio di non cambiare abitudini die-tetiche da parte dell’autore di Regime nelle malattie acute (18): cfr. G. Camassa,L’idea del mutamento nel Corpus Hippocraticum, in Medicina e società nelmondo antico, a cura di A. Marcone (atti del convegno di Udine 4-5 ottobre2005), Firenze 2006, pp. 16-25.
re, in quanto garanzia d’ordine e di buon governo, al cam-biamento ottenuto immettendo il nuovo, anche quandoquest’ultimo abbia l’apparenza di un miglioramento. Sonoquesti i motivi ricorrenti, quasi i luoghi comuni che si ripe-tono nelle nostre fonti, quelli che appaiono distillati nellaformulazione sentenziosa e moralistica di Livio accolta daMontaigne. Dalle testimonianze che costituiscono tale tradi-zione emerge un invito generalizzato a diffidare del cambia-mento e della novità, a meno che non se ne dimostri un’ef-fettiva necessità in vista di un’utilità: in rebus novis consti-tuendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure,quod diu aequum, affermerà in età severiana il giurista Ul-piano16, con una implicita assimilazione del diritto vigente algiusto, all’aequum, e quindi della novità all’iniquum, desti-nata ad avere, come abbiamo accennato, una lunga storia17.Come un argomento topico proveniente da un repertorioormai di scuola ripeterà in forma quasi letterale l’enunciatoaristotelico il bitinico Dione Cassio: scrivendo la storia diRoma nel pieno della crisi del III secolo d.C., egli accompa-gnerà la narrazione di uno dei momenti più importanti dimutamento istituzionale nella storia di Roma, il passaggiodalla monarchia alla repubblica, con il seguente commento:
tutti i cambiamenti (metabolái) sono molto pericolosi, soprattuttoquelli che riguardano i sistemi di governo, che nuocciono moltosia agli individui sia alle città; per questo gli uomini sensati preferi-scono restare sempre nella stessa situazione, anche se non è la mi-gliore, piuttosto che vagare sempre cambiando ora in un modo orain un altro18.
Se dunque la linea di pensiero che nelle nostre fonti ap-pare dominante, quella che per convenzione viene indicatacome tradizione aristotelica, condanna il nuovo (il kainòn),o comunque lo sottopone a forti limitazioni e condiziona-menti, la domanda «Quanto è antico il nuovo?»19, formulatain uno studio recente, appare carica di un significato che vaal di là del gioco di parole e del paradosso ossimorico. Se èvero che il rapporto dialettico fra antico e nuovo (in altreparole, fra tradizione e continuità da un lato, innovazione ecambiamento dall’altro) si dispone lungo un asse non solo
12 Primo piano
16 Dig., 1.4.2.17 Cfr. supra, nota 9, p. 9.18 Si tratta del frammento 12.3a, collocato dagli editori nel libro III e posto in
relazione con la caduta di Tarquinio nel 509 a.C.19 R. Bubner, Wie alt ist das Neue?, in Eine Denkfigur der Moderne, a cura
di M. Moog-Grünewald, Heidelberg 2002, pp. 1-12.
cronologico, ma anche qualitativo, e se è vero che la valuta-zione positiva della novità come cambiamento in meglio siafferma solo in età moderna, e pienamente solo a partiredall’Illuminismo20, è legittimo chiedersi «che cosa significa ilnuovo prima della modernità, prima che si affermi l’idea diprogresso»21.
«Quanto è antico il nuovo?»: la risposta più diffusa neglistudi che affrontano l’argomento sottolinea il segno quasiesclusivamente negativo del cambiamento e della novità nelmondo greco e romano, fino al punto di indicare nella tema-tizzazione del nuovo una delle principali discriminanti dellacultura moderna rispetto a quella antica, e nell’acquisizionedel suo valore positivo un forte segno di discontinuità fral’antichità e la modernità. Prerogativa esclusivamente diquest’ultima22, l’idea del nuovo sarebbe pregiudizialmenterifiutata da tutto il mondo antico.
Siamo di fronte a un punto di vista largamente condiviso,che si ritrova formulato sia all’interno sia al di fuori deglistudi di antichistica, come un assunto che non necessita didimostrazioni23. Esso fa riferimento all’immagine di una so-cietà incapace di attivare un rapporto dinamico fra antico enuovo, in cui la forza costrittiva del passato limita la possibi-lità di assumere il nuovo in quanto elemento non previsto:di una società (potrebbe essere così descritta adoperando lecategorie di Koselleck) in cui l’orizzonte delle aspettative sa-rebbe interamente schiacciato sullo spazio di esperienza.
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 13
20 R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Genova1986: «l’espressione tedesca neue Zeit può indicare o la semplice constatazioneche il nunc di ogni dato momento è nuovo, che il tempo odierno è in antitesicol tempo passato […] ma d’altro lato il tempo nuovo può avanzare una pretesaqualitativa, e cioè la pretesa di essere nuovo nel senso di completamente diver-so, o persino migliore, nei confronti del tempo precedente. […] inizialmenteprevale il primo significato, in cui non interviene il riferimento a un’epoca spe-cifica, mentre il secondo significato, accompagnato dalla coscienza dell’epoca,si afferma solo nell’età dell’Illuminismo, peraltro senza rimuovere il primo»,pp. 266-7 (ed. orig. Frankfurt a.M. 1979).
21 Cfr. la premessa di M. Gaille-Nikodimov, P. Girard, O. Remaud aL’épreuve de la nouveauté, in «Laboratoire Italien», 6, 2005, pp. 7-15.
22 Cfr. M. Moog-Grünewald nella premessa a Eine Denkfigur cit. Sottoli-neano le implicazioni di posizioni teoriche di questo tipo Gaille-Nikodimov,Girard, Remaud, L’épreuve cit.: l’idea che nel pensiero antico e medievale man-chi il concetto di nuovo in senso proprio non sarà un invito a pensare che solola modernità conosce il senso storico? (p. 8: «n’invitera-t-on pas à penser queseule la modernité connaît le sens historique?»).
23 Recentemente cfr. le pagine introduttive di A. von Müller a DieWahrnehmung des Neuen in Antike und Renaissance, a cura di Id. e J. vonUngern-Sternberg, München-Leipzig 2004, pp. VII-XVII: «Die Neue war derAlten Welt verdächtig. Mit dieser allgemeinen Feststellung bleibt man zunächstdurchaus unangreifbar» (p. VII).
2. Roma: una «città immobile»?
La rappresentazione diffusa cui abbiamo fatto cenno, èinnegabile, trova ampia conferma nelle fonti antiche di cuidisponiamo. Tuttavia affermazioni sbrigative come quellasecondo cui «il concetto di nuovo nell’antichità aveva unsuono negativo e minaccioso, diversamente da quello cheavviene oggi»24, solo per citare le parole con cui si apre unodei più recenti contributi sul tema, appaiono come l’ennesi-ma replica di un pregiudizio non sottoposto a verifica. Inrealtà, la presunta esclusione del concetto di nuovo dall’an-tichità tutta, nel suo complesso, si rivela un tassello in piùdel quadro compatto e monolitico con cui ancora troppospesso si continua a far coincidere l’antichità (o, peggio, la«classicità»), in una ricerca di grandi quadri morfologici checonduce a generalizzazioni vaghe e indistinte. Una prima,obbligatoria precisazione di fronte a giudizi come quelloappena citato riguarda l’uso della generica categoria di«mondo antico» per indicare la Grecia classica e l’anticaRoma: anche un rapido sguardo basta infatti a mostrare co-me l’atteggiamento dei greci e dei romani rispetto al concet-to e alla pratica della novità e del cambiamento non siauniforme. Gli esempi precedentemente ricordati lascianointravedere una pluralità di opinioni, all’interno della cultu-ra greca, che impedisce di parlare di una generale ostilità deigreci verso la novità e il cambiamento25. Diverso è il conte-sto romano, dominato dalla cultura del mos maiorum: il pe-so decisivo della tradizione e dell’autorità degli antenati,inizialmente connesso a una cultura genealogica elaboratada una formazione sociale e politica a struttura gentilizia,ma destinato a durare fino alla fine dell’impero, fa di Roma,di quella arcaica come di quella medio- e tardo-repubblica-na, e poi di quella imperiale, una società quasi «sottomessaal suo passato», una sorta di «città immobile»26. In questoquadro, e nel quadro ancor più complessivo di una rappre-sentazione prevalente del tempo priva di un’idea di pro-gresso, si collocherebbe l’ostilità dei romani verso il nuovo,così descritta in una efficace sintesi da Ronald Syme:
14 Primo piano
24 Ivi, p. 67: «Ganz anders als heute hatte in der Antike der Begriff des‘Neuen’ von vornherein einen negativen, ja gefährlichen Klang».
25 A questa conclusione giungono i più recenti contributi sull’argomento,tra cui quelli già citati di Camassa.
26 B. Lepetit, Le présent de l’histoire, in Id., Carnet de croquis. Sur la connais-sance historique, Paris 1999, pp. 252-83 (sul concetto di «cité immobile» p. 270).
i Romani, presi come popolo, erano dominati da una particolarevenerazione per l’autorità, i precedenti, la tradizione, e insieme dauna radicata avversione per ogni mutamento, a meno che il muta-mento non potesse dimostrarsi in armonia col costume avito, colmos maiorum. Mancando ancora una qualsiasi idea di fede nel pro-gresso, che non era ancora stata inventata, i Romani guardavano al-la novità con sfiducia e avversione. La parola novus suonava male27.
«Tuttavia – concludeva Syme – la storia del passato ricor-dava ai Romani che mutamenti c’erano stati, anche se lenti ecombattuti». Questo richiamo finale a considerare i muta-menti, sia pur lenti e contrastati, verificatisi nel corso dellastoria di Roma contiene un implicito invito a operare un’ul-teriore distinzione, a separare il piano degli eventi storici ri-spetto a quello delle idee e del sentire diffuso; spesso invecel’analisi dei mutamenti realmente verificatisi si è sovrappostaall’analisi delle rappresentazioni che di tali processi di cam-biamento avevano gli attori e gli osservatori.
Un’altra precisazione sembra necessaria: cosa si intendequando si fa riferimento alla novità verso cui i romaniavrebbero manifestato sfiducia e avversione? Quale signifi-cato era attribuito all’aggettivo novus, al sostantivo novitas oal verbo novare? Il campo semantico e concettuale di questafamiglia lessicale si presenta come straordinariamente am-pio, riferibile agli oggetti più diversi, senza chiare delimita-zioni. Basteranno pochi esempi (alcuni dei quali saranno ri-presi nelle pagine seguenti) per scoraggiare qualsiasi tentati-vo di generalizzazione. Novitas è per definizione quella delcittadino che intraprende la carriera politica senza avereconsoli fra i propri antenati, l’homo novus, appunto28; è,nell’ambito della religione, l’introduzione di culti stranieri; èl’apertura di una scuola che pratica in modo inconsueto l’in-segnamento della retorica; è l’affidamento a Pompeo di co-mandi speciali nel 66 a.C. È la normale attività legislativacon cui le leggi vengono abrogate e sostituite29, ma è anche ilgesto incostituzionale con cui Pompeo cancella il diritto diveto dei tribuni della plebe, offrendo a Cesare un pretesto
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 15
27 R. Syme, La rivoluzione romana, Torino 1962, p. 317 (ed. orig. Oxford1939).
28 Senza dubbio, l’accezione di novità più studiata fra gli aspetti dell’usodella categoria della novitas all’interno degli studi di lessicografia politica (cfr. J.Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous larépublique, Paris 1963, pp. 472-83) e di storiografia (cfr. P.A. Brunt, Nobilitasand Novitas, in «Journal of Roman Studies», 73, 1982, pp. 1-17).
29 Cfr. Varrone, De lingua latina, 9, 20: an non saepe veteres leges abrogataenovis cedunt?
per lo scoppio della guerra civile30; ed è il marchio che con-trassegna il progetto sovversivo di Catilina. Novae sono siale leggi con cui nell’81 a.C. Silla riforma la repubblica31 siaquelle con le quali Augusto fonda l’ordinamento costituzio-nale che sarà definito, per l’appunto, novus status 32. All’am-piezza dello spettro semantico e alla molteplicità di usi delconcetto in questione, che possono generare ambiguità econfusioni, si aggiunge un ulteriore rischio di equivoco, cau-sato dalla spiccata tendenza, evidente nelle fonti, ad associa-re le parole della novitas a quelle del disordine e del conflittopolitico: seditio, discordia, tumultus, coniuratio, con uno slit-tamento verso la sfera semantica e concettuale della ribellio-ne e della congiura che mostra con nettezza il segno dell’ere-dità aristotelica.
Questa schiacciante prevalenza, nelle testimonianze anti-che, di combinazioni linguistiche in cui il lessico della novitàsi intreccia con quello del rivolgimento politico, nel solcodella tradizione aristotelica costituitasi a partire dal quintolibro della Politica, sembra aver avuto una ripercussione an-che sulle interpretazioni moderne, che mostrano una analo-ga tendenza a sovrapporre le due sfere, a far coincidere lenovità e i cambiamenti con le novità e i cambiamenti politici,ovvero, sulla scia del collegamento fra metabolè e stasis, conla ribellione e la congiura; e che finiscono per attribuire airomani una percezione e valutazione complessivamente ne-gativa del nuovo, con una impropria estensione della loropercezione e valutazione negativa, questa sì manifestata apiù riprese, della destabilizzazione e del sovvertimentoall’interno della politica in senso stretto.
Nello stesso tempo, se lo spazio della novità di caratterepolitico si è ampliato fino ad occupare, nella rappresentazio-ne vulgata che si ha dell’antichità, e di quella romana in par-ticolare, tutti i possibili spazi dell’innovazione, ciò sarà an-che effetto della costruzione, da parte della storiografia mo-derna, di un paradigma del cambiamento e della novità quasiesclusivamente inteso come cambiamento e novità dell’ordi-ne politico, anzi, senz’altro, come «rivoluzione»: un para-digma ingombrante, che ha sottratto attenzione ad altri am-biti del mutamento.
16 Primo piano
30 Cfr. Cesare, Bellum civile, 1, 7, 2: novum in re publica introductumexemplum queritur, ut tribunicia intercessio armis votaretur atqueopprimeretur.
31 Livio, Periochae, l. 89: Sylla dictator factus [...] legibus novis rei publicaestatum confirmavit.
32 Da Svetonio, Vita Augusti, 28, 3.
Si pensi, in particolare, alla ricca e vivace discussionesulla legittimità di descrivere come rivoluzione la soluzio-ne della crisi della repubblica aristocratica. Fu Mommsen,come è noto, ad adoperare questo concetto per descriverealcune grandi svolte della storia di Roma, dalla cacciata diTarquinio il Superbo, «la prima rivoluzione romana»33, finoalla rivoluzione definitiva, die Revolution, secondo il titolodel capitolo di Römische Geschichte dedicato agli eventi daiGracchi a Silla, o, come è definita altrove, «rivoluzione len-ta ma permanente»34. Ma fu soprattutto la Roman revolu-tion di Syme, che restringeva il periodo rivoluzionario aglianni fra il 60 a.C. e il 14 d.C., a provocare un’ampia discus-sione35, in larga parte incentrata sulla legittimità dell’usodel concetto di rivoluzione36: un dibattito che lasciava daparte l’analisi delle rappresentazioni dei mutamenti presi inesame.
Come veniva concettualizzata, espressa linguisticamen-te, percepita, valutata la novità a Roma? Da queste doman-de parte l’esplorazione qui proposta nel campo della novità
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 17
33 Römische Geschichte, I, Leipzig 1903, p. 257. A proposito di Mommsensi è potuto dire che aveva costruito l’intera storia della repubblica come unastoria di rivoluzioni: A. Heuss, Der Untergang der römischen Republik unddas Problem der Revolution, in «Historische Zeitschrift», 182, 1956, pp. 1-28.
34 Römisches Staatsrecht, II, Leipzig 1887, p. 1133.35 Per limitarsi a ricordare intere raccolte di contributi sull’opera di Syme si
vedano: Inchiesta: la rivoluzione romana, in «Labeo», 26, 1980; La rivoluzioneromana: inchiesta tra gli antichisti, a cura di A. Heuss, Napoli 1982; BetweenRepublic and Empire. Interpretations of Augustus and his Principate, a cura diK.A. Raaflaub e H. Toher, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1990; La RévolutionRomaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives, in «Entretiens FondationHardt», 46, Vandoeuvres-Genève 2000.
36 Ammettono l’uso del concetto di rivoluzione, fra gli altri: C. Nicolet, LesGracques ou Crise agraire et Révolution à Rome, Paris 1967; P.A. Brunt, TheFall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988 (soprattutto pp.2-12), il quale precisa che si trattò di una rivoluzione in senso proprio, anche sesoltanto politica e non sociale. Secondo A. Heuss (Das Revolutionsproblem imSpiegel der antiken Geschichte, in «Historische Zeitschrift», 216, 1973, pp. 1-72), anche se il concetto moderno di «rivoluzione» non si adatta ai fenomenidell’antichità, si può comunque parlare di un periodo rivoluzionario,cominciato con i moti graccani, il cui esito fu il Principato. Per marcare unadistinzione rispetto all’apparato concettuale e alle esperienze storiche cui fariferimento il termine «rivoluzione» sono state proposte altre categoriedescrittive: «crisi senza alternativa» in C. Meier, Res Publica Amissa. EineStudie zur Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik,Wiesbaden 1966 (2a ed. 1980); cfr. R. Rilinger, Die Interpretation desNiedergangs der römischen Republik durch ‘Revolution’ und ‘Krise ohneAlternative’, in «Archiv für Kulturgeschichte», 64, 1982, pp. 279-306;«rivoluzione mancata» in F. De Martino, Una rivoluzione mancata?, in«Labeo», 26, 1980, pp. 90-103; «contro-rivoluzione», in J.A. North, TheRoman Counter-Revolution (rec. a Brunt, The Fall of the Roman Republic cit.)in «Journal of Roman Studies», 79, 1989, pp. 151-6.
e del cambiamento a Roma, attraverso l’esame di una seriedi testimonianze significative37.
3. Un pensiero della novità
A questo punto si pone una questione piuttosto difficile: si de-vono talvolta anteporre amici nuovi ai vecchi (num quando amicinovi veteribus sint anteponendi), come a vecchi cavalli siamo solitipreferire i puledri? No, quanto più un’amicizia è antica tanto piùdeve essere cara, come quei vini che invecchiando migliorano. Lenovità, se portano in germe qualche speranza di frutti futuri, nonsono da respingere; tuttavia bisogna mantenere le vecchie amicizie,poiché la forza più grande è quella di una antica consuetudine (no-vitates autem si spem adferunt non sunt illae quidem repudiandae,vetustas tamen suo loco conservanda; maxima est enim vis vetusta-tis et consuetudinis). Anzi, se niente lo impedisce, ognuno usa piùvolentieri un cavallo cui è abituato piuttosto che uno nuovo; e nonsolo riguardo agli animali, ma anche per gli oggetti si afferma laforza della consuetudine (in iis etiam, quae sunt inanima, consue-tudo valet), tanto è vero che ci sono cari quei luoghi nei quali ab-biamo vissuto a lungo, anche se sono monti e boschi38.
Nessun passo più efficacemente di questo, tratto dal dia-logo ciceroniano sull’amicizia, potrebbe aprire uno squarciosu quello che i romani pensavano della novità in rapporto ein alternativa alla consuetudine. Perché in esso appaiono de-positate le tracce di un pensiero che ha radici arcaiche e che,attraverso i canali sotterranei di un senso comune diffuso,era arrivato a permeare ogni aspetto della vita, anche i piùprivati: gli amici da frequentare, la scelta di un cavallo, il go-dimento di un paesaggio di montagna, tutto il mondodell’esperienza appare attraversato dall’antitesi fra vecchio enuovo, fra la tradizione convalidata dal tempo (la vetustas ela consuetudo) e la novitas carica di aspettative (concetto in-sito in spem adferunt). Trovarsi a scegliere fra questi due ele-menti in conflitto pone un vero e proprio dilemma (unaquaestio subdifficilis).
Siamo in presenza di uno schema mentale che costituiscel’ossatura di una riflessione teorica in cui il concetto di nuo-vo è sempre presentato in antitesi a quello di vecchio. Que-sta contrapposizione doveva essere declinata su vari piani,
18 Primo piano
37 Queste sono le coordinate indicate nei più recenti contributi dedicati allastoria del concetto di nuovo/novità: Gaille-Nikodimov, Girard, Remaud,L’épreuve cit. (appréhension, description, évaluation) e von Müller in DieWahrnehmung cit. (Wahrnehmung, Bewertung, Perzeption).
38 Cicerone, Laelius de amicitia, 67-8.
lungo l’intero arco delle possibilità della vita degli uomini eanche degli dei, della natura e del cosmo. All’interno di unaargomentazione di Lucrezio che rispecchia una posizioneepicurea si è conservata traccia di una valutazione del nuovoin ambito teologico:
gli dei non hanno creato il mondo a vantaggio degli uomini; qualenovità infatti (quid novi?) avrebbe potuto spingerli a voler cambia-re la loro condizione di esseri felici e immortali? A compiacersi diuna situazione nuova (gaudere novis rebus) può essere solo chi ri-ceve un danno dalla vecchia (cui veteres obsunt), ma se non è suc-cesso niente di negativo nel passato, perché questo desiderio si do-vrebbe accendere?39
Tale argomentazione si ribalta, nella riflessione lucrezianasul contrasto fra antico e nuovo, se dalla considerazione de-gli dei si passa a quella del genere umano, impegnato agli ini-zi della sua storia in un faticoso sviluppo. Il desiderio dicambiare diventa allora elemento di progresso, incentivo a«mutare il precedente modo di vivere grazie alle innovazioni(novis rebus)»40: vecchio e nuovo rappresentano stadi succes-sivi di una storia dell’umanità. Ma questo accenno di visioneprogressista rimane un’eccezione del tutto isolata41, e l’op-zione per il nuovo in contrapposizione al vecchio costituiscepiuttosto il nucleo di una antropologia negativa dell’agireumano: «in ogni comunità succede sempre così: quanti nonpossiedono ricchezza né potere odiano il vecchio, desidera-no il nuovo (vetera odere, nova exoptant), ed è per odio dellapropria condizione che aspirano a che tutto cambi»42. A for-mulare questa considerazione universale è Sallustio in unodei capitoli centrali della monografia dedicata alla congiuradi Catilina, sventata e soffocata in modo cruento nel 63 a.C.
La teoria del nuovo come antitesi rispetto al vecchio, ov-vero all’ordine precedente delle cose, che come abbiamo vi-sto trova anche un fondamento teologico, viene confermatadalla scienza della natura e dalla cosmologia: l’antico e la tra-dizione possono essere assimilati all’ordine cosmico oppureall’ordine di una natura regolata dalla legge della ripetizione
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 19
39 Lucrezio, De rerum natura, 5, 168-73.40 Ivi, 1105-7.41 Sarebbe d’altra parte un errore attribuire a Lucrezio (troppo spesso con-
siderato un illuminista ante litteram) un pensiero positivo della novità. Il passodel quinto libro su riportato fa eccezione anche all’interno del De rerumnatura: un’analisi sistematica di cui esporrò i risultati in altra sede porta a con-cludere che novum è per il poeta epicureo soprattutto il naturale rinnovarsi del-la materia, rinnovamento ciclico piuttosto che elemento di discontinuità.
42 Sallustio, Bellum Catilinae, 37, 3.
dei fenomeni, rispetto ai quali il nuovo equivarrà a un even-to catastrofico. «Novità» è perciò definita l’eruzione di unvulcano, che suscita negli uomini l’angoscioso dubbio su«cosa stia tramando la natura (quid moliretur rerum naturanovarum)», ancora in un passo del poema di Lucrezio43, cosìcome «novità» sarà la catastrofe finale che, quando lo stabi-lirà la razionalità divina che lo governa, porrà fine al mondo,inaugurando un nuovo ciclo cosmico: scriverà Seneca ripe-tendo un tema vulgato della filosofia stoica
il diluvio e la conflagrazione universale avvengono quando la divi-nità ritiene opportuno l’inizio di un mondo migliore e la fine diquello antico (ordiri meliora, vetera finiri): una volta stabilito ilrinnovamento universale (quando placuere res novae mundo), ilmare così come il fuoco si rovesceranno sugli uomini44.
L’antico e il nuovo appaiono elementi in contrapposizio-ne anche nel macrocosmo fisico: non c’è dialettica né possi-bilità di mediazione fra loro, il nuovo può solo soppiantareil vecchio dopo la sua distruzione. E se è vero che la provvi-denziale divinità stoica di cui parla Seneca penserà a un nuo-vo mondo migliore del precedente, questo mondo migliorerichiederà la distruzione di quello precedente: l’instaurarsi diun nuovo ordine, così come nel microcosmo della città ter-rena, comporterà la violenta sostituzione dell’ordine preesi-stente attraverso uno sconvolgimento catastrofico, l’imposi-zione del cambiamento e del nuovo come negatività45.
4. Un lessico della novità: le res novae
La teoria politica aristotelica, abbiamo visto, associava ilconcetto di metabolè a quelli di stasis («guerra interna») e ditarachè («rivolgimento, tumulto»): sui termini del muta-mento (oltre a metabolè, kínesis) si proiettava così un’ombranegativa. Ma ancor prima di Aristotele, già per esempio nellastoriografia di Erodoto e di Tucidide, questa sfumatura peg-giorativa era presente nella famiglia lessicale che designa lanovità: la si coglie in numerose attestazioni dell’aggettivoneos e di alcuni suoi derivati, in particolare neochmoo e neo-terizo («innovare», ma anche «preparare una ribellione»),
20 Primo piano
43 Lucrezio, De rerum natura, 6, 641-6.44 Seneca, Naturales quaestiones, 3, 28, 7.45 Cfr. anche Seneca, Consolatio ad Marciam, 26, 6, 6, dove si descrive la
renovatio mundi come annientamento dell’universo nella conflagrazione totale.
neoterismòs («innovazione», ma anche «rivolgimento»),neoteristès («innovatore» e «ribelle»), neoteropoiéo ecc. Tuttiquesti termini, di per sé semanticamente neutri, ricevonopresto una connotazione aggiuntiva che fa riferimento almutamento politico, in accordo con la tendenza già osserva-ta a percepire e descrivere l’innovazione e il cambiamentocome prevalentemente politici. Essi costituiscono un glossa-rio del mutamento che diventa il linguaggio codificato nelladescrizione delle crisi e dei conflitti politici; a questo reper-torio lessicale attingeranno, fra l’altro, le narrazioni dellagrande crisi della repubblica romana, dai Gracchi in poi, nel-la storiografia di Roma in lingua greca46.
Se dal lessico greco passiamo a quello latino, una primaconstatazione riguarda l’ambiguità semantica della famigliadi novus, che riproduce quella della corrispondente famigliadel greco neos: un’ambiguità che si mantiene per tutto l’arcodella latinità, fino ai suoi sviluppi più tardi, e poi nella tradi-zione medievale47. Il significato primario neutro rischia con-tinuamente di slittare verso il negativo. A volte si giocasull’ambiguità del concetto: come quando Cicerone, riferen-dosi a una moda poetica contemporanea che disapprova, lachiama dei poetae novi (o, nella forma greca, neóteroi)48. Avolte l’accezione negativa emerge con nettezza, come nelsecco, burocratico haec nova non placent in un testo ufficia-le, l’editto censorio sulla scuola dei «retori latini»49. Questaambiguità, sempre sull’orlo della negatività, che caratterizzala sfera concettuale dell’innovazione si estende a tutta la ter-minologia del mutamento, a partire dalla famiglia del verbomutor, le cui parole sono spesso associate a termini che desi-gnano propriamente il disordine e il tumulto (come già os-servato a proposito della famiglia di novus)50. Se comune èl’associazione del lessico della novità e del cambiamento aquello del disordine e del rivolgimento, altrettanto frequen-te, fino a diventare prevedibile, è l’antitesi, nella quale si
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 21
46 Su Appiano e sul suo uso di stasis a proposito dei Gracchi cfr. F. Hinard,Appien et la logique interne de la crise, in Fondements et crises du pouvoir, a cu-ra di S. Franchet d’Espèrey, V. Fromentin, S. Gotteland e J.-M. Roddaz, Bor-deaux 2003, pp. 317-24. In questo stesso volume si veda M.-L. Freyburger, Levocabulaire de la crise du pouvoir chez Dion Cassius, pp. 325-36.
47 In epoca medievale l’ambivalenza semantica della famiglia di novus si tro-va registrata in una ricca letteratura lessicografica: cfr. Zendri, Novitates cit.
48 Cicerone, Orator, 161; Epistulae ad Atticum, 7, 2, 1.49 Cfr. infra, pp. 31 sgg.50 Cfr. per esempio Cicerone, Pro Caecina, 74: perturbari commutarique;
Epistulae ad familiares, 5, 12, 4: civilium commutationum scientia vel inexplicandis causis rerum novarum.
esprime il conflitto fra nuovo e tradizione, fra tale lessico etermini come consuetudo o mores51. La ripetitività dei conte-sti linguistici sembra corrispondere a un atteggiamento benradicato, che si mantiene nel tempo: un’idea negativa dellanovità e del cambiamento, che collega, nella tradizione te-stuale di cui disponiamo, gli attacchi della prima oratoria ci-ceroniana all’accusa postuma mossa nel 360 dall’imperatoreGiuliano a Costantino, di essere stato un innovatore, di ave-re sconvolto la antiche leggi e la tradizione (ut novatoris tur-batorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti)52.
In questo lessico stilizzato, caratterizzato dalla ripetiti-vità, spicca con particolare evidenza, per l’altissima fre-quenza di attestazioni, il nesso res novae, nel quale sembraessersi depositata in massimo grado la carica negativa con-tenuta nella famiglia semantica e concettuale della novità.Questo sintagma, dotato in origine del significato neutro egenerico di «situazione nuova», appare infatti essersi spe-cializzato ben presto come voce del lessico politico e storio-grafico, con il significato di «cambiamento negativo», quin-di «rivolta, tumulto, complotto», che appare già codificatonella lessicografia antica. Un dizionario di sinonimi proba-bilmente del IV secolo d.C. inserisce il nesso perifrastico re-rum novarum cupidus («desideroso di novità») in una seriesinonimica che comprende i termini «sobillatore, provoca-tore, cospiratore, agitatore, calunniatore, sedizioso, turbo-lento, nemico della pace e della tranquillità»53. Nelle linguemoderne il nesso viene di solito tradotto con vocaboli equi-valenti a «rivolgimenti» o, molto spesso, «rivoluzione»54.Come dimostra uno spoglio sistematico delle testimonian-ze, il nesso res novae appartiene soprattutto al lessico delle
22 Primo piano
51 Cfr. per esempio Cicerone, Pro Quinctio, 44: quod consuetudine patresfaciunt, id quasi novum reprehendis; In Verrem actio II, 3, 142: nova lege con-tra consuetudinem. Sulle dinamiche del rapporto fra consuetudine e novità cfr.M. Bettini, Mos, mores e mos maiorum. L’invenzione dei «buoni costumi» nellacultura romana, in Id., Le orecchie di Hermes, Torino 2000, pp. 241-92.
52 Come riferisce Ammiano Marcellino nelle sue Storie (21, 10, 8), infra p. 41.53 Pseudo-Carisio, Synonyma Ciceronis, in Grammatici Latini, I, 420, 27,
a cura di H. Keil.54 Traduzione impropria, che nasce dalla sovrapposizione di un concetto mo-
derno ai conflitti del mondo antico (cfr. supra, nota 36; una verifica sulle fonti la-tine, che conferma l’assenza di un concetto confrontabile con quello di rivoluzio-ne, in E. Burck, Das Bild der Revolution bei römischen Historikern, in «Gymna-sium», 73, 1966, pp. 86-109). Sulla «corrispondenza solo molto approssimativadei concetti di stasis, tarachè, kinesis, neoterismòs, res novae, tumultus, seditio conil concetto esclusivamente moderno di rivoluzione» valgano per tutte le osserva-zioni di S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, III, Roma-Bari (1a ed. 1966), pp.183 e 253 sgg.; cfr. anche Heuss, Das Revolutionsproblem cit., pp. 4 sgg.
analisi politiche e sociali, per cui (a parte scarse e poco si-gnificative eccezioni) ricorre con una schiacciante predomi-nanza di attestazioni nella storiografia e nell’oratoria politi-ca. All’interno del linguaggio politico e storiografico, inol-tre, esso ricorre, nella quasi totalità degli esempi, in combi-nazione con alcuni termini: con i verbi molior (tramare), cu-pio (desiderare), studeo (impegnarsi per desiderio di qualco-sa), e con i connessi sostantivi cupiditas e studium; con gliaggettivi cupidus e avidus; con sostantivi che designano lapaura, la speranza, l’attesa (metus, spes, exspectatio). In que-sto repertorio formulare le res novae appaiono codificateall’interno di una gamma di situazioni prevedibili: di esse siha desiderio o speranza o paura, le si prepara ordendo tra-me, le si attende. Alla formularità di questo uso linguisticocristallizzato corrisponde tuttavia una grande varietà disoggetti e di situazioni.
5. Descrizione e percezione della novità: soggetti, contesti, obiettivi delle res novae
Catone, nell’orazione in difesa degli abitanti di Rodi, ac-cusati di avere assunto una posizione antiromana nella guer-ra contro il re Perseo di Macedonia nel 167 a.C., chiedeva alSenato di perdonare i Rodiesi, «perché in tal caso la gran-dezza del popolo romano si sarebbe conservata, mentre senon si fosse praticato il perdono si profilava la paura di ri-volgimenti nello o (metus in republica rerum novarum)»55. Èsignificativo che egli agitasse di fronte al senato lo spettrodelle res novae: la paura che qualcosa di nuovo (di generica-mente nuovo) potesse minacciare la grandezza stessa di Ro-ma si accorda perfettamente con la personalità politica e cul-turale del grande protagonista del II secolo a.C., l’esponentepiù rilevante di una politica volta a mantenere gli equilibridell’antica res publica nella fase in cui questa si trasformavain una «repubblica imperiale», figura simbolica del richiamoalla tradizione. Candidandosi alla carica di censore, nel 189a.C., Catone aveva posto al centro del suo programmal’obiettivo di contrastare le nuove, vergognose abitudini e diripristinare l’antica morale (castigare nova flagitia et priscosrevocare mores)56.
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 23
55 Catone, fr. 125 Sblendorio; dell’orazione, per noi perduta, si legge unaparafrasi nelle Noctes Atticae di Aulo Gellio (6, 3, 47).
56 Cfr. Livio, Ab urbe condita, 39, 41, 4.
La rappresentazione, di probabile matrice catoniana, delnuovo come pericolo, come elemento di disgregazione e disquilibrio sarebbe a ripresa dai difensori della tradizione re-pubblicana; in particolare, essa avrebbe avuto un ruolo im-portante in alcuni momenti dell’oratoria ciceroniana. Non èun caso che l’attacco alla ricerca di res novae e il contempo-raneo richiamo ai tempi antichi e all’eredità ricevuta dagliantenati compaia nelle orazioni che risalgono all’anno delconsolato, il 63 a.C., nella fase più conservatrice, quando Ci-cerone era nettamente schierato dalla parte degli ottimati,che avevano appoggiato la sua elezione a console, contro ipopolari. Nella prima delle quattro orazioni contro Catilinal’attacco al cospiratore, e nello stesso tempo alla colpevoleincertezza del Senato nel prendere i necessari provvedimen-ti, trova sostegno negli esempi forniti dalla storia passata:l’uccisione nel 133 a.C., per ordine del console Scipione Na-sica, di Tiberio Gracco e, in epoca molto più antica, l’ucci-sione, decisa dal dittatore Cincinnato, di un cavaliere «cheaspirava a cambiamenti (novis rebus studentem)», SpurioMelio (439 a.C.)57. I due esempi sono accomunati dal riferi-mento a politiche favorevoli alla plebe; essi rivelano una po-sizione filosenatoria e antipopolare che si traduce nella con-danna di ogni tentativo riformista come attacco allo Stato eche giustifica il ricorso alla violenza, autorizzato da un pas-sato che diventa fonte di legittimazione della coercizione percontrastare ogni tentativo di sovvertire la res publica. Qual-che anno dopo, nel 56 a.C., i Gracchi avrebbero ricevutouna parziale riabilitazione in quel manifesto di una nuova li-nea politica che è l’orazione in difesa dell’ex tribuno dellaplebe Publio Sestio. Il progetto politico ciceroniano prevedeora l’alleanza trasversale di tutti i cittadini moderati per sal-vare le istituzioni e la pace sociale; la politica antiriformistapraticata in passato dagli ottimati viene giustificata come unalinea difensiva nell’interesse della res publica, ma ora, nel cli-ma di auspicata pacificazione che anima l’orazione, «non viè più nessun motivo perché il popolo desideri un rivolgi-mento (neque populus novarum rerum est cupidus)»58. L’av-versario da combattere è in questo momento Publio Clodio,
24 Primo piano
57 Cicerone, In Catilinam, I, 3. Spurio Melio, ricco cavaliere che si sarebbeprocurato il favore della plebe mediante distribuzioni di grano (cfr. Livio, Aburbe condita, 4, 14), appartiene a una galleria di figure esemplari, e in parte in-ventate, di sovversivi, da richiamare alla memoria come esempi negativi (cfr.Brunt, The Fall of the Roman Republic cit., p. 51).
58 Cicerone, Pro Sestio, 104.
l’agitatore dei popolari, l’organizzatore di bande armate,l’uomo che non poteva non suscitare «la più grande paura dirivolgimenti (maximus rerum novarum metus)»59, dirà Cice-rone qualche anno dopo, nel discorso in difesa di Milone,responsabile dell’uccisione di Clodio nel 52 a.C. Ora sonoClodio e i suoi seguaci ad essere definiti «agitatori sediziosi(homines seditiosi ac turbulenti)», che cercano di ottenerecon lo strumento della corruzione quel favore popolare che iGracchi si erano guadagnati con le promesse contenute nelleriforme agrarie60. Alla luce della nuova posizione politica diCicerone, il campo delle res novae non comprende piùl’azione dei tribuni della plebe promotori di riforme, defini-sce soltanto la violenza sovversiva dei clodiani. Fra questiultimi, spicca uno dei più ferventi sostenitori del capo deipopolari, un certo Gellio Publicola, uno scialacquatore cheaveva dissipato il patrimonio familiare per i propri vizi e, or-mai ridotto in povertà, viveva nella speranza di un muta-mento della situazione (in spe rerum novarum), mal tolle-rando la pace e la tranquillità dello Stato. Egli era perciò unseditiosus, un turbulentus, un concitator. Si tratta di un ritrat-to tipologico, che ha tutti i tratti essenziali di quello dell’agi-tatore di popolo per eccellenza, Catilina, che qualche annodopo sarà disegnato da Sallustio. Questo ritratto tipologicorivela i segni di un duplice procedimento di stilizzazione cheriguarda i soggetti che aspirano alla novità e al cambiamento,e che cristallizza sia gli epiteti con cui essi vengono denomi-nati sia la descrizione della loro personalità. Tale stilizzazio-ne, che sul piano letterario si traduce in una topica ricorren-te, presuppone l’esistenza, all’interno del linguaggio politi-co, di un repertorio di motivi propagandistici riguardanti leres novae e i loro fautori. L’ipotesi è rafforzata da due testi-monianze di grande importanza per la ricostruzione del di-battito e della polemica politica negli ultimi anni della re-pubblica. In un’epistola indirizzata nel 46 a.C. a Giulio Ce-sare al potere, il cui autore è quasi certamente Sallustio, aturbare l’ordine costituito (movet composita) e a cercare no-vità (res novas) è «una mente malvagia che ha preso la via delmale (animus ferox prava via ingressus)»61. Sallustio a suavolta, in un pamphlet rivolto contro di lui dopo il 43 a.C. daun autore ignoto, preziosa testimonianza della diffusione
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 25
59 Cicerone, Pro Milone, 34.60 Id., Pro Sestio, 104 sgg.61 Sallustio, Epistulae ad Caesarem, I, 6.
della libellistica diffamatoria, una delle armi con cui si com-batteva negli ultimi anni della repubblica romana una guerraanche «di parole»62, viene descritto come esponente di unafazione politica che era «una concentrazione di tutti i vizipossibili, un’accozzaglia di parricidi irreligiosi e senza pudo-re, che avevano perso ogni reputazione ed erano noti soloper la sfrenatezza dei loro vizi e per il desiderio di rivolgi-menti (cupiditate rerum novarum)»63. L’aspirazione alle resnovae diventa polo d’attrazione di una vera e propria «anti-società»64; attorno al progetto di innovazione e di cambia-mento concepito da un soggetto singolo si coagula un sog-getto collettivo: nella Roma repubblicana questo soggettocollettivo è, per definizione, la plebe.
Sempre denominata, con epiteto formulare, rerum nova-rum cupida, irrazionale e agitata da passioni elementari,massa di manovra per agitatori e nemici dello Stato, la plebeè uno dei soggetti protagonisti della monografia di Sallustiosu Catilina: la plebe come grande soggetto indifferenziato(omnino cuncta plebes); la plebe di Roma che per desideriodi rivolgimenti sosteneva i piani sovversivi di Catilina65; laplebe sobillata e aizzata contro il Senato dai tribuni, allettatacon elargizioni e promesse da demagoghi che intendevanosconvolgere lo Stato66; la plebe che, una volta scoperta lacongiura, con la stessa facilità con cui per desiderio di resnovae aveva favorito Catilina volta le spalle a quest’ultimo eporta alle stelle il suo principale accusatore Cicerone67; laplebe dell’Etruria, anch’essa desiderosa di cambiamenti, sul-la quale fanno leva i congiurati per arruolare nuovi seguaci68.All’interno della digressione sulle cause del malcontentodella plebe e sui motivi della potenzialità eversiva che in essasi era accumulata, nei capitoli centrali dell’opera69, si troval’analisi più acuta e più articolata che ci sia giunta dall’anti-chità dei soggetti sociali che aspirano al cambiamento. Laplebe, osserva Sallustio, si comportava come d’abitudine,
26 Primo piano
62 «A war of words», secondo la definizione di Brunt, The Fall of the RomanRepublic cit., p. 49.
63 Pseudo-Cicerone, Invectiva in Sallustium, 18.64 Cfr. C. Lévy, Rhétorique et philosophie: la monstruosité politique chez
Cicéron, in «Révue des Études Latines», 76, 1998, pp. 139-57 (in particolare,analisi dell’«antisocietà» costituitasi attorno a Catilina).
65 Sallustio, Bellum Catilinae, 37, 1.66 Ivi, 38.67 Ivi, 48, 1; 57, 1.68 Ivi, 28, 1.69 Ivi, 36-39.
desiderando un cambiamento della situazione per insoffe-renza di quella presente70; ma a Roma in quegli anni, fra l’80e il 60 a.C., ad essa si erano aggregati altri soggetti, che perragioni diverse speravano tutti in un cambiamento: perso-naggi corrotti e criminali provenienti da altre parti d’Italia,ricchi che avevano dissipato il loro patrimonio, militari arri-visti incoraggiati dalle fortunate carriere politiche e finanzia-rie dovute alla vittoria di Silla, agricoltori che abbandonava-no le campagne impoverite sperando di arricchirsi, gli eredidelle vittime delle proscrizioni sillane, ancora esclusi per leg-ge dalle cariche politiche. Il desiderio di res novae viene in-dividuato come fattore patogeno primario nella diagnosi enell’analisi eziologica di quella crisi della repubblica romanache viene senz’altro definita come una malattia (morbus,malum), una vera peste (tabes). In questo quadro patologicol’ansia di rivolgimenti, tradizionalmente propria della plebe,sembra contagiare tutti, ed è su di essa che fanno leva tribu-ni, demagoghi, avventurieri mossi da interessi personali, fin-ché interprete del desiderio di res novae si fa Catilina, l’uo-mo corrotto che cerca di sovvertire l’ordine istituzionale so-lo per salvarsi dal proprio disastro economico71.
Le testimonianze prese in esame, tutte appartenenti adun periodo compreso fra il 63 e il 43 a.C., ci portano a unaconclusione: il tema delle res novae, dei cambiamenti reali,possibili o temuti dell’ordine esistente, mostra la sua più lar-ga diffusione, ed insieme la maggiore varietà di soggetti, dicontesti e di obiettivi cui si riferisce, nel clima politico dellatarda repubblica. La politica imperiale rivela uno scenariomutato. Soggetto principale di aspirazione alle res novae di-ventano, da una parte, gli eserciti:
Roma era piena di truppe non abitualmente di stanza: repartitrasferiti dalla Spagna, dalla Germania, dalla Britannia, dall’Illirico:enorme riserva per azioni sovversive (ingens novis rebus materia),che non parteggiava per un individuo in particolare, ma era sem-plicemente pronta a seguire chi osasse di più72.
Così Tacito descrive la situazione del 69 d.C., l’annodell’instabilità seguita alla destituzione di Nerone; ed ag-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 27
70 Ivi, 37, 3: Nam semper in civitate, quibus opes nullae sunt, bonis invident,malos extollunt, vetera odere, nova exoptant, odio suarum rerum mutari omniastudent, turba atque seditionibus sine cura aluntur, quoniam egestas facilehabetur sine damno: cfr. supra, p. 19.
71 Ivi, 39, 3: sed ubi primum dubiis rebus novandi spes oblata est; 39, 6: quo-scumque moribus aut fortuna novis rebus idoneos credebat.
72 Tacito, Historiae, 1, 6, 2.
giunge che erano soprattutto i pretoriani ad essere propensiai rivolgimenti (miles urbanus [...] pronus ad novas res).Dall’altra parte, soggetto complementare e in stretta relazio-ne con le masse irrequiete di soldati, vi sono i capi militariche tramano per il potere: la rivolta dei Batavi, all’inizio delprincipato di Vespasiano, destinata ad allargarsi a tutta laGermania, viene fomentata da Giulio Civile, che fa leva sulloro malcontento per dare inizio all’attuazione del suo ten-tativo di rivolta (novare res hoc modo coepit)73. Ma nella sto-riografia di età imperiale è presente una lunga galleria di per-sonaggi che tentano di realizzare cambiamenti contro gli im-peratori regnanti: dal proconsole d’Africa Lucio Pisone inTacito74 al Procopio di Ammiano Marcellino75. La stilizza-zione delle situazioni e la formularità del linguaggio relativoalle res novae, già evidenti nelle testimonianze di età repub-blicana, risultano ancora visibili nella descrizione in Ammia-no di un certo Valentino, autore nel 369 di un tentativo di ri-volta contro Teodosio: un uomo arrogante (superbi spiritushomo), nemico della pace, portato alla novità e al pericolocome un animale malvagio (quietis impatiens ut malefica be-stia, ad res perniciosas consurgebat et novas), che, spintodall’impeto sempre crescente della sua immensa cupidigia(crescente flatu cupiditatis immensae), istigava gli esuli e isoldati promettendo ricompense allettanti (exsules sollicita-bat et milites illecebrosas pollicendo mercedes)76. Il ritratto ti-pologico di questo «Catilina del basso impero» mostra tuttii tratti di una retorizzazione dei soggetti del cambiamentoche si inserisce in una tradizione fissatasi da tempo. Ma segià nella tarda repubblica le res novae erano diventate ogget-to di slogan propagandistici, nel tardo impero esse sopravvi-vono come un fossile linguistico staccato dalle dinamiche edai conflitti della lotta politica: un cliché stereotipato al pun-to che «tramare res novae» era diventato un generico capod’accusa utilizzato per eliminare personaggi scomodi77.
28 Primo piano
73 Ivi, 4, 14, 1; cfr. anche Annales, 3, 12, 2 (l’esercito corrotto da Pisone) e 12,44, 5 (gli Armeni sobillati da Radamisto); Svetonio, Vita Augusti, 49, 2 (l’esercitogratificato da Augusto per prevenire la sua propensione alle res novae); VitaGalbae, 11, 1 (l’esercito sobillato da Ninfidio Sabino); Vita Vitellii, 7, 3(l’esercito, sempre incline alle res novae, favorisce Vitellio).
74 Tacito, Historiae, 4, 49, 1.75 Ammiano Marcellino, Historiae, 26, 5, 8: Procopius in res surrexerat
novas (questo riferimento alla sollevazione del 365 contro Valente è anticipatoin 17, 14, 3: Procopius tunc notarius, qui postea ad res consurrexerat novas).
76 Ivi, 28, 3, 3.77 Cfr. per esempio Tacito, Historiae, 4, 38, 1 (falsa diceria sulle trame di L.
Pisone); Annales, 2, 27, 1 (accusa a Libone Druso); 15, 35, 2 (Torquato Silano
Nella storia della rappresentazione delle res novae rima-ne tuttavia una costante: la genericità del desiderio o del ten-tativo di «cambiare le cose». La novità viene indicata comenegativa in sé e per sé, indipendentemente dal progetto cheanima i tentativi di introdurla; i vari soggetti portatori o in-terpreti di istanze di cambiamento non vengono presentaticome dotati di un progetto alternativo rispetto all’ordineesistente, ma sembrano limitarsi a volere sconvolgere que-st’ordine. Era lo sconvolgimento in quanto tale che suscitavapaura nei difensori delle istituzioni e delle tradizioni repub-blicane, provocando la loro dura reazione. Così come unagenerica difesa contro possibili rivolgimenti di potere guida-va le strategie repressive dei vari imperatori contro la richie-sta di res novae. Ancor prima che la realizzazione di uncambiamento, i ceti dirigenti di età repubblicana e poi le éli-tes imperiali sembrano aver temuto e combattuto l’aspira-zione stessa al cambiamento.
Ma quella che è stata chiamata «paura delle res novae»78
aveva anche una radice più profonda. Come abbiamo già os-servato, le nostre testimonianze collocano molto spesso leres novae entro un contesto caratterizzato da un intreccio diemozioni. Il repertorio formulare entro il quale esse vengo-no evocate coincide per lo più con la terminologia con cui lariflessione etica definiva le passioni: desiderio, speranza,paura (cupiditas, spes, metus o pavor). I soggetti che aspiranoalle res novae agiscono spesso sull’onda di altre passioni: ildolore (dolor), l’euforia (gaudium, laetitia), l’odio (odium),l’invidia. Il possibile effetto delle res novae è definito comeun generico «turbamento» mediante verbi, come turbare oconturbare, che ci riportano alla sfera psichica della pertur-batio animi, dell’emozione (il pathos dei greci)79. Le res no-vae, in conclusione, sono innanzitutto, in una percezioneprofonda, un’emozione, un turbamento che può creare unosquilibrio. Si tratta di una percezione che presuppone unmodello organicistico in cui la comunità sociale e politica èassimilata a un organismo vivente esposto al rischio di ma-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 29
nelle calunnie degli accusatores); 16, 7, 2 (Lucio Silano accusato da Nerone);Svetonio, Vita Neronis, 35, 4 (Antonia, figlia di Claudio, fatta uccidere da Ne-rone perché sospettata di tramare res novae); Ammiano Marcellino, Historiae,18, 5, 5 (Ursicino sospettato di fomentare rivolgimenti).
78 È il titolo del capitolo che A. La Penna, Sallustio e la “rivoluzione roma-na”, Milano 1968, pp. 68-158 dedica al Bellum Catilinae di Sallustio.
79 Evidenti coincidenze terminologiche sono rivelate per esempio dal con-fronto con la classificazione stoica delle passioni e la loro denominazione in Ci-cerone, Tusculanae disputationes, 4, 11-4.
lattia, malattia causata a sua volta dalla rottura di un equili-brio80. Questa concezione della comunità come corpo e delcambiamento come fattore patogeno era certamente nell’ar-cheologia del pensiero politico romano: basti pensare al ce-lebre apologo sullo sciopero delle membra contro lo stoma-co con cui nel 494 a.C. Menenio Agrippa aveva convinto laplebe a rientrare dalla secessione sull’Aventino81. Ma nellostesso tempo essa ci riporta alle radici del pensiero politicoantico, alla concezione della polis come corpo82 e alla rappre-sentazione della stasis come malattia (nosos)83.
6. «Vecchio» e «nuovo»: rappresentazioni del conflitto
Torniamo al punto di partenza. Secondo il giudizio sto-riografico vulgato, nella cultura romana il rapporto fra latradizione del mos maiorum e il cambiamento introdottodall’innovazione sarebbe definibile nei termini di una rigidacontrapposizione che individua nel primo termine il model-lo positivo, da mantenere e riprodurre, e nel secondo quellonegativo, da temere e da evitare. Le testimonianze finoraesaminate sembrerebbero confermare quest’ipotesi. La ne-gatività del nuovo appare teorizzata in rapporto ai grandiquadri cosmologici così come alla società; è dimostrata at-traverso il suo frequente collegamento a episodi di disordinesociale, a congiure e a complotti sovversivi; è attribuita apersonaggi tanto negativi da sfiorare la mostruosità; cristal-lizzata in un repertorio di formule propagandistiche; enfa-tizzata nell’espressione linguistica mediante l’assimilazionealle malattie che distruggono il corpo e alle passioni chesconvolgono la psiche. Queste coordinate delimitano unospazio interamente chiuso, all’apparenza, alla novità e alcambiamento.
30 Primo piano
80 Cfr. per esempio Sallustio, Bellum Catilinae, 36, 5: tanta vis morbi atqueuti tabes.
81 Cfr. L. Bertelli, L’apologo di Menenio Agrippa: incunabolo della‘Homonoia’ a Roma?, in «Index», 3, 1972, pp. 224-34.
82 Sull’assimilazione di corpo e città nella cultura greca cfr. G. Cambiano,Patologia e metafora politica, in «Elenchos», 2, 1982, pp. 219-36; M. Vegetti,Metafora politica e immagine del corpo nella medicina greca, in Id., Tra Edipo eEuclide. Forme del sapere antico, Milano 1983, pp. 41-58.
83 Cfr. S. Gotteland, La cité malade chez les orateurs grecs de l’époqueclassique, in Fondements cit., pp. 237-51. Sul lessico medico come strumento dirappresentazione dei mali che affliggono il corpo sociale cfr. J. Jouanna, Causeset crises chez les historiens et les médecins de l’époque classique, ivi, pp. 217-35.
Tuttavia, malgrado una cultura profonda segnata dalla re-sistenza all’innovazione, ricordava Ronald Syme nel passodi Roman revolution da cui ha preso le mosse questa rico-gnizione sulla concezione e sulla pratica della novità presso iromani84, nella storia di Roma si registrano importanti cam-biamenti, sia pur lenti e faticosi. Il giudizio di Syme mostrauna impressionante coincidenza con un’affermazione che silegge in uno storico antico. All’interno del discorso pronun-ciato in Senato a favore della richiesta dei maggiorenti dellaGallia di poter accedere alle cariche pubbliche a Roma, l’im-peratore Claudio aveva adoperato un argomento che Tacitoriferisce con le seguenti parole:
tutto ciò che ora si ritiene antichissimo un tempo fu nuovo (omniaquae nunc vetustissima creduntur nova fuere): le magistrature deiplebei, che si affiancarono a quelle dei soli patrizi, e dopo quelledei plebei quelle dei Latini, e dopo quelle dei Latini quelle di tuttigli Italici. Anche questa cosa diventerà antica, e ciò che oggi ponia-mo sotto la tutela degli esempi del passato sarà citato a sua voltacome esempio (inveterascet hoc quoque, et quod hodie exemplistuemur inter exempla erit)85.
Nel tempo dunque le novità si erano imposte, in un pro-cesso di successive acquisizioni, e queste novità si erano pro-gressivamente trasformate, fino a costituire fonte di esem-plarità e a presentarsi come tradizione. Prima i plebei, poi iLatini, poi gli Italici avevano avuto accesso alla carriera poli-tica; ma altri cambiamenti si erano affermati, oltre a questiricordati da Tacito. Non sempre i romani avevano avversatola novità: un’immagine più precisa della varietà dei loro at-teggiamenti di fronte alla novità può essere data da una bre-ve rassegna di episodi significativi.
6.1. I «retori latini»: l’unicità della tradizioneCi è stato riferito che alcune persone hanno istituito un nuovo
tipo di insegnamento (novum genus disciplinae) e che i giovani fre-quentano questa scuola: si sono dati il nome di «retori latini». Ma inostri antenati (maiores nostri) avevano stabilito i contenutidell’educazione che volevano per i propri figli e quali scuole vole-vano che frequentassero. Queste novità, praticate al di fuori dellatradizione e del costume degli antenati, non solo non hanno la no-stra approvazione, ma, in assoluto, non appaiono corrette (haecnova, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, ne-que placent neque recta videntur). Abbiamo deciso pertanto dimanifestare il nostro giudizio sia a coloro che praticano tale inse-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 31
84 Cfr. supra, p. 15.85 Tacito, Annales, 11, 24.
gnamento sia a quelli che hanno preso l’abitudine di frequentarli:non approviamo (nobis non placere).
Se dovessimo indicare la testimonianza dell’antica Romain cui con maggiore evidenza, con una chiarezza addiritturaschematica, si delinea la contrapposizione fra novità da unlato e, dall’altro, tradizione e mos maiorum, penseremmo aquesto testo. Si tratta di un documento ufficiale, riportato daautori di età imperiale che continuavano a essere colpiti dalladurezza di un simile intervento politico nell’ambito delleistituzioni culturali86: è il testo dell’editto emanato dai censo-ri Lucio Licinio Crasso e Cneo Domizio Enobarbo nel 92a.C. contro l’attività delle scuole dei cosiddetti rhetores lati-ni, in cui si praticava un insegnamento della retorica alterna-tivo a quello tradizionale stabilito dagli antenati, più volteevocati nell’arco di poche righe. L’educazione retorica erauna componente fondamentale della formazione culturaledei gruppi dirigenti, essendo l’oratoria una pratica integrantedell’attività politica; l’organizzazione dell’insegnamento eraperciò affidato ai gruppi gentilizi e si svolgeva dapprima, du-rante l’infanzia, in ambito domestico, affidato a maestri gre-ci, in seguito attraverso il tirocinio forense svolto sotto laguida di un autorevole politico. In cosa consisteva l’innova-zione praticata dai cosiddetti «retori latini»?87 Nel fatto dicreare una istituzione alternativa alla famiglia aristocratica,togliendole il monopolio in un settore così delicato dell’edu-cazione delle élites? Nel facilitare grazie all’uso della lingualatina l’apprendimento della retorica, estendendolo ad unpubblico più ampio e divulgandolo al di fuori dei tradizio-nali canali aristocratici? Nel fatto di essere destinata ad adu-lescentes, che non avrebbero dovuto frequentare una scuola,ma dare inizio al loro impegno pubblico, di cui il previsto ti-rocinio forense faceva parte?88 Qualunque fosse il suo reale
32 Primo piano
86 Il testo dell’editto è riportato da Svetonio (De grammaticis et rhetoribus,25, 2) e da Aulo Gellio (Noctes Atticae, 15, 11, 2).
87 È stata formulata più di un’ipotesi in proposito: una rassegna in E.S.Gruen, Studies in Greek Culture and Roman Policy, Leiden-New York-København-Köln 1990, pp. 158-92 e in M.T. Luzzatto, Lo scandalo dei “Retorilatini”. Contributo alla storia dei rapporti culturali fra Grecia e Roma, in StudiStorici», 43, 2002, pp. 301-46. Sulla possibile implicazione politica della scuola,alla luce del legame fra il suo fondatore Plozio Gallo e il partito di Gaio Mario,e sul suo possibile rapporto con l’emergere di una fazione di accusatoriprofessionali cfr. J.M. David, Promotion civique et droit à la parole: L. LiciniusCrassus, les accusateurs et les rhéteurs latins, in «Mélanges de l’École françaisede Rome» 91, 1979, pp. 135-81; Id., Le patronat jiudiciaire au dernier siècle dela République Romaine, Roma 1992.
88 Cfr. Luzzatto, Lo scandalo cit.
contenuto, l’iniziativa era stata comunque sentita come unradicale attacco al mos maiorum. Ma ciò che rende ancor piùinteressante il documento è il fatto che la novità venga con-dannata non solo perché comporta una violazione al mosmaiorum, ma perché rischia di sostituire la consuetudinecon un’altra (iis qui eo venire consuerunt), perché contienein sé una consuetudine alternativa che potrebbe instaurarsisenza controllo né approvazione, sostituendo la regola vi-gente, quella stabilita dagli antenati. Non potrebbe essercitestimonianza più netta della chiusura dei gruppi dirigentiromani verso la novità, resa ancor più evidente dall’essenzia-lità burocratica di un atto ufficiale, che sancisce con una for-mulazione secca l’incompatibilità fra antico e nuovo, l’im-possibilità per quest’ultimo di avere spazio all’interno di unacomunità schiacciata sul proprio passato, in cui l’autorità ela legge si identificano con la tradizione.
6.2. La novità come sconvolgimento: i Baccanali
Dell’atteggiamento e delle strategie antiinnovative deigruppi dirigenti romani abbiamo almeno un altrodocumento ufficiale: il decreto con cui nel 186 a.C. il Senatoaffidò ai consoli in carica un mandato eccezionale perrisolvere una situazione ritenuta di estremo pericolo per loStato. L’attacco repressivo era rivolto contro un nuovo cultoreligioso, ma non è un caso che la procedura straordinariaaffidata ai consoli fosse stata denominata quaestio declandestinis coniurationibus: il culto dionisiaco dei Baccanali,importato dalla Grecia e diffusosi rapidamente aggregandoun largo numero di adepti fra plebei e aristocratici, frauomini e donne, era stato assimilato, nella percezione deigruppi dirigenti, ad una cospirazione politica (coniuratio)89.Coniurationes furono senz’altro definite le riunioni segretenotturne degli iniziati90, così come questi ultimi furono defi-niti congiurati91; e la violenta, sanguinosa azione con cui ilculto fu represso fu condotta come se si dovesse soffocare
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 33
89 La repressione dei Baccanali e il senatusconsultum del 186 a.C. sono og-getto di numerosissimi studi. Alla ricca ed esauriente trattazione di J.-M. Pailler,Bacchanalia: la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie, Roma 1988 ag-giungiamo il riesame critico di Gruen, Studies in Greek Culture cit., pp. 34-78.
90 Così Livio, Ab urbe condita, 39, 14, 6 riferisce i timori espressi in senatonel corso del dibattito che precedette l’approvazione del decreto: patres pavoringens cepit [...] ne quid eae coniurationes coetusque nocturni [...] periculiimportarent.
91 Oltre a Livio, Ab urbe condita, 39, 14, 10 (qui coierint coniuraverintve),si veda l’altra fonte che riporta il testo del decreto, l’iscrizione di Tiriolo, IL-LRP 511 (l. 13: neve posthac inter sed conioura[se]).
un complotto contro lo Stato92. L’ampio resoconto che leg-giamo in Livio (39, 8-18), costruito attorno a termini abitua-li nelle descrizioni di rivolte politiche e di sollevazioni po-polari (coniuratio/coniurare e tumultus), rispecchia senzadubbio la rappresentazione dei Baccanali costruita dai grup-pi dirigenti, che si esprimeva attraverso la semantica delle resnovae (non a caso, osserviamo di sfuggita, alcuni tratti delracconto liviano coincidono con quello sallustiano dellacongiura di Catilina): una rappresentazione che portava ilcontrassegno della negatività del nuovo. Nella quale, innan-zitutto, i Baccanali erano assimilati a una malattia che colpi-va il corpo sociale, diffondendosi come una epidemia93; ali-mentavano la formazione patologica di un secondo popolo,di una vera e propria antisocietà94; contenevano una concen-trazione di tutte le peggiori azioni e di ogni delitto95; suscita-vano reazioni emotive, soprattutto paura96. In realtà, il Sena-to non aveva fondati motivi di temere che gli adepti al cultodionisiaco si preparassero a sfidare il controllo dello Stato oa promuovere una sollevazione politica o che mirassero asconvolgere l’ordine sociale. Ma, al di là delle giustificazioniufficiali, vi era una motivazione più profonda alla base diun’avversione tale da provocare una risposta tanto dura. Ilnuovo culto presentava significativi nuclei di estraneità ri-spetto alla tradizione: la sua origine straniera, la sua trasver-salità (uomini e donne, liberi e schiavi, plebei e nobili), lapresenza non marginale delle donne erano elementi di rottu-ra rispetto al mos maiorum. Facendo leva sulla paura irra-zionale della popolazione, agitando lo spettro di uno scon-volgimento tanto radicale quanto generico e imprecisato,sotto la veste chiaramente pretestuosa della congiura dasoffocare, i gruppi dirigenti combatterono una battaglia noncerto contro una ribellione immaginata, ma piuttosto in di-fesa della tradizione, per l’immodificabilità di quest’ultima.È proprio attorno a quest’asse ideologico che nel racconto
34 Primo piano
92 Cfr. Gruen, Studies in Greek Culture cit., p. 47: «the consul and senatelabelled the cult’s activities as coniuratio, thereby to assimilate it in the publicmind to subversion and insurrection».
93 Livio, Ab urbe condita, 39, 9.1: labes [...] velut contagione morbi; 39, 16,3: crescit et serpit quotidie malum, iam [...] ad summam rem publicam spectat.
94 Ivi, 39, 13, 14: multitudinem ingentem, alterum iam populum. 95 Ivi, 39, 13, 10: nihil facinoris, nihil flagitii praetermissum; 39, 16, 2:
quidquid libidine, quidquid fraude, quidquid scelere.96 Ivi, 39, 14, 4: pavor ingens; 39, 15, 4: nimium terroris; 39, 15, 8: necesse est
exterreamini; 39, 16, 4: timendi erunt; 39, 17, 4: terror magnus; 39, 17, 5:trepidari coeptum est.
di Livio uno dei consoli, Postumio Albino, costruisce l’ora-zione rivolta al popolo che aveva convocato in assembleaper suscitare la sua paura e assicurarsi così la sua collabora-zione alla campagna repressiva:
quante volte ai tempi dei nostri padri e dei nostri avi fu dato già aimagistrati l’incarico di vietare culti stranieri! Pensavano, quegli uo-mini esperti di diritto divino ed umano, che nulla valesse a distrug-gere la religione quanto sacrificare non secondo il rito nazionale,ma secondo un rito straniero97.
L’episodio dei Baccanali, esemplare come documentodell’ostilità verso il nuovo, può essere assunto nello stessotempo come paradigmatico dell’ambiguità e della contrad-dittorietà che caratterizza l’atteggiamento verso la novità e iconseguenti comportamenti. Lo stesso Senato che mise inatto una spietata persecuzione contro la minaccia di una in-novazione nelle pratiche religiose vent’anni prima, nel 205a.C., nella fase più critica della campagna di Annibale in Ita-lia, aveva accettato l’introduzione del culto della GrandeMadre e il trasferimento dell’idolo della divinità dall’AsiaMinore. Questa apertura, in stridente contrasto con un at-teggiamento prevalente di rifiuto nei confronti di nuovi cultireligiosi, aveva trovato una motivazione formale nell’originedella divinità, proveniente dalla stessa terra da cui era partitoEnea e destinata perciò ad approdare nella stessa terra in cuiera giunto l’eroe fondatore. In questa rappresentazioneideologica l’introduzione del nuovo culto, favorita in realtàcome possibile elemento di coesione sociale in un momentocritico della politica estera, trovava giustificazione nel passa-to più antico di Roma, nella sua genealogia mitica; e la no-vità finiva per presentarsi come recupero e rivitalizzazionedi una delle radici più lontane della stessa identità romana98.
La vistosa contraddizione tra i fatti del 205 e quelli del186 a.C. rivela che, dietro una ostilità preconcetta nei con-fronti della novità, sempre e comunque ostentata come in-segna ufficiale, i comportamenti non sono univoci, maoscillano dal rifiuto più intransigente a una integrazioneadeguatamente motivata. Il grado di assorbimento del nuo-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 35
97 Ivi, 39, 15, 8 s.: quotiens hoc patrum avorumque aetate negotium estmagistratibus datum, uti sacra externa fieri vetarent [...] iudicabant enimprudentissimi viri omnis divini humanique iuris nihil aeque dissolvendaereligionis esse, quam ubi non patrio, sed externo ritu sacrificaretur.
98 Sulle motivazioni reali e sulle giustificazioni ideologiche dell’importa-zione del culto della Magna Mater cfr. Gruen, Studies in Greek Culture cit.,pp. 5-33.
vo sembra in rapporto con la possibilità di essere rivestitodi antico, di presentarsi come aderente alla tradizione. Tan-to più ci si può aprire al nuovo quanto più si riesce a mo-strarne un legame con il passato, quanto più la discontinuitàpuò essere manipolata fino ad assumere l’aspetto di una ras-sicurante continuità.
6.3. I comandi speciali: valore del «precedente» e legittima-zione del nuovo
«Ma il motivo principale della mia opposizione eccoloqui: non si deve introdurre nessuna novità che contrasti coni modelli e le consuetudini stabilite dagli antenati» (ne quidnovi fiat contra exempla atque instituta maiorum). L’obie-zione del senatore Q. Lutazio Catulo alla proposta di legge,presentata nel 66 a.C. dal tribuno della plebe Manilio, cheattribuiva a Pompeo il comando supremo della guerra con-tro i re del Ponto e dell’Armenia, così sinteticamente riferitada Cicerone99, ripete un classico argomento antiinnovativo,ripreso dal repertorio tradizionale. Il punto di vista manife-stato dal senatore non rinvia però, in questo caso, a una po-sizione compatta: il Senato era diviso fra quanti si oppone-vano all’affidamento a Pompeo dei comandi speciali, consi-derati una violazione di regole consolidate, e quanti eranoschierati a favore della proposta. Il discorso pronunciato daCicerone, che fu determinante per l’approvazione della leg-ge, contiene una sorprendente difesa della novità, del tuttoinaspettata da parte di un senatore, e per di più di un coeren-te difensore del mos maiorum e, come abbiamo visto, avver-sario delle res novae. La strategia persuasiva di Cicerone èarticolata in una serie di argomentazioni, tutte trattedall’esperienza del passato di Roma. Il primo riferimento èad un passato remoto e indistinto, quello dei maiores, i quali«in tempo di pace hanno sempre obbedito alla tradizione(consuetudini paruisse), è vero, ma in tempo di guerra hannosempre adattato le loro decisioni alle nuove circostanze(semper ad novos casus temporum novorum consiliorum ra-tiones accommodasse)»100; seguono due esempi concreti of-ferti dalla storia recente di Roma, i comandi militari supremiattribuiti in deroga alle regole a Scipione Emiliano e a GaioMario101. Risposte eccezionali a situazioni eccezionali, questi
36 Primo piano
99 Cicerone, Pro lege Manilia (de imperio Cn. Pompeii), 60.100 Ibid.101 Riferimenti al comando supremo dell’ultima guerra contro Cartagine e di
quella contro Numanzia, affidato a Scipione senza che fossero trascorsi i previsti
due precedenti autorizzano già, secondo Cicerone, un’ulte-riore eccezione alla regola, una innovazione rispetto alla tra-dizione. Ma l’argomento decisivo è tratto dal passato più re-cente, dalla biografia dello stesso Pompeo: il quale, per averearruolato un esercito privato, per aver governato due pro-vincie in età inferiore a quella minima per entrare in Senato,per avere riportato un trionfo senza ricoprire una regolaremagistratura, per avere ricevuto il comando della guerra inSpagna da proconsole al posto dei due consoli, rappresentadi per sé un precedente, un esempio vivente di attuazionedella novità in violazione delle regole (in ipso Cn. Pompeio[...] quam multa sint nova)102, al punto da potersi affermareche tutte le innovazioni introdotte a memoria d’uomo nonsono tante quante nella persona del solo Pompeo103. Innova-zioni numerose e rilevanti104, tutte deliberate per iniziativadel Senato e con l’approvazione di quello stesso senatore,Catulo, che ora contrasta la «novità» in discussione105. L’ar-gomentazione è scandita da una sequenza di interrogazioniin cui è ripetuto in modo martellante il concetto di novitas,declinato in tutte le sue possibilità sinonimiche: quid tamnovum [...]? quid tam praeter consuetudinem [...]? quid verotam inauditum [...]? quid tam inusitatum [...]? quid tam sin-gulare [...]? quid tam incredibile [...]?106 Questa difesa del no-vum da parte di un difensore del mos maiorum, ripetiamo, èa prima vista sconcertante; ma ridurla a una prova di abilitàoratoria e/o ad un calcolo opportunistico di Cicerone signi-ficherebbe sminuire il valore di una testimonianza preziosa,che ci permette, caso forse unico nel panorama della lettera-tura di età romana sopravvissuta, di assistere a una messa inscena del conflitto sul nuovo107. Un conflitto che, per unavolta, non si svolge fra un soggetto istituzionale difensoredei valori e delle pratiche della tradizione, da un lato, e,dall’altro, un soggetto esterno portatore di istanze di novitàe di cambiamento, ma è interno a un gruppo dirigente che, a
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 37
dieci anni fra i due consolati; e a Gaio Mario, eletto console cinque volte di segui-to per poter condurre la guerra contro Giugurta e poi quella contro Cimbri eTeutoni.
102 Ibid.103 Ivi, 62: quae in omnibus hominibus nova post hominum memoriam
constituta sunt, ea tam multa non sunt quae in hoc uno homine videmus.104 Ivi, 63: haec tot exempla tanta ac tam nova.105 Ivi, 60: in ipso Cn. Pompeio in quo novi constitui nihil volt Q. Catulus.106 Ivi, 61 sgg.107 Come tale, è stata valorizzata da C. Moatti, La raison de Rome. Naissance
de l’esprit critique à la fin de la République, Paris 1997, pp. 36 sgg. e da Bettini,Mos, mores e mos maiorum cit., pp. 268 sgg.
differenza che in altre situazioni prima ricordate, non assu-me un atteggiamento unanime. La divisione non era certa-mente sulla legittimità di praticare il nuovo o, ancor piùastrattamente, sulla definizione del concetto di nuovo; sitrattava di una contrapposizione fra parti politiche. Ma è si-gnificativo che tale scontro sia riportato a uno scontro sullalegittimazione del nuovo. Che sia proprio un difensore delmos maiorum come Cicerone a sostenere l’opportunitàdell’innovazione è dunque tutt’altro che sorprendente, e di-mostra piuttosto il valore relativo di questa strategia legitti-mante. Una strategia costruita attorno a due linee essenziali:in primo luogo, la giustificazione della novità in quanto ne-cessaria risposta a una situazione eccezionale. Alla fine, at-traverso il varco così aperto, decisive innovazioni si sarebbe-ro imposte, prima fra tutte la cosiddetta rivoluzione augu-stea. Altra fonte di legittimazione erano i precedenti, i casiesemplari forniti dalla storia. Questo aggancio al passato at-tenuava, quasi disattivava la carica della novità, rendeva ilnuovo simile all’antico, lo inseriva nel quadro della tradizio-ne, con una operazione di «travestimento» che la politicaaugustea avrebbe portato a conseguenze estreme108.
6.4. Il nuovo come antico: AugustoCon quella fase di trasformazioni radicali che a torto o a
ragione109 è stata chiamata rivoluzione augustea trova la suapiù compiuta realizzazione questa forma di presentazionedel nuovo come una sorta di riproposizione dell’antico. Stu-di recenti hanno posto l’accento sul fatto che il nuovo asset-to costituzionale non fu solo risultato di abili meccanismi diingegneria istituzionale, che consentissero di mantenere lestrutture esistenti introducendo sostanziali innovazioni, maanche di un’operazione culturale che mirava fra l’altro a de-lineare una nuova rappresentazione del tempo storico, in cuil’idea stessa di passato e di futuro e, conseguentemente, lasemantica dell’antico e del nuovo assumevano una nuovaconfigurazione110. L’ambiguo intreccio fra nuovo e antico
38 Primo piano
108 Sul travestimento insistono, fin dal titolo, A. von Müller, J. von Ungern-Sternberg, Das Alte als Maske des Neuen: Augustus und Cosimo de’ Medici, inDie Wahrnehmung cit., pp. 67-89.
109 Cfr. supra, p. 17 e nota 36.110 Sul mutato rapporto con l’antico in età augustea, all’interno di una
diversa concezione della temporalità, cfr. Moatti, La raison cit., pp. 47 sgg.; sullarappresentazione del tempo come uno degli ambiti in cui si attuò la rivoluzioneculturale augustea cfr. A. Wallace-Hadrill, Mutatio morum: the idea of acultural revolution, in The Roman Cultural Revolution, a cura di T. Habinek eA. Schiesaro, Cambridge 1997, pp. 3-22.
che caratterizza il periodo augusteo, e che si concretizza nelprogetto di rivitalizzazione dei valori morali e dello stile divita della Roma arcaica (fino al ritorno dell’età dell’oro au-spicato dai poeti dell’epoca), ha trovato una sintetica defini-zione in alcune formulazioni paradossali, come quella di«revolution entirely conservative»111. Del resto, Augustostesso mostrava piena consapevolezza dell’opera di media-zione culturale da lui svolta facendo corrispondere all’intro-duzione delle novità un recupero di tradizioni del passato,quando si vantava, in un capitolo centrale della sua autobio-grafia, di avere riportato in vita molti modelli lasciati dagliantenati ma ormai quasi svaniti dalla memoria dei contem-poranei (multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostrosaeculo reduxi), e di aver fatto ciò emanando nuove leggi (le-gibus novis)112. L’esemplarità del mos maiorum viene riaffer-mata attraverso una nuova legislazione: exempla maiorum[...] legibus novis. La formulazione augustea si risolverebbein un gioco di parole di puro gusto retorico se non vi co-gliessimo piuttosto la testimonianza di una riconfigurazionedella semantica del nuovo. E, soprattutto, di un mutamentonella percezione della novità rispetto alla tradizione, che nonè da attribuirsi soltanto al progetto del princeps, ma anche adaltri attori, e che non sfuggì alla storiografia antica. Ricor-diamo l’efficace sintesi della «rivoluzione» attuata da Augu-sto che si legge in Tacito:
cominciò la sua ascesa graduale, concentrando su di sé le funzionidel senato, dei magistrati e delle leggi; e nessuno gli si oppose, per-ché i più aspri avversari erano morti in guerra o a causa delle pro-scrizioni, e gli altri aristocratici vedevano accrescersi il loro benes-sere ed elevarsi il loro prestigio, per cui, avvantaggiatisi in seguitoal nuovo assetto (novis ex rebus), preferivano la tranquillità dellasituazione attuale ai pericoli di quella antica (tuta et praesentiaquam vetera et periculosa mallent)113.
Aver condotto i gruppi tradizionalmente conservatori apreferire il nuovo Stato (le tanto temute e avversate res no-
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 39
111 F. Millar, The First Revolution: Imperator Caesar, 36-28 BC, in LaRévolution Romaine après Ronald Syme cit., pp. 1-38.
112 Res gestae divi Augusti, 8. Il riferimento è al complesso di leggi emanateal fine di moralizzare la vita pubblica e privata (fra i commenti più recenti aquesto passo, A.M. Ferrero, in Gli Atti Compiuti e i frammenti delle opere diCesare Augusto Imperatore, a cura di L. De Biasi e A.M. Ferrero, Torino 2003,pp. 164 sgg.). Sull’«amalgama del vecchio con il nuovo» come punto centraledel programma di Augusto, a partire dal capitolo autobiografico in questione,cfr. F. Guizzi, Augusto. La politica della memoria, Roma 1999, pp. 50-1.
113 Tacito, Annales, 1, 2, 1.
vae) al vecchio: questo l’effetto sorprendente della «rivolu-zione» augustea. Nell’analisi di Tacito questo mutamentoviene descritto attraverso una singolare inversione di sensonel rapporto tradizionale fra l’antico, che va ad assumere ilsegno negativo del rischio e dell’incertezza, e il nuovo, che sifa garante dell’ordine e della tranquillità; ed è significativoche questo rovesciamento di opzioni sia attribuito a queglistessi soggetti che avevano a lungo difeso i valori della tradi-zione contro il cambiamento. In forma semplificata, e perciòforse ancora più esplicita, l’atteggiamento del Senato sarà co-sì ricordato in Dione Cassio: «alcuni senatori ormai detesta-vano il governo repubblicano in quanto portatore di rivolte(stasiodes), approvavano un cambiamento costituzionale(metàstasis tes politeias) ed erano favorevoli a Ottaviano»114.Il lessico adottato, che è quello codificato del conflitto politi-co, rivela il ribaltamento rispetto alla rappresentazione tradi-zionale del cambiamento: non più rivolgimento negativo, marimedio da opporre alla stasis delle istituzioni repubblicane.
Se tale ribaltamento può essere letto come esito di unadelle due tendenze riconoscibili nella valutazione e nellarappresentazione diffusa del nuovo, quella che trovava perquest’ultimo una legittimazione nell’antico, rimane tuttaviain piedi, nell’ambiguo contesto augusteo, anche l’altra ten-denza, riassumibile in una ostilità e in un giudizio negativoriguardo alla novità. Illuminante a questo proposito una te-stimonianza conservata in una fonte del IV secolo d.C. Rac-conta Macrobio che una volta l’imperatore Augusto si trovòa dover difendere con le seguenti parole Catone, l’anticesa-riano suicida a Utica, divenuto ben presto un simbolo dellalibertas repubblicana, della difesa dell’ordine e del rifiuto diogni sovvertimento, contro un personaggio che ne criticavala troppo rigorosa intransigenza: «chiunque non desideri ilmutamento dello stato vigente è un cittadino e un uomomodello». Questo il commento di Macrobio: «così, con unabattuta, lodò Catone e nello stesso tempo, nel proprio inte-resse, avvertì che nessuno aspirasse a cambiare la situazione(ne quis adfectaret res novare)»115.
Se dunque a fronte dei cambiamenti effettivi è possibileadottare una strategia giustificativa che tende a riassorbirel’innovazione entro la tradizione, parallelamente la novità ri-mane al centro di una rappresentazione negativa che qui si
40 Primo piano
114 Dione Cassio, 53, 11, 2.115 Macrobio, Saturnalia, 2, 4, 18.
riassume emblematicamente, ancora una volta, nello spettrodelle res novae.
Questa retorica negativa della novità era destinata a so-pravvivere a lungo, anche fra gli eventi sconvolgenti e leprofonde trasformazioni culturali che avrebbero segnato isecoli successivi alla «rivoluzione» augustea. Un’idea di que-sta tenace sopravvivenza può essere data da due testimo-nianze significative. La prima risale al 197 e appartiene a unoscritto apologetico di Tertulliano:
in ogni aspetto della vita sociale è sotto gli occhi quanti cambia-menti abbiate apportato rispetto ai vostri antenati (quantum amaioribus mutaveritis) nelle abitudini di vita, perfino negli usi ali-mentari e nel linguaggio, poiché ciò che è antico lo mettete da par-te come stantio (pristinum ut rancidum relegatis). La tradizioneantica è dappertutto al bando (exclusa ubique antiquitas), nelle vo-stre attività, nelle funzioni pubbliche; la vostra autorità ha sop-piantato l’intera autorità degli antenati (totam auctoritatem maio-rum vestra auctoritas deiecit), e continuate a elogiare a parole leantichità (vetustates), e a ripudiarle nei fatti116.
Una delle accuse più frequentemente rivolte ai cristianiera quella di innovare allontanandosi dalla tradizione; e laloro stessa religione era stata definita superstitio nova ac ma-lefica117. L’argomentazione apologetica di Tertulliano respin-ge questa accusa, ritorcendola contro i pagani: modificandocontinuamente le loro leggi e i costumi di un tempo, questiavrebbero distrutto l’antica tradizione (deletam in vobis an-tiquitatem recognosco)118.
La seconda testimonianza, cui abbiamo già accennato119,ci riporta a una grande svolta storica, segnata dalla conver-sione di Costantino. A distanza di alcuni decenni, nel 360,l’imperatore Giuliano, come riferisce Ammiano Marcellino,«attaccò la memoria di Costantino, accusando quest’ultimodi essere stato un innovatore, che aveva sconvolto l’ordinerappresentato dalle vecchie leggi e dalla tradizione ricevutadall’antichità»120.
Romano, «Allontanarsi dall’antico» 41
116 Tertulliano, Ad nationes, 1, 10, 5-7.117 Da Nerone, come ricorda Svetonio in Vita Neronis, 16, 2. Per l’accusa
frequente di rottura innovativa rispetto alla tradizione cfr. il commento al passodi Tertulliano di A. Schneider, Le premier livre Ad nationes de Tertullien, Ro-ma 1968, p. 208.
118 Tertulliano, Ad nationes, 1, 10, 4. Sull’importanza di questo capitolo ter-tullianeo per la storia del concetto di mos maiorum richiamò l’attenzione Maz-zarino, Il pensiero storico classico cit., III, p. 254.
119 Cfr. supra, p. 22.120 Ammiano Marcellino, 21, 10, 8: tunc et memoriam Constantini, ut
novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit.Anche in Zosimo (V d.C.) si trova l’accusa mossa a Costantino di essersiallontanato dalla tradizione (2, 29, 4: ton patríon).
Sia Tertulliano per accusare i pagani sia Giuliano per ac-cusare la svolta cristiana di Costantino attingono al tradizio-nale repertorio di motivi antiinnovativi e ad un lessico codi-ficato. Era quanto rimaneva di una vicenda culturale moltopiù complessa, non riducibile, come abbiamo visto, a pocheparole d’ordine contro la novità e il cambiamento. Eppurel’argomentazione retorica contro la novità, così come il les-sico negativo del cambiamento e dell’innovazione, sarebbe-ro giunti, indipendentemente dal piano dei mutamenti ancheprofondi realmente avvenuti nel corso dei secoli, fino allesoglie della modernità.
42 Primo piano