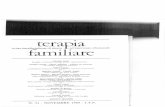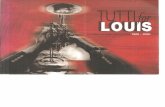Filosofia e scienza nelle biblioteche del Cinquecento: una prospettiva pinelliana
Novità sul "gentil huomo famoso pittore" Giovanni Maria Morandi, in Prospettiva. Rivista di storia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Novità sul "gentil huomo famoso pittore" Giovanni Maria Morandi, in Prospettiva. Rivista di storia...
147 148Luglio-Ottobre 2012
ProspettivaRivista di storia dell’arte antica e moderna
Università degli Studi di SienaUniversità degli Studi di Napoli ‘Federico II’Centro Di
ProspettivaRivista di storia dell’arte antica e moderna
Nn. 147-148, Luglio-Ottobre 2012
Università degli Studi di SienaUniversità degli Studi di Napoli ‘Federico II’Centro Di della Edifimi srl
Rivista fondata daMauro Cristofani e Giovanni Previtali.Redazione scientifica:Fiorella Sricchia Santoro, direttoreFrancesco Aceto, Benedetta Adembri,Giovanni Agosti, Alessandro Angelini,Alessandro Bagnoli, Roberto Bartalini,Evelina Borea, Francesco Caglioti, LauraCavazzini, Lucia Faedo, Aldo Galli, CarloGasparri, Adriano Maggiani, ClementeMarconi, Marina Martelli, Anna MariaMura, Vincenzo Saladino, Fausto Zevi.Segretari di redazione:Benedetta Adembri, Alessandro Bagnoli.Consulenti:Paola Barocchi, Sible L. de Blaauw,Caroline Elam, Michel Gras, Nicholas Penny,Victor M. Schmidt, Carl Brandon Strehlke,Andrew Wallace-Hadrill, Paul Zanker.Redazione:Università degli Studi di Siena,Dipartimento di Archeologiae Storia delle Artivia Roma 56, 53100 Siena,e-mail: [email protected]
Direttore responsabile:Fiorella Sricchia Santoro© Copyright: Centro Di, 1975-1982.Dal 1983, Centro Di della Edifimi srl,Lungarno Serristori 35, 50125 Firenze.ISSN: 0394-0802Stampa: Alpi Lito, Firenze, giugno 2014
Pubblicazione trimestrale.Un numero € 26 (Italia e estero).Arretrati € 29.Abbonamento annuo, 4 numeri€ 100 (Italia), € 150 (estero).C.c.p. 53003067.
Distribuzione, abbonamenti:Centro Di della Edifimi srlvia de’ Renai 20r, 50125 Firenze,telefono: 055 2342668, fax: 055 2342667,[email protected]
Autorizzazione del Tribunale di Firenzen. 2406 del 26.3.75.Iscrizione al Registro Operatoridi Comunicazione n. 7257.
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Sommario
Saggi:
Francesco Aceto Spazio ecclesiale e pale di ‘primitivi’ in San LorenzoMaggiore a Napoli: dal ‘San Ludovico’ di SimoneMartini al ‘San Girolamo’ di Colantonio. II 2
Gianluca Amato I ‘Crocifissi’ lignei di Giuliano, Antonio e Francescoda Sangallo 62
Contributi:
Fernando Gilotta Un nuovo cratere del Pittore Fould 124
Alessandro Angelini Jacometto Veneziano e gli umanisti. Proposta per il‘Ritratto di Luca Pacioli e di Guidubaldo da Montefeltro’del Museo di Capodimonte 126
Antonio Mazzotta ‘Ritratti’ veneziani per Jacometto, Marco Basaitie Andrea Previtali 150
Carlo Catturini Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco di Milano:una citazione di Luca Pacioli per la “Sala delle Asse”ovvero la “camera dei moroni” 159
Alessandra Pattanaro Un ‘Ritratto d’uomo’ di Girolamo da Carpi da casaSpreti in Ravenna 167
Stefano L’Occaso Lattanzio Gambara a Maguzzano 173
Elena Rame Un disegno di Lattanzio Gambara per il ‘Martiriodi Santo Stefano’ a Vimercate 178
Gennaro De Luca Novità sul “gentil huomo famoso pittore”Giovanni Maria Morandi 180
Fabio Sottili Il ‘Ritratto del conte di Bonneval’ di Violante Siriese le turqueries dei Sansedoni 192
English Abstracts 198
180 [Contributi]1. Giovanni Maria Morandi: ‘Predica di San Francescodi Sales’. Modena, Banca popolare dell’Emilia.
È il 2 febbraio 1708 quando, regnante inRoma Clemente XI Albani, l’allora ottan-taseienne Giovanni Maria Morandi decidedi affidare ad un notaio le sue ultime vo-lontà, o per dirla con le parole dello stes-so, di “disporre per tempo della mia rob-ba”.1 Il “buon vecchio pittore”,2 da oltremezzo secolo attivo nella città dei papi,dichiarando la nullità di ogni precedentetestamento, riconosce quale unico benefi-ciario di ogni suo avere la Congregazionefiorentina di San Filippo Neri. In diverseoccasioni l’artista si era trovato a lavorareper la comunità romana alla Vallicella ri-traendo, tra gli altri, il preposito France-
sco Marchese, nipote di Gian LorenzoBernini e i padri Sebastiano Resta e Ma-riano Sozzini,3 oppure celebrando con leproprie tele la figura del Neri che, insie-me al Santo eponimo (“S: Gio: Batta”), ri-conosce nel documento quali “suoi Avvo-cati”.4 La designazione dei religiosi fio-rentini come eredi universali, in parte di-retta conseguenza dell’assenza dei piùprossimi congiunti,5 può essere letta pro-prio alla luce della forte devozione mani-festata in più occasioni per il Santo fon-datore dell’Oratorio. Il Morandi aveva, in-fatti, potuto vivere da vicino la fondazio-ne della Congregazione dei filippini a Fi-renze dal momento che suo nonno “Lio-nardo” e la famiglia di questi abitavano invia dell’Anguillara (“Quartiere di SantaCroce”),6 nei pressi del nascente comples-so di San Firenze e anche persone a luimolto vicine condividevano questo speci-fico culto: è il caso del maestro GiovanniBilivert che “fra gli altri santi ebbe parti-colar divozione a san Filippo Neri” a cui“fece un ritratto” 7 e della famiglia Chigi,che molto si spese per l’affermazione del-l’artista fiorentino a Roma e possedeva, amo’ di reliquia, un armadio in noce ap-partenuto al Santo.8
Nell’atto testamentario il pittore ordina lafondazione “d’una cappellina perpetuanella Chiesa delli molto RR: PP: di SanFirenze9 […] col peso d’una messa quoti-diana in perpetuo da celebrarsi in dettachiesa da proprio Cappellano”10 e che “sidebbano vendere tutti i miei mobili, ar-genti, quadri, et ogni altro esistente che sitroverà in mia casa, et il prezzo che se necaverà rinvestire in tanti luoghi di montecamerali”,11 al fine di ricavarne denaroper “l’elemosina del d:o Cappellano” e“per maritare o monacare l’Oneste di Ca-sa Morandi fiorentine”. Nella necessità diavere prontezza dell’intero patrimonio invista della vendita, gli esecutori testamen-tari Filippo Filisboni, computista di casaSalviati, e l’allievo Pietro Nelli, definiti“amici, confidenti, ed affezionati” ma an-che “informatissimi” dei suoi interessi,stilano un inventario legale, accluso al te-stamento che ci ragguaglia sui beni pos-seduti dall’artista.12 Più che a una colle-zione d’arte le opere registrate, perlopiùcopie, dovevano rispondere a esigenze distudio e di confronto e sono da intendersicome tracce sedimentate di una pluride-cennale carriera. L’inventario, parzialmen-te pubblicato per la sezione relativa ai ri-tratti,13 rappresenta quindi una preziosissi-ma miniera di notizie per arricchire la co-noscenza del Morandi sul piano umano eprofessionale e ricostruirne con maggioreprecisione la fisionomia artistica, in quan-to sintesi e riflesso dei suoi gusti e interes-
Novità sul“gentil huomofamoso pittore”GiovanniMaria MorandiGennaro De Luca
[Contributi] 1812. Giovanni Maria Morandi: ‘Transito della Vergine’.Roma, Galleria Borghese.
il vescovo francese, ma anche il fatto cheil pontefice registra nel suo diario quoti-diano, alla data 19 luglio 1654, di aver ri-cevuto dal Morandi un dipinto raffiguran-te appunto il Sales.18 Senza eccedere nellespeculazioni, si potrebbe ipotizzare che,proprio sulla base delle qualità apprezza-te in questa tela, il papa senese possa es-sersi convinto di coinvolgere anche il“pittore del duca Salviati”19 nel ciclo a te-ma mariano della Pace e che la doppia do-nazione, collegata a opere di notevole ri-lievo per l’avvio della sua carriera a Ro-ma, sia un estremo atto di gratitudine chel’artista offre ai mecenati di una vita, re-
(fig. 1; Modena, Banca popolare dell’E-milia) e il “Transito della Vergine”16 (fig.2; Roma, Galleria Borghese). È propriocon questi due soggetti sacri che si aprel’attività pubblica di Giovanni Maria Mo-randi: all’iconografia della morte dellaMadonna è, infatti, dedicata la sua primapala d’altare, realizzata su diretta com-missione papale per la chiesa di SantaMaria della Pace al tempo del “bellim.tonovo”17 sovrinteso da Pietro da Cortona.Allo stesso modo, anche l’altro quadro èriferibile ad un ambito strettamente chi-giano considerando, non solo la grandedevozione che Alessandro VII nutriva per
si, ma anche perfettamente complementa-re alla comprensione del suo stile.L’elenco si apre menzionando alcuni di-pinti non numerati e, quindi, estranei allapratica di alienazione del patrimonio. Sitratta, come chiarisce il compilatore, ditre doni lasciati ad altrettanti esponentidella famiglia Salviati: il duca AntonioMaria, il cardinale Alamanno e CaterinaZeffirina Colonna. Oltre a un olio su ra-me, donato a quest’ultima e dedicato alsoggetto della “Meditazione del Signorefatta dall’Angeli”,14 è da richiamare l’at-tenzione sulle altre due tele: “un S.Franc.o di Sales in atto di predicare”15
182 [Contributi]
sponsabili del suo avvicinamento alla fa-miglia Chigi e del conseguente successoin campo professionale che gli era deriva-to. È la “dimostrazione in segno delle mieinfinite obbligazioni verso l’Eccellenzaloro, et Ecc.ma casa”, dichiara nel testa-mento del 1708 nel quale si rivolge al du-ca Antonio Maria chiamandolo “mio par-ticolarissimo Sig:re, e Pa(dr)one”. Eglidimostra così di essere pienamente consa-pevole dell’importanza della protezione edell’appoggio finanziario concessoglidalla famiglia Salviati, senza i quali in-dubbiamente avrebbe molto faticato peraffermarsi nel difficile mercato artisticoromano perché, come giustamente rileva-va Giovanni Battista Passeri, “per verità asollevare il nome è necessario ad ognibuon principio la protettione di personag-gi, li quali con amorevolezza si compiac-cino di beneficare alcuno”.20
Sebbene la sua attività professionale siaquasi completamente legata alle chiese ealle collezioni romane, le radici di Gio-vanni Maria Morandi, come quelle dellafamiglia Salviati, sono profondamente to-scane. È a Firenze che il pittore nasce il30 aprile 1622, ricevendo il battesimo ilgiorno seguente,21 ed è nella capitalegranducale che, ancora ragazzino, maturaun precoce avvicinamento alla pratica ar-tistica nel corso dell’esperienza di paggiopresso la corte medicea.22 Quanto poi allavera e propria educazione professionaledel giovane, le uniche basi affidabili dacui trarre notizie sono le prime biografiedalle quali sappiamo che questi “dal Coc-capani ebbe da fanciullo i principi dell’ar-te”23 e acquisì “sotto la direzione di Gio-vanni Bilivert col copiar molte opere suepratica de’ colori”.24 Segnando una cesuratra “imparato ch’egli ebbe in patria il di-segno” e l’impratichirsi del mezzo pittori-co nella bottega bilivertiana, anche LionePascoli, pur senza citare il Coccapani, pa-re essere a conoscenza del fatto che l’ap-prendimento della tecnica artistica da par-te del Morandi si sia svolto in due fasi. Laprima di queste porta il fiorentino a pa-droneggiare l’arte grafica, campo nelquale Sigismondo Coccapani fu ricono-sciuto grande esperto al punto da esserericordato con l’appellativo di “Maestrodel disegno”.25 Il passaggio dall’approccioal disegno tecnico al tempo della pagge-ria, alla bottega del Coccapani, vicino aiGranduchi proprio per via delle sue com-petenze in campo architettonico e inge-gneristico,26 dovette sembrare al ragazzouna naturale evoluzione del suo percorsodi studi. L’assenza di testimonianze pitto-riche o grafiche non consente comunque
di valutare le conseguenze di questo ini-ziale apprendistato, dal quale dovette de-rivare solo i rudimenti dell’arte.Dallo studio presso un continuatore dellericerche cigolesche, Giovanni Maria passaalla bottega di un altro artista formatosiagli insegnamenti del Cardi, ovvero Gio-vanni Bilivert. L’esperienza di AgostinoMelissi al seguito del caposcuola fiorenti-no può risultare chiarificatrice di un cur-sus comune a molti giovani e forse ancheal nostro artista: questi “al principio sitrattenne in quella scuola, disegnando dalrilievo […] copiando prima piccoli quadridel maestro, e poi figure intere”27 fino ache l’esercitazione si estese anche a un’o-pera del “maestro del maestro”, il Cigoli.28
La presenza nell’inventario del Morandi diuna “tela da testa rappresentante un S.Francesco copia del Civoli”29 crea un ine-vitabile parallelo al racconto baldinuccia-no e conferma ulteriormente la natura diquesto percorso formativo basato sul co-piare, che doveva altresì riservare un oc-chio di riguardo anche ai grandi artisti delsecolo precedente comeAgnolo Bronzino,una cui replica “rappresentante un Christoin mezza figura” è elencata nelle proprie-tà del pittore. La consultazione dell’esiguopatrimonio di disegni tradizionalmente ca-talogati con l’attribuzione al Morandipresso il Gabinetto degli Uffizi ci permet-te di incontrare una delle sue prime operegrafiche, una copia della figura del SanGiovanni Battista (fig. 3) protagonista del-la ‘Predica nel deserto’ di Jacopo Chimen-ti nella cappella Gianni in San Nicola Ol-trarno.30 Vista l’enorme quantità di artistitransitati nell’atelier di Giovanni Bilivert,molti dei quali conosciuti solo per il loronome, sarebbe però arbitrario provare aidentificare nel corpus del Maestro, so-prattutto in parti circoscritte delle sue ulti-me composizioni, testimonianze primitivedello stile di Giovanni Maria Morandi.L’operazione risulterebbe ancor di più ri-schiosa e passibile di errori se si conside-ra che quando questi accede alla schieradei suoi allievi, l’anziano pittore affetto dauna grave malattia aveva quasi del tuttoabbandonato l’attività artistica e, per ov-viare alle difficoltà di salute e per rispon-dere alla costante domanda della clientela,aveva impiegato massicciamente l’operadi collaboratori, tra i quali, occupa un ruo-lo di primo piano il già menzionato Ago-stino Melissi che “non solamente fu suodiscepolo e seguace per gran tempo, masuo confidentissimo”.31 Nonostante le fon-ti ricordino il solo caposcuola quale suomaestro, è fondamentale riconoscere l’im-portanza che anche il meno illustre Melis-si, responsabile della bottega bilivertiana aseguito della morte del pittore (1644), de-
ve aver avuto per la formazione del Mo-randi. Allo stato attuale degli studi non èpossibile cogliere tracce dell’educazioneche questi ricevette in patria cercando ci-tazioni dirette nel suo operato. Molto piùgenericamente si può provare a ipotizzareche l’artista acquisì dal Bilivert prima, edal Melissi poi, i segreti del mestiere com-prendenti non solo una piena competenzadella tecnica pittorica ma anche il modusoperandi del caposcuola affermato, allaguida di un’affollata e industriosa bottega.
Com’è evidente poco ci resta della produ-zione giovanile di Giovanni Maria Mo-randi. Ciò però non esclude che sia statoproprio in questi anni, ancora nell’alveobilivertiano, che questi abbia gettato lebasi per la sua futura carriera come con-fermano le prime opere di cui l’artista èresponsabile, note a noi solo per via do-cumentaria. La precoce datazione 1645,la stessa di una sua partecipazione in qua-lità di testimone ad una causa che vedevaimputato il maestro Agostino Melissi,32 ri-portavano due tele pendant raffiguranti lesante martiri ‘Agata’ e ‘Caterina d’Ales-sandria’,33 da intendersi come una presen-tazione del proprio talento alla nobile fa-miglia dei Salviati che subito dopo lo co-involge, insieme ad altri artisti (AgostinoMelissi, Lorenzo Martelli e BartolomeoPoggi), in un ciclo a tema mitologico de-stinato alla villa di Ponte a Badia, neipressi di Firenze. Il Morandi, autore inquesta occasione di un’‘Incoronazione diArianna’,34 si propone ai suoi committen-ti come pittore in cerca di affermazione enon ancora autonomo, tanto che il registrodi cassa di Jacopo Salviati indica lui e ilMelissi come “allievi del Bilivert”.35
Non deve trascorrere molto tempo daquesti primi contatti che il duca Jacopo,dopo aver tentato inutilmente di convince-re Francesco Furini a spostarsi a Romaper lavorare al suo servizio,36 raggiunge ilconvincimento che sia più adeguato alleproprie esigenze un giovane artista comeil Morandi, non legato a nessun protetto-re, e quindi completamente disponibilealle sue richieste.37 Nel 1648 lo troviamoper la prima volta attestato nella sua nuo-va patria dal censimento pasquale degliStati d’Anime.38 Il suo arrivo in città è dacollocarsi entro gli ultimi dodici mesi an-tecedenti e, più precisamente dopo il gen-naio, quando l’artista è ancora a Firenze,scrutinato e ammesso all’Accademia deldisegno.39 L’anno 1648 si configura, quin-di, come decisivo e di svolta, compren-dendo non solo il trasferimento in unanuova città ma anche l’inizio ufficiale delrapporto di lavoro alle dipendenze dellafamiglia Salviati, la cui lista dei salariati
approfondimento dell’antico, suggeritoda uno studio raffigurante l’‘Ercole Far-nese’ (inv. 14242, Parigi, Louvre, Dépar-tement des arts graphiques),42 il processodi aggiornamento stilistico prosegue indi-rizzando il Morandi verso la pittura piùrecente. Le note inventariali relative allacollezione dell’artista, per la rilevantequantità di copie tratte da opere di grandimaestri, risultano essenziali per chiariremeglio a quale repertorio artistico eglipossa essersi ispirato in questi primi anni
sco ‘Cristo risorto’ di Santa Maria sopraMinerva. È un momento cruciale questo,per la formazione del Morandi, il cui lin-guaggio artistico viene letteralmente pla-smato secondo i gusti e le richieste deimecenati come dimostra l’acquisto nel1648 da parte di Jacopo Salviati di una te-la di Tiziano per la propria collezione edell’occorrente necessario perché “Gio:M(ar)ia Pittore” la replicasse.49 Siamo al-
[Contributi] 183
romani. Appoggiandosi a modelli ben af-fermati, Giovanni Maria rivolge la propriaattenzione a un’ideale accademia diexempla che riconosce in Raffaello, di cuil’inventario menziona riproduzioni della‘Trasfigurazione’ e della ‘Galatea’,43 laprincipale autorità a cui guardare insiemeal Correggio e a Tiziano, dal quale deriva“un quadro di cinque palmi in circa rap-presentante un Baccanario”.44 Quanto alsuo secolo, il Morandi mostra coerente-mente un interesse esclusivo verso Anni-bale Carracci, della cui attività romanacopia la “Santa Margherita” dipinta per lacappella Bombasi in Santa Caterina dei
entrambe nella basilica di San Pietro.47 Inassenza di prove pittoriche, ancora unavolta è la produzione grafica di GiovanniMaria Morandi a fornirci un tassello perla ricostruzione di questa prima fase ro-mana dell’artista. Si fa riferimento a duedisegni, uno ripreso dalla ‘Santa Barbara’dipinta da Giuseppe Cesari per Santa Ma-ria in Traspontina48 (fig. 4, inv. 2736, Fi-renze, Gabinetto Disegni e Stampe degliUffizi), e l’altro rappresentante l’episodiodel ‘Domine, quo vadis?’ (inv. 1351, Pari-gi, Louvre, Département des arts graphi-ques), in cui la figura di Gesù risulta for-temente suggestionata dal michelangiole-
menziona il suo nome proprio a partire daquesta data.40
Giovanni Maria Morandi non perde l’oc-casione di trarre profitto del privilegio of-fertogli dai suoi protettori sollevandolo daogni preoccupazione economica e si dedi-ca allo studio, al disegnare e al copiare“l’opere più insigni”.41 Grazie ad un con-tatto diretto con le testimonianze artisti-che presenti in Roma, il pittore si costrui-sce, come un autodidatta, una propria cul-tura, adattandosi pienamente al gusto im-perante nell’Urbe e segnando una nettacesura sul piano stilistico con le primeesperienze fiorentine. Dopo un iniziale
3. Giovanni Maria Morandi: ‘Studio di San GiovanniBattista’. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degliUffizi (inv. 2229).
4. Giovanni Maria Morandi: ‘Studio di Santa Barbara’.Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (inv.2736).
funari,45 e verso la prima generazione di“Eroi carracceschi”, come ebbe a definir-li Sebastiano Resta,46 ovvero Guido Reni,Francesco Albani ma anche GiovanniLanfranco e il Guercino, ricordati rispetti-vamente per “la Navicella di S. Pietro” e“la copia della Santa Petronilla” collocate
Nella città lagunare il Morandi vive uncontatto diretto con la celebrata tradizionedei coloristi veneti, a partire da Tizianodal quale copia il “Martirio di S. Pietromartire da Verona”53 nella chiesa dei San-ti Giovanni e Paolo e il ‘Miracolo del ma-rito geloso’ del ciclo della scuola del San-to a Padova,54 ma anche Paolo Veronese,modello per la sua ‘Cena in casa di Levi’ridotta “in cinque pezzi di quadri”55 e Tin-toretto, studiato nella Scuola grande diSan Rocco.56 È lo stesso storiografo peru-gino a sintetizzare le conseguenze di que-sto articolato viaggio, sottolineando comeil Morandi “s’attaccò al gusto, alla forza,
ed al sapore del colorito Lombardo”.57 Fi-nalmente arricchitosi di una conoscenzadiretta e più capillare dell’arte italiana,nel 1653 Giovanni Maria Morandi torna aRoma dove le competenze acquisite e laprofonda conoscenza delle diverse manie-
la vigilia del decisivo viaggio in “Lom-bardia”, economicamente e idealmentesostenuto dal duca50 come ultimo traguar-do per il compimento del processo di ac-quisizione di uno stile pienamente “roma-no”. Alla ricerca delle maniere dei “Sena-tori del Disegno e della Pittura Italiana”,51
il triennio trascorso nelle città dell’Italiasettentrionale, si configura come un per-corso a ritroso alle origini della scuola ro-mana e permette al Morandi il raggiungi-mento della piena maturazione nella qua-lità di professore ed esperto d’arte. Lapuntuale cronaca di Lione Pascoli tracciatappa per tappa l’itinerario seguito lungo
re gli consentono di operare non solo inqualità di pittore ma anche di consulenteper l’acquisto di opere d’arte.58 La famaraggiunta in questo campo è tale che Pie-tro de Sebastiani, pur senza citarne espli-citamente il nome, riferisce a lui nel suo“Viaggio curioso de’ palazzi e ville piùnotabili di Roma”, il merito della ricchez-za della quadreria del Palazzo Salviati al-la Lungara,59 e scrive: “Hora il Duca Re-gnante si trova belle, e stimate pitture dihuomini grandi […] sotto la buona Curadi un suo gentil huomo famoso pittore,che lo accompagna con cortesia grande”.60
La considerevole quantità di riproduzioninon originali dei capolavori dell’arte delpassato nella collezione del Morandi a cuisi è finora fatto cenno, non deve far di-menticare la presenza, seppur minoritaria,di opere che si possono riferire alla suadiretta attività oppure al coinvolgimentodei suoi collaboratori. Sulla scorta delcensimento operato, si può provare a di-stinguere le tele menzionate con riferi-mento all’artista come quadri finiti, di-pinti “sbozzi” o non conclusi, copie “ri-tocche” e, infine, semplici copie dal Mo-randi. Quest’ultima sezione, comprenden-te con molte probabilità le opere non au-tografe compiute dagli allievi per venireincontro alle richieste del mercato, gettanuova luce sulla schiera di artisti attivinella bottega di Giovanni Maria Moran-di.61 La compresenza di copie e copie “ri-tocche” da parte del titolare della “Scoladi pittori”62 lascia intendere che per luifosse pratica frequente affidare le repli-che delle sue opere illustri o più ricercatedagli intendenti, ai collaboratori più stret-ti, ritagliando per sé, in alcuni casi, ilcompito di realizzare delle varianti icono-grafiche o compositive.63 Menzionandocopie o modelletti dei suoi dipinti, l’in-ventario segna tutte le tappe della carrieradel Morandi, comprovando l’abitudinedel pittore di conservare in bottega traccedel proprio percorso artistico: dalle primeopere per i Salviati,64 alle pale d’altare de-gli anni cinquanta,65 a cui fanno seguito letante commissioni chiesastiche che lo im-pegnarono tra l’ottavo decennio del seco-lo e gli ultimi anni della sua esistenza.66
Emerge, poi, la produzione ritrattistica,con effigi di aristocratici, di cardinali67 esoprattutto di papi.68 Quest’ultima tipolo-gia di opere è senza dubbio quella che hamaggiormente contribuito all’affermazio-ne e alla diffusione del nome del pittorepresso collezionisti e illustri committenti,rendendolo uno specialista del genere, alpunto da risultare, per quantità di pontefi-ci ritratti, cinque (Alessandro VII, Cle-mente IX, Innocenzo XI, Innocenzo XII eAlessandro VIII), secondo soltanto a Gio-184 [Contributi]
5. Giovanni Maria Morandi: ‘Ritratto di Clemente IX’.Firenze, Galleria Palatina (inv. 2631).
l’asse viario Roma-Ancona-Bologna, sul-la via Flaminia, oltre la quale raggiungen-do il Nord Est Italia, visita Verona, Vicen-za, Padova e Venezia, perché come solevadire il Passignano “chi Venezia non videnon si può lusingare di esser pittore”.52
[Contributi] 185
vanni Battista Gaulli per il quale posaro-no sette papi. Eppure esigua è la quantitàeffettivamente rintracciata di esemplariautografi dipinti dal fiorentino. Utile ri-sulta dunque il supporto offerto dalle in-cisioni. Dalle tre stampe di Giuseppe Te-stana, Albert Clouwet e Conrad Waumanssi può provare, ad esempio, a riconoscerecome originali una tela conservata nellacollezione romana Sforza Cesarini eun’altra da me identificata nei Depositidella Galleria Palatina (fig. 5). Quest’ulti-mo quadro, catalogato come effigie di Ur-bano VIII (inv. 2631, 73 x 58 cm) e attri-buito a un non meglio specificato artista
di ambito fiorentino, ritrae Clemente IX amezzo busto.69 Gli studi hanno negli anniprovato a riconoscere tracce del ritrattopapale del Rospigliosi in una tela conser-vata nelle collezioni del Museo di Roma,70
la cui attribuzione non trova però giudiziconcordi,71 e in un dipinto ubicato nel pa-lazzo Chigi di Ariccia.72 La qualità pittori-ca di entrambe queste opere fa però pro-pendere per una realizzazione di bottega,non giustificando la mano del Maestro, ilcui diretto intervento è invece riconosci-bile nel ritratto fiorentino. Gli evidentiproblemi conservativi del manufatto (tela
6. Giovanni Maria Morandi: ‘Studio per Ritratto diInnocenzo XII’. Londra, British Museum, Departmentof Prints and Drawings.
7. Giovanni Maria Morandi: ‘Ritratto di Innocenzo XII’.Firenze, Poggio Imperiale (n. cat. 00196018).
slargata e consumata ai lati, graffi sullasuperficie, macchie) non possono deviarel’attenzione dalla buona qualità con cui ècondotto il dipinto, vicino ai ritratti diGiulio Rospigliosi nelle vesti di cardinaleche lo stesso Morandi aveva creato (Ro-ma, Galleria Nazionale d’Arte antica;Montpellier, Musée Fabre). Raffinata è lapennellata delicatamente liquida e pasto-sa, soprattutto nella definizione della ber-retta e del pizzetto, con soluzioni di deri-vazione gaullesca già adottate nel ‘Ritrat-to di Mario Chigi’ (Ariccia, Palazzo Chi-gi). Ben rilevata con sottilissimi passaggidi piano è la mozzetta, di solito delineata
con grande semplicità e posta in secondopiano rispetto alla cura riservata alla resafisionomica del volto.Alla luce delle affinità con un disegnoraffigurante il solo volto del pontefice(fig. 6, Londra, Department of Prints andDrawings, British Museum)73 e con le in-cisioni derivanti dal ritratto del Morandi(opera di Benedetto Farjat, David Louis eNicolas Habert), si può, a mio avviso, ri-conoscere anche un’altra sicura prova au-tografa dell’artista in un dipinto ubicato aFirenze presso la villa di Poggio Imperia-le, catalogato come opera di Carlo Marat-ta (fig. 7) e raffigurante papa InnocenzoXII Pignatelli. È stato proposto di identi-ficare un esemplare del dipinto morandia-
no, in una piccola tela (68,5 x 58 cm) con-servata presso il Palazzo Chigi di Ariccia,in cui Francesco Petrucci riconosce unabuona qualità degli impasti nel viso.74 Adifferenza del ritratto ariccino, il quadrodi Poggio Imperiale riprende con maggio-re fedeltà i tratti fisionomici dell’anzianopontefice tramandatici dalle versioni inci-se e dallo studio grafico.75 Oltre che per lapregevole qualità, il dipinto, documentoritrattistico della fase più tarda del pittorefiorentino, esprimente austerità e aulicorigore, è ancora più significativo per ilcontributo apportato al catalogo dell’arti-sta: è la seconda volta, dopo Clemente IX,
che, nella sua lunga carriera, il pittore hamodo di ritrarre un pontefice prima “inhabito di cardinale”76 e, in un secondotempo, nelle vesti di capo della Chiesa. Lanostra conoscenza della ritrattistica papa-le del Morandi registra così l’importanteacquisizione dell’ultima incursione del-l’artista in questo genere.
Un’analisi complessiva dell’attività crea-tiva di Giovanni Maria Morandi, com-prendente pale d’altare, ritratti e quadri dadevozione privata, molti dei quali non an-
186 [Contributi]
servì fino alla decrepità, perché non ebbemai uopo d’occhiali neppur nel quadro,che faceva per Firenze, e la Flagellazionedi N.S. vi figurava”.82 Il dipinto al quale loscrittore fa riferimento è quello menzio-nato nel testamento del 1715, in quantodonato alla Congregazione fiorentina diSan Filippo Neri come arredo per la lorochiesa83 e indicato nell’inventario col nu-mero 252.84 Per via delle enormi dimen-sioni rispetto agli altari esistenti però, es-so non trovò subito una collocazione defi-nitiva, e venne dunque riposto in sagrestiadove rimase fino a che la nuova cappellacostruita su progetto di Zanobi del Rosso
cora emersi, ci pone di fronte al problemadi non poco conto della sua fortuna criti-ca.77 Le principali fonti della storiografiaartistica contemporanea al pittore78 offro-no un suo profilo biografico,79 attestandocon i propri elogi un valore artistico rico-nosciuto fino agli ultimi anni della suaesistenza sia nell’attività ritrattistica nellaquale primeggiò insieme a Giovanni Bat-tista Gaulli e a Ferdinand Voet, sia nellarealizzazione di dipinti a soggetto sacro.80
Il frequente uso della valutazione “assaiusato e vecchio” nelle stime dei beni delpittore ribadisce l’immagine fornitaci dal-le biografie che ricordano una persona as-
sai umile e frugale e dalla proverbiale lon-gevità, tanto da essere presa a modellodall’archiatra papale, il medico GiovanniMaria Lancisi (1654-1720), per dimostra-re “la bonta dell’aria di Roma”.81
Nel tracciare un profilo di Giovanni Ma-ria Morandi colto negli ultimi anni dellasua esistenza, Lione Pascoli ricorda che“la vista sufficientemente gli serviva, e lo
occasione (fig. 8), è possibile riconoscereil dipinto, ancora oggi ritenuto perduto88
in quanto assente dalla sua collocazioneoriginaria, in una tela conservata presso iDepositi del Museo del Cenacolo di An-drea del Sarto (fig. 9).89 La tela riproducefedelmente l’incisione e, come tutte lestampe realizzate per l’Etruria pittrice,non presenta la composizione riversata.Nonostante il pessimo stato di conserva-zione, emerge da un’analisi attenta delmanufatto la sua elevata qualità nella co-struzione della composizione e nella pre-ziosità cromatica che doveva offrirsi agliamatori al tempo del Morandi. La dram-
maticità dell’episodio evangelico si coglienella costruzione chiasmica che vede Cri-sto ritrarsi e il soldato che lo percuote ca-ricare il colpo volgendosi indietro. Attor-no a loro, in un contesto architettonico al-l’antica (suggerito dal busto di Tiberio,come nell’‘Incoronazione di spine’ di Ti-ziano oggi al Louvre e dalle insegne mili-tari romane purtroppo leggibili solo nel-l’incisione), trovano spazio un gruppo disoldati anch’essi intenti, secondo sapienti
8. Gaetano Vascellini (da Giovanni Maria Morandi):‘Flagellazione di Cristo’. Siena, Biblioteca comunaledegli Intronati.
9. Giovanni Maria Morandi: ‘Flagellazione di Cristo’.Firenze, Depositi del Museo del Cenacolo di Andrea delSarto (inv. 8286).
(1772-6) non venne identificata quale se-de adatta a ospitarlo.85 La pala è pronta-mente menzionata dalle molte guide diFirenze pubblicate tra Settecento e Otto-cento, attente a registrare con particolarecura le vicende della donazione.86 Il ‘Cri-sto flagellato’ di San Firenze è anche l’o-pera scelta da Marco Lastri per rappre-sentare la produzione artistica di Giovan-ni Maria Morandi, elogiato per “la sicu-rezza del pennello”,87 nelle pagine a luidedicate nell’“Etruria pittrice”. Propriograzie alla testimonianza dell’incisionerealizzata da Gaetano Vascellini in questa
[Contributi] 187
molto tempo di una chiara interpretazioneiconografica e catalogata genericamentecome “Scena biblica” (fig. 10),94 fannosupporre che siano state realizzate insie-me, nella medesima occasione e per lostesso committente.Ad un esame attento si può concludereche la tela dal soggetto di difficile ricono-scimento mette in scena il ‘Congedo diCristo dalla madre’ (n. cat. 00117090), unepisodio assente dai Vangeli sinottici ederivante dal trattato medievale delloPseudo-Bonaventura (Meditationi de lapassione del nostro Signore Misser IesuChristo, 1308) che lo pone come origina-
tore della Passione di Gesù. Credo che lapoetica dei sentimenti orchestrati in que-sto quadretto da Giovanni Maria Morandipresenti più di un’episodica affinità conun componimento poetico intorno a Cri-sto che “si licenzia dalla Madre prima diandare a patire” creato dal “dilettante” Ja-copo Salviati95 ed edito nella raccolta disonetti religiosi a tema pasquale Fiori del-l’orto di Gessemani e del Calvario(1667).96 Come nella sacra rappresenta-
variazioni di posa,90 a percuotere Cristoche, così accerchiato, è colto nella suarassegnata sofferenza, riassunta negli oc-chi rivolti al cielo in attesa che “passi via[…] questo calice”. La pala di San Firen-ze, privata della sua sede originaria nellacappella della Flagellazione perché rovi-nata, era giunta a Firenze già in pessimostato nel 1717, tanto da spingere i padrioratoriani ad affidare al pittore GiovanniCamillo Sagrestani un intervento conser-vativo finalizzato a restaurare il dipinto“dove haveva patito”.91 La data della suarealizzazione deve essere avvenuta perquesto in anni molto antecedenti rispetto
alla donazione del Morandi e, in partico-lare, tra il 1710, quando presso il chiostrodi San Salvatore in Lauro per la festa del-la Santa Casa è esposto un “Quadro gran-de d’altare, con la Flagellazione alla co-lonna, del S.r Morandi”, e il 1712, annoriportato sull’‘Album Rensi’, raccolta didisegni del Morandi (Lipsia, Museum derbildenden Kunste) contenente uno studioa matita per una gamba maschile, collega-to da Erich Schleier al particolare omolo-go del ‘Cristo alla colonna’.92 La leggibi-lità e la qualità del dipinto si presentano
oggi fortemente compromesse dai moltistrappi del supporto e dalla vernice in-giallita che mortifica la ricchezza e viva-cità cromatica che alcuni dettagli dellacomposizione paiono suggerire e auspicoche questo studio possa offrire un contri-buto ad una necessaria azione di salva-guardia dell’opera.Di quanto è stato possibile ricostruire del-l’attività di Giovanni Maria Morandi siconoscono soprattutto i ritratti e le grandipale d’altare, mentre ancora parziale è laconoscenza della sua produzione creativaper la devozione e il collezionismo priva-to che, sulla base delle tante citazioni in-
ventariali non dovette essere quantitativa-mente e qualitativamente trascurabile. Lodimostrano i due quadri conservati nellasede fiorentina della Congregazione diSan Filippo Neri.93 La collocazione dei di-pinti confermerebbe un rapporto del Mo-randi con la comunità di San Firenze piùprofondo di quanto sappiamo, giustifi-cando così le decisioni prese nel testa-mento al di là della particolare predilezio-ne del pittore per il Santo dell’Oratorio.Le identiche dimensioni delle due tele (90x 74 cm), di cui una raffigurante l’incon-tro di Gesù con la samaritana presso ilpozzo di Sicar (fig. 11) e l’altra priva per
10. Giovanni Maria Morandi: ‘Congedo di Cristo dallamadre’. Firenze, San Firenze.
11. Giovanni Maria Morandi: ‘Cristo e la samaritana’.Firenze, San Firenze.
188 [Contributi]
L’illustrazione dell’estremo addio di Gesùalla madre messa in scena dall’anzianopittore va, a mio avviso, contestualizzatanell’ultima fase della sua attività e colle-gata alla ‘Flagellazione’: le accomunal’originale medesima sede conservativama anche un’affine presunta datazione,ruotante attorno ai primi anni del secondodecennio del Settecento. Sintetizzandol’ultima esperienza terrena di Cristo, dalcongedo da Maria alla necessaria mortifi-cazione del flagello, le due opere suggeri-scono così la crescente sensibilità dell’ar-tista, con l’avvicinarsi della morte, a que-sti temi, sintetizzata dall’atto di fede pre-sente nel testamento.97
Giovanni Maria Morandi è stato certa-mente un uomo radicato nel suo secolo, lacui fama non è riuscita a coprire la lungagittata dei trecento anni che intercorronotra il suo tempo e il nostro. Nelle produ-zioni della sua pluridecennale esperienza,egli è capace di creare una perfetta sinto-nia con le aspettative della committenza,dimostrando un grande talento nel coglie-re le aspirazioni più profonde dell’aristo-crazia romana ed europea. È lo stesso in-ventario del pittore a creare concreti ri-scontri al racconto dei contemporanei e asuggerire i molti segni di riconoscenza of-fertigli da illustri mecenati nel corso delsuo lavoro come l’“anello di sette dia-manti a’ facciata legati in oro” donatoglidal Cosimo III entusiasta per un ritrattodella “granprincipessa” Anna Maria Lui-sa,98 l’“eccantieretta piccola d’argentocarlino” offertagli “piena di scelti liquori[…] per aver saputo il granduca lo straor-dinario piacere, che prendavavi il Moran-di nel bere il vino diacciato”,99 e la “me-daglia d’oro con l’effigie di S. LeopoldoImperatore” ottenuta probabilmente nelcorso del soggiorno viennese alla corteasburgica, a conclusione del quale “ricevè[…] moltissime finezze”.100 Non bastasse-ro le parecchie menzioni in ambito acca-demico, la “fiorita scuola tenuta in Ro-ma”,101 annoverante personalità di rilievoquali Paolo de Matteis e Francesco Zuc-carelli, nonché la partecipazione all’Arca-dia del Crescimbeni,102 i dati offerti dal-l’inventario presentato in questa sede, trai quali occorre ricordare anche il breve masignificativo accenno alla biblioteca del-l’artista (“Libri diversi in num.o settantad’Istorie Vite di Pittori, e d’Architettu-ra”), attestano ancora una volta il ritrattodi una persona colta, pienamente integra-ta nell’ambiente culturale dell’Urbe, ga-rantendo le fondamenta per un generaleripensamento della figura e della produ-zione autografa di Giovanni Maria Mo-randi.103
zione in versi del suo mecenate, il pittoredelinea questo raro tema iconografico conuna composizione tesa a sottolineare ilgrande patetismo dell’episodio: Maria,madre disperata occupa il primo pianodella scena, circondata di angeli che par-tecipano al suo dolore, mentre sulla sini-stra si allontana, non senza esitazione, ilfiglio (“Madre m’invio là dove un’almaavara,/ ribellatasi al ciel, lacci mi tende:/ove spine, flagelli, ingiurie orrende, Sion-ne ingrata a’ danni miei prepara/ ove perfabbricarmi indegna bara,/ tronchi recide,e a temprar chiodi attende;/ ma quanto,ah, d’ogni pena a me si rende/ la partenzada te più dura e amara!”). La sofferenzamaterna è però composta e dignitosa, tan-to da confondere chi ha catalogato l’ope-ra a considerare la Vergine come dor-miente (“alla novella atroce,/ ella bramò,ma non poteo morire./ Amor la tenne invita a quella voce;/ perché voleale forse ilcuore ferire/ con lancia più crudel pressoalla Croce”). Peculiarità della pittura delMorandi si configura ancora una volta laraffinata costruzione degli affetti che legai protagonisti della scena: la Madonnavolge lo sguardo in una direzione oppostaa quella del figlio, quasi a sfuggire dall’i-nevitabile dolore mentre Gesù, in posizio-ne diametralmente opposta, in atto di al-lontanarsi, cerca con umana debolezza ilvolto rassicurante di Maria.La paternità del pittore fiorentino può es-sere confermata anche dal repertorio difigure e atteggiamenti tipizzati e accade-mizzanti ripetuti costantemente in ognisuo dipinto. In particolare, il piccolo an-gelo che accanto all’inginocchiatoio a cuiè appoggiata, si solleva per avvicinarsi al-la Madonna, pare derivare dal medesimocartone, anche se riversato, del puttinoche offre il cuore palpitante a San FilippoNeri, nella pala d’altare pensata per ilDuomo di Siena. Propria della sensibilitàcreativa del Morandi è anche la necessitàdi circoscrivere lo spazio messo in scenaattraverso la rigorosa definizione prospet-tica del pavimento, caratteristica presenteanche nell’‘Annunciazione’ di Siena (fig.12) e nella ‘Madonna del Rosario’ (Roma,Museo Domenicano di Santa Sabina al-l’Aventino). Una sedia, un cesto e l’ingi-nocchiatoio contribuiscono alla razionali-tà dello spazio e fungono da indicatorispaziali. L’ambientazione dell’episodio èsemplificata e ridotta alla rappresentazio-ne di un interno, definito da arredi archi-tettonici classicheggianti e da un tendag-gio teatrale su cui si apre, attraverso unampio arco, uno squarcio paesaggisticoessenzialmente trattato.
1) Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi indica-to con ASF), Corporazioni religiose soppresse dalgoverno francese, 136. San Firenze, Casa di Preti fi-lippini, Testamento di Giovanni Maria Morandi, fo-gli sciolti. Il documento non registra le disposizionidefinitive del pittore essendo seguito da un testa-mento stilato nel 1715, dal quale non differisce cheper la designazione degli esecutori testamentari Fi-lippo Filisboni e Pietro Nelli in sostituzione di An-tonio Maria Salviati. F. Petrucci, Pittura di ritratto aRoma. il Seicento, Budai, Roma 2008, II, p. 420.2) Così il padre oratoriano Sebastiano Resta chiamail Morandi in una lettera del 20 novembre 1700pubblicata in L. Sacchetti Lelli, Hinc priscae re-deunt artes: Giovan Matteo Marchetti, vescovo diArezzo, collezionista e mecenate a Pistoia (1647 -1704), Aska, Firenze 2005, p. 166.3) Come ricorda Nicola Pio, il Morandi realizzò “inSanti Nereo e Achilleo nel claustro molti fatti diSan Filippo Neri, con alcuni ritratti de’ Padri del-l’Oratorio”. N. Pio, Le vite di pittori, scultori et ar-chitetti, 1724, a cura di C. e R. Engass, BibliotecaApostolica Vaticana, Città del Vaticano 1977, p. 54.4) Si possono ricordare a titolo di esempio la palad’altare per il Duomo di Siena dedicata alla mistica‘Apparizione della Trinità e della Vergine a San Fi-lippo Neri’ e il “S. Filippo Neri […] che mandò aFirenze” (L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori et ar-chitetti moderni, Roma, 1730-36, a cura di A. Ma-rabottini, Electa-Editori umbri associati, Perugia1992, p. 580).5) L. Pascoli, Vite cit., 1730-36, p. 582.6) Il censimento operato nella città di Firenze nel1632 (Descritione del numero delle case e dellepersone della città di Firenze fatta l’anno MD-CXXXII, Biblioteca Nazionale di Firenze, FondoManoscritti, Cod. Pal. E. B. 15. 2 Grandi formati133) ricorda la residenza di “Lionardo Morandi,spazaturaio”, responsabile di un nucleo familiarecomposto di “4 bocche in tutto” di cui due “maschiso. i 15 anni, 2 femmine “so. i 15 anni” e 1 femmi-na minore, nel Quartiere di Santa Croce, in via del-l’Anguillara.7) F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegnoda Cimabue in qua…, 1681-1728, a cura di F. Ra-nalli, Studio per edizioni scelte, Firenze 1974-1975,IV, p. 74.8) F. Petrucci, Alcuni arredi seicenteschi del palaz-zo Chigi di Ariccia nei documenti d’archivio, in‘Studi romani’, 1998, pp. 320-336.9) Come conferma il registro di debitori e creditoridella Congregazione dei padri filippini, il “31Xbre” 1723 si svolge l’ufficiatura della “sua cap-pella”. ASF, Corporazioni religiose soppresse dalgoverno francese, 136. San Firenze. Casa di PretiFilippini, F.9. Debitori e Creditori, p. 451.10) Il pittore chiede un’attenzione particolare perla nomina del primo cappellano, da scegliersi nelnovero dei membri della propria famiglia, indi-cando il “Sig: re D: Gaetano Maria della mia casaMorandi raccomandatomi dal pred:o Monsig:e Ill-mo Salviati”.11) Il registro dei debitori e creditori dei padri ora-toriani di Firenze conferma l’ossequio delle richie-ste del Morandi per gli anni 1719-27. ASF, Corpo-razioni religiose soppresse dal governo francese,136. San Firenze. Casa di Preti Filippini, F.9, Debi-tori e Creditori, p. 442.12) Biblioteca della Scuola Normale Superiore diPisa (d’ora in poi indicato BNSP), Archivio Salvia-ti, Miscellanea I, filza 60, fascicolo 13, Testamento,ed Inventario dell’Eredità del S: Morandi. La natu-ra del documento (prima parte dedicata alle opered’arte e seconda meramente amministrativa) sugge-risce che, anche tenendo conto delle specifichecompetenze, il Filisboni e il Nelli si siano divisi icompiti e che la redazione dell’elenco dei dipintispetti a quest’ultimo, pittore professionista, sodaledel Morandi, e quindi, decisamente affidabile per leattribuzioni avanzate.
12. Giovanni Maria Morandi:‘Annunciazione’. Siena,chiesa della SantissimaAnnunziata.
26) E. Acanfora, Sigismondo Coccapani disegnato-re e trattatista, in ‘Paragone’, 1989, pp. 71-99; E.Acanfora, Sigismondo Coccapani un artista equi-vocato, in ‘Antichità viva’, XXIX, 1990, pp. 11-25.27) F. Baldinucci, Notizie cit., IV, p. 316.28) “Essendovi poi capitato un bel quadro d’unCristo morto, e appresso la Vergine e San Giovanni,di mano del Cigoli […] il Melissi ne fece una copiaper suo studio”. F. Baldinucci, Notizie cit., IV, p.316.29) “Altro da testa rappresentante un S. Francescocopia del Civoli”, BNSP, Testamento cit., c. 10v n.121.30) Il disegno riproduce con attenta fedeltà l’inven-zione dell’Empoli, mostrando l’artista in una fasegiovanile, per noi inedita, ancora legato ai modi eallo stile del Bilivert da cui deriva la perfetta pa-dronanza anatomica.31) F. Baldinucci, Notizie cit., IV, p. 302.32) È proprio attraverso questa vicenda giudiziariache incontriamo per la prima volta il nome del Mo-randi accanto a quello del Melissi, rara testimo-nianza non letteraria della permanenza del pittorealla bottega del Bilivert. R. Contini, Bilivert cit., p.180.33) Già nella quadreria romana dei Salviati (lo con-ferma l’inventario del 1704), i due dipinti risultanodispersi a seguito delle vendite Rospigliosi del1931-2. P. Costamagna, La collection de peinturesd’une famille Florentine établie à Rome: l’inventai-
13) E. Villa, Un episodio sconosciuto della ritratti-stica del ’600, in L’ultimo Bernini, 1665-1680: nuo-vi argomenti, documenti e immagini, a cura di V.Martinelli, Quasar, Roma 1994, p. 152.14) “Altro quadro in Rame in circa palmi trè concornice intagliata e dorata rappresentante una Me-ditazione del Signore fatta dall’Angeli opera delmed.o lasciato per legato all’Eccma Sig.ra D. Cate-rina Maria Zeffirina Salviati”, BNSP, Testamentocit., c. 1r.15) “Altro quadro in tela d’Imperatore con corniceliscia dorata rappresentante la Predica di S. France-sco di Sales lasciato per legato all’Illmo, e RmdSig.r Alemanno Salviati opera di detto”, BNSP, Te-stamento cit., c. 1r.16) “Un quadro in tela da sette a cinque in circa,cornice liscia dorata rappresentante il Transito del-la Madonna opera del Sig.r Morandi lasciato per le-gato dall’Ecc:mo Sig.r Duca Antonio Maria Salvia-ti”, BNSP, Testamento cit., c. 1r.17) G.B. Mola, Breve racconto delle miglior opered’architettura, scultura et pittura fatte in Roma: etalcuni fuor di Roma descritto da Giov. Battista Mo-la l’anno 1663, a cura di K. Noehles, Bruno VerlagHesslinghe, Berlin 1966, pp. 106-107.18) F. Petrucci, Bernini, Algardi, Cortona ed altriartisti nel diario di Fabio Chigi cardinale (1652 -1655), in ‘Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeo-logia e Storia dell’Arte’, 1998, pp. 169-196.19) R. Krautheimer, R.B.S. Jones, The diary ofAlexander VII: notes on art, artists and buildings,in ‘Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte’,1975, pp. 199-236 (p. 204, n. 67).20) G.B. Passeri, Vite de’ pittori scultori ed archi-tetti che anno lavorato in Roma morti dal 1641 fi-no al 1673 di Giambattista Passeri pittore e poeta,presso Gregorio Settari librajo al Corso all’insegnad’Omero, Roma 1772, I, p. 141.21) “Giovanmaria di Ottavio di Lionardo Morandiet di Maria di Lorenzo Pardini, Popolo S. Lucia sulPrato, nato adì 30 d’aprile, hore 21, battezzato adìprimo detto. Compare il signor cavalieri Donatodell’Illustrissimo sig. Niccolò del’Antella, comarela sig. Lessandra Orlandini negli Attavanti”. Archi-vio dell’Opera del Duomo di Firenze, Registri bat-tesimali, 33, fg. 138, 1 maggio 1622. Il dato offer-to dal registro battesimale costituisce un’importan-te conferma visto che ancora nella scheda recente-mente pubblicata per il Dizionario Biografico degliItaliani, si mette in dubbio l’effettiva data di nasci-ta, facendola oscillare tra il 1620 e il 1622. L. Moc-ci, Giovanni Maria Morandi, in Dizionario Biogra-fico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italia-na, Roma 2012, vol. 76, pp. 459-461.22) L’attività alle dipendenze dei granduchi, in as-senza di conferme documentarie attestata solo dal-la didascalia apposta da Pier Leone Ghezzi ad unasua caricatura, prevedeva, infatti, l’alternanza diservizio e scuola e, nel novero degli insegnamentistabiliti nel piano di studi, c’era anche il disegno. Ilnome del Morandi non compare nella Nota dei SSriPaggi de Serenissimi di Toscana dall’Assunzionedel Ser.mo Gran Duca Ferdinando sino al presentegiorno (1587-1629) (ASF, Miscellanea Medicea)né negli elenchi dei Paggi del Granduca relativi aglianni 1642-1660. L’intervallo di date 1629-1642, peril quale non esistono elenchi, rimane comunque ilpiù probabile nel quale il pittore può aver prestatoservizio a corte. In assenza di una conferma non sipuò, a mio avviso, procedere nemmeno con unasmentita soprattutto se si tiene conto delle paroledel biografo Lione Pascoli che attribuisce al pittore“parecchie qualità cavalleresche” ricordando che“ballava assai bene, sapeva addestrar cavalli, e tira-va prodigiosamente di spada”. L. Pascoli, Vite cit.,p. 579.23) F. Baldinucci, Notizie cit., IV, p. 41924) L. Pascoli, Vite cit., p. 578.25) F. Baldinucci, Notizie cit., IV, p. 419.
re après décès du duc Anton Maria Salviati dresséen 1704, in ‘Nuovi Studi’, 8, pp. 177-233.34) Si può identificare una prova grafica in prepa-razione della tela di Ponte a Badia in un disegnoconservato presso il Gabinetto disegni e stampe de-gli Uffizi, attribuito al Melissi (pubblicato in S. Ba-reggi, Disegnare un’arte stupefacente: fogli dalXVI al XIX secolo, Stanza del Borgo, Milano 1984,p. 77) con un soggetto evidentemente coincidentecon l’incontro sull’isola di Nasso tra il dio Bacco,di ritorno dall’India e la giovane Arianna, disperataper l’abbandono di Teseo. L’ipotesi attributiva perquesto progetto grafico, le cui dimensioni (29 x22,8 cm) fanno supporre fosse uno studio prepara-torio precedente alla costruzione compositiva dellascena, non poggia su base documentaria ma solo suquella stilistica. La definizione essenzialmente li-neare delle figure, all’interno di una scena del tuttopriva di allusioni ambientali, come anche il com-plesso gioco di affetti realizzato nei delicati incrocidi sguardi e nelle eleganti intersezioni di mani egambe, mostrano nel complesso una grande abilitàdisegnativa e compositiva.35) BNSP, Archivio Salviati, Libri di commercioecc. III, 244, Quaderno di cassa di Jacopo di Lo-renzo Salviati, 1630-1648, pp. 33, 44, 49. La se-gnatura di questo prezioso documento era già se-gnalata in P. Hurtubise, Une famille témoin: les Sal-viati, Biblioteca Apostolica del Vaticano, Città delVaticano 1985, p. 462.36) G. Corti, Contributi cit., pp. 14-23.
190 [Contributi]
“copia del Tintoretto” e le copie “della Leda delCorreggio”, “della Battaglia di Giulio Romano” e“della Resurrezzione di Lazzaro di Cecchino Salvia-ti”. P. Costamagna, La collection cit., pp. 177-233.48) La citazione è talmente precisa da presupporreun attento studio sul testo pittorico del Cesari, dacui il disegno del Morandi differisce solo nel man-to che è lasciato a mezz’aria senza accenni allacreatura angelica presente sulla tela.49) Alla data 1648 il Quaderno di Cassa di JacopoSalviati registra: “E adi detto g. trentacinque pl. Pa-gati a Gio. Baldini Procaccio p. suo porto, e spesefatte in condurre da Venezia a qui il Quadro di Tiz-ziano compro, Cassa – 69-35 […] E adi detto g.ventotto pl. Pagati a Pier Mia Mesticatore p. valutad’una tela grande mesticato p. copiare il Quadro diTizziano compreso in qta spesa alcuni colori, e al-tro p. ser.o di Gio: Mia Pittore, Cassa havuta 69-28”. Biblioteca della Scuola Normale Superiore diPisa, Archivio Salviati, Libri di commercio ecc. III,244, Quaderno di cassa di Jacopo di Lorenzo Sal-viati, 1630-1648, p. 70.50) P. Hurtubise, Une famille témoin: les Salviaticit., p. 463.51) L. Sacchetti Lelli, Hinc priscae cit., p. 344.52) L. Lanzi, Storia pittorica della Italia: dal Ri-sorgimento delle belle arti fin presso alla fine delXVIII secolo, 1809, a cura di M. Capucci, Sansoni,Firenze 1968, I, p. 168.53) “Un quadro rappresentante S. Pietro Martirecopia di Tiziano con cornice stretta intagliata dora-ta”; BNSP, Testamento cit., c. 3v n. 44.54) “Una copia di Tiziano rappresentante un Tede-sco che ammazza la moglie con cornice liscia dora-ta”; BNSP, Testamento cit., c. 3v n. 45.55) “Cinque pezzi di quadri, che tutti insieme for-marono la Cena copia di Paolo Veronese”; BNSP,Testamento cit., c. 5v n. 81.56) “Un quadro di palmi sei bislongo rappresentan-te la Peste copia dal Tintoretto con cornice noce, &oro”; BNSP, Testamento cit., c. 6r n. 86.57) L. Pascoli, Vite cit., p. 578. Nella bottega diGiovanni Maria Morandi transiteranno, per brevis-simi periodi di tempo, giovani pittori dalle più dis-parate provenienze geografiche, interessati ad ac-quisire attraverso brevi corsi di formazione uno sti-le pienamente romano per poi portare con sé in pa-tria questo prezioso bagaglio culturale con cui di-mostrare presso la propria committenza l’avvenutoaggiornamento stilistico. Si può immaginare che lostesso sia avvenuto per il Morandi, e che quindi an-che lui abbia soggiornato presso le botteghe più af-fermate nelle città toccate dal suo itinerario.58) L. Pascoli, Vite cit., p. 578.59) Il ruolo di responsabile della quadreria dei suoiprotettori da parte del Morandi viene ricordatoesplicitamente dal solo De Sebastiani, ma non è dif-ficile da credere che giudizi riferiti alla ricchezzadelle collezioni del palazzo alla Lungara, da scrit-tori quali Giovanni Pietro Bellori (“adornato di pre-giatissime pitture”, Nota delli Musei, Librerie, Gal-lerie e ornamenti di Statue, e pitture, ne’ Palazzi,nelle case e ne’ Giardini di Roma, Roma 1664, acura di E. Zocca, Arti grafiche, Roma 1976, p. 108)e Filippo Titi (“le sue stanze, e gli appartamenti so-no molto magnifici forse più di qualsivoglia palaz-zo di Roma, toltone il Farnese”, Studio di pittura,scultura et architettura nelle chiese di Roma, 1674-1763, a cura di B. Contardi e S. Romano, CentroDi, Firenze 1987, I, p. 314), non possano riferirsiindirettamente proprio al valore del pittore fiorenti-no quale procacciatore e stimatore di opere d’arteantica e moderna per conto dei propri generosi me-cenati.60) P. De Sebastiani, Viaggio curioso di Romasagra, e profana gentile, per contentare i forastieri.Di Pietro de’ Sebastiani professore della linguatoscana, che dimostra le sudette cose, per il Mone-ta, Roma 1683, p. 34.
37) Le parole adoperate nel profilo biografico daLione Pascoli, nella cui narrazione si ricorda che almomento del trasferimento del Morandi a Roma, ilduca Salviati “ne avea già presa particolare prote-zione”, suggeriscono implicitamente il già avvenu-to contatto tra il pittore e il nobile fiorentino attra-verso le prime commissioni. L. Pascoli, Vite cit., p.58738) F. Petrucci, Pittura di ritratto cit., II, p. 416.39) ASF, Accademia del disegno, Vacchetta disquittini, f. 34, c. 21v. La notizia è già riportata inL. Zangheri, Accademia delle arti del disegno. GliAccademici del disegno: elenco alfabetico, Olsch-ki, Firenze 2000, p. 233.40) BNSP, Archivio Salviati, Libri di commercioecc., III, 244, Quaderno di cassa di Jacopo di Lo-renzo Salviati, 1630-1648, p. 66. Si deve immagi-nare il legame instauratosi tra i mecenati e il pitto-re come perfettamente parallelo a quello ratificatonel contratto del 1689 tra un altro esponente dellafamiglia, Giovanni Vincenzo e Giovanni NicolaRombouts, secondo il quale quest’ultimo si impe-gnava per la durata dell’accordo, stabilita in tre an-ni, a dipingere tutto ciò che il marchese gli avrebberichiesto, ottenendone in cambio vitto, alloggio eun salario mensile di 5 doble di Spagna. V. Pinche-ra, Lusso e decoro: vita quotidiana e spese dei Sal-viati di Firenze nel Sei e Settecento, Scuola Norma-le Superiore, Pisa 1999, p. 138.41) L. Pascoli, Vite cit., p. 578.42) Il pittore ambienta gli episodi sacri dipinti nel-le sue prime opere (‘Transito della Vergine’, ‘Visi-tazione’, ‘Predica di San Francesco di Sales’) in ar-ticolate scenografie all’antica, accuratamente de-scritte nella loro verità storica. Fatta eccezione peril ‘San Pietro’, oggi nella chiesa omonima a SanBelvedere Ostrense, tale scelta non verrà reiteratanelle pale d’altare successive, sempre basate sul-l’assenza di riferimenti spaziali e dominate da vo-luminose e soffici nubi che rafforzano il misticismodell’evento miracoloso. Le suggestioni del classiconon si riducono per Giovanni Maria Morandi soloai colti riferimenti all’architettura di un tempo anti-co. Il pittore è, infatti, attentissimo a ricreare unarealtà “universalmente” aulica fatta di gesti maesto-si e atteggiamenti solenni.43) “Una copia in tela d’Imperatore del quadro diRaffaelle in S. Pietro Montorio” (BNSP, Testamen-to cit., c. 12v. n. 194); “Altro simile copia della Ga-latea di Raffaelle” (BNSP, Testamento cit., c. 11r. n.170).44) “Un quadro di cinque palmi in circa rappresen-tante un Baccanario copia di Tiziano con Corniceintagliata, e dorata”; BNSP, Testamento cit., c. 3v.n. 46.45) “Un quadro di nove palmi in circa rappresen-tante una Santa Margherita copia del Caracci corni-ce liscia dorata”; BNSP, Testamento cit., c. 6r n. 88.46) G. Bora, I disegni cit., p. 283.47) “Un quadretto in tela di mezza testa fuor di mi-sura copia della Santa Petronilla del Guercino”(BNSP, Testamento cit., c. 13r n. 203); “Un quadroin tela d’Imperatore rappresentante la Navicella diS. Pietro Copia di Lanfranco, Cornice noce, & oro”(BNSP, Testamento cit., c. 1v n. 2). L’accesso privi-legiato alla ricca quadreria dei Duchi di Giuliano,una delle “Accademie et virtuosi alberghi delle Mu-se” che Giovan Pietro Bellori celebra ne “La notadelli Musei”, gli permette di arricchire ulteriormen-te le fonti del proprio sapere e, grazie al confrontotra l’inventario della collezione Salviati del 1704 el’elenco del Morandi, è possibile verificare con ca-pillarità le corrispondenze, sulla scorta dell’attribu-zione offerta e del soggetto dipinto, tra gli originaliappartenenti ai nobili fiorentini e le copie derivatedall’esercitazione dell’artista. Sono ascrivibili aquesta categoria i quadri raffiguranti due Angeli
61) Nel Vocabolario toscano dell’arte del disegno(per Santi Franchi al segno della Passione, Firenze1681, p. 39) Filippo Baldinucci definisce la “co-pia”, come “quella opera che non si fa di propria in-venzione, ma si ricava per l’appunto da un’altra, osia maggiore, o minore, o eguale dell’originale”.62) Dal 1682 gli Stati d’anime iniziano a registrarea casa del Morandi la bottega del pittore. F. Petruc-ci, Pittura di ritratto cit., II, pp. 419-420.63) A ulteriore conferma della loro natura definiti-va, si può indicare la presenza di cornici di vario ti-po, col fine di impreziosire il manufatto.64) “Una Santa Appollonia in tela di mezza testapiccola copia del Sig.r Morandi con cornice inta-gliata, et indorata” (BNSP, Testamento cit., c. 3v n.59); “Altro rappresentante una S. Catterina conCornice come sopra” (BNSP, Testamento cit., c. 3vn. 60); “Un quadro di quattro palmi per larghezzarappresentante Arianda, e Bacco sbozzo del sig.Morandi” (BNSP, Testamento cit., c. 2r n. 185);“Un quadro rappresentante Cefalo, e Aurora sboz-zo del Sig.r Morandi” (BNSP, Testamento cit., c.12v n. 30).65) “Altro simile sbozzetto del transito della Ma-donna del Sig.r Morandi” (BNSP, Testamento cit.,c. 3r n. 42); “Una copia del Sig.r Morandi rappre-sentante la Visitazione di S. Elisabetta in tela diquattro palmi grande” (BNSP, Testamento cit. p.11r n. 161).66) “Un quadro di cinque palmi per altezza rappre-sentante la Santissima Annunciata, copia” (BNSP,Testamento cit. c. 16r n. 253); “Altro di quattro pal-mi per Altezza rappresentante S. Filippo Neri congloria copia del Sig.r Morandi” (BNSP, Testamentocit., c. 16r n. 255); “Un quadro da testa bislongorappresentante lo Sposalizio della Madonna ritoccodall Sig.r Morandi” (BNSP, Testamento cit., c. 6r n.78); “Altro quadro in tela simile rappresentante S.Pietro del Sig.r Morandi” (BNSP, Testamento cit.,c. 14r n. 213); “Un quadro simile rappresentante laVenuta dello Spirito Santo copia del Sig.r Morandi”(BNSP, Testamento cit., c. 6r n. 79); “Un quadro intela di sette, e cinque rappresentante le tre Marie alsepolcro sbozzo del sud.to” (BNSP, Testamento cit.,c. 12v n. 187); “Altro da testa rappresentante S.Francesco, S. Antonio sbozzo del Sig.r Morandi”(BNSP, Testamento cit., c. 8v n. 123).67) “Un ritratto del Sig.r Cardinal Cibo tela da trepalmi” (BNSP, Testamento cit,. c. 1v n. 3); “Un ri-tratto in tela di trè palmi d’una Signora di Casad’Austria” (BNSP, Testamento cit., c. 2r n. 13); “Al-tro Ritratto di Leopoldo Imperatore con Cornicedorata” (BNSP, Testamento cit., c. 2r n. 16); “UnRitratto del Sig.r Duca Antonio Maria Salviati delmed:o” (BNSP, Testamento cit., c. 3r n. 43); “UnRitratto del Sig.r Cardinale del Medici senza corni-ce” (BNSP, Testamento cit., c. 3v n. 49); “Una telad’Imperadore ed una Testina del Ritratto della fi-gliola di Cesarini del sig.r Morandi” (BNSP, Testa-mento cit., c. 10v n. 163); “Un Ritratto in tela comesopra del Sig.r Cardinale Omodei” (BNSP, Testa-mento cit., c. 14v n. 232); “Altro simile del Sig.rCardinale Rospigliosi” (BNSP, Testamento cit., c.14v n. 233); “Altro del Sig.r Cardinal Giansone”(BNSP, Testamento cit., c. 14v n. 235). Mutuandoper il Morandi le parole usate da Filippo Baldinuc-ci, in riferimento al ritrattista fiammingo Jan Vanden Hoecke, allievo di Rubens e attivo a Roma trail 1638 circa e il 1646, “molti cardinali adoperaro-no il suo pennello”, risultando così un costante pun-to di riferimento per qualsiasi nuovo cardinale desi-deroso di avere un’attestazione artistica del proprionuovo status.68) “Un ritratto in tela di tre palmi con Cornice do-rata della Santa mem. di Clemente Nono” (BNSP,Testamento cit., c. 1v n. 1); “Un ritratto d’Alessan-dro Sett.o con cornice di legno intagliata” (BNSP,Testamento cit., c. 1v n. 9); “Un Ritratto d’Inno-cenzo Duodecimo con cornice dorata” (BNSP, Te-stamento cit., c. 2v n. 24); “Un Ritratto d’Alessan-dro Ottavo con Cornice dorata” (BNSP, Testamento
91) ASF, Corporazioni religiose soppresse dal go-verno francese, 136. San Firenze, Casa di Preti fi-lippini, Conto del Mol. Rev.di padri di S: FilippoNeri di S: Firenze, fogli sciolti, p. 89.92) Il dipinto doveva comunque essere già termina-to nel 1715, quando l’ultimo testamento del Mo-randi lo cita. E. Schleier, Disegni di Giovanni Ma-ria Morandi nelle collezioni pubbliche tedesche:l’album del museo di Lipsia con alcune note di sul-la sua provenienza di Andreas Stolzenburg, in ‘Stu-di di storia dell’arte’, 9, 1998, pp. 247-276.93) L’inventario del pittore menziona delle replichedei dipinti in questione: “Un quadro in tela da testain circa rappresentante la Sammaritana copia ritoc-ca dal Sig.r Morandi con cornice dorata intagliata”(BNSP, Testamento cit., c. 4v. n. 63); “Un quadro ditela di tre palmi rappresentante la Partenza di Chri-sto dalla Madre con diversi Angeli opera del mede-simo Cornice indorata, & intagliata” (BNSP, Testa-mento cit., c. 5v. n. 77).94) S. Meloni Trkulja, Cortonismo nelle galleriefiorentine, in ‘Antichità viva’, 2-3, 1997, pp. 36-44(p. 44 n. 18).95) Oltre che protettore delle arti e ispiratore, suomalgrado, di tanti versi dedicati alla sfortunata vitamatrimoniale con Veronica di Carlo I Cybo, JacopoSalviati fu anche “poeta gentilissimo” (F. Trucchi,Poesie italiane inedite di dugento autori dall'origi-ne della lingua infino al secolo decimosettimo…,per Ranieri Guasti, Prato 1846, p. 279). Sull’attivi-tà letteraria e, più in generale, sul profilo culturaledel duca Jacopo Salviati, non esistono indagini po-steriori al XIX secolo. Si veda: F. Baldinucci, Noti-zie cit., pp. 563-4; Giulio Negri, Istoria degli scrit-tori fiorentini…, per Bernardino Pomatelli stampa-tore vescovile, Ferrara 1722, p. 334; G.M. Cre-scimbeni, Commentari del Canonico Gio. MarioCrescimbeni custode d’Arcadia, intorno alla suaIstoria della Volgar Poesia, presso Lorenzo Base-gio, Venezia 1730, III, p. 222; F. Trucchi, Poesie ita-liane cit., pp. 279-86.96) J. Salviati, Fiori dell’orto di Gessemani e delCalvario, sonetti del duca Jacopo Salviati alla San-tità di N. S. Clemente IX…, Firenze 1667.97) “In primo luogo professo di voler morire qualsempre vissi Cattolico Romano, acciò l’anima miaseparatasi dal corpo ritorni sicuramente al suo crea-tore, e salvatore quale supplico umilmente per suainfinita bontà a volerli perdonare ogni colpa com-messa et applicabili i meriti della Sua Santissimapassione”.98) L. Pascoli, Vite cit., p. 582.99) F. Moucke, Serie di ritratti degli eccellenti pit-tori dipinti di propria mano che esistono nell’impe-rial galleria di Firenze colle vite in compendio de’medesimi descritte da Francesco Moucke, stampe-ria Mouckiana, Firenze 1762, III, p. 179.100) L. Pascoli, Vite cit., pp. 579-580.101) R. Soprani, C.G. Ratti, Vite de’pittori, scultoried architetti genovesi, Forni Editore, Bologna 1969,II, p. 276.102) G.M. Crescimbeni, Notizie cit., III, p. 224.103) Le tele indicate con le note n. 158 (“Altro si-mile sbozzetto d’una cupola”, BNSP, Testamentocit., c. 11r.) e 162 (“Tela di cinque palmi con unsbozzo d’Angelo di una Cuppola del Sig.r Moran-di”, BNSP, Testamento cit., c. 11v.) suggeriscono,ad esempio, che il pittore possa aver lavorato comefrescante, circostanza non confermata dalle fonti eipotizzata a proposito di due disegni provenientidalla collezione di Marcello Aldega. Disegni italia-ni dal XVI al XVIII secolo, De Luca Editore, Roma1980, pp. 31-32 n. 70-71 (p. 92).
[Contributi] 191
rando la scelta programmatica operata da questi let-terati, di celebrare non semplicemente coloro che“distinti si sono coll’azioni” (L. Pascoli, Vite cit., p.42), ma esclusivamente i “più eccellenti, ed illu-stri”. Lo stesso vale per il Crescimbeni che ricordacome tra “i Professori d’altre arti liberali […] nonebbe l’ultimo luogo Gio. Maria Morandi […] pitto-re insigne de’ nostri tempi” (G.M. Crescimbeni,Notizie cit., III, p. 224) e per Filippo Baldinucciche, dall’osservatorio privilegiato della comune pa-tria fiorentina, e non senza orgoglio, lo riconosce“oggi pittore di chiara fama nella città di Roma”(Cominciamento e progresso dell’arte dell’in-tagliare in rame colle vite di molti de’ più eccellen-ti Maestri della stessa professione, a cura di D.M.Manni, dalla Società tipografica de’ Classici italia-ni, Milano 1808, p. 221).80) Giovanni Maria Morandi “andava sempre gua-dagnando ne’ lavori istoriati non meno, che ne’ ri-tratti”. L. Pascoli, Vite cit., p. 58281) G.M. Lancisi, Opera quae hactenus prodieruntomnia; dissertationibus nonnullis adhuc dum inedi-tis locupletata, et ab ipso auctore, recognita atqueemendata. Collegit, ac in ordinem digessit PetrusAssaltus…, sumptibus Fratrum de Tournes, Genova1718, I, p. 182. Il medico romano Giovanni MariaLancisi (1654-1720), archiatra di Innocenzo XI epoi di Innocenzo XII e Clemente XI, considera i ca-si di Giovanni Maria Morandi e di Carlo Maratta“Romanorum longaevitas salubritatis aeris testimo-nium”: “Celeberrimi quoque Pictores Carolus Ma-ratta, octoginta sex annorum, et Jo: Maria Moran-dius nonagenarius, adhuc pingunt aeternitati”.82) L. Pascoli, Vite cit., p. 582.83) F. Petrucci, Pittura di ritratto cit., II, p. 420.84) “Un altro quadro grande da Altare rappresen-tante la Flagellazione di Nostro Signore lasciato perlegato alli RR. Padri di S. Firenze di Firenze”;BNSP, Testamento cit., c. 15v n. 252.85) Nel 1840 si decise, infatti, “di rimuovere dal-l’altare il quadro della Flagellazione, il quale peressere alquanto annerito, ed illuminato da fioca lu-ce pochi consideravano, e taluno ignorava perfinoche cosa rappresentasse”. G. Masselli, Della cap-pella della Madonna annessa alla chiesa dei pp.della congregazione dell’oratorio di s. Filippo Neridi Firenze, Baracchi, Firenze 1847, pp. 3-8.86) L’opera è ricordata da Raffaello del Bruno (“inSagrestia è un Quadro molto stimato di Gio. MariaMorandi”. R. Del Bruno, Ristretto cit., p. 43), dalRastrelli (“La pittura è degna di pregio, e la figuradel Salvatore è molto bene intesa ed esprimente”. V.Follini, M. Rastrelli, Firenze antica cit., VI, p. 122)e poi da Luigi Biadi che arricchisce la schiera digiudizi positivi, scrivendo che “il pregio di quest’o-pera fu tale che prima di esser trasportata da Romain Firenze offrì taluno che volea acquistarla 300 do-ble”. L. Biadi, Notizie cit., p. 61.87) M. Lastri, Etruria cit., c.79r-v.88) L. Mocci, Giovanni Maria Morandi cit., pp.459-461.89) Esso venne requisito il 1 luglio 1867 per esserecondotto nelle Gallerie Fiorentine dove l’inventariodel 1890 (l’opera non è ancora oggi stata cataloga-ta dalla Soprintendenza del Polo Museale fiorenti-no) lo registra come produzione alla “maniera bo-lognese sec. XVII”.90) Quello che lo frusta alle spalle richiama percontrasto l’altro collocato di fronte a lui, mentre unterzo militare sembra infliggere un’ulteriore pena alcondannato stringendo con forza le sue mani. Cu-riosa è la posa del quarto soldato che, riverso a ter-ra a “quattro zampe”, volge le spalle all’osservato-re e scopre l’anziano con turbante e barba lunga,quasi una citazione-omaggio di figure analoghe delBilivert (si veda un ‘Ecce Homo’ del Départementdes Arts Graphiques del Louvre, inv. 16689) e rife-rimento all’autorità religiosa responsabile del sup-plizio.
cit., c. 3r n. 35); “Un sbozzetto del ritratto d’Inno-cenzo Undecimo” (BNSP, Testamento cit., c. 10rvn. 155).69) Non corrisponde dunque alla prima effigie cheil neoeletto pontefice richiese al Morandi, dopoaverlo richiamato a Roma da Vienna dove questi siera nel frattempo impegnato al servizio di Leopol-do I, “in figura intera maestosamente assiso” (L.Pascoli, Vite cit., p. 580) e a noi ignota, se non peruno studio compositivo (Parigi, Département desarts graphiques, Louvre) recante lo stemma dellafamiglia pistoiese, con il papa in trono circondatodalla corte di cardinali.70) E. Waterhouse, A note cit., p. 120; D. Gallavot-ti Cavallero, in L. Pascoli, Vite cit., p. 584 n. 8.71) A. Negro, La collezione Rospigliosi: la quadre-ria e la committenza artistica di una famiglia patri-zia a Roma nel Sei e Settecento, Argos, Roma 1999,p. 280, R. Sansone, Giammaria cit., p. 25 n. 2.72) Le stanze del cardinale, catalogo della mostra acura di F. Petrucci (Ariccia, Palazzo Chigi, 20 lu-glio - 21 settembre 2003), De Luca, Roma 2003,pp. 73-74.73) N. Turner, Roman baroque drawings, BritishMuseum, London 1999, n. 236.74) Le stanze cit., pp. 73-74; I volti del potere: ri-tratti di uomini illustri a Roma dall’impero romanoal neoclassicismo, catalogo della mostra a cura di F.Petrucci (Ariccia, Palazzo Chigi, 24 marzo - 20 giu-gno 2004), De Luca, Roma 2004, pp. 128-129.75) Come consuetudine nella ritrattistica pontificia,Giovanni Maria Morandi concentra l’essenzialecomposizione del dipinto sul volto del papa, realiz-zando un’effigie tipologica, tesa a esaltare il valoredel ruolo ricoperto, e meno attenta al carattere psi-cologico del personaggio. Del Pignatelli il Morandiregistra fedelmente le particolarità fisionomiche, li-mitando con buone probabilità un diretto interven-to all’altezza del camauro. Lo schematismo dellamozzetta suggerisce, infatti, la partecipazione dicollaboratori al completamento della parte inferio-re del ritratto.76) F. Petrucci, Pittura di ritratto cit., p. 36177) L’Anonimo autore di un settecentesco “Elogio”del Morandi era sicuro che le pale d’altare da lui di-pinte avrebbero fatto “chiaramente conoscere inogni tempo a quale alto grado di eccellenza giun-gesse la di lui abilità nel dipignere” (Serie degli uo-mini i più illustri nella pittura, scultura, e architet-tura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame comin-ciando dalla sua prima restaurazione fino ai tempipresenti, nella Stamperia Allegrini, Pisoni e comp.,Firenze 1775, XI, pp. 145-148). Così non è statoper la loro esiguità e le condizioni di conservazionespesso pessime. Lo scorrere del tempo e l’indiffe-renza degli studi hanno offuscato l’identità artisticadel pittore condannandolo ad una condizione dianonimato impensabile per i suoi principali compe-titors nell’ambiente artistico romano ovvero CarloMaratti e Giovanni Battista Gaulli. Accade così cheMelchior Missirini, nella ricostruzione della storiadell’Accademia di San Luca a Roma, istituzioneche vide il Morandi impegnato costantemente nelcorso della sua lunga esistenza, dichiari: “Sulletracce del Pascoli, e d’altri Istorici, si può dire cheMaria Morando […] fu buon pittore”. M. Missirini,Memorie per servire alla storia della romana acca-demia di San Luca, stamperia de Romanis, Roma1823, p. 130.78) A.P. Orlandi, Abcedario pittorico..., per Costan-tino Pisarri sotto le scuole, in Bologna 1704, ad vo-cem; G.M. Crescimbeni, Notizie degli arcadi morti,Antonio De Rossi, Roma 1720, III, pp. 224-228; N.Pio, Le vite cit., 1724, p. 54; L. Pascoli, Vite cit., p.578. Manca all’appello una biografia del Morandicompilata dall’abate fiorentino Francesco Marucel-li. F.A. Zaccaria, Storia letteraria d’Italia, AntonioZatta, Venezia 1748-55, p. 562.79) Non è questo un dato da sottovalutare conside-