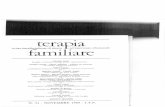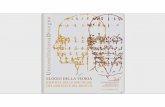Giulio Ciampoltrini, Gli ozi dei Venulei. Considerazioni sulle 'Terme' di Massaciuccoli, in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Giulio Ciampoltrini, Gli ozi dei Venulei. Considerazioni sulle 'Terme' di Massaciuccoli, in...
l . M:m aciuccoli (Massarosa. Lul:(:aj 'la picve ( 1· 2\ e i resli roma lli (3).
c
[Contribut i! 119
'-------Jb
MET RI
4 03 0
(fig. 2.a) si ritrovò "un bellissimo pav imento largo braccia d ieci ci rcondato daogn i pa rte con muro, qu al pavim ent o peresser flIbri della detta tribun a da una parte solame nte braccia 2 112 e dall 'altrabracc ia 7, ed il restante term inando sottola chiesa non pu ò sapersi q ua nto sia longo... d i qu esta parte di pavimen to se n'ècavata la pianta nella precisa gra ndezza, epreciso di segno, e si è dipinto al naturalein un quadro, Quale es iste in Casa delnobil signo re Domen ico Spada padronedella terra dove esisto no dette a nti chità... " .L'allargamento dello scavo porta in luceanche a ltr i ambien ti: " si è trovato un condotto di matton i, che andava in una vascalonta na dal de tto pavim ento braccia 4,cdera più fonda del delta pavime nto braccia I 112ed era larga braccia 2. Non pu òsapersi la longhezza per essere im peditol'inoltrarsi da un mu ro che regge il porti-
..20
SC A LA 1 : 500
2. La ,·illa di MassaciuC(oli: planimerna generale .
ba tteva l'an nosa question e se ricon oscerenel monume nto la parte termale di unimpian to res idenziale privato, o termepubbliche, e finiva per preferire la seconda ipotesi, an che pe r " la ma nca nza d itracce sicure ed evide nti della villa stessa" ;" seppure non senza pe rplessità, se mbra questa l'interpretazion e an cor più seguita. IO
In realtà il recuperc negli archivi lucchesid i una re lazion e sui primi scavi nell' aread i Massaciuccoli , fra 1756 e 1770, e neidepositi de i musei lucchesi della tela chene forma il singolare 'co rredo ' iconografico ha trasformat o il qu ad ro delle conoscenze, I l offrendo le " tracce sic ure ed evidenti della villa " invan o ricercate daMin to con la cam pagna di scavo dell'es tate de1 1920;ll il recente recupero d i interesse per il monument o, concretatos i ininterventi di con solida me nto e in unaser ie di saggi mirat i, ha infi ne permessod i pu ntualiz zar e la sua ' storia', integrando la sequ enza delle fasi strun ive che giàMint o aveva intuito.'!Nel 1756, " in occas ione d i sbassare ilterreno dietro alla canonica, coro e sagrestia de lla suddetta (di San Lorenzo d iMassaciuccoli] chiesa per levarvi affattol'umido, si rit rovò una statua di marmo(che credesi greca) che può dirsi gigantesca, mentre se fosse intera avrebbe circabraccia 4 d 'altezza, essendo mancante ditesta, b raccia e gambe". 14 11 ritrovam entostimolò ad ampliare lo scavo - soprattutto per la spe ranza di recuperare i frammenti man canti alla statua - sull' este rnode ll'area absida le della ch iesa e della canonica, adiacente allato meridionale della chiesa ;" in co rrispo ndenza de ll'absid e
" Mihi nune Ligus ora I intepet, hibernatqu c meum mare, qua latus ingens / dantscopuli, et multa litus se valle recept at '' :la mit ezza dell'inverno chiamava Per siaa soggiorna re in una villa sospesa tra gliscogli della costa ' ligure' e la pian a al cuicentro si a priva i l celebrato porto d i Lun i. ' Se q ui Persia ce rcava rifugio agli invern i urban i, un alt rimenti ignoto Gal1U5, amico d i Stazìo, poteva scegliere ditemperare le calure estive sulle coste delLazio o a Luni : "Quid IUUS ante omnes,tua cura pctissima Gallus, I cee non noster amor(dubium, morumne probandusI ingeniine bonis) Latii s aestivat io o ris?Anne metalliferae repet it iam moeniaLunae Tyrrhenasque dom us?"."Sulla scorta dei versi di Stazio, la raffinatozza delle dotazioni ind urrebbe d unquea sospet ta re a nche in alcune ragguardevoli domus d i Luni - ad esempio la Casadegli Affreschi,' profondamente ristrutturata proprio in età neronia na - l'interesse ' residenziale' di famigli e non loca-l, ,L
Per il mom ento, la rete di ville d'Ol ium'Iueensi' che anticipa no alla tarda rep ubblica la fortuna ' tu rist ica ' della Versi lia edella Liguri a d i Levante, e offrono unacon ferma 'a rcheologica' ai versi d i Pers ioe Staz io, è t racc iata a nord dai complessidel varignano ' e d i Bocca di Magra .sq uesta potrebbe anzi esse re identi ficata nellavilla di Persio, giacché, com e il rifugio delpoeta, domina da un prom ontori o roecioso l" ampia piana' in cui penetra lacosta, e, essendo sulla destra del fium e,era ammi nist rat ivamente compresa nellaregione augustea della Liguria. A sud lecosi ddette 'Terme' di Massaciuccoli, ormai nel territorio di Pisae. sembrano racco rdare i ' r ifugi' dell'est rema Etruria settentriona le alle ville d' oiium dcll'Arci pelago , che i recentissimi ritrovam cnti d iGorgona dimostrano di stribu ìte siste maticamente in tutt e le isole."Anto nio Minto, nell' insostituita ed izione dei rest i d i Massaci uccoli" (fig. l) , di-
G iulio Ciampoltrini
Gli ozi dei Venulei.Considerazionisulle 'Tenne'di Massaciuccoli
y ,
co della cuci na di detta canonica. Questavasca benché scavata nel tar so era fod ratadi quadro ni ben grand i, e vi si è t rovatodue picciole fistul e di piombo da un aparte, ed erano longhe circa oncie d ue.Fina lmente vi si trovò ancora del mosaico di di versa qu alità, men tre ve n 'erafor mato con q uad rucc i un poco gran di, econ qu ad rucc i più piccoli, e nell'una cnell' alt ra Qual ità vi era un d isegno fattodi quadrucci neri, q uale no n si è potutoricavare perché a ndava a term ina re nellacanonica pa ssando sotto il mura dellamedesima , solo si è tagliato e levato Quelpoco che usciva in fuo ri, e fu creduto
120 [Contributi]
parte di pavimento d'un mosai co ordi nario " .Il resocon to de llo sca vo poco aiuta a comprendere la sequenza degli a mbient i, anche se è ev ide nte che dovette ro essereesplorat i alme no du e van i, uno dotatodella pavimen tazion e in opus secu!e chesi ri tenne di dover riprod urre ' al naturale' in una tela (figg. 3-5), oggi giu nta alMuseo nazion ale di Villa Guinigi; l' altrocon pavimenta zione musiva.L'accuratezza del dipi nto (fig. 3) conse n
. te di riconoscere nello schema della pavimenta zione in opus secli /e di Massac iuccol i una variante de l m od ulo definito dalGuidobaldi ' ad isodom o Iistellato ';" inquesto caso , p ropriamente, si dovrebbe
a sin i~ l nt:
J . Anonimo della fine del Senc ceruo: 'St rutturee oggel1i ril rovati nd 17.'56 a MassaciuC{;oli'.LUl'C:l, Museo Nazionale di Villa Guin igi.4. Pan icolare della Iig. J: pa"imenlo in oPUS seClile.foOp ra :.'5 , Parl icolare della Fig. J: statua virile panneggiala.
parlare di 'pseudo-iso dom o', per l' alternarsi d i una larga fascia di q uadrati e diun sottile ricorso di rettangoli e Quadrati ;il bardiglio d i Lu ni, fedelm ente riprodotto an che nelle venature, dà il ton o difondo al pavim ento. Nei quadrati, d isti nti da una fascia di giallo antico, !istelli d imarmo rosso" iscrivo no un quadrato,mentre i rettangoli della fascia minoresono ca rnpit i da un rom bo in giallo an tico; lungo le paret i, una cornice, an cor a d iba rdiglio .Nell'es trema di fficoltà di proporre unacronologia pu ntuale per gli sche mi dell'OpllS secli/e , semb ra parti colarm entepreziosa la parentela con la pavimentazione d i un a villa tiberian a di Capri;"comuni accorgimenti tecni ci - in particola re i sotti li listelli che di segn ano i quad ri - e la sosta nz iale affinità nell' impianto potrebbero denotare un a co nt igu itàanche cro nologica fra i d ue pavim en ti.Alt ri indi zi confortano del resto l'ipotesiche il p rimo impianto della villa di Massaci uccoli debba cad ere ent ro gli an niiniziali de l I seco lo d .C. 1tralci vegeta li innero che flutt uan o liberamente nel campo bianco della pavimentazion e musivadell'ambient e cont iguo a qu ello cope rtoin opllssectile pot rebbero t rovare qu alch eanalogia, in amb ito regionale, nel riquad ro centra le di un pavime nto aretino;"ma richiamano an che il pavimento musi-
,
Il
laterizi (in buona parte tegole fra tte) eblocchetti d'arenaria sommariame ntesbozzati - accomuna infatti le opere disostru zione del terrazzo superiore" almuraglione che chiude a nord il terrazzoinferiore (fig. 9.a); i saggi del 1991 hannomesso in luce un avancorpo semicircolare che potrebbe segnalare la presenza dito rri, secondo il tipo architettonico sinqui esclusivo dell'agro di Cosa." All'ipotesi deve essere naturalmente assegnat oun conside revole margine di labili t à, masi potrà almeno aggiungere che anche ilraccordo con il muro di terrazza mentomeridionale, seppur conservato in min i-
ma parte, ha un andam ento curvilineo,quasi che anche questo tratto presentasseavancorpi simili a quello riconosciuto sullato sett entrionale. Le ville con fronte atorrette dell'agro cosano han no del restoun'a rticolazione simile a quella che potrebbe essere postulata per il primo impianto di Ma ssaciuccoli: d istribuzi one sudue terrazzi , il superiore ' residenzia le',l'inferiore - coronato da una fronte a torrette - non occupato da strutture, destinato evide nteme nte a giard ino.Op era di sostruzio ne, ma non solo funzionale, doveva essere anche la strutt uracurvilinea, fondata sulla roccia , e realizzata con i consu eti irregolari ricorsi ditegole fratte e blocchetti d'arenaria, già
Il fase
I fas e
[Contributi] 121
s•
degli ambienti 'd i rappresentanza'. Intrecciando le analogie tra i due edifici, sipotrebbe ipotizzare che anche a Massaciuccoli l'oecuscon pavimentazione ma rmarea e l'adiacente con campitura musiva si affacciassero su un peri stifio che'distribuiva ' gli ambienti della villa sulterrazzo artificiale formato dalle sostruzioni incontrate nel piazzale della chiesacon gli scavi de l 1920 (fig. 2.d-e),31e dalmuraglione oggi in vista subito ad est delpiazzale (fig. 2.f).Allo stato attuale delle conoscenze non èpossibi le congett urare sull'articolazionedel terrazzo inferio re, che comunque doveva già essere definito. La sostanzialeident ità di tecni ca - ricorsi irregolari di
6. Re~l i roman i alla Pieve Vecchia di Casale Mar itlim o:plunimelri a schemalica.
vano con pavimenta zione in cocciopesto,arricchita da scundae marmoree regolarmente distribuite (fig. 6.A).18 La datazione dell'edificio di Casale Marittimo è indiziata anche da un lembo di intonacoparietale del peri stilio, che conserva unaspecchiatu ra archi tettonica con mod ulitipi ci - anc he per il quadro con scena 'digenere' che vi è inserit o - del Terzo Stileavanzato (fig. 8), collocabile latamen tenel secondo quarto del I secolo d.C."Come a Massaciuccoli, nella villa di Casale vani 'di servizio ' (fig. 6.0-F) consemplice pavimentazione in laterizio" sidispongono immediatamente a ridosso
ve dci colombario degli Arrunzi, d 'etàtardo-augustea;" riporta a ques to periodo, infine , la decorazione architetton icain terracott a - lastre Ca mpana di sim acon sfingi bicorpor i alterna le a pa lmettec ant efisse - d i cu i fram men ti sono stat irestituit i a più riprese, da l Sett ecent o aigiorn i nostri. "La 'v asca' scavata nell'a renaria d i base,rivestita in laterizio e alimentata con duefistul e in piombo, è difficilmente collocabile fra i due vani 'residenziali ', e la sivorrebbe suppcre all'esterno di questi ,forse in rapporto con gli ambienti pavimentati in opus spicatum che venneroalla luce negli anni Ci nquanta qua lchemet ro a sud-est della ch iesa (fig. 2.C);22come si vedrà, è consistente l'ipote si cheapparte nga alla ristrutturazi one d' età f1aVia.
Il settore residenziale dell' imp iant o tardo-a ugusteo avrebbe dunque occupato ilterrazzo di Massaciu ccoli su cui insisteoggi la pieve (fig. 1.1-2); è anzi probabileche i due ambienti incontrati nello scavodel 1756 ne formassero il 'cuore', completato da una serie di vani di serviziocome quelli vist i a nord della chiesa nellacampagna del 1920: nella " trincea iniziata a Nord della chiesa ed alla profond itàdi m. 1,30, si rinvenne un pavimento dicalcestruzzo dello spessore di cem. 5 ricoperto da piccoli mattonci ni collocativia spina di pesce; lungh. II cent. largh. 5 edello spessore di 3 cent."." Come eraaccaduto per la pavimentazione in opussecli/e dello scavo 1756, inglobata in uned ificio altom edievale, an che questotratto della villa aveva subito le conseguenze della con tinuità di vita nel Medicevo." il proseguim ent o dello scavoportò alla luce "un fram mento di muroantico a fianco del quale molte ossa umane" , evidente resto dell'uso cimiter ialedell 'a rea, ancora nel Rinascimento," maanche "qua lche frammento di terra cottacon palmeue econ avoli" , evide nteme ntedi last re Campana.Nella modestia di dimensioni , contemperat a dalla raffinatezza degli arre di, ilprim o impianto di Massaciuccoli parrebbe ricadere in un tipo di edifi cio d' ol Èllmche nella fascia costiera dell'Etru ria settentrionale trova ancora la redazione meglio docume ntata nel complesso esplorato negli anni '30 da Enrico Paribeni allaPieve Vecchia di Casale Marittimo, nellafascia costiera dell'agro volterrano.> Anche qui ambiente nodale della zona residenziale sembra fosse un oecus pavimentato di opus sectile a 'modulo quadrato 'd i piccole dimensioni, che ripete tipiusuali nella pr ima metà del I secolo d.C.(figg. 6.8 , 7);27 adiacente a questo, un
..
messa in luce nel 1920 (fig. 9.b), e dinuovo sondata nel 1991 (fig. IO), La presenza de ll' intonaco conferma che last rutt ura spiccava or igina ria mente in elevato, e defin iva - ass ieme al pi last ro chene completava la funzione po rtante a setten tri on e, e for se ad un omo logo simmet rico a sud - una 'q uinta' posta sull 'assedi simmetri a del terrazzo, se l'originariolim ite meridion ale d i q uesto è tracciatodal mu raglione incont rato dal Minto nell' area del vano A. 34 Fra la sost ruzionecu rvilinea d i Ma ssaciuccoli e le fron t i d ivilla a emiciclo che su l finir e del l seco loa.c. trovan o ad Anguillara Sabazia la più
7. Resti rumani alla Pieve Vetthia di CasaleMarittim o: i .'ani A·n.8. Intonaco parieta lc de ll'edific';o romanoalla Pieve vecchia di Ca s.alc.
limpida espressione" il di stacco è cospicuo, se non alt ro per l' impeg no st ruuivo,m a nell'insieme (fig. llj il primoimpianto d i Massaci uccoli parrebbe un 'a pplica zione 'scolas tica' dei temi archi tettonicipre d iletti dall'edilizia residenziale de lloscorcio finale de lla Repu bblica e dell'etàaugustea: l'articolaz ione su terrazzi art ificiali , con funzi on i 'specializzate'; l'inseriment o 'scenografico ' nel paesaggio,co rroborato dagli elTetti 'illus ionistici 'affidati a sostru zion i ' mosse' da avancorp i o da rientran ze."Anche per l' arredo - noto soprattuttodalle reliq uie ma rrnoree ed ite dal Minto,oggi quasi del tutto perdute" - la villa diMassaciu ccoli pare ad un livello simile aque llo esemplificato da ll'e dificio res idenziale d i Casale Marittimo." Eleme nto d i spicco era certamente la statua mar-
122 [Contributi]
marca di grandezza superiore al natu ra leche d iede impulso allo scavo del 1756.Vista per l' ultima volta , a quan to pare,all'inizio del seco lo da l Pellegrini , che net rasse una fotog ra fia ed ita dal Min to.v'lastatua può essere adeguata men te app rezzata grazie all'accuratezza de l pittore settecen tesco che la rip rod usse ' al naturale'{fig. 5): è il classico t ipo con m antellogettato sui fianchi (' Hiiftma ntel '),40 redatto in una versione che nel panneggioreplica puntualme nte lo sche ma attestatoda ritratti di Tiberio co llocabili negli anni centrali del I seco lo."I È applica to dallastat ua di Ti berio dal Foro d i Lept is Ma-
gna, dei primi anni d i Claudio, " a nche ilpart icolare de l ma ntello tratto su lla spalla sinistra , leggibil e nella vedut a lateraleofferta dalla fotografia Pellegrini, e esplicita mente segna lato da lla relazione settecentesca: " la medesima [statua] mostraessere ricoperta con ma nt o, che scendendo li dalle spa lle viene co n genti l panneggiamento d 'avanti a ricopri rl i il corpo, edil restante non coperto da detto ma nto, osia lenzuolo, è sì naturale che vi si sco rgeogni muscolo"."Pur se non ne è ignoto l' impiego per rit ratt i 'privat i', il t ipo con ' Hiiftmantel 'sembra pec uliare soprattutto delle figurazioni imperiali;" è du nq ue plausibi leche sotto Claud io il pro pri eta rio dellavilla d i Massaciuccoli avesse voluto celebrare la sua devozion e alla casa imperi ale, e il part ico lare favore da questa ricevuto, innalzando nella sua villa la sta tuadell' imperatore che lo aveva pa rt icola rmente favor ito , o, pi uttosto , l' in tero ciclosta tuario della fam iglia imperia le." Lecircostanze po lit ico-cultu rali de ll'avanzala et à giulio-claud ia rendono per con-
tre decisamente meno convincen te l' ipotesi che fosse ce lebrato con il tipo stat uario per eccellenza 'c roi zzantc' il pro pri etario o un suo avo.
La progressiva ascesa della fam iglia proprie taria de lla villa non tarda a imporrel' integrale rinn ova mento del complesso.l 'segni' de lla rist rut tura zionc possonoessere co lti soprattu tto nei fra mmen ti diin ton aco, di mat eriale da cos t ruzio ne, diterreco tte archi tettoniche, rest itu iti dailivellamenti sopravvissuti a secol i di scavi e sterri, e ancora indagat i nei saggi del1991-92 :4 (, i termini di rife rimento olTertidallo sca rso mat er iale ceram ico recuperat o , in cui si osserva la presenza di solasigillata tardoitalica, liscia , e l'assen za d iproduzioni d iffuse a partire da llo sco rciofinale del l secolo d.C. - dalle sigilla tetardoitaliche decorate a rilievo alla sigillata chiar a A africana - sono asso lutamente congruenti con le indi cazioni offer te da lla raffinat a tec nica late rizia imp iegata nelle 'Terme', espr essione deimodi urba ni ben documentati in età neroniana e Oavi'14 7 e im piegat i anche nellavicina Pisae nella cos t ruzione de lle cosiddette 'Terme di Nerone'."Le vice nde de l terrazzo superiore sonoignote, ma certamente anche questo dovette essere radi calmente trasforma to,con ilconsolidame nto de lla fron te settentr ionale affidato ad una poderosa operad i sos truz ione ad arco di ce rchio, racco rdata sul lat o occidentale alle preesiste nt iopere d i sost ruzione da un breve trattorett ilineo (figg. 9, 12-13).Lo scopo eminentemente fun zionale diq uesta struttu ra sembra confermato dalla regola re serie d i bocc he d i drenaggioche vi rimasero aper te," e da ll'imp iegonel pa ra mento dell 'op era mista, con ricorsi laterizi alternati a alte fasce di bloccheui irregolari d'a renar ia;" m a.si ap rivaanche un 'belvedere ' su l lato più frescode l settore residenziale della villa, in aderenza al gusto che ha in età flavia unarea lizza zion e monumentate nella Domus Augus tana, ma è anche attestato, inun a red az ione più coe rente con quella diMassaciuccoli, nella ristrutt urata villa diPiano sa."Il capite llo recuperato negli sterri del1920 sul piazz ale ant istant e la ch iesa (fig.14), che sembra rifer ibile ai dece nn i cen t rali del l secolo d,C. ,:!2 pot rebbe esse restato messo in opera in ambienti del rinnavata settore ' res ide nziale' della villa .Nell a rimodellazione del terrazzo inferio re parrebbe di dover riconoscere l'appl icazione dell o schema di villa che nasceintorno alla me tà del l secolo d .C., pergiungere a com piutezza nella villa tibur-
,
,
•
' . '' .
. ' . n' .. ..·..;...~ .....
".-'"'.:,.
l ' ,
..'
'.
: r
• • r • • ' ,D.., , , 1 .• e 'LA >O•
' ". "," ..' " ': 'i r ....
;. »,-:
..., .-
o:.
o' . ....
.. ,..... ~ .e :l5 .,..
.,-
. '~. , .'
..... :'~
...•
.O .. . j
.' .
..,.
"" "., ...•.•
.... ~ ..
'"'".-
,,,.:CI
I ..
.~ :'
"l u ~I "
..:; ,";'
'9 '
l
--D ~",.
D ti . ..
[J .."-.-,,m<occ_u'o
B ''''''''''Cl
MASSACIUCCOU M.T.
,
" ,rI
9. Le "Tume' dì Mussaciu<Xol i. [Contr ibuti] 123
tina di Adriano: blocchi funzionali, tcpograficamente dist int i. tende nzialmenteindipendent i. Nell'area già a giardino sistruttura infatti un più amp io ripiano.con nuoveopere di terrazzamento a sud ea ovest, e piccoli ciptopcrt ici,H che acca.glie un complesso di ambi enti per i qualila dest inazione termale, che ha dato ilnome al monumento, sembra solo parte ,seppur prevalente, di una più ecletti caserie di ruoli.La defin izione di fng idarium» sembrainfatti almeno ridu uiva per il 'cuore' d iquesto setto redella villa (fig. 15), composto dal grande ambiente H. completato
io. Saggio a montc dell'ambien te I:la struttura curvilinea.
dalla vasca I, e dall'esedra, ugualmenteprovvista d i vasca, L, i cui art icolati volumi erano scand iti anche dai rivest imentimarmoreidelle superfici e dei paviment i,e dalla decorazione scultorea, in panesuperstite al momento dello scavo. nel1770:H " In seguito si trovò un bagnogrande di figura quad rangolare tutt o incrostato di marm o bianco nel mezzo dciquale vi scendeva l'acqua a velo e da unaparte. e dall'a lim di detta scesa vi sonodue nicchie all'istessa altezza, ma nondella stessa fattura. Si trovò pure unapicciola vasca (giacché non lo credo unbagno per contenere poca acqua) ed èfatto a guisa di picciola tribuna, ed erasopra ricoperta a volta fatta di tufi, comeda lle vestigia siconosce,e l'acqua vi scendeva da una piccola nicchia, nella qualevi sarà stato qualche piccol delfino, esscndosene diquesti trovati de i pezzi. fra iquali uno con sopra un purtino ma ancora questo rovinato, e la detta vasca o sia
124 [Contributi}
bagno era pure incrostato di marmi bianchi, essendosene sempre sì nell'uno. chenell'altra dc i pezzi fermati al muro"."L'anali si de i tessuti murari segnala chel'a mbiente. al momento della costruzione, era isolato a sud e a nord (fig. 16.1); learcheggiature che danno sulla ' vasca ' Jnon erano soffocate dai sett i murari deirifaciment i successivi, e l'esedra L conl'a mpia finest ra che si apriva al centrodella parete curvilinea (fig. 17), era ungeneroso ' pozzo di luce'."L'insieme dei vani H-I-L ripete d unque iltema della "grande sala con prospettiveaperte su due ali gemelle" impiegato per
tr iclini-ninfei dci complessi residenzialiimperiali ncronian i c flavi," con un ricercato contrasto di luminosità fra le ombredell'ambiente H, interrotte solo nel tardopomeriggioda l fascio di luce che penetrava dall'esed ra L, e il chiaro re matt utino eserale che faceva scintillare le acque cheprecipitavano nella 'vasca' I - forse suuna scalinata, come nella Sala Ottagonadella Domus Aurea o nell'edifi cio, ancora nerouian o, del Palatino" - al centro diuna fronte mossa da nicchie (fig. 18).L'alimentazione era garantita dallagrande cisterna che raccordava i due terrazzi,w il cui pavimento incocciopestc da unlato si impostava sui contraffort i dci pristino muro di rcrrazzamento, dall'a ltroinsisteva su un rnuraglione parallelo aquesto, di nuovo impian to.L'ambiente I è dunque un ninfea , e diconseguenza nel vano H-L. almeno nell' impianto originario. si dovrà riconoscere un triclinio estivo, progettato secondolo schema ancora vitale nella prima redazione dell"Edificio a tre esedre ' di VillaAdriana."È probabile che lo scrosciare delle acque
fosse ' assecondato' da scansic ni arc hitettoniche. Lo stato att uale del tessuto murario della fronte del ninfea I. nella facciaa monte. induce infatti ad ipotizzare lapresenza di volte che la raccordavano allasostru zione della grande cisterna: la scalpellatura del tratto superio re della pareteorientale difficilmente può essere att ribuita alla spoliazione del rivestimentolaterizio, da to che il filo del muro è quasipcrfettamente perpend icolare, e parrebbe piuttosto indiziare la presenza di volteche nella ristrutturazione del raccordofra idue terrazzi furono demolite, avendoperò cura di conservare al muro uno spes-
l L Resu dcll;aprima fase dc l1;a \'illa.
sore coerente con quello del tratto inferiore. L' ipotesi è corroborata anche dallatraccia dell'i nnesto di un pavimento incocciopcsto sulla risega che scandisce iltra tto inferiore della parete (fig. 19).L'area termale vera e prop ria del complesso, nella sua ani colazione originaria,dovrebbe essere cercata al margine settent rionale dell'edificio. imm ediatamente raggiungibile, grazie alla scalinataP,62anche dagli ambi enti residenziali delterrazzo superiore. La latr ina Q/ ' in questo caso, si porrebbe 'canonicamente' almargine del percorso termal e, che ecomunque assai difficile tracciare," pur seil rilievo settece ntesco pubblicato dal Ridolfi' "(fig. 20) ind ica am bienti con pavimentazioni su suspensurae proprio inquesto settore della villa. Forse le valutazioni sul complesso sono condizionatedalla perdita pressoché completa dei vaniS c T, c di altri ad essi event ualmenteadiacenti nel quadrante nord-occidentale del terrazzo: un lembo murario in crolloche giace sul fianco della collina immed iatame nte a valle (figg. 9.c, 2 1), verosimilmente in giacitura primaria, segnalache almeno uno degli ambienti di questosetto reera capen a da una volta di sviluppo impegnat ivo, se per alleggeri rla vi siinserirono anfore,o grandi vasi.v e si fecericorso per i caemenla a blocchett i dileggera panchina .
Nel percorso termale era certamente integrato anche il grande vano 2 ,67apertosul lato soleggiato delcomplesso, e riscaldato da un fama impiantato al centro,subito sotto il pavimento, ancora benconservato al momento dello scavo, nel1770: "Un calida rio fallo quasi a guisad'anfiteat ro con Ire ord ini di scalini. quale an fiteatro anzi calidario posava sopradiversi pilastri. cd era distante dal muromaestro circa un sesto d i braccio, ed inquesto vacuo vi erano all' intorno per tu tto delle cassette di terra per portare ilcalore all'i nterno. vi era ancora la portaper andare a far il fuoco in un forno che
era in mezzo a detto calidario, e sopra ildelta forno viera una granlas tra di piombo incastrata nello smalto, forse per impedire che il cala r del forno calcinasse imarmi bianchi di che era ricoperto...".6'Mentre appare incongrua la destinazionea piscina per la calida tavatio, in relazionead un calidarium non identificato, e a cuioccorrerebbe att ribuire proporzioni gigantesche, sono evidenti le precise analogie dell'ambiente 2 di Massaciuccoli conil cosidetto heliocaminus che dà il nomead una delle terme di Villa Adriana. Come in questo, i gradini sono disposti suilati ' interni' dell'ambiente, lasciando li-
bera la parete esterna; le suspensurae nonsono i consueti pilastrini, ma un poderoso sistema struttivo; manca un vero eproprio impianto di adduzione e smalti mento delle acque.s" È dunque verosimile che l'ambiente Z sia una sudano. chedoveva avere un ruolo cospicuo nel complesso termale, forse anche parzialmenteautonomo dal circuito balneare vero eproprio, o comunq ue periferico rispettoa Questo. Se al tipo di ambiente termaleesemplificato da llo pseudo-heliocamiflllS di Villa Adriana appart iene anche ilvano 1delle terme della villa di Domiziano a Sabaudia. come ha proposto con
S C Al A , ; so IIl!TII I
Il·ll. La 5O$lnUIORC' K1,cnlrionalc c OCl."Kknl2kdd ,crrazzo SUJl'C'ÒOft' <Iella ,·,Ila. o ... ' 2.........
S CAU 1 SO
, 1 ,
""U'
•
I
uv
- - - - --argomenti co nvince nt i la Verduchi ,1O Il'organi co inserimento della villa di Massaciuccol i nelle esperienze a rchitettoni-che dell'avanzat o I secolo d.C. sarebbeco nfermalo; come a Massaciuccoli, nellavilla imperiale d i Sabaudia all 'impiantoter male vero e proprio era inn esta to uncomplesso siste ma di ambienti per il banochetto o il riposo ." Si pot rà infine notareche a Massaciuccoli è impi egato . comenello pseudo-he/i ocam in lls d i VillaAdriana, c in impiant i termali dci dece nni di pa ssaggio fra I e Il secolo, l'accorgimento della lastra di piombo ' immersa'nel cocciopesto, nel punto maggio rmente
14. Capilcllo . dal terrazzo su jXrioc>« <klb ' "lUI .MassaciuCC'Oli. Anl iqlla"um.
sollecitato dal calore."Soluzione cara all'architettura della villad 'età flavia pare l'am bien te co n unicoaccesso, a pareti lateral i cu rvilinee. Il vano Y, se. co me rilevò il Mint o, la sudatioZ era accessibile so lo dagli ambienti X edY, poteva infatt i svolgere un ruolo sim ilea Quello d i un ambi ente icnografica mente ident ico della villa di Pianosa, accessibile dal picco lo at rio che art ico la il quadrante soleggiato de lla villa." A Massaciuccoli il vano con pare t i cu rvilinee èombrato , ma i cont igui a mb ienti termalica ld i poteva no farne il "rifugio "nei gio rni- o nelle ore - di freddo.
I nuovi dat i prosopogra fici sulla famigl iapisana dci ve nulei offe rt i dal recupero d iun ' iscrizione dalla Vald egola" permettono d i da tare negli a nn i intorno al 70 a nche la fistula in piombo siglata da L. venuleius Mo ntanus et L. Venulciu s Apronianus (C1L XI. 1433a) ritrovata nel1770 - sta ndo alla relazione settecentesca ~ Dei pressi dci pu nto in cui era venuto alla luce un to rso virile, " in vicinanzade lla sopradetta an t ica t ribu na dellachiesa": "si trovò pure nello stesso luogolongo un muro una fistula d i pio mbo , chenaturalmente portava l'acqu a a i son oposti bagni , nella qual fistula vi era no inrilievo le seguenti par ole L.L. VENUL EIO R,
I MO NT, ET APRON~ , 75 La preci sazione
126 [Cont ribut i]
- opera Iarenzta......... ...... coera mista: ricorsi di laterizi e blocchi darenaria- opera mista: arena ria e eoecctuat ore di larerìno- are nana
- ltt nJt.turc COI'6erv.ate i'l fondazm
1
IS. Tecniche ediline e di p;l~imentazionc
eelra rea delle 'Terme',16, le due fa§i delle 'Terme'.
I I I
z
2
•
r:
potrebbe suscita re qualche dubbio: lostesso cronista. ri ferendo del ritrovamento del 1756 , qua ndo - come si è visto furono rccuperatc " due picciole fist ule d ipiombo" , non menzion a l' iscrizione, chenon viene ripro dotta nella tela, e non ècitata da ch i, com e il Donat i o il TargioniTozzeui , bene info rma ti sui ritrovarn en tidel 1756,76certamente av rebbe com menta to un recupcro epigrafico d i tal ril ievo;d 'a ltro canto potrebbe esser diffi cile am mette re che il " to rso d i sta tua bellissimopoiché a vcderlo pare si deva toccare lacarne" degli scav i del 1770 77 sia cosa d iversa dal torso del ri trovament o 1756.Tuttavia l'accen no dci Pellegrini ad unasecon da stat ua nella collezione Mi nutoli " può indurre ad acce ttare la sequenzadei ritrovamen ti ricostruita dall a relazione settece ntesca: nel 1770 si rip resero gliscav i nell'area abs idale della chiesa, e sitrovò, con un seco ndo to rso, anche laconduttura d i piombo siglata da i vcnulei, che offrirebbe qu ind i un termine diriferimento anche per data re la vasca delritrovam ento 1756, e pa rla nella ristrutturazione d 'età neroniano-flavia.Dati gli interessi dei venulei nelle att ivitàman ifatt uriere, dimostrati dalle produzioni lat erizie siglate da L. VenuleiusApronian us," i rapporti fra la fam iglia ela villa d i Massaciuccol i potrebbero a nche essere stat i limitati alla forn itura dicondutt ure in piombo; tu ttavia l' int reccia rsi degli ind izi rende particolarmen teconsistente l' ipotesi, affacciata già daglier udi t i del Settecento , che de lla villa d iMassac iuccoli i Venul ei, e segnatamenteL ven uleius Montanus - quasi certa mente il Montanus proconsole d i Ponto eBitinia sotto Nerone" - e il figlio, L.Venuleius Monta nus Apro nianus, console nel 92 d.C., fossero i prop rietari.Gi à si è detto delle evidenti conness ionifra le 'Terme ' di Massaciu ccof e le 'Terme di Nero ne ' a Pisa, probabilmen te ed ificate dall e stesse maestranze, guidate daun architetto che, in entramb i i casi , propone un ' progetto ' che adegua alla scalamu nicipale gli esiti della ricerca archi tet toni ca sviluppata dai grand i ed ifici imperiali: la cupola del ìaconicurn delle 'Terme di Nerone?" riflette i modi della Domus Aurea come il triclini o-ninfeo H-I-Ldi Massaciucco li. Le terme pisane son oprobabi lmente frutt o dell'evergetis monei confronti della città della massimafamig lia local e;" che cos ì, negli ultimidecenni del I seco lo d.C. , celebrava contemp oran eamente l'apice della carrie radel Mon tanus, for se fondato re delle fortu ne della famiglia, e il brillante inizio diquella del figlio.Nel territo rio gravitante almeno econo-
micamente su Pisae la 'p resentazione 'dei nuovi fast i fam iliari era affidata adaltre iniziati ve, com e la ded ica alla DeaBona da lla valdegola," e, con ogni probabi lità, il rinnovamen to e l'a deguamento al nuovo rango della villa di Massaciuccoli. Posta in un punto be n visibiledalla città , e dall ' intera fascia settent rionale del territorio pisano, la villa era un'segno ' del paesaggio che, pu r sen za essere dom inante, am moniva sul ruolo dellafami glia nella via cittad ina .Si può imm agina re che Mo nta nus (se nonil pad re) già vi avesse magnificato constat ue imperiali la devozion e alla casa
17, La sm nde finestra della prima fase dell' esedra L.18 La fronte del ninfe e l.
giulio-cla udia, facendone elemento primario nella strategia d i ' promozione'della fami glia; la fama di Luni com e luogo di olia, forse da non sopravvalu tare,madi certo ta ngibile, fra l'età nero niana equella flavia, gli pcrmeueva di pro po rre achi viaggiasse per terra o pcr ma re daRoma verso gli ozi ' tirreni' e ' figur i', o,sempliceme nte, verso Nord, un ' rifugio'di cui po i parlare nell ' Urbe; cedendo allasuggestione delle date , si potrebbe perfi no imm aginare che il ciclo di sta tue imperiali sia sta to allestito in occasione delviaggio di Claud io verso la Britannia, nel43, quando l'imperat ore toccò Luni."
[Contributi] 127
Il rinn ovam ento dell' tarredo' era naturalmente insuffi cien te a qualificarel'ascesa della fam iglia, e quindi si passòalla radicale trasformazione , cui offre untermi ne di riferimento assoluto, coerentecon i dati stratigrafici e architettonici, lafistula plumbea: l'apice della carriera delMontanus, l' inizio di quella del figlio devono essere posti fra gli ultimi anni diNerone e quelli di Vespasiano.Lesoluzioni architettoniche proposte peril terrazzo inferiore dovettero presto apparire limita te, o poco funz ionali ; è eviden te, in particolare, che il triclinionin fea H-I-L poneva problemi per una
19. Possibile in nesto di p;lvimemo sul blu Ndella fronte del ninfe".
reale ' vivibilit à', forse per l'eccessiva ' immersione' nell 'a mbiente , ta nto perl'aperto che verso i vani adiace nti. Siprovvide qui ndi ad inserire il complessoH-I-L in un circuito obbligato, con un'vestibolo ' E, e, simmetri came nte , completando il corridoio N; l'oscu ram entodell'ambiente è concluso dal tamponamento de lla grande finestra nell'esedra L,conseguente anche alla cost ruzion e di unangusto vano M, riscaldato da un'apert ura rozzamente ricavata nella parete sull'ambiente di serviz io adiacente a ovest(fig. l 7.2).SjVerrebbe da supporre che gli apprestament i siano funziona li a trasformare iltr iclinio-ninfco in un vero e propriojrigidarium, forse perché si avvert iva l'assenza di un vano per il bagno fredd o adeguato al complesso , e comunque l'aperturaallo spazio del tr iclinio -ninfeo, pur di
128 [Contributi]
grande suggestione, ne lim itava le concrete possibilità di sfruttamento.Per il momento non è possibile datarequesta trasform azione cosi come quella,più radi cale ancora, che ha portato all'aspetto att ua le (fig. 15). L'impi ego diblocchett i informi d'arenaria permette diatt ribuire ad un unico momento la definit iva chiusura del vano H-l-L: due van i(O e F) vengono definiti a est e a ovest, ilcriptoport ico laterizio che chiud eva amonte l'ambiente B è demolito, sostituito da un muraglione di conten imento chetraccia, assieme alla parete di F, ancheuna nuova rampa d'accesso al terrazzosuperiore. È dunque in questo momen toche vengono abbattute le volte che raccordavano il nin feo I alle struttu re di terrazzamen to; queste ricevono una frontemovimentata da sei nicchie (fig. 13) simmetric amente disposte, per cui si ricorreal rivestimento laterizio, pri vo tuttaviade l rigore e della coere nza che connotal' imp ianto flavio e la pri ma ristrutturazicne. La buca superstite al di sopra dellenicchie fa presumere la presenza di unpiano soprelevato , affidato ad una trabeazione lignea , che doveva da ll'altraparte impostarsi sulla parete de ll'anticoninfea , offrendo un modesto sostitu to almovimento che la sequenza di volte imprimeva all'impianto originario.Nell'assenza di concreti riferiment i cronologici, soccorrono solo le vicende famil iari dci Venulci, la cui fortuna raggiunge l'apice alla terza e alla quarta generazione, con il conso le ordina rio del123, L. Yenuleius Apronian us OctaviusPriscus, e il figlio omonimo, console ordina rio del 168.86
20. t.e 'Tcrmc': planimetria R idolli(da 'NOIizic Scavi'. 1878)
È almeno verisimile che anche l' ultimaristrutt ura zione sia avvenuta quando [avilla apparteneva ancora alla fam iglia: ilconsol e del 168 finanzia opere sussidiarie (o di restauro) alle terme di Pisa, rin nova ndo il legame tra famiglia c citt à;"ed è possibi le che a questo ciclo di lavoripossa essere collegata anche la nuova definizio ne dci percorsi della villa, che - adispetto de lla modestia della tecnica edilizia - sembrano scaturire da un precisoprogett o architetton ico.Con l'o mbrosa am bulatìo si apriva in effetti un ' terzo' piano di vita, fondendo inun unico blocco i nucle i autonom i del-
21. Frammento d i '"olta con anfore di alleggerimento.
l'i mpian to nero niano-flavio, rimasti talianche nel pri mo rifacimento. L'ornamento di sta tue che le nicchie permettono di attribuire all'ambiente ne confermail ruolo di rilievo nella nuova articolazione della villa, divenu ta ora la compattamole che potrà sopravvivere alla fine delmondo antico come sede di un primoedificio di culto, costruito con materialedi spoglio su[l'opussectìledel settore residenziale," e del villaggio che ancora nelTrecento si disponeva fra i ruderi romani ,trasformati dalla stupefatta fantasia deicontempo ranei in un muraglium Seracenorum. 89
,.
,
•
J
f
•
l ) Pers.. Sal .. V. v.6 55.2) Stai.. Sitvae, IV, 4. v.20 55.3) Per questa. da ultimo A.P. Zacca ria Ruggiu. inLuni, Guida Archeologica , Sarzana 1985, p.88 ss.4) Ptr la t rama d i interessi fra famiglie urba ne eV nlNcminenti di Luni. cfr. p. es. G. Ciampoltri ni.A/IOOru per L Tìtlnius Gteucus Lucretia nus . in'Athenaeum" SO. 1992, p.233 ss.5) FI"O\'a. in Lunidl ., p.138 55.• con altra bibl.; sullavilla del Varignano, da ultimo A. Bcrtinc . L M.Benino. va rignano. in Archoolugia;n Liguria //1.1.Scovi e scoperte / 981·6, Genova 1987 (ma 1990).p.25 l 55.6) Per questo. A , Frova. /J{/(L'u di Magra. inA rd llv.tog ìa il!U~lIri(l_ Scavi e scoperte 1967- /9 75, s.l.s.d .,p.55 55., fig. 70: Id., in LImi eu.. p.138, fig. 24 8.7) Per que sta. P. Gambogi. GorgO/IO (Li). R/cr rc/wItel/a villa romana d'l'la altRII.f/('(I , di prossima puhblicazic ne su 'Bollett ino di Archeo logia'. Le villeinsulari taréorepu bbhca ne e della prima età imperiale, quasi sempre rad ica lmente tras formate in etàtraia nec-adrianea. sono ind iziate da sca rsi resti. e.scerauuuo . dalle rerrecenc arcbue ncniche: cfr. P.Rendin i, Correntidigll$IQnelfeterrecottearcnitenomche dell'EtruriacostieraIra tafìne dl'llaReprlbbli(li e ia prima età imperiale. in corso di sta mpa negliAtti del CoO\'CgIlO di Pisa 1992. ,lleiWl t' gli altri,8) A, Minto. Le erme romane di MU$SllcillCCOli. in'Monumenti Am ichi dei Lincei' 37. 1922 (in seguito Minto 1922), col. 405 55.
9) Minto 1922, col. 440 ss.l O) Cfr. da ult imo H. Man derscbeìd. Bihiiographieznm rIJmischen tìadovosen. Milnchen 1988, p. 147,fig. 246: 1. Nrcrscn. rtwnnae l'I Balnea, Aarhus1990. vol. II. p. re, C. 6 1.I l ) G, Arr ighi, Le lerme romane di Massacìvccotì,in 'Giornale Storico de lla Lunigiana' 14, 196 3 (inseguito Arrighi 1963), p.42 ss.12) Documentata p urt roppo da un giornale d i sca.\'0 decìsameme sommario (Arch. Sopri ntende nzaArctaeologk a per la Tosca na. Lucca 1920- 1925.fase. Massaciuccoìi; in segui to Arch. SAT, Giornale).13) La\'ori 199 1-92 della Soprintendenza Archeologica per la Toscana. con la collabo razione delCo mune d i Massa rosa . L'abili tà art igiana d i BrunoSodi ni e Renzo Merciadri. del l'i mpresa Sod ini diLucca .e stata ind ispensabile per il successo delri m·presa: Paolo Noti ni ha curato la documentazionestratigrafica , men tre il nuovo rilievo del monumen·to (figg. 9, 12-13) è st:1I0 redatto dal la CooperativaArcheologia di Fircnz e (arch. Anna Mannari e Roberto Sabclli).14) Arrighi 196 3. p.46 sS. ; il bracciÒlucchese, di viso in 12 once. è di cm. 59 circa.15) La collocazione de.tle trin~dcI 17 56 e confe r
m:lla. olt~ cbe.da lla tela. anche da lla planimetri adel complesso rcda lla nel 1698, riprodona in G.Lera . Massaciuccoli, in ·Giornal e. Stori co de lla lunigiana' 14, 1963 (in seguito lcra 1963). p.27, fig.12. La ' cucina' de lla canonica. in partico lare, tpressoché in corrisponde nza dell'att uale spigolomerid ionale dell'edi ficio, che sembra leggermen tearretrato riSpellO allo stato ~i-set1c:u: ntesco (fig.2.b).16) F.Guidobal di. Parimemi in 0pusseclife di RQma e del/'area romana: PfQlHJs/e per una cf(J5$ifica.:ione f! cri/eri di data:ione, in Marmi anlichi. Problemi di impiego. di r('Slauro (' d'idenlifim:iOllt'('Sl ud i Miscella nei' 26). Roma 1985, p.205 ss.. tipofi g. 25.F.17) 'Porta santa', come vuole la Relazione. o piuttosto rosso antico? Cfr. p. es. Marmi amichi. a curadi G . Borgh ini. Rom a 1989, p.2S5 ss., in pan .p.288, per il rosso an tico; per il ba rdiglio di 'Ca rrara'. pietra pred ilelta proprio per le pavimen tazioni ,iI'i, p. 15J.IS) G uidobaldi. arI. cit.. p.207. nota 107, tav.S,I.19) G . Cia mpoltrini . Mosaici d 'etàgiulto-claudianell'Etruria settentrionale. in ·Pros petti\'3.' 69 ,1993, p5 8 55.• flg. 20.
20) I~e r qu esto, p. cs., P. Grimal, Les 'horti Tanriam: E/ude /opograMiqllesnr lo régìon dr la Por/eMajeure, in 'Mel. Ecole Fra nçaise dc Rome' 53.1936. in partop.2 74; d is. (di P.L Ghezzi) in Cod.Ollob. Lat. 31OS. c.189.21) Per q uesta , da ultimo Rendi ni, an. m. a Dotat .22) Lera 1963. 1'.23, fig. 11: ri trova mento del1955.23) Arch. SAT. Gioma ìe s.d. (15-22) agosto 1920.
24) Per questa G. Ciampoltrini - P. Noti ni, Massac ìvccon (Massllrosa. Lu). L 'insediamento POSIclassicone/l'areadello vitta, in 'Archeologia Med ievale' 20, 1993. p.393 ss.25) Nel rilievo 1698 l'area - già occup ata dallanavata latera le dell' edifi cio rom anico. è ind icatacome " Cemeterio vecchio, già Nave an tica dellachiesa": Lera 1963, fig. 12.26) Cfr. E. Pari beni, in ' LeArti' l , 1938-39. p.323.fig . 36-37; A. Minto , Uhimescopertearcheologichein Etruria che interessanofa romanuà, in Atli drl VCongr. Naz. di Sludi Romani, Roma 1940. p.3 55.(delrcstrallo);Arch. SAl; Disegni, fase. 'Casale Maritti mo '. dis. 173.27) Guidobaldi, an 0'1.. p.209 SS.. fig. 26a.28) Per queste. in generale M.L Morricone.&ulukua pavimenta. I pavimenti con inserti di marmo odi pietralroYOli a Roma e nei dintomi, Rom a 1980.p.80 ss.. in partonota 4: per la datazione ancora aglianni centrali del I secolo d.C.. si veda l'ese mpio diLuni: Ruggiu Zaccatia. un cii.• p.S8 ss.29} Cfr. p. es. W. Ehrhardt. Stilgeschichtliche Umersuchungen an ròmischen wandmatereien, Main zam Rhein 1987, p.74 ss.. tnv, 44 (Casa del Bell' l mplu vioj: ta v, 49, fig. 202: ecc .
30) Non si può escludere che i laterizi fungesseroda piano d i posa d i suspensurae. di cu i qu alchetraccia sembra segnalata nel va no G; la desunazì one termale di questo seuoredell'ed ificio apparterrebbe dunque già al primo imp ianto. La costruz jone dei due van i ' termali' E e F,posti ad una quota d ivita supe riore a q uella de ll'impianto originario, d icui impl icano la defini t i\"3 obliteraz ione pambbetrO\'are un lerminus penI f[lIl'm nella moncla tetrarchica d i Valerio severo rccupcrala al liveUo de lpavimento in opu.JSe<:liledel vano B(an notazioni alrilie \"O cito a nota 26).31) Minto 1922. co l. 4 11. Vaste trincee in q uestosetto re doveva no essere già sta te apene sul finiredell'Ottocento: G . Pellegrini , Vìar('ggio. Slii prege\"oli DI'allzi dellt' terme romanI! di ll1u.\'sac!lIcco{i. in' Notizie Scavi' 1901 (in seguito Pellegrini 190 1).1'.198.32) In questa t~nica era no realizz ate anche lest rutt ure esplorate nel 1920 sul piaualc della cbiesa: Minto 1922. co l. 4 11.33) Cfr. in meri to A. Ca... ndini, in Sf!(Il'/ines/re.Una,'i1/asclu"al'isl;canellElnlriaromana, I, Modena 1985. p.155 55.; H. Mielsch, LlJ l'ma l'Qmana. tr.il., Firenze 1990 (in segui to Mielsch 1990). p.45...34) Minto 1922. col. 4 15. lav. I.35) Mielsch 1990. p.52 ss.. fig. 28.36) Mielsch 1990. p,4 7 ss.37) Minto 1922 , co l. 437 SS.
38) SlIpra, nota 26.39) Pellegrini 190 1, p.199: Mint o 1922, col. 438,fig. 12.40) Sul tipo. da ultimo S. Maggi. AlIgllstoeiapolilica del/(' immagini: lo Hiifimallldt }'fJus (sul significaI/) di una icol1 ogrqjìa e slllla sI/a [orma:iolle), in'Rivista d i Archeolo gia ' 14, 1990, 1'.63 sS.: p. 73,nota 3. per l'escmplare d i Massaciuccoli.4 1) H.G. Nieme.yer, Studien ;:urslOlIlarischenDarslelfung deT r6miscl!t.'11Kaiser. Berlin 1968 ,1'. 10255. , nn.74 e 78. tavv. 24. 1 e 24.4.42) Niemcyer, op. cit.. p. 10 3. n.77. tav. 25.43) Arrighi 1963, 1'.46 .44) Si \'edano le osservazioni d i Maggì, art. cii..p.67, nota 71.45) Cfr. in merito R. Neudecker, Die SklllplllTen-
ausnanung ròmischer tqllen in tudren . Mainz1988. p.84 55.: ad un secondo torso " palhatc" accenna Pellegrini 190 1. p. I99.46) Ind icazioni st ra tigra fiche affidabi li sono stateolTene dal saggio C, nell'ambient e N. e dal saggioM,disposto a montedelrangolo NOdclla 'vasce" LIl primo ha permesso d i cogliere, a ridosso dellapare te merid ion ale del corridoio, un lembo del ccccicpesto d i pavimentazione (o di allenamento dellapavimentazionc musica; US 19), che copriva unuve uamenrc (US 18) di pezzame eterogeneo, caotico , sciolto , che suggellava la copertu ra della SOItG-
stante cloaca (US I I); illivellamentc 18. connessoalla cost ruzione dell a cloaca e del co rridoio, restituisce fra mmenti d i lastre di marmo. di lateriz i,tessere di marmo (bianco e ne ro), e rar i frammenticeramici. fra cu i du e di sigillata itatica, ldcnrica è lacompos izione oetrìvenamcnro 2 del saggio M (fig.IO), che viene deposto di retta mente sulla roccia,per obli terarc la sosrruztone curvilinea e il pila stroche ne segna il margine N, parzialmente demolito: illivello è con nesso al la elevaz ione della strut tura J.cd ~ tagliato dal muro in blocche u i irregolari d'a renaria che chiude il vano O: esigui i ma teriali da tantirestituiti . ma la sigillata italica liscia. ed un fra mmente d i lucerna ' a disco ', sem bran o forn ire unterminut posI f[1/l'm intorno alla metà del I seco\0.47) Si \'OOa per tutti G. Lugli, LA tecnica edìtiziaromana, Roma 1957. tavv, C LX I-CLXII.48) Per que ste Pisa: le terme 'di Nel"()lIt.' ; a cura diM. Pasq uin ucci e S. Menchelli, Pontedera 1989. inpan. 1'.65 ss.49) È decisamente meno prob abil e la propo sta diMinto 1922, col. 41 I s., di leggere nella st rutt ura unninfeo , face ndo delle bocche altrettante fontane:l'ass enza di baci ni per la raccolta delle acqu e alpiede de lla struttura (co nfermata anche dagli srerriesegui ti a più riprese dagli anni Cinquanta) e, amon te. di impiant i per la raccolta e la dis tribuzionede lle acqu e. rendono verisimile l'eco nomica ipotes iche le bocche fossero destinate esclusiva me nte ald~naggio delle acq ue sotte rra nee. alleggere ndo lapress ione che comunq ue gra va\ 'a su ll'opera d i sostruzio ne.50) Per la tecnica . lugli. op. cit., tav. CUx.51) Miclsch 1990 . p.63.52) Minto 1922. col. 4 37, tav. V,5; ritrovamentodell'agosto 1920 (Arch. SAT. Giornale, 2-7 agosto);- Alla pro fond itàdi m. I,80 de110 scavo a O \·cst dellapiazzen a della chiesa si rin venne nelle terri (sic.l) discarico un bellissimo capitel1ino di marmo biancodi forma rettangolare (quadr icorno)... Anch e inquesta sett imana non mancano frammenti di matton i, di lastre d i marmo. alcune delle qu ali colorate,qual che frammento di terra cotta. uso fregio confoglia acand us (si<:,'J ~ . Una datazione al terzo quartodel I secolo pot rebbe contemperare lo sch ema iconogra fico. che a rrieehisce con i corimbi il tipo -00
rinzieggia nte a calice centrale con foglie lat erali infunzioni di volutc~ attestato da un ~mplare
osti eose dci prim i de l Il secolo (p. Pensabcne. Sca.·;di Ostia. VII. I capi/t'Ili. Roma 1972, p.145. n.584.Iav. LVI), e i lrall i st ilistid, che non si discosta no.sopratlun o nelle foglie dal margjne mosso e perl'inse rimento d i un elemen to suss id iario - foglie,co rimb i - nelle foglie laterali , da escmplari ur bani ed i Luni co llocabil i in età giulio-claudia (A. Gal1 ottini. in Must'O Nazionalt.' Romano. LeSCllllure. 1.11,acura di A. Giuliano. Roma 199 1, 1'.26. 0,43).53) Ha stru tt ure e volta laterizie quello adi acente alvano B, che completa il terrazzo supe riore (Minto1922, col. 4 15): con apparato murario più modesto,e fun zion i forse 'di servizio' quello che forma labase dei vani U c V (Minto 1922, co l. 428 ss.).54) Minto 1922. col. 4 17 55.
55) la data dello scavo è confermata dai riliev isett ecenteschi ; si \'eda la sequ enza de lla doc umentazione icon ografi ca su lla villa proposta da Pellegrini 1901. p. 196 ss.56) Arrigbi 1963. 1',49. Per ele ment i del thiasosmarino _ ta lora 'con ta minati' con tipi delthiasosd ionisiaco - nell'arredo di ville. soprallullo in rela-
(Con tr ibut i] 129
aio ne a fon tan e, Neudecker; op. ÒI . (3 nota 45), 1'047ss.: in contesti termali. H. Mand erscheid . l>ieSku/ptrm',wussta/llllrg der kaiserzeitlichen Thermenantagen. Berlin 198 1. 1'.30 s.57) Sul ruolo delle esed re come ele mento di luccnei tr iclini. Mielsch 1990. 1'.73.58) L Fabbrini. Dom us Al/fea: una mlO"a teuwuplanimetrica dd pofa=::osu/ ColJI.' Oppiu, in CiI/ lÌ l.'arcnueunra nella Roma i mprfjale, 'Anale<:ta Romana Inst. Danici', Suppi. X. 1982,1'.169 55" inpart. nota 37.59) A. BoCthius. Thl:'Golden JlOIISi'DJNWD. Somessoeas DJ Roma n ArchlIecl ure, Ann Arbcr 1960.1',107 fig. 58.60) Minto 1922, col. 412 ss.61) Sintesi in Mielsch 1990.1'.73 ss.62) Minto 1922, col. 425.63) Minto 1922, co l. 426 s.64) Nell'a mbiente R i saggi 199 1 hanno messo inluce una vascbeua con fondo in laterizi e. nellagettata cement izia ad essa adi acente, tracce d i quattro alloggiamenti. che pot rebbero anche esse re riferi ti alla ca ldaia che doveva produ rre l'aria ealdaimmessa nel cont iguo ambiente S. In questo casoI'a mbierue R avr ebbe avuto essen zialm ente un ruolo 'di serv izio' al circuito term ale vero e proprio.Solo per congett ura. si porrebbe tracciare un percorso circo lare 'completo ' che dal vano X (con funlioni ' tecnic he' di apodyurium. d unque) potevasnodarsi nell'area terma le S·T·Z, c intre cciarsi conun percorso ' breve' affida to alla sndatìo Z.65) E. Ridclfi, in 'Notizie degli Scavi', 1878,1'.22 7SS., rig. a 1'.229 ( rig. 20): si noti che la soluzione diconti nuit à nella sequenza di napensurae e la l'resenza di uevapertura' nel ' co rpo ' indica to nel vano16 (R) parrebbero confermare l'esegesi prospettataper gli alloggiamenti colt i nel saggio 199 1.66) Per questa tecnica. applicata - seppur forse inmisura men o sistematica - anche nelle term e pisane, Lugli. op. CII ., pp.67 I SS.• 689 s.67) Min lo 1922 , col . 4 29 ss.68) Arrigh i 1963, 1'.49,69) Cfr, P. Verduchi. Le lerme ron cos ìddeuo h('/j()cammns. in Ricef('h('Slfll 'archi lellura di Villa AdriaIla. 'Quade rni de ll'Istituto d i 'Ibpcgrafia Anticadell'Università di Rom a' 8, 1975. p.55 ss., in part.p.6955.70) vcrd ucnt. an. cù.. 1'.92: per Saba udia. G, tacopio Sabaudia . Scavi nella villa di Domiziano in {IX."Palazzo" sullago d ì Paola. in ' Notizie Scavi' J936.1'.29 ss. Elizabcth J. Sbep herd mi fa osse rvare che ilsistema d i riscaldamento del van o Z di Massaciucco li ritorna anche a Bocca di Magra (S lIpra , nota 6),in un va no attribuibile alla nst ruu urazione delt'avanzato I secolo .71) Mielsch 1990. p.67.72) vercocn t. an. cit., 1'.70 s.73) Miclsch 1990, p.63 , fi g. 39, ambi ente L.74) G. Ciampoltrini, VII nuo voframmento di CILXI, 1715, in ' Ep jgrapbica' 42, 1980 . p,160 ss.: M.Th . Raepsaet-Cha rles. L 'ÙISI: r ipl iOIl ClL XI. 1715romp/tlltt' t'l /N l 'emllei, in 'Latomcs' 42, 1983 ,p.152 ss.:J. Scbcid. ,!\'Q/e$lIT la l 'ell u/t'ii Apro"ia" i,in ' Zc:i tsehrifì fiirPapyro logie und Epigraphik ' 52,1983.1'.225 ss.75) "roghi 1963.1'.50: seguono discettazjoni suidu e pt'rsonaggi .76) Per la documentazio ne relati va, Arrighi 1% 3.1'043.77) Arri ghi 1963, 1'.50,78) Slipra. noia 45.79) Cfr. da ultimo G . Cia mpoltrini - A. Andreoni.Figlll1c pisane. in 'Opus" 9-10, 1990-91, p.16 1 ss.80) Supra, nota 74.8 1) Da ultimo Pasqui nucci-Menchelli. 0l' . cii .. anota 48, p.82 ss..82 ) Per questo, G . Cinmpo h rini. Le I/'m l/' pubbli·che /j/,/h- cillà dctt'Etruria ceruroscttentrtonalcfru I
130 [Contributi]
c Il secotoa.C, di prossi ma pubblicazione in 'Stud iClassic i e Orientali',83J Supra. nota 74,84) Scribonio Largo, Comp.. ( LX III: - ...nam inlta liae regionibus nusq uam eam [sciI. tri fcliumacut um] vidi hcrbam nisi in Lunae pc rt u, cumBritanniam petercmus cum deo nos tro Caesare.plurimum super circu mda tcs mcrnes". La 'comitiva' di Cl audio compi dunque escu~ion i nei dintcrni di Lun i.85) Il vano non ha propria numerazione neìrediaione Mimo: per il vano M, Minto 1922,001. 424l .
86) Per loro, ! upra. nota 74.87) M . Vallebo na. in Pisa: ìeterme cito a nota 48.p. 1655.88) Arrighi 1963. p.49: "Sopra quel bellissimo pavime nto senza punto guas tarlo li primi christianivenuti alla Santa Fede) vi fondarono immedia tame nte una tr ibun a di co ro d istante proporaionalme nte dalla present e circ a un braccio, e terzo... Nevi vuole maggior prova ad asserire il d isprezzo, chefacevano quei prim i fedeli d i derro tempio, che ilvede re che si erano servit i per inca lzo dc i muri dicorn ici di marmo di dive rsa qualità, e di altri pezzami pure di marm o, c fra gl'a ltri di un busto o siato rso d i donna, che aveva la schiena lavorata all'ultima perfezione c nel resto pareva un sasso di cavacos i ridouo acclpi d i marte llo-oNella tela il tracciato della ' prima tri buna' e leggibile al marg ine destro .89) Ctamponrini-Notini, an. cii. 3 no ta 24.1'0402.
-,,
l ,~
l\•