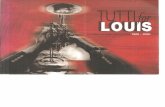Il PEfIl nel Master: per una formazione iniziale in prospettiva europea
L'Eneolitico in Italia centro-meridionale e Sicilia attraverso la prospettiva delle nuove ricerche...
Transcript of L'Eneolitico in Italia centro-meridionale e Sicilia attraverso la prospettiva delle nuove ricerche...
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
PREISTORIA E PROTOSTORIA
DIRETTORE
Daniela Cocchi Genick
COmITATO SCIEnTIfICO
Diego Angelucci, Alessandra Aspes, Paolo Bellintani, Maria Bernabò Brea, Paola Cassola Guida, Maurizio Cattani, Angiolo Del Lucchese, Raffaele C. de Marinis, Filippo M. Gambari, Stefano Grimaldi, Alessandro Guidi, Giovanni Leonardi, Roberto Maggi, Franco Marzatico, Emanuela Montagnari, Fabio Negrino, Nuccia Negroni Catacchio, Franco Nicolis, Annaluisa Pedrotti, Marco Peresani, Andrea Pessina, Luciano Salzani, Elisabetta Starnini, Giuliana Steffè, Maurizio Tosi, Marica Venturino
Copyright© by QuiEdit s.n.c.Via S. Francesco, 7 – 37129 Verona, Italywww.quiedit.ite-mail: [email protected] I – Anno 2013ISBN: 978-88-6464-248-2Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
La riproduzione per uso personale, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è con-sentita esclusivamente nei limiti del 15%.
213
mASSImO CulTRARO(1)
L’Eneolitico in Italia centro-meridionale e Sicilia attraverso la prospettiva delle nuove ricerche nel mondo egeo-balcanico
RIASSunTO
Viene preso in esame il problema delle relazioni tra l’Italia centro-meridionale, la Sicilia e il mondo balcanico dalla fine del IV al III millennio a.C. Nuovi dati provengono da un recente studio su alcuni contesti eneolitici dislocati tra il Montenegro e l’Albania settentrionale, che offrono sequenze stratigrafiche di lunga durata. Lo studio si concentra su aspetti della produ-zione ceramica e di alcuni macro fenomeni, come la formazione di ampi agglomerati insedia-tivi, l’introduzione di nuove tipologie residenziali (le long houses a pianta rettangolare e lato absidato) e, infine, l’emergere di necropoli con tombe a grotticella artificiale. Una particolare attenzione viene rivolta ad una categoria di figurine in pietra dalla Sicilia, per le quali sono stati proposti confronti con il mondo cicladico. Nonostante la notevole convergenza di dati tra le due aree, rimane ancora difficile ricostruire un quadro unitario delle diverse sfere di in-terazione, delle ragioni che stanno alla base di tali fenomeni e dei meccanismi di contatto.
AbSTRACT
This paper aims at examining the main questions about the relationships between cen-tral-southern Italy, Sicily and Balkans since the end of IVth to the IIIrd millennium BC. New data are recorded from a recent study on some Eneolithic sites settled in modern Montenegro and North Albania, which have long-time stratigraphic sequence. This research focuses main-ly on some features of pottery craftwork and on important cultural macro phenomena, such as the growth of large settlements, the introduction of new dwellings (i.e the rectangu-lar-shaped long houses with short apse), and then the emergence of large cemeteries with rock-cut tombs. A specific attention is paid on a category of stone figurines found in Sicily, which are commonly related to the Cycladic Bronze Age. Despite of many concordances between both areas, it is still difficult to have a complete framework of these interactions, the reasons of establishing connections and of the mechanisms of interactions.
Parole chiave: Eneolitico balcanico, Montenegro, età del Rame in Sicilia; tombe a grotticella artificiale, idoli litici, modelli di interazione, forme di contatto.Keywords: Balkan Eneolithic Age, Montenegro, Eneolithic period in Sicily, rock-cut tombs, stone idols, interaction models, strategies of contact.
A distanza di diversi anni da un primo tentativo di formalizzare il sistema delle re-lazioni tra la penisola italiana e i Balcani occidentali nel corso del III millennio a.C. (Cultraro 2001, 2006), appare oggi necessario riprendere il tema dei contatti culturali tra le due aree indirizzando la ricerca verso due specifici ambiti: il primo è quello di circoscrivere l’indagine di confronto a quei complessi archeologici meglio caratteriz-zanti sul piano tipologico-formale, con una specifica attenzione verso i contesti con serie stratigrafica e con datazioni radiometriche. Nel secondo caso occorre definire con maggiore rigore la compatibilità cronologica tra le correlazioni di volta in volta
(1) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Via Biblioteca 4, 95124 Catania; tel. 095/311981; email: [email protected]
214
proposte, tenendo in considerazione eventuali criticità connesse all’impiego, nell’am-bito della preistoria balcanica, di campioni di legno per le datazioni al radiocarbonio. È infatti noto che il carbone di legno può fornire date piuttosto antiche come risul-tato del c.d. heartwood effect (Gjerdrum 2003), con riferimento all’utilizzo di legno sta-gionato, che, in ogni caso, sarebbe un indicatore della data di costruzione della strut-tura lignea piuttosto che del suo abbandono.
Evitando di entrare nel tema del dibattito teorico-metodologico contemporaneo relativo ai meccanismi di interazione tra l’Eneolitico italiano e altri coevi contesti del Mediterraneo centrale, per i quali resta valida una recente lettura critica dei problemi (Cazzella et alii 2011, pp. 157-158), in questa sede risulta opportuno ampliare il qua-dro delle relazioni a suo tempo proposte, spostando l’attenzione su un’unità territo-riale circoscritta, dove è possibile leggere con maggiore chiarezza ed eventualmente seguire geograficamente tutta la concatenazione dei probabili contatti a breve e me-dia distanza.
Un sollecito in tale direzione proviene dall’avvio di un progetto italo-montenegri-no, sotto la direzione scientifica dello scrivente e di M. Bacović, finalizzato allo studio dei processi di interazione tra Balcani sud-occidentali ed Italia centro-meridionale nel IV e III millennio a.C. Il progetto scientifico, nel quadro degli accordi bilaterali tra Italia e Montenegro promossi nel 2013 dal Ministero degli Affari Esteri e dal Consi-glio Nazionale delle Ricerche, prevede la ricognizione ed edizione di quei contesti ar-cheologici con serie stratigrafiche e, laddove possibile, anche con l’ausilio di sistemi di datazione esterne, come il radiocarbonio calibrato e la dendrocronologia.
In questa sede, in relazione al tema in esame, vengono presentate alcune conside-razioni di carattere generale che sono emerse nel corso di una valutazione prelimina-re dei principali fenomeni storico-culturali che coinvolgono i Balcani meridionali a partire dalla fine del IV millennio a.C., momento nel quale è possibile identificare i principali termini di confronto con i processi di contatto e di circolazione di elemen-ti simbolici e tecnici nei coevi contesti della penisola italiana.
Non diversamente dal dibattito metodologico recentemente sollevato sull’Eneoli-tico in Italia (Cocchi Genick 2005, 2011), anche nel caso della preistoria recente del comprensorio tra Montenegro e Albania settentrionale, la costruzione dei principali gruppi culturali si fonda sulla definizione della produzione ceramica, in assenza di studi sull’industria litica o di altri aspetti della cultura materiale. Tuttavia, l’ampia co-noscenza di insediamenti, all’aperto e in grotta, con sequenze stratigrafiche assai arti-colate, rende il panorama balcanico un ottimo laboratorio per una più puntuale defi-nizione dei processi culturali, con la possibilità di cogliere, su scala regionale e ma-cro-territoriale, differenze e convergenze nelle forme e nella decorazione della pro-duzione ceramica.
Con il termine Eneolitico si indica, per l’ampia fascia costiera albanese-montene-grina, l’insieme di quei processi culturali che, in un sostrato ancora permeato di ele-menti di tradizione neolitica, segnano una profonda frattura con il precedente oriz-zonte culturale (Marković 2006, pp. 151-154). Gli elementi di novità possono essere ricondotti a tre macro-processi che si sviluppano su un’ampia dimensione interregio-nale: la formazione di grandi agglomerati insediativi (Bailey 2000, pp. 156-160), frut-
215
to di processi sinecistici, a cui corrispondono necropoli formalizzate sul piano spa-ziale e dei rituali funerari, e infine l’affermarsi della metallotecnica (Radivojević et alii 2010, pp. 2777-2779).
Un esempio illuminante in tale prospettiva è il sito di Maliq, nell’Albania sud- orientale, che copre una superficie di circa 11 ettari (Prendi 1976, p. 21); un recente riesame della vecchia documentazione di scavo porta a concludere che il villaggio si presentava come un insediamento palafitticolo con abitazioni di grandi dimensioni, delimitato da un complesso sistema difensivo ad aggere e doppia palizzata lignea (Aliu 2006, p. 49). Questa tipologia di insediamento non è isolata, ma faceva parte di un più ampio modello insediativo perilacustre che trova riscontro nell’Epiro greco, a Kastorià (Alram Stern 1996, p. 375), e ad Ustie, nella vicina Macedonia (Korkuti e Prendi 1992, p. 15).
Il fenomeno di aggregazione insediativa su ampia scala appare ancora oggi scar-samente documentato nell’Eneolitico della penisola italiana, ma potrebbe trattarsi solo della diretta conseguenza di una modesta conoscenza degli abitati, sui quali man-cano indagini estensive e pubblicazioni definitive di scavi.
La formazione di ampie necropoli strutturate in contesti della cultura di Rinaldo-ne nell’Italia centrale, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico (Miari 1993; Sil-vestrini e Pignocchi 1997), a cui si aggiunge oggi il recente rinvenimento nel Lazio a Lucrezia Romana di 69 tombe e di altre 43 nella vicina Romanina (Anzidei et alii 2011), potrebbe essere una cartina di tornasole per leggere in filigrana fenomeni di aggregazione insediativa o, comunque, di una differente strutturazione degli abitati.
Per il tema in esame un’altra recente scoperta merita una particolare attenzione: l’insediamento di Via Guidorossi a Parma, che si caratterizza per le singolari strutture abitative a pianta rettangolare allungata e lato corto absidato (Bernabò Brea et alii 2011, pp. 234-237, fig. 1) (fig. 1), potrebbe essere letto in tale direzione. Sempre a Par-ma, in Via La Spezia, la grande capanna rettangolare absidata, larga circa 4,5 m e lun-ga 8 m, resta al momento isolata nel panorama italiano, ponendo una serie di interro-gativi sul sistema strutturale della copertura che implica l’impiego di travature lignee di adeguata lunghezza, ma soprattutto sull’origine del tipo che, per l’editore del com-plesso, potrebbe essere accostata a modelli dell’area danubiana (Ibid., p. 237).
I casi di Parma restano assolutamente eccezionali nel panorama dell’edilizia do-mestica dell’Eneolitico italiano e, allo stesso tempo, rappresentano la realizzazione di un modello di abitato, con una chiara suddivisione tra spazi privati e collettivi, che implica una struttura sociale di riferimento ben definita.
Appare, pertanto, difficile pensare ad una linea di continuità con le più antiche strutture neolitiche di Catignano (Tozzi e Zamagni 2003, pp. 21-87, figg. 11-12) non solo per le differenze cronologiche tra i due complessi, ma soprattutto per la diversa concezione icnografica delle strutture, dal momento che quelle parmensi, alle quali si associano adesso anche quelle di Provezza (Cesena) (Miari et alii 2011), appaiono ri-spondere ad una più complessa organizzazione dello spazio domestico.
I dati radiometrici, che collocano le strutture di Via Guidorossi a Parma intorno al 3310-2900 cal 2σ BC (Bernabò Brea et alii 2011, p. 234), aprono nuove prospettive di ricerca sui tempi e modi dell’introduzione del modello della capanna allungata ab-
216
sidata, che risulta documentato in altre parti della penisola, come nel sito dell’Eneo-litico tardo di Quadrato di Torre Spaccata (Roma), dove compare una struttura ret-tangolare priva di abside (Anzidei e Carboni 2007, p. 426, fig. 4) e nei villaggi di fase Agnano-Monte Spina a Gricignano-Us Navy in Campania (Fugazzola Delpino et alii 2007, pp. 525-528, fig. 1.1).
Spostandoci verso la Sicilia, un interessante confronto per le strutture parmensi è offerto da tre edifici individuati sull’altipiano di Fildidonna, ai margini della Piana di Catania (fig. 2.1). Il modello è quello della struttura a pianta allungata e absidata, con le pareti definite da trincee e buche per palo scavate nel calcare tenero, con una lun-ghezza tra 17 e 21 m e una larghezza tra 4.80 e 5.40 m (Cazzella e Maniscalco 2012, pp. 84-86, figg. 1, 2). Nella stessa area, inoltre, si segnalano le due capanne presso la Gisira di Brucoli (Siracusa) (Ibid., p. 86, fig. 3) (fig. 2.2), mentre il medesimo modello architettonico si ripete nel caso del villaggio eneolitico di Roccazzo, presso Mazara del Vallo (Tusa 1992, pp. 291-294, fig. 34) (fig. 2.3).
I dati relativi alla Sicilia concordano nell’assegnare le strutture allungate rettango-lari ad un momento iniziale dell’Eneolitico che coinciderebbe con la diffusione della facies di San Cono-Piano Notaro, contraddistinta dall’introduzione della lavorazione dei metalli, da cambiamenti nell’industria litica e dall’affermarsi di ampie necropoli extra-moenia strutturate sul piano spaziale (Leighton 1999, pp. 87-91).
Non ci sono al momento elementi più affidabili per stabilire se ci sia una possibi-le concatenazione tra l’emergere delle strutture a pianta rettangolare in Sicilia e il fe-nomeno parallelo che riguarda l’Italia centrale. I dati relativi alla Sicilia, supportati an-
Fig. 1 - Parma. Via Guidorossi: planimetria delle capanne a pianta allungata (da Bernabò Brea et alii 2011).
217
che da una sequenza di date radiometriche relative alla cultura di San Cono-Piano Notaro (Ibid., p. 271, tab. 4), tendono a sottolineare una certa priorità del contesto isolano nella ricezione di un modello di abitazione che non sembra avere alcuna rela-zione con l’architettura domestica neolitica. Non essendoci elementi di confronto sia in Italia meridionale quanto nel vicino arcipelago maltese, l’ipotesi più probabile è quella di riconoscere nelle long houses della cultura di San Cono Piano Notaro un mo-dello di origine allogena.
Tornando all’area montenegrina, di grande rilevanza per il tema in esame appare l’evidenza offerta dal sito di Beran, lungo il corso del fiume Lim, al confine setten-trionale con l’Albania, dove è stata messa in luce una successione stratigrafica dal Neo litico all’antica età del Bronzo (Marković 1985, pp. 70-72). La fase IIc, che corri-sponde all’Eneolitico iniziale assegnato agli inizi del IV millennio a.C., risulta con-traddistinta da strutture abitative a pianta rettangolare allungata, delimitate da trincee e buche di palo, in qualche caso con lato corto absidato (Id. 2006, pp. 152-153).
L’aspetto più interessante è rappresentato dall’orizzonte ceramico che caratterizza la fase d’uso delle strutture rettangolari: la tradizionale ceramica a superficie lustrata in rosso del Neolitico Finale, talvolta contraddistinta dalla comparsa di anse a roc-chetto, cede il posto ad una nuova classe ceramica, a superfici brunite di color grigio o nero, decorata con motivi impressi puntiformi (Ibid., p. 153) (fig. 3).
Nella prospettiva dell’Eneolitico italiano, è quest’ultima classe ceramica ad offrire suggestivi elementi di confronto: infatti, nello strato IIc di Beran, coesistono, senza alcuna apparente differenza cronologica, la ceramica d’impasto bruno, decorata con impressioni a tacche o linee puntiformi, e quella, sempre dalla superficie bruno-gri-gia, ornata con scanalature e comunemente accostata alla tradizione nord-balcanica dell’orizzonte di Nakovan (Forenbaher 1999-2000) (fig. 3). Tra le forme della cerami-ca brunita domina un tipo di scodella a vasca rastremata e ampia spalla arrotondata con colletto distinto, ma non mancano le fogge a profilo più carenato (Marković
Fig. 2 - 1. strutture abitative dell’Eneolitico iniziale a Fildidonna (Catania); 2. capanna a doppia abside da Gisira-Brucoli (SR); 3. edificio a pianta rettangolare da Roccazzo (Mazara del Vallo, TP) (1-2. rielab. da Cazzella e Maniscalco 2012; 3. da Tusa 1992).
218
1985, pp. 72-74) (fig. 4.1).La sequenza di Beran, che può essere estesa ad altri complessi del medesimo com-
prensorio sia in Montenegro (Id. 2006, pp. 176-177) che in Albania (Aliu e Jubani 1969), trova un sorprendente parallelo nelle successioni crono-tipologiche messe in luce sull’Acropoli di Lipari e in Sicilia: ad una fase tardo-neolitica, dominata dalla ce-ramica a superficie rossa e dalle prese a rocchetto, segue un orizzonte con una cera-mica che differisce dalla precedente sul piano tecnico e formale.
L’insieme degli elementi che caratterizzano la produzione vascolare della fase IIc di Beran trova puntali riscontri nel gruppo ceramico siciliano di San Cono-Piano No-taro, dove è possibile isolare una varietà di scodella a profilo convesso ed orlo forte-mente rientrante, che rappresenta un segno di forte discontinuità con il precedente orizzonte tardo-neolitico di Diana (Orsi 1908, tav. IV.6) (fig. 4.2). Il confronto con Beran IIc può essere esteso anche al sistema di decoro con file puntinate, che rappre-senta uno dei tratti meglio caratterizzanti la produzione dell’Eneolitico iniziale nel-l’area montenegrino-albanese.
La ricerca è solo agli esordi e numerose sono le questioni che ancora oggi restano non sufficientemente chiarite, a cominciare dal significato da attribuire, in termini di processi culturali, al cambiamento che coinvolge le comunità dei Balcani meridionali agli inizi del IV millennio a.C., le eventuali connessioni tra la classe ceramica Black Burnished ware decorata con punti impressi e coeve produzioni riscontrabili nella Ser-bia interna (Cultraro 2001, p. 221; 2006, p. 410) ed infine la comparsa di questi pro-dotti nelle isole ioniche (ad esempio nella grotta di Choirospilia a Leucade: Souyoud-zoglou-Haywood 1990, pp. 54-57), che rappresenta un’importante testimonianza per seguire geograficamente la possibile concatenazione dei rapporti tra il mondo balca-nico e le coste dell’Italia meridionale.
Se per i contesti dell’Italia centrale menzionati in precedenza l’introduzione del nuovo modello abitativo della struttura rettangolare non sembra accompagnarsi, al-meno in apparenza, con cambiamenti nella produzione materiale, nel caso della Sici-
Fig. 3 - Ceramica decorata con incisioni e impressioni da Beran strato IIc (Museo Archeologico di Ce-tinje, Montenegro) (foto dell’autore).
219
lia l’affermarsi delle residenze a pianta al-lungata e l’introduzione della ceramica di San Cono-Piano Notaro, che rientra nel-la più ampia famiglia della Burnished ware diffusa nel Mediterraneo centrale a parti-re dalla prima metà del IV millennio a.C. (Cultraro 2008, pp. 13-14), appaiono come fenomeni correlabili sul piano delle dinami-che culturali a breve distanza e compatibili su quello cronologico.
La precocità della Sicilia nella ricezio-ne di questi modelli allogeni trova un’ul-teriore conferma nelle nuove datazioni radiometriche relative ad alcune necro-poli del comprensorio di Agrigento, che portano a collocare la fase più antica dell’Eneolitico nella prima metà del IV millennio a.C. (vedi il contributo di D.Gullì in questo volume). Questo dato, che a prima vista potrebbe sembrare as-
sai sbilanciato, in realtà troverebbe buoni riscontri nelle datazioni proposte per il gruppo di Zebbug e per lo stile di Mgarr a Malta, per i quali sono stati riconosciuti punti di contatto con il repertorio vascolare di San Cono-Piano Notaro (Cazzella 2000; Cultraro 2008, pp. 9-11).
Malta e la Sicilia, dunque, agli inizi del IV millennio a.C. presenterebbero numero-si elementi comuni, non solo per la concordanza cronologica delle date radiometri-che, ma anche per la condivisione di aspetti del repertorio ceramico e del sistema de-corativo, presupponendo un’intensificazione di quei contatti avviati a partire dal pe-riodo neolitico (Giannitrapani 1997).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, non escluderei che la classe ceramica di San Cono-Piano Notaro, ben definita nel suo repertorio tipologico-decorativo e contraddistinta da elementi di forte discontinuità con il precedente orizzonte tar-do-neolitico, sia il risultato di contatti a lunga distanza tra la costa meridionale dei Balcani e la Sicilia, forse attraverso la mediazione della Grecia nord-occidentale, dove nelle Isole Ionie (Corfù e Itaca) è presente la ceramica bruna lustrata con elementi puntiformi in contesti assegnati al tardo-neolitico o di transizione all’antico Elladico I (Cultraro 2008, p. 13).
La diffusione della ceramica di San Cono-Piano Notaro sembra sovrapporsi a quella di Spatarella: nel Riparo della Serra presso Adrano (Catania), lungo le pendici occidentali dell’Etna, il livello con ceramica a decoro puntiforme impresso si sovrap-pone ad uno strato misto con elementi della cultura di Diana e di Spatarella (Ibid., p. 7). Sul versante centro-meridionale dell’isola, a Piano Vento, presso Palma di Mon-techiaro (AG) i frammenti di scodelle nello stile di Spatarella provengono dall’abitato, riferendosi all’ultima fase di occupazione a cui segue la distruzione del villaggio e il successivo impianto della necropoli con materiali San Cono-Piano Notaro (Castella-na 1995, pp. 81-83, figg. 57-60).
Fig. 4 - 1. scodella ad orlo rientrante da Beran strato IIc (Museo Archeologico di Cetinje, Mon-tenegro); 2. scodella dalla necropoli di San Co-no-Piano (Museo Archeologico di Siracusa inv. 21986) (disegni dell’autore).
220
La classe con decoro puntiforme, pertanto, rappresenterebbe un momento avan-zato dell’Eneolitico antico in Sicilia, quando elementi culturali di tradizione allogena, che riteniamo collegati al mondo balcanico, si sono progressivamente inseriti nel so-strato locale, interrompendo quel flusso di contatti lungo l’asse Nord-Sud tra Sicilia ed Italia continentale, ben documentato dalla circolazione di motivi decorativi di tipo chasseano nelle isole Eolie e sul versante medio-tirrenico della penisola (Cocchi Ge-nick 2009, p. 138).
Resta assai singolare il fatto che la nuova classe ceramica di tipo San Cono-Piano Notaro non sia documentata nell’Italia meridionale e nell’arcipelago eoliano, dove la fase iniziale dell’Eneolitico coincide con la comparsa della ceramica di tipo Piano Conte, come risulta anche nei contesti del versante tirrenico ed ionico della Calabria (Salerno e Vanzetti 2004, pp. 208-211).
Questa classe, pur con varianti locali, registra un’ampia diffusione in altre parti della penisola, spingendosi dalla Puglia fino alle Marche (Cazzella et alii 2011, p. 161). Anche in questo caso la produzione di Piano Conte segna una forte discontinuità con quella del Neolitico finale non solo per gli aspetti morfotecnici, ma soprattutto per l’introduzione di una varietà di fogge vascolari non altrimenti documentate. Per que-ste ragioni, tenendo in considerazione la particolare tecnica della decorazione a sca-nalatura, avevo proposto un possibile collegamento con la ceramica di Proto-Nako-van e Nakovan dei Balcani Occidentali (Cultraro 2001, pp. 221-222). A supporto di tale proposta di comparazione possono essere chiamati in causa alcuni contesti con serie stratigrafica della Grecia continentale, grazie ai quali è possibile seguire la tran-sizione dal Neolitico Finale all’Antico Elladico I.
Una delle sequenze stratigrafiche più complete è quella della Grotta dei Laghi, presso Kalavrita, in Acaia: il livello III, assegnato al Late Neolithic II, registra l’introdu-zione delle ciotole a profilo convesso e colletto distinto decorate con triangoli incisi. Nello stesso livello, inoltre, compaiono le prime attestazioni di ceramica con decora-zione a scanalatura, spesso all’interno della vasca di grandi scodelle a profilo tronco-conico (Sampson 1997, pp. 245-246, fig. 70).
Un deposito con le medesime caratteristiche è stato isolato nel c.d. Pre-Helladic Level sulla collina di Aspis ad Argo; la ceramica può essere distinta in due differenti gruppi, il primo comprende una classe di scodelle con ansa subcutanea e decorazione a solcature che, in qualche caso, è ravvivata dall’uso della dipintura bianca (Alram Stern 1996, pp. 239-241, fig. 15) (fig. 5.1,2,4). Un secondo gruppo, d’impasto fine, presenta un sistema decorativo con sottili linee a graffito dopo la cottura (fig. 5.6-8). Di particolare interesse, infine, appare la parete di una tazza con labbro distinto, de-corata con una sequenza di linee e file puntinate incise e riempite di pasta bianca (fig. 5.5), mentre assolutamente isolato nel panorama locale è la porzione di vasca di una forma chiusa con decorazione a linea ondulata puntinata (fig. 5.9).
Se letto nella prospettiva dell’Eneolitico dell’Italia continentale ed insulare, nel de-posito di Argo si possono identificare numerosi elementi che ricorrono, anche se in aree diverse, come le linee puntinate che compaiono sia nella ceramica dal fossato di Arcevia (Cazzella e Moscoloni 1999, pp. 67-68, tav. 68.33-37), che in quella siciliana di San Cono-Piano Notaro (Orsi 1908, tavv. II.9; III.4). Anche per la tecnica White -
221
On Dark presente nel deposito di Argo il collegamento immediato è con l’uso della pittura bianca su fondo scuro, che risulta ben rappresentata in contesti dell’Eneolitico della Sicilia occidentale (Cazzella 1972, pp. 254-258).
Manca ancora oggi una datazione su base radiometrica per i due depositi greci ap-pena descritti, ma una serie di confronti con altri complessi coevi permette di formu-lare qualche osservazione sulla cronologia.
La recente edizione della sequenza stratigrafica nella grotta di Skoteini Tharrou-nion, in Eubea, invita a stabilire una correlazione tra datazioni su base radiometrica e gruppi ceramici: la ‘fase calcolitica’, che segue all’orizzonte tardo-neolitico, risulta ca-ratterizzata dall’introduzione della classe ceramica Scratch Crusted Ware, la quale pre-senta ampie bande excise o asportate parzialmente lasciando una superficie corruga-ta che, in qualche caso, viene riempita di un impasto di ocra (Sampson 1993, 152-154, tavv. 118-120). Il livello riferibile a questo gruppo ceramico viene collocato su base radiometrica tra il 4100 e il 3600 cal BC (Ibid., pp. 21-25). Questo quadro cronologico risulta compatibile con quello relativo al deposito di Halieis, in Achaia, non lontano dalla Grotta dei Laghi menzionata in precedenza, che ha fornito una data intorno al 3909-3367 cal BC (Pullen 2000, p. 184): anche in questo caso il deposito, a livello di repertorio ceramico, presenta la coesistenza tra una classe d’impasto grigio con deco-razione scanalata e una varietà con fasci di linee a graffito.
Un ultimo riferimento riguarda l’abitato di Kephala, nell’isola di Keos, dove il pa-norama tipologico è dominato dall’introduzione delle ‘prese a testa di elefante’, che costituiscono uno degli elementi più rappresentativi della classe di Piano Conte in Italia (Cazzella e Maniscalco 2012, p. 97). L’unica data radiometrica calibrata a 2σ ri-manda al 3711-3507 BC. (Alram Stern 2007, p. 2), offrendo un interessante aggancio cronologico per l’inquadramento di questa particolare foggia di prese.
In una prospettiva italiana, i dati provenienti dai complessi della Grecia continen-tale ed insulare finora indagati risulterebbero compatibili con i contesti dell’Eneoliti-co antico della penisola italiana e della Sicilia. Ancora più interessante appare la con-testualizzazione della classe Scratch Crusted Ware, che presenta stretti paralleli con una
Fig. 5 - Ceramiche dal deposito ‘pre-elladico’ sull’Aspis di Argo (rielab. da Alram Stern 1996).
222
varietà di prodotti con decorazione excisa nell’ambito del gruppo San Cono-Piano Notaro della Sicilia centro-meridionale. Mi riferisco ad una categoria di ciotole e ol-lette documentate nelle tombe a grotticella artificiale 1, 6, 8, 9 e 11 della necropoli Piano Vento (AG) (Castellana 1995, figg. 64, 71, 73-74, 78), che presentano uno pic-colo solco exciso nella massima espansione del corpo, riempito con pasta di ocra ros-sa. Per questo gruppo ceramico avevo suggerito una datazione ad una fase iniziale dell’Eneolitico, distinguendolo da una seconda classe, con decorazione a linee punti-formi, che si diffonde insieme alle più antiche ceramiche dipinte in bruno su fondo chiaro (Cultraro 2008, pp. 7-9, fig. 1.5) (fig. 6). La suddivisione era stata proposta su base stilistico-formale e sull’organizzazione spaziale della necropoli, non disponendo di alcun datazione assoluta. Oggi la documentazione relativa alla necropoli agrigenti-na di Scintillia (vedi il contributo di D. Gullì in questo volume) sembra validare tale successione crono-tipologica, ponendo la classe ceramica con decorazione excisa in un orizzonte assai antico dell’Eneolitico siciliano e coerente con le cronologie relative al Neolitico Finale e/o Calcolitico della Grecia continentale.
Il quadro di concordanze finora proposto trova piena compatibilità cronologica tra le sequenze del comprensorio nord-albanese-montenegrino e quelle dell’Italia centro-meridionale. È pur vero che il sistema di relazioni finora esaminato si basa su elementi presenti nella produzione ceramica che rappresenta una classe di manufatti che, almeno per la fase in esame, non sembra essere andata oltre l’ambito organizza-tivo del ‘laboratorio domestico’. Tuttavia, se leggiamo certi cambiamenti e soprattut-to i confronti tipologico-formali con i contesti coevi allargando l’indagine ad altri ele-menti di valutazione, risulta possibile ridurre eventuali zone d’ombra nella definizio-ne di tali meccanismi di interazione. Tra gli elementi chiamati in causa prenderei in esame il tema delle tombe a grotticella artificiale, per le quali in passato è stata soste-nuta un’origine dall’area egeo-anatolica (Tiné 1963), con una conseguente replica, che oggi può apparire dai toni estremizzati, di rigettare il carattere meccanico nella tra-smissione di tale modello funerario a favore di una genesi locale ed indipendente (Renfrew e Whitehouse 1974).
La questione di identificare in una sola area il luogo di origine è un’operazione ste-rile e pericolosa, come è stato correttamente sottolineato (Cazzella e Maniscalco 2011, p. 94). Il tema delle tombe a grotticella non può essere affrontato soltanto sul-la base di un’analisi formale e architettonica del tipo, perché occorre ampliare il cam-po di indagine verso altri fattori di valutazione, come un più ampio sistema di crono-logie assolute, la relazione tra tipologia funeraria e gruppi di manufatti (non solo limi-tati alla ceramica), l’analisi del rituale funerario, il rapporto tra necropoli strutturate e insediamento.
La rassegna sulla distribuzione del tipo di tomba a grotticella artificiale nell’Egeo (Cultraro 2000) rimane valida per la carta di distribuzione, ma non certo per la se-quenza cronologica che, alla luce dei dati recentemente acquisiti, suggerisce di datare la comparsa della tipologia funeraria in esame, almeno nella Grecia continentale ed insulare, non prima dell’Antico Elladico I, ovvero intorno ai primi secoli del III mil-lennio a.C. in date calibrate. Questo dato appare oggi saldamente confermato dal-l’edizione della necropoli di Ayia Photià, sulla costa settentrionale di Creta (Davaras
223
e Betancourt 2012), dove l’adozione del tipo architettonico è strettamente collegata con la presenza di piccoli gruppi di genti provenienti dalle Cicladi che avrebbero oc-cupato il sito intorno al 3000-2800 cal BC.
Tenendo presente il nuovo quadro di sincronismi, il tipo della tomba a grotticella preceduta dal pozzetto verticale risulterebbe in Grecia più recente degli esempi della penisola italiana, ma anche della Sicilia. La sola eccezione potrebbe essere la necropo-li presso l’antica Elis, in Elide, dove alla tomba a pozzetto più volte menzionata come possibile confronto per i tipi italiani (Cultraro 2001, pp. 222-223, 2006, pp. 406-407; Cazzella et alii 2011, p. 161) si sono aggiunte oggi altre sepolture dello stesso tipo che consentono di ricostruire una necropoli strutturata sul piano dell’organizzazione spa-ziale e del rituale funerario.
Le affinità proposte per il vaso a fiasco proveniente dalla tomba scavata negli anni ’60 del secolo scorso (Koumouzelis 1980, pp. 53-63), trovano oggi un ulteriore validazione nell’edizione dei materiali dalle sepolture esplorate in anni recenti (Rambach 2007).
Fig. 6 - Successione crono-tipologica dell’Eneolitico nella necropoli di Piano Vento (Ag) (da Cultraro 2008).
224
Un primo elemento di confronto è il vaso a collo basso e distinto, con vasca con-cava e prese canaliculate verticali, documentato in numerose tombe della necropoli di Elis (Ibid., p. 66, fig. 30). Questa foggia trova puntuali riscontri nella necropoli mar-chigiana di Fontenoce-area Guzzini (tomba 8, Silvestrini e Pignocchi 1997, fig. 9.2), ma anche in ambienti più propriamente rinaldoniani del versante tirrenico, come Bel-vedere di Cetona, Ponte Cucule nel senese (Cocchi Genick 2008, p. 66) e la necropo-li di Ponte San Pietro (tomba 23, Miari 1993, fig. 11B.1).
Disponiamo di una datazione calibrata dalla tomba 8 di Fontenoce (4478±68 BP = 3360-2930 cal 2σ BC) (Cocchi Genich 2008, p. 66), ma al momento non abbiamo elementi per un più solido aggancio con la necropoli di Elis, per la quale l’editore ha proposto un’attribuzione ad una fase di transizione tra il Neolitico Finale e l’Antico Elladico I (Rambach 2007, p. 68). Se questa ipotesi venisse confermata, anche le tom-be a grotticella artificiale del Peloponneso nord-occidentale risulterebbero compati-bili con la cronologia proposta per le necropoli della cultura di Rinaldone nell’Italia centrale.
Elis rimane, in assenza di altri elementi probanti, un contesto sub iudice, dal mo-mento che la maggior parte delle necropoli con strutture ipogeiche artificiali, sia nel resto della Grecia continentale che nell’Egeo insulare, sembrano coerentemente di-stribuirsi tra una fase avanzata dell’Antico Elladico I e l’Antico Ellladico II (Cultraro 2000), risultando quindi posteriori al fenomeno che interessa la penisola italiana e la Sicilia.
Il secondo elemento di confronto è rappresentato dalla circolazione e trasmissio-ne di manufatti rivestiti di uno specifico valore simbolico. Rientrano in questa cate-goria le due note figurine in pietra metamorfica da Camaro, alla periferia di Messina, che appartengono ad una categoria di rappresentazioni antropomorfe estremamente schematizzate, per le quali è stato proposta una filiazione con la varietà ‘a violino’ di ambito cicladico ed egeo-anatolico (Bacci 1997) (fig. 7) . Le due figurine, che proven-gono da un’area dell’abitato eneolitico dove sono state individuate una sepoltura e al-cune fosse rituali contenenti ossa e ceramiche, sono di fattura locale perché sono sta-te realizzate utilizzando una varietà di roccia metamorfica assai compatibile, sul piano mineralogico e petrografico, con la struttura geologica del comprensorio della Sicilia nord-orientale (Ibid., p. 296).
Le due statuette, indicate con Cam 1 e Cam 2, vengono comunemente messe a confronto l’una con l’altra per la particolare forma ‘a violino’, termine preso in pre-stito dalla letteratura paletnologica egea con il quale viene indicata una classe di figu-rine in marmo, schematic violin-shaped figurines, che risultano diffuse prevalentemente in ambito cicladico-insulare (Ekschmitt 1986, pp. 59-60). Tuttavia, ad un più attento esame, i due idoletti siciliani mostrerebbero profonde differenze strutturali nella co-struzione dei volumi e nella resa del corpo, con la sola eccezione del lungo collo e te-sta non caratterizzata che li accomuna.
Se la forma piatta e il collo allungato possono essere elementi che in qualche ma-niera rimandano alla varietà di idoli in marmo diffusa nell’Antico Cicladico I, in real-tà le differenze con quest’ultima categoria appaiono più marcate rispetto alle possibi-li analogie formali. L’idolo Cam 1 (fig. 7.1) presenta il corpo a paletta desinente in un
225
ampio arco di cerchio, che è stato messo in rapporto dal primo editore con un gruppo di idoli in marmo databili all’An-tico Cicladico I (Bacci 1997, p. 296). In seguito, sono stati proposti altri confron-ti con il gruppo di figurine in marmo di Pelos-Lakkoudes (Bacci et alii 2003, p. 840), ma si tratta di affinità che appaiono alquanto generiche e soprattutto proble-matiche in termini di compatibilità cro-nologica.
Il confronto con la categoria nota come Drios type, che si colloca tra le più antiche della serie cicladica (Marangou 1990, p. 143, n. 145) (fig. 8), spinge inve-ce a mettere in evidenza le differenze piuttosto che le analogie. Ad esempio, negli esemplari egei la parte inferiore del corpo è semilunata, con una sezione bi-convessa, mentre l’esemplare siciliano è piatto. Differiscono anche le braccia che nella varietà di Drios sono di forma ret-tangolare-convessa, mentre in Cam 1 sono di forma allungata; mancano infine nel modello siciliano i dettagli che carat-terizzano il corpo, che nella produzione cicladica sono ottenuti in maniera plasti-ca (il seno) e mediante incisione (base del collo e partizione del ventre).
Occorre, dunque, cercare altrove il possibile luogo di origine o quanto meno la fonte di ispirazione, trattandosi di pro-dotti di fattura locale, che non può certo essere l’ambito cicladico. Se spostiamo l’attenzione verso l’area balcanica, nella vasta zona compresa tra l’attuale Monte-negro e l’Albania settentrionale è docu-
mentata una classe assai particolare di manufatti finora trascurata dalla letteratura sull’argomento. Il tumulo funerario di Kuće Raćika, nella piana di Zeta lungo il corso del fiume Cijevna, a sud della moderna Podgorica, è una struttura a pianta circolare con copertura di ciottoli: il circolo, esplorato nel 1989, conteneva sette deposizioni e una fossa trovata vuota (Marković 2006, pp. 204-205). All’esterno di una delle sepol-ture fu rinvenuto un gruppo di quattro figurine fittili, tre femminili e una maschile (Velimirović-Zizić 1995; Lutovac 2005, p. 15) (fig. 9). Le tre figure femminili sono
Fig. 7 - Idoli in pietra da Camaro (Me): 1. CAM 1; 2. CAM 2 (rielab. da Bacci et alii 2003).
Fig. 8 - Figurina in marmo ‘a violino’ - tipo Drios - dalla t. 6 di Akrotiri, Naxos (Atene, Museo Gou-landris) (da Marangou 1990).
226
quelle che meritano una particolare at-tenzione, perché per la struttura del cor-po, la costruzione delle braccia e le di-mensioni trovano un puntuale riscontro nell’esemplare siciliano Cam 1. Il tumulo di Kuće Raćika viene assegnato all’Eneo-litico Tardo, orizzonte per il quale dispo-niamo di alcune date radiometriche da al-tri siti coevi, che pongono questa fase in-torno al 2800-2500 a.C. (Marković 2006, p. 170).
Idoli fittili a forma di violino sono noti anche in un altro importante com-plesso funerario, il tumulo 6 di Shtoj, ai margini del lago di Skodar, nell’Albania settentrionale, lungo il confine con il Montenegro. Dentro una fossa che stava all’interno del circolo funerario erano collocati sei idoli in terracotta a forma di violino (Koka 1990, pp. 38, 60, fig. 2, tav. 8.95,99-101) (fig. 10). Le analogie con i complessi di Shtoj e Kuće Raćika sono sorprendenti non solo per la foggia degli idoletti, ma soprattutto per la loro fun-zione che risulta strettamente collegata con le pratiche dei rituali funerari. Non può certo sfuggire che anche i due idolet-ti di Camaro siano stati rinvenuti in un’a-rea prossima ad una deposizione ad en-chytrismòs, rafforzando la destinazione simbolico-ideologica di questi manufatti all’interno della sfera funeraria.
Gli esemplari di Shtoj sono assegnati, sulla base del corredo di una delle tombe
a cista, ad un orizzonte proto-Cetina, correlabile con Maliq IIIa, che rappresenta in Albania la fase più antica dell’età del Bronzo, comunemente assegnata, in base a da-tazioni radiometriche, al 2500-2300 a.C. (Maran 1998, p. 329, tavv. 50.4-8; 51.1).
Se i confronti formali tra i gli idoletti balcanici e quelli siciliani appaiono al mo-mento quelli più verosimili, rimane il problema della compatibilità cronologica, per-ché i tipi albanesi risulterebbero più recenti dei due esemplari di Camaro. Infatti, quest’ultimo sito viene messo in relazione con lo sviluppo delle ceramiche del tipo Piano Conte (Bacci et alii 2003; Martinelli e Procelli 2011, p. 117). Le date radiometri-che provenienti da Camaro, a cui si aggiungono ora anche quelle da Venetico (Me) (Gusmano e Martinelli 2011, p. 683), portano a concludere che la ceramica del tipo
Fig. 9 - Gruppo di statuine fittili dal tumulo di Kuće Raćika, Montenegro (Museo Nazionale di Podgorica) (rielab. da Lutovac 2005).
Fig. 10 - Statuine fittili dal tumulo 6 di Shtoj, Al-bania (rielab. da Maran 1998).
227
Piano Conte, almeno nella cuspide pelo-ritana dell’isola, si sia sviluppata in un ampio arco cronologico compreso tra gli inizi del IV e la metà del III millennio a.C. (Martinelli e Procelli 2011, p. 119, tab. 1).
La discordanza tra la cronologia dei Balcani e quella proposta per la Sicilia po-trebbe essere superata solo ipotizzando che l’insediamento di Camaro abbia avu to una continuità di occupazione sino all’E-neolitico Tardo, correlabile con l’ori z-zonte di Malpasso-Piano Quartara. In at-tesa dell’edizione completa dei materiali, mi pare di un certo interesse per il tema in esame la descrizione del complesso ce-ramico degli strati 3-4 dove è documen-tata la presenza di elementi formali e de-corativi nel patrimonio vascolare ritenuti “….estranei alla cultura di Piano Conte, poiché rappresentanti di un substrato culturale eneolitico siciliano indicato dal-la facies Chiusazza-Malpasso” (Ibid., p. 117). Anche la descrizione della sepoltu-ra entro pithos, presso la quale furono tro-vati i due idoletti, risulterebbe meglio compatibile con l’orizzonte tardo-eneo-litico di Malpasso-Piano Quartara, tro-vando un interessante parallelo nel grup-po di inumazioni ad enchytrismòs messo in luce a Monte Castellazzo di Marianopoli (Caltanissetta): le singolari sepolture en-tro pithoi, note solo da una preliminare
segnalazione (Fiorentini 1980-81, pp. 586-587) e oggetto di una revisione da parte dello scrivente, sono saldamente assegnate all’orizzonte tardo-eneolitico di Malpasso, sulla base della presenza di ceramica a superficie lustrata rossa tra i corredi.
Nel caso di Camaro, si avrebbe, dunque, un’evidenza assai simile a quella di Vene-tico, citato in precedenza (Gusmano e Martinelli 2011), dove alle tradizionali fogge riconducibili alla cultura di Piano Conte si associano i nuovi elementi tipologico-for-mali dell’orizzonte di Malpasso.
Per quel che riguarda il secondo esemplare, Cam 2 (fig. 7.2), il carattere ‘egeo’ in questo caso risulta meglio definibile. Infatti, lo schema allungato del corpo e la forma delle braccia rimanda ad una categoria di idoli in marmo databile all’Antico Cicladico I, come si evince anche dal confronto con una statuetta dalla tomba 5 della necropo-
Fig. 11 - Figurina in marmo del tipo schematico dalla t. 5 di Akrotiri, Naxos (Atene, Museo Gou-landris) (da Marangou 1990).
228
li di Akrotiri nell’isola di Naxos (Marangou 1990, p. 144, n. 146) (fig. 11). Una figuri-na in pietra di foggia simile è stata recentemente segnalata dalla grotta Marca presso Castiglione, nella vallata del fiume Alcantara, in una zona di confine tra l’area etnea e quella più propriamente peloritana (Privitera 2012). Il deposito ha restituito cerami-che del tipo Piano Conte, anche se alcuni elementi riferibili al gruppo di Malpas-so-Piano Quartara farebbero pensare ad una fase abbastanza avanzata dell’Eneoliti-co, correlabile con Venetico e Camaro (Ibid., p. 678, fig. 3C.2).
Non c’è ragione di dubitare che siamo in presenza di una categoria di oggetti rive-stiti di un forte valore simbolico, che, pur essendo di fattura locale, risulterebbero connessi ad un modello di ispirazione esterno, in questo caso riconducibile al mondo cicladico.
Resta ancora aperto il problema della possibile relazione con una classe di figurine piatte da contesti della fase Zebbug, come il gruppo di statuine in osso dal Circolo Bochtorff di Xaghra a Malta, che risultano assai compatibili con gli esemplari sicilia-ni per il corpo a violino e la testa allungata (Malone et alii 2009, pp. 277-280, figg. 10.43-44) (fig. 12). Le numerose attestazioni a Malta confermano che si tratta di un oggetto strettamente connesso con la sfera ideologico-simbolica, come documenta la distribuzione prevalentemente in ambito funerario, anche se la pratica della deposi-zione collettiva non consente di stabilire una possibile relazione tra l’uso di questi pendagli e una specifica classe di sesso e/o di età. Sarebbe opportuno interrogarsi, dunque, su quanto l’artigianato maltese sia stato eventualmente influenzato da mo-delli esterni, in questo caso riconducibili non tanto all’ambito cicladico, quanto alla classe di statuette schematiche sub-rettangolari che si diffondono nella Grecia conti-nentale e nei Balcani meridionali durante il Neolitico Finale (Gallis e Orphanidis 1996, pp. 386-393, nn. 339-343).
Alla luce di queste osservazioni, i tre esemplari di figurine dalla Sicilia eneolitica sono uno dei migliori esempi della possibile circolazione di manufatti di pregio, vero-similmente importati, che sarebbero diventati, al tempo stesso, fonti e modelli di ispi-razione per una vivace produzione locale. Nella medesima direzione vanno interpre-tati anche gli esemplari, in versione ‘povera’ perché realizzati in argilla, dall’area alba-nese-montenegrina, che giustamente sono considerati come l’adattamento locale di un modello allogeno riconducibile al mondo egeo (Marković 2006, pp. 214-216).
I dati in nostro possesso restano ancora esegui e richiedono un maggiore appro-fondimento, soprattutto nella prospettiva di un più solido rapporto tra sistemi di da-tazione assoluta e gruppi ceramici che, nel caso dei Balcani meridionali, almeno per l’Eneolitico, rimane affidata a pochi elementi, non sempre chiari e verificabili.
Il confronto tra l’idolo di Camaro e il gruppo di statuette fittili dal Montenegro appare assai suggestivo e in futuro potrebbe essere ulteriormente verificato attraver-so altri elementi di indagine, come l’introduzione delle tecniche metallurgiche che po-trebbero essere ricondotte ad una matrice balcanica (Dolfini 2013, pp. 49-50). All’in-terno di questi aspetti di carattere ampio va inserita anche la circolazione di oggetti di ampia diffusione quali le teste di mazza litiche con foro centrale, che, pur presentan-do una distribuzione alquanto discontinua nella penisola italiana e in Sicilia, rimanda-no ad ambiti lontani, come il Mediterraneo centro-orientale e l’Europa continentale (Cazzella et alii 2011, pp. 161-162).
229
Per concludere, a partire dalla fine del IV millennio a.C. l’Italia centro-meridiona-le e la Sicilia risultano coinvolte in fenomeni di circolazione di elementi simbolico- ideologici (idoli antropomorfi) insieme ad altri più propriamente tecnologici (metal-lurgia, industria litica della pietra levigata, asce-martello forate), che appaiono inseriti all’interno di un più ampio sistema di contatti non strutturati con il mondo balcanico. Appare assai probabile che questi meccanismi di interazione siano stati favoriti da un sistema di contatti interregionali tra la Sicilia e l’Italia continentale a partire dal IV millennio, come dimostrerebbero la condivisione di fogge vascolari e sistemi decora-tivi, ma anche certe convergenze nei rituali funerari (Cocchi Genick 2009).
Numerosi sono gli elementi che rimandano ai Balcani sud-occidentali, ma è pur vero che altrettanto ampie sono ancora le zone d’ombra che persistono nella correla-zione tra i vari fenomeni finora indagati. Ad esempio, allo stato attuale della docu-mentazione, solo nel caso della Sicilia possiamo stabilire una relazione tra i gruppi della cultura di San Cono-Piano Notaro ed alcuni significativi fenomeni, quali l’intro-duzione della metallurgia, l’impiego delle teste di mazza forate, l’adozione delle long houses absidate e la scelta delle tombe a grotticella artificiale. In altre parti della peni-sola la correlazione tra questi singoli processi, che in ogni caso presuppongono scam-bio di informazioni e mobilità di piccoli gruppi umani, appare più evanescente o sfu-mata, ma in alcun modo non può essere confrontata con l’organicità dell’evidenza siciliana, dove i gruppi portatori della ceramica di San Cono- Piano Notaro esprimo-no un insieme culturalmente omogeneo e strutturato.
Fig. 12 - Figurine-pendaglio in osso del tipo schematico, dal Circolo funerario di Brochtorff, Malta (rielab. da Malone et alii 2009).
230
RingraziamentiDesidero ringraziare D. Cocchi per avermi invitato a partecipare al convegno e per le proficue discussioni sull’argomento. Un particolare ringraziamento va anche al collega Mile Bacović (Center for Archaeological Researches of Montenegro) per la traduzione dei lavori in lingua serba e per gli utili commenti.
RIfERImEnTI bIblIOgRAfICI
AlIu S. 2006, Recent prehistoric research in southeast Albania: A review, in l. bEjkO e R. HODgES, a cura di, New directions in Albanian Archaeology. Studies presented to Muzafer Korkuti, Tirana, pp. 43-55.
AlRAm STERn E. 1996, Ägäische Frühzeit 1. Das Neolithikum in Griechenland, Wien.AlRAm STERn E. 2007, Das Chalcolithikum in Südgriechenland. Versuch einer chrononologischen und
topographischen Gliederung, in Stephanos Aristeios. Festschrift für Stephan Hiiller zum 65, Wien, pp. 1-10.
AnzIDEI A.P., CARbOnI g. 2007, Il villaggio neo-eneolitico di Quadrato di Torre Spaccata (Roma): nuovi dati dagli scavi del Giubileo 2000, AttiIIPP XL, pp. 421-435.
AnzIDEI m.P., CARbOnI g., CARbOnI l., CASTAgnA m.A., CATAlAnO P., EgIDI R., mAlvOnE m., SPADOnI D. 2011, Il gruppo Roma-Colli Albani della facies di Rinaldone: organizzazione spaziale, rituali e cultura materiale nelle necropoli di Lucrezia Romana e Romanina (Roma), AttiIIPP XLIII, pp. 297-308.
bACCI g.m. 1997, Due idoletti di tipo Egeo-cicladico da Camaro presso Messina, in Prima Sicilia, pp. 295-298.
bACCI g.m., CARAmuTA j., mARTInEllI m.C. 2003, L’insediamento neo-eneolitico di Camaro (ME), AttiIIPP XXV, pp. 839-842.
bAIlEy D. 2000, Balkan Prehistory, New York and London.bERnAbò bREA m., bIAnCHI P., bROnzOnI l., mAzzIERI P. 2011, Abitati dell’età del rame nel Par-
mense, AttiIIPP XLIII, pp. 233-240.CASTEllAnA g. 1995, La necropoli protoeneolitica di Piano Vento nel territorio di Palma di Montechiaro,
Palermo.CAzzEllA A. 1972, Considerazioni su alcuni aspetti eneolitici dell’Italia meridionale e della Sicilia, Ori-
gini VI, pp. 171-298.CAzzEllA A. 2000, Sicilia e Malta durante l’età del Rame, SicA 98, pp. 87-96. CAzzEllA A., CulTRARO m., RECCHIA g. 2011, Relazioni tra l’Italia centro-meridionale, la Sicilia e
l’area egeo-balcanica durante l’Eneolitico, AttiIIPP XLIII, pp. 157-164.CAzzEllA A., mAnISCAlCO l. 2012, L’età del Rame in Sicilia, AttiIIPP XLI, pp. 81-104.CAzzEllA A., mOSCOlOnI m. 1999, a cura di, Conelle di Arcevia. Un insediamento eneolitico nelle
Marche, Roma.COCCHI gEnICk 2005, Considerazioni sull’uso del termine “facies” e sulla definizione delle facies archeo-
logiche, RSP LV, pp. 5-27.COCCHI gEnICk D. 2008, La tipologia in funzione della ricerca storica. Le forme vascolari dell’età del
Rame dell’Italia centrale, Origines, Firenze.COCCHI gEnICk D. 2009, Correlazioni tra l’Eneolitico siciliano e peninsulare, Origini n.s. IV, pp.
129-154.
231
COCCHI gEnICk D. 2011, Problematiche e prospettive della ricerca sull’età del rame in Italia in ricordo di Gianni Bailo Modesti, AttiIIPP XLIII, pp. 13-21.
DAvARAS k., bETAnCOuRT P.P. 2012, The Haghia Phothia Cemetery II. The pottery, Philadelphia Pennsylvania.
CulTRARO m. 2000, Il tipo di tomba ipogeica a grotticella artificiale in ambito egeo: alcune osservazioni, in AA.vv., L’ipogeismo nel Mediterraneo, Atti del Convegno, Sassari, pp. 473-499.
CulTRARO m. 2001, Aspetti dell’Eneolitico dell’Italia centrale nel quadro dei rapporti con la penisola balcanica e l’Egeo, AttiIIPP XXXIV, pp. 215-233.
CulTRARO m. 2006, La cultura di Rinaldone nel quadro delle relazioni con il mondo egeo-balcanico: un aggiornamento, AttiPPE VII, pp. 405-420.
CulTRARO m. 2008, Domesticating landscapes: Sicily and the Maltese Islands in the later Neolithic and Eneolithic Ages (IV-III millennium BC), in bOnAnnO A., mIlITEllO P., a cura di, Intercon-nections in the Central Mediterranean: the Maltese Islands and Sicily in History, Atti del Congresso, Palermo, pp. 5-19.
DOlfInI A. 2013, The Emergence of Metallurgy in the Central Mediterranean Region: a New Model, EJA 16.1, pp. 21-62.
ECkSCHmITT W. 1986, Kunst und Kultur der Kykladen 1, Mainz am Rheim.fIOREnTInI g. 1980-81, Ricerche archeologiche nella Sicilia centro-meridionale, Kokalos XXVI-
XXVII, 2.1, pp. 583-593.fOREnbAHER S. 1999-2000, Nakovana Culture. State of Research, Opuscula Archaeologica 23-24,
pp. 373-385.fugAzzOlA DElPInO m.A., SAlERnO A., TIné v. 2007, Villaggi e necropoli dell’area ‘Centro Com-
merciale’ di Gricignano d’Aversa - US Navy (Caserta), AttiIIIPP XL, pp. 521-537.gAllIS k., ORPHAnIDIS l. 1996, Figurines of Neolithic Thessaly, Athens.gIAnnITRAPAnI E. 1997, Sicilia e Malta durante il Neolitico, in Prima Sicilia, pp. 201-211.gjERDRum P., Heartwood in relation to age and growth in Pinus Sylvestris L. in Scandinavia, Forestry
76.4, pp. 414-424.guSmAnO m., mARTInEllI m.C. 2011, Una cava di calcare e gesso della facies di Malpasso a Venetico
(Messina), AttiIIPP XLIII, pp. 679-684.kOkA A. 1990, Tuma nr. 6 e varrezës së Shtojit, Iliria 20.1, pp. 27-39.kORkuTI m., PREnDI f. 1992, Forma dhe struktura e vendbanimeve neolitike dhe eneolithike në Shqipëri,
Iliria 22, pp. 7-21.kOumOuzElIS m. 1980, The Early and Middle Helladic Period in Elis, PhD. Thesis Ann Arbour.lEIgHTOn R. 1999, Sicily Before History, London.luTOvAC P. 2005, Muzej Grada Podgorice, Podgorica.mAlOnE C., bOnAnnO A., TRumP D., DIxOn j., lEIgHTOn R., PEDlEy m., STODDART S., P.j.
SCHEmbRI 2009, Material Culture, in C. mAlOnE, S. STODDART, A. bOnAnnO, D. TRumP, a cura di, Mortuary Customs in prehistoric Malta, Cambridge, pp. 277-314.
mAnfREDInI A. 2002, a cura di, Le dune, il lago, il mare. Una comunità di villaggio dell’età del Rame a Maccarese, Origines, Firenze.
mARAn j. 1998, Kulturwandel auf dem griechischen Fesland und den Kykladen im späten 3. Jahrtausend v. Chr., Bonn.
mARAngOu l. 1990, a cura di, Cycladic Culture. Naxos in the 3rd Millennium BC, Catalogo della Mostra, Athens.
232
Marković C. 1985, Neolit Crne Gore, Beograd.Marković C. 2006, Arheologija Crne Gore, Podgorica.mARTInEllI m.C., PROCEllI E. 2011, L’età del Rame in Sicilia: dalla facies ceramica alla facies archeo-
logica, una strada difficile, AttiIIPP XLIII, pp. 113-120.mIARI m. 1993, La necropoli eneolitica di Ponte S. Pietro (Ischia di Castro, Viterbo), RSP XLV, pp.
101-166.mIARI m., CAPORAlI C., CASADEI m., mAzzOnI C. 2011, Le strutture del villaggio eneolitico di Pro-
vezza (Cesena), AttiIIPP XLIII, pp. 639-644.ORSI P. 1908, Sepolcri protosiculi di Gela, BPI XXXIV, pp. 155-168.PREnDI f. 1976, Neoliti dhe Eneoliti në Shqipëri, Iliria 6, pp. 21-45.Prima Sicilia - S. TuSA 1997, a cura di, Prima Sicilia. Alle origini della civiltà siciliana, Palermo.PRIvITERA f. 2012, Un nuovo idoletto tipo Camaro da contrada Marca (Castiglione di Sicilia), AttiIIPP
XLI, pp. 673-681.PullEn D. 2000, The Prehistoric Remains of the Acropolis at Halieis. A Final Report, Hesperia 69,
pp. 133-187.radivojević M., rehren T., PerniCka e., Sljivar d., BraunS M. 2010, On the origins of extracti-
ve metallurgy: new evidence from Europe, JAS 37, pp. 2775-2787.RAmbACH j. 2007, To PEI Nekrotapheio tes Archaias Elidas, in Praktika 8 Diethnous Synedriou Pelo-
ponnesiakon Spoudon, Athenai, pp. 63-92.REnfREW C., WHITEHOuSE R. 1974, The copper Age of peninsular Italy and the Aegean, ABSA
LXIX, pp. 343-390.SAlERnO A., vAnzETTI A. 2004, L’Eneolitico e il Bronzo antico in Calabria, AttiIIPP XXXVII,
Firenze, pp. 207-234.SAmPSOn A. 1993, Skoteine Tharrounion, Athens.SAmPSOn A. 1997, To spelaio ton Limnon sta Kastria Kalavryton, Athens.SIlvESTRInI m., PIgnOCCHI g. 1997, La necropoli eneolitica di Fontenoce di Recanati: lo scavo 1992,
RSP XLVIII, pp. 309-366.SOuyOuDzOglOu-HAyWOOD C. 1999, The Ionian Islands in the Bronze Age and Early Iron Age
3000-800 BC, Liverpool.TIné S. 1963, L’origine delle tombe a forno della Sicilia, Kokalos IX, pp. 73-92.TOzzI C., zAmAgnI b. 2003, a cura di, Gli scavi nel villaggio neolitico di Catignano (1971-1980),
Origines, Firenze.TuSA S. 1992, La Sicilia nella preistoria, Palermo.veliMirović-ZiZić o. 1995, Violinski idoli-tumul iz Zetske ravnice, in Glasnik Crnogorske akademije
14, Podgorica, pp. 22-31.