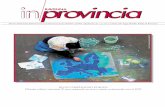Il PEfIl nel Master: per una formazione iniziale in prospettiva europea
Transcript of Il PEfIl nel Master: per una formazione iniziale in prospettiva europea
strumenti e ricerche
della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo
Collana diretta da Mari D’Agostino
scuola di lingua italiana per stranieri
dipartimento di scienze umanistiche
università di palermo
verso una didatticalinguistica riflessiva
Percorsi di formazione inizialeper insegnanti di italiano come lingua non materna
a cura di
Adriana Arcuri e Egle Mocciaro
UNIVERSITà dEglI STUdIdI palERmo
Unione europeaFondo sociale europeo
In copertina foto di Antonio Gervasi - Palermo 2014
CoMItAto SCIENtIFICo
Monica Barni (Università per Stranieri di Siena), Mari D'Agostino (Università di Palermo),Yang Lin(Università di Chongqing), Graziella Favaro (Pedagogista, esperta di Educazione interculturale,Centro CoME, Milano), Antonia Rubino (Università di Sidney)
Questo volume è stato pubblicato con fondi erogati dal Dipartimento regionale dell’Istruzione e dellaFormazione Professionale, Autorità di Gestione del PO Sicilia FSE 2007-2013, Programma OperativoRegionale Regione Siciliana FSE 2007-2013C(2007)6722 del 18.12.07
ISBN 978-88-908671-4-9
Indice
9
17
25
61
89
Verso una didattica linguistica riflessivapercorsi di formazione inizialeper insegnanti di italiano come lingua non materna
prefazioneadriana arcuri e Egle mocciaro
paRTE pRImalE cooRdINaTE
Ragionando sull’insegnamento dell’italianocome lingua non materna adriana arcuri e Egle mocciaro
l’Italia e l’Europa. le lingue e i diritti di tuttimari d’agostino
paRTE SEcoNdalINEE gUIda
Un’idea di didattica della lingua:per un approccio integrato l1, l2, lSadriana arcuri
Un’idea di lingua: modelli, teorie e prospettive acquisizionali Egle mocciaro
109
117
133
155
163
183
203
225
247
257
Il tirocinio: l’occasione di giano adriana arcuri
la valutazione:indicazioni metodologiche e suggerimenti operativimaria Rosa Turrisi
la scrittura autobiografica come strumento di riflessioneadriana arcuri, giuseppe paternostro e Vincenzo pinello
Il pEFIl nel master: per una formazione iniziale in prospettiva europeaadriana arcuri
Il Quadro comune europeo di riferimentoe la sua valenza formativaluciano mariani
paRTE TERzaSTRUmENTI E pRoSpETTIVE
Norma/e ed errore in italiano l2luisa amenta
Un test d’ingresso per gli alunni stranieri:ideazione, sperimentazione, valutazionechiara amoruso
la valutazione in rapporto alla certificazione linguistica.la cIlS a palermo Sara anselmi e miriam mesi
apprendimento integrato in contesto formativo post laureamRosanna Barranco
Repertorio dei software per la didattica dell’italiano l2/lSa cura di Rosanna Barranco
271
285
315
341
393
415
421
433
443
448
Risorse per l’insegnamento-apprendimento dell’italianocome lingua non materna.caratteristiche e scelta dei materiali didatticiTindara Ignazzitto
Insegnare la pragmatica della l2 nella l2.problemi teorici e suggerimenti metodologicigiuseppe paternostro e adele pellitteri
Insegnare attraverso l’interazione, insegnare l’interazione.Il caso del task-based language learning and teachinggiuseppe paternostro e adele pellitteri
Il testo letterario nella didattica dell’italiano l2/lS.Tra agonia, morte e qualche ipotesi di resurrezione Vincenzo pinello
l’italiano per scopi specialistici: caratteristiche e didatticamonica Rizzo
Un’esperienza formativa con christopher Humphris(e il bisogno di chiarire con un’intervista)marcello amoruso
Intervista a christopher Humphrisa cura di marcello amoruso
Insegnare a leggere e a scrivere in una seconda lingua.Intervista ad arcangela mastromarcoa cura di adele pellitteri
paRTE qUaRTaINSEgNaRE ITalIaNo all’ESTERo
Insegnare italiano in gran Bretagna (liverpool) Rosalba Biasini
Insegnare italiano in grecia (atene) domenica minniti gonias
455
457
465
469
472
474
478
482
483
485
Insegnare italiano in Bulgaria (Sofia) Neli Radanova
Insegnare italiano in Bosnia-Erzegovina (Banja luka) Salvatore cavaliere
Insegnare italiano in polonia (Varsavia) Joanna Jarczynska
Insegnare italiano in Russia (mosca) Elena Borisova
Insegnare l’italiano in cina (chongqing) Yang lin
Insegnare l’italiano in Vietnam (Hanoi) dang Thi phuong Thao
Insegnare l’italiano in australia (Sidney) antonia Rubino
Insegnare l’italiano in argentina (Rosario) mariano Strano
Insegnare l’italiano in Egitto (Il cairo) Hussein mahmoud
Profilo degli autori
* dell’impiego del pEFIl come strumento di formazione nel master si parla ampiamente in: arcuri(2012) e arcuri (2013) ai quali si rimanda.
Il PEfIl nel Master: per una formazione inizialein prospettiva europeaadriana arcuri
1. chE cos’è Il PEfIl*
Il Portfolio europeo per la formazione iniziale degli insegnanti di lingue(pEFIl) viene pubblicato nel 2006 nell’ambito di un progetto promosso dal-l’Ecml (European Centre for Modern Languages), che lo aveva affidatonel 2004 a un gruppo di formatori coordinati da david Newby, per contri-buire all’armonizzazione della formazione dei docenti in Europa; si presentacome uno “strumento di riflessione”, che ha come scopi:
1. incoraggiare i soggetti in formazione a riflettere sulle competenze che un docentemira a raggiungere e sulle conoscenze sottostanti che alimentano queste compe-tenze;
2. aiutare a preparare i soggetti in formazione per la futura professione in una seriedi contesti;
3. promuovere la discussione sia fra i docenti in formazione, sia fra loro e i loro do-centi, formatori e mentor;
4. facilitare l’autovalutazione delle competenze dei docenti in formazione;5. fornire uno strumento che aiuti a realizzare un diagramma dei progressi (consi-
glio d’Europa, 2006: 5).
Il nucleo del pEFIl è costituito da centonovantatrè descrittori per l’autova-lutazione distribuiti su sette categorie e da un modello per organizzare undossier dei prodotti di ciascun soggetto in formazione. Inoltre, dopo un’in-troduzione che ne definisce le caratteristiche e le finalità, sono presenti unasezione dedicata alle riflessioni personali, un glossario, un riepilogo dei ter-mini usati nei descrittori e una guida per l’uso.
la coerenza fra l’approccio linguistico-didattico del master e le scelte di
fondo del documento europeo ci ha confermato sull’opportunità delle nostrescelte e ha fatto sì che lo strumento si rivelasse particolarmente spendibile.Infatti come spiega Newby (2007: 26),
a reading of the descriptors will reveal the authors’ commitment to a generally “com-municative” approach to language learning and teaching, an advocation of certainprinciples of autonomous learning, an acceptance of the interdependence of lan-guage and culture.
queste, come si ricorderà, sono le coordinate di riferimento del nostro per-corso.
anche il qcER, del resto, pur dichiarando che esso
non può schierarsi da una parte o dall’altra nelle attuali dispute teoriche sulla naturadell’acquisizione del linguaggio e sui relativi rapporti con l’apprendimento; né puòabbracciare un determinato metodo di insegnamento, escludendo tutti gli altri (con-siglio d’Europa, 2002: 23),
rivela comunque di riconoscere gli approcci comunicativi (al plurale)come sfondo di riferimento didattico e la centralità degli apprendenticome prospettiva pedagogica (cfr. mariani, in questo volume).
Il pEFIl si inscrive nella produzione europea di documenti dedicati al-l’insegnamento-apprendimento delle lingue, e in particolare riconoscecome antecedenti il qcER, il Profilo europeo dell’insegnante di linguae il Portfolio europeo delle lingue (pEl).
della complementarità tra il qcER e il pEFIl, che traspare anche dal-l’uso, da parte degli autori, delle medesime parole per descrivere le fina-lità di ciascuno dei documenti, abbiamo già parlato nel corso di questovolume, nel capitolo sull’idea di didattica. dall’Elp, invece il pEFIl ri-conosce di aver mutuato l’attenzione all’approccio riflessivo e all’auto-valutazione.
l’impostazione dei descrittori in prospettiva positiva, “can-do de-scriptors”, infine è condivisa in tutti e tre i documenti, anche se nel qcERl’uso della prima persona è limitato alla griglia di autovalutazione, men-tre tutte le altre griglie sono declinate alla terza persona.
per la prospettiva e le finalità che si propone, il qcER, infatti, pur sot-tolineandone l’importanza, non mette al centro del suo ragionamentol’aspetto dell’autovalutazione che invece costituisce la ragion d’esseredei portfolii.
È interessante notare che mentre il qcER e l’Elp prevedono l’arti-
adriana arcuri156
colazione in livelli, che è la parte più conosciuta e usata dei due docu-menti per la sua spendibilità in ambito didattico, gli estensori del pEFIlhanno deciso di non articolare in livelli la competenza dei docenti. Rac-conta david Newby che l’ipotesi era stata presa in considerazione, so-prattutto perché la presenza dei livelli avrebbe reso ancora piùriconoscibile l’ analogia con il qcER e l’Elp. Il gruppo di ricerca haperò convenuto che
there are essential differences between the nature of language descriptors and didac-tic descriptors. didactic descriptors proved extremely difficult to scale and to assessin a quantitative fashion […]. In general, the project group felt that didactic compe-tences do not develop in a linear fashion and are difficult to quantify. moreover, tosome extent at least, it is the process of competence development which is importantin teacher education rather than the product of this education (Newby, 2007: 25).
questa posizione, che meriterebbe un approfondimento a parte sotto l’aspettodella valutazione, è coerente con una delle finalità principali del master, cheè, come si è più volte detto, quella di innescare nei corsisti l’habitus del ri-cercatore per tutto l’arco della vita, avviando appunto il processo di sviluppodelle competenze.
molti sono infine i punti di contatto fra il pEFIl e il Profilo degli inse-gnanti di lingue. quest’ultimo è un repertorio di quaranta descrittori sullabase dei quali progettare percorsi formativi, pertanto, come spiegano Kellye grenfell (2002; citati da Newby, 2007: 24),
It could be used as a checklist for institutions with longstanding strengths in lan-guage teacher education, and as a reference document providing guidance to insti-tutions with plans to develop their language teacher education programmes.
come spiega ancora david Newby,
the Profile targets teacher educators in general and teacher training curriculum de-velopers in particular. It thus takes a top-down view of teacher education, which in-cludes not only specific competences but structural aspects of teacher educationprogrammes. The EPOSTL, on the other hand, takes a bottom-up view, targetingstudent teachers and focusing on specific didactic competences which trainee teach-ers need to develop (Newby, 2007: 24).
È proprio questa prospettiva bottom up e l’attenzione che essa permette alpunto di vista dei docenti in formazione che ci ha convinti a usare il pEFIlnel nostro percorso. la scelta si è rivelata produttiva perché il lavoro sulpEFIl è stato in tutte le edizioni del master fertile e costruttivo.
Il pEFIl nel master: per una formazione iniziale in prospettiva europea 157
2. IMPIEgo dEl PEfIl
Il pEFIl viene utilizzato in tutte le fasi dell’itinerario formativo. la linea dilavoro che proponiamo, nella quale il pEFIl viene impiegato come stru-mento euristico e non solo autovalutativo, passa per una lettura del docu-mento finalizzata alla risistemazione dei descrittori dalle categorie dipartenza, che sono: il contesto; la metodologia; le risorse; la progettazionedidattica; la realizzazione didattica; l’apprendimento autonomo; la valuta-zione dell’apprendimento, in nuove categorie: riflettere su di sé; progettare;gestire la classe e l’apprendimento; gestire la disciplina; valutare; gestire ma-teriali e strumenti.
questa scelta, sicuramente arbitraria, ha lo scopo di ridurre il numerodelle categorie e di mettere in evidenza alcuni aspetti del nostro percorso,soprattutto in prospettiva della principale esperienza di tirocinio previstadall’offerta formativa, quella presso la Scuola di Italiano per stranieri del-l’Università di palermo, fornendo agli studenti già nelle categorie un’ideadella professione coerente con essa. Se si confrontano le due liste di ca-tegorie si nota, ad esempio, che la categoria il contesto è stata espuntadalla nostra classificazione. Nel pEFIl infatti questa categoria comprendedescrittori pertinenti alla relazione con la normativa che regola l’inse-gnamento e il rapporto con i programmi ufficiali (ad esempio, “sono ca-pace di capire le esigenze dei curricoli nazionali e locali”, pag.15); talidescrittori non riguardano l’esperienza dei tirocinanti neanche in fase diosservazione.
Inoltre la scelta di identificare come categoria autonoma “riflettere su disé” consente di mettere a tema da subito un aspetto irrinunciabile della pro-posta formativa.
per collocare poi i descrittori nelle nuove categorie, i corsisti trasformanola formulazione dei descrittori, che come abbiamo detto rispettano il mo-dello “can-do descriptors”, in proposizioni col verbo all’infinito. questa ri-formulazione rende trasparente il passaggio dalla dimensione autovalutativaa quella conoscitiva.
all’inizio del percorso l’analisi della mappa delle categorie dei descrittorie il confronto con gli schemi d’azione dei corsisti (cfr. arcuri b, in questo vo-lume) permettono di identificare le tappe del processo didattico, dalla pro-gettazione alla valutazione. È poi la lettura dei descrittori che lo configuracome un processo a spirale, sostenuto dalla continua riflessione su se stessi,ad esempio:
adriana arcuri158
sono capace di usare il processo e i risultati della valutazione per dare forma al mioinsegnamento e programmare l’apprendimento per i singoli o per gruppi di studenti(pag. 31); sono capace di valutare criticamente il mio insegnamento in relazione aiprincipi teorici; sono capace di valutare criticamente il mio insegnamento sulla basedell’esperienza, del feedback degli allievi e dei risultati dell’apprendimento, por-tando i necessari adattamenti (pag.15).
I corsisti eseguono poi un lavoro di tipo artigianale, smontando e rimon-tando la classificazione dei descrittori per risalire ai contenuti fondamentalidella professione docente, l’idea di lingua e di didattica.
le quattro abilità in relazione con i testi, la grammatica, il lessico e lacultura emergono dalla lettura minuziosa dei descrittori come gli oggetti dell’insegnamento; gli studenti comprendono così, in modo naturale, in che cosaconsista effettivamente l’approccio comunicativo: i descrittori che fanno ri-ferimento all’uso della lingua in situazioni reali di comunicazione e con testiautentici sono assai più numerosi dei descrittori dedicati alla grammatica eal lessico.
Un altro contenuto rilevante che emerge dalla manipolazione dei descrit-tori è che i descrittori del tipo “creare un ponte con le altre abilità” sono ci-tati nell’ambito della lettura e dell’ascolto ma non nell’ambito della scritturae del parlato; inoltre per ciascun apprendimento si parla di “riconoscere eusare”, “individuare e usare”, ecc.. appare chiaro come il percorso delineatodai descrittori coincida col modello che proponiamo agli studenti e ci con-fermi sulla validità dell’ipotesi che per favorire la competenza comunicativaè efficace connettere strettamente l’apprendimento delle abilità produttive aquello delle abilità ricettive.
la compilazione della categoria relativa alla gestione della classe e allarelazione con gli allievi contribuisce a dare concretezza al principio dellacentralità dello studente e della sua responsabilità nel processo formativo.dal pEFIl si ricavano chiare indicazioni relative al ruolo che rivestono laconsapevolezza e l’autonomia nella gestione del processo di apprendimento:
(Sono capace di) valutare e selezionare una serie di attività che aiutano gli appren-denti a riflettere sulle proprie attuali conoscenze e competenze; valutare e selezionareuna serie di attività che aiutano gli apprendenti a identificare e riflettere sui processie gli stili individuali di apprendimento; guidare e assistere gli apprendenti nel met-tere a fuoco i propri obiettivi e nel programmare il proprio apprendimento (pag. 27).
In questo caso, inoltre, gli studenti riconoscono come in un interessante giocodi specchi la proposta didattica cui loro stessi partecipano come discenti.
Il pEFIl nel master: per una formazione iniziale in prospettiva europea 159
Tab.1 - griglia di osservazione “gestione della disciplina”
con i descrittori gli studenti costruiscono le griglie di osservazione con lequali affronteranno le diverse fasi del tirocinio (cfr. arcuri, b, in questo vo-lume); il lavoro avviene in gruppo e con la supervisione del docente. Sonostrumenti che useranno per tutto il percorso e che costituiscono il fulcro at-torno a cui gira l’esperienza di apprendimento secondo l’approccio riflessivo.
Tali griglie rispondono a diverse esigenze di analisi: riconoscere all’in-terno di situazioni complesse – quali sono le classi reali – variabili che al-trimenti sfuggirebbero; cercare esempi dei descrittori fino ad alloraconosciuti soltanto sulla carta; tenere memoria dell’esperienza e consentirnecosì la documentazione e la ricostruzione in termini formativi.
le griglie vengono impiegate per l’osservazione dei docenti delle classidove i corsisti realizzano il tirocinio, e nella fase successiva per l’osserva-zione dei colleghi che intervengono, e infine per l’autoosservazione.
per mantenere chiaro il nesso tra esperienza didattica e input disciplinari,le griglie di osservazione dei docenti prevedono una colonna detta di po-stosservazione, nella quale, in sede di riflessione fuori dall’aula i corsisti an-notano i riferimenti alle discipline che rintracciano nelle attività didatticheche osservano.
Un altro degli strumenti utilizzati per permettere di porre attenzione al-l’interazione fra saperi e azione didattica è la “scheda di tessitura”, una sem-plice tabella nella quale gli studenti sono invitati a classificare i contenutiformativi affrontati in ciascun segmento didattico, a seconda se siano utiliz-zabili direttamente in aula o che servano all’insegnante per progettare o peridentificare problemi.
quello che segue è un esempio tratto dalla griglia di osservazione “ge-stione della disciplina”. come si vede, il descrittore tratto dal pEFIl è statoprivato della forma “can-do descriptors” e riformulato per individuare uncomportamento osservabile dal tirocinante nel docente d’aula, mentrel’esempio fa riferimento a un’attività effettivamente svolta in aula. In sededi postosservazione il corsista ha rintracciato in uno dei contenuti appresidurante le lezioni la motivazione della scelta del docente d’aula nell’attivitàosservata:
adriana arcuri160
Va detto infine che le griglie così costruite subiscono poi degli adattamentie delle integrazioni per essere usate nel contesto di osservazione della l2,nelle scuole in cui l’italiano è la lingua di scolarizzazione. la logica del pro-cesso e la base dei descrittori restano tuttavia le medesime.
Infine le griglie di osservazione costituiscono una buona parte del mate-riale in base a cui verrà costruita l’autobiografia di apprendimento (cfr. ar-curi, paternostro e pinello, in questo volume).
Nell’ultima parte del percorso, il pEFIl riacquista invece la sua funzionepreminente, cioè quella di strumento autovalutativo: in base ai descrittoricoerenti col percorso di cui hanno fatto esperienza i corsisti tracciano un pro-prio profilo valutativo.
3. sVIluPPI fuTuRI
per compilare le griglie i corsisti devono associare a ciascun indicatore, cheidentifica in questo caso un aspetto della professione da osservare, esempi dicomportamento didattico e consegne operative. In questo modo le grigliesortiscono la realizzazione di repertori di pratiche, che alla luce della rifles-sione successiva possono essere valutate in relazione alla loro efficacia, se-lezionando quelle che maggiormente si rivelano stimolanti.
questa direzione sembra promettere sviluppi convincenti, perché po-trebbe permettere la costruzione di una banca dati di buone pratiche e si ponesu una delle linee di lavoro previste dalle fasi successive del progetto pEFIl1.
In collaborazione con l’American Council on the Teaching of ForeignLanguages (acTFl), infatti, il gruppo di progetto del pEFIl ha lanciato unainiziativa che va proprio in questa direzione (Actostl Project). In molti paesid’Europa e d’america si è appena conclusa una ricerca sulle buone prati-che, a partire dalla compilazione di griglie molto simili a quelle realizzate nelmaster, basate sul pEFIl e sul suo corrispettivo americano, il Program Stan-dards for the Preparation of Foreign LanguageTeachers.
In particolare la ricerca si concentra su ventiquattro competenze profes-sionali identificate sulla base dei due documenti e adattate da quelle decli-nate nel pEFIl; esse riguardano gli ambiti della progettazione, della
1 l’articolazione degli sviluppi del progetto gestito dall’Ecml riguarda numerosi ambiti e impieghi delpEFIl, che nel frattempo si è diffuso in molte parti del mondo. Una documentazione ampia sulle atti-vità di ricerca e di applicazione è disponibile all’indirizzo:http://epostl2.ecml.at/EpoSTl/tabid/2324/language/en-gB/default.aspx
Il pEFIl nel master: per una formazione iniziale in prospettiva europea 161
realizzazione didattica, degli aspetti interculturali e della valutazione. Unconfronto tra i risultati della ricerca e le osservazioni ricavate dagli studentici permetteranno un ulteriore affinamento delle procedure, in vista di unasempre maggiore efficacia formativa.
RIfERIMEnTI bIblIogRAfIcI
arcuri, adriana, 2012. Il portfolio europeo per la formazione iniziale degli insegnanti(pEFIl) come strumento di insegnamento/apprendimento, Italiano LinguaDue, 2,328-335.
arcuri, adriana, 2013. Il Modulo Tessuto, un percorso per la formazione di insegnantiriflessivi, Idee in form@zione, 2 (1), 57-66.
consiglio d’Europa, 2002. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Appren-dimento, insegnamento, valutazione. Firenze: la Nuova Italia - oxford (trad. it. di Com-mon European Framework for Languages. Learning, Teaching, Assessment, a cura did. Bertocchi e F. quartapelle, 2001, in: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Fra-mework_en.pdf).
consiglio d’Europa, 2006. Portfolio Europeo per la formazione iniziale degli insegnantidi lingue (PEFIL). Uno strumento di riflessione (trad. it. a cura di p. diadori di Eu-ropean Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). A reflection tool forlanguage teacher education, graz 2007), in:http://www.ecml.at/tabid/277/publicationId/16/default.asp.
Kelly, michael e michael grenfell, 2002. European Profile for Language Teacher Ed-ucation. A Frame of Reference. University of Southampton.
Newby, david, 2007. The European portfolio for Student Teachers of languages, Baby-lonia, 3, 23-26, in: http://babylonia.ch/it/archivio/2007/numero-3-07/the-european-portfolio-for-student-teachers-of-languages/.
adriana arcuri162