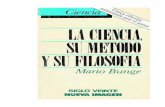LA FORMAZIONE DEI RICERCATORI : TRA METODO, DEBOLEZZA E PASSIONE
Transcript of LA FORMAZIONE DEI RICERCATORI : TRA METODO, DEBOLEZZA E PASSIONE
1
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
LA FORMAZIONE DEI RICERCATORI :
TRA METODO, DEBOLEZZA E PASSIONE
Antonia Chiara Scardicchio
1. SULL’ISOMORFISMO TRA COMPETENZE DI RICERCA E COMPETENZE
DELL’EDUCAZIONE.
La formazione dei ricercatori è un ambito delicato e cruciale.
Cruciale: perché da essa dipende il futuro della Accademia. La sua fertilità, intesa come
capacità di produrre conoscenze che si incarnino e servano alla vita al di fuori dei confini dei saperi
scritti solo per i dotti . Delicato: poiché inerisce questioni di metodo intrise con questioni di scienza,
poiché implica non solo un fare ma, soprattutto, come anche altrove ribadito1, un essere in ricerca,
ed un impegno per il cambiamento inteso come urgenza e spinta2.
E’ la formazione di un habitus interiore, prima ancora che di un modus operandi.
La ricerca nei contesti pedagogici poi, richiede al ricercatore non soltanto le medesime
competenze di tutti gli altri suoi colleghi che per mestiere ricercano ma, anche, insieme, le
medesime competenze del pedagogista e dell’educatore, non essendo mai l’operazione di
progettazione di un piano sperimentale scevra dall’intenzionalità pedagogica che mira al
miglioramento della realtà, non alla sua mera ratifica, mai paga della semplice raccolta dei dati
finalizzata alla descrizione ed analisi di un fenomeno.
La tesi che dunque attraversa questo saggio è, pertanto, la consapevolezza che un
ricercatore in pedagogia è sì un professionista delle metodologie della ricerca ma, anche e prima di
tutto, un pedagogista ed un filosofo dell’educazione ed, anche, un educatore: un esperto di saperi e
di pratiche, di episteme e technè, di teorie e rel-azioni.
Chi che compie ricerca empirica in educazione sa che “maneggia” contesti e persone e che,
dunque, il rigore e la precisione dei protocolli richiedono, in egual misura rispetto alla verificabilità
delle procedure, anche un habitus interiore che consenta, come da indicazione di Salomon, di
lavorare con i soggetti e non sui soggetti3 : pertanto, anche la formazione al metodo si configura
come connotata pedagogicamente e salda nell’epistemologia così come nella metodologia.
Questa la premessa imprescindibile per illustrare la scelta di progettare ed attuare un piano
formativo per i ricercatori sul campo che ha coniugato epistemologia e metodologia, formazione e
1 Cfr. BALDASSARRE V. A., DI GREGORIO L., SCARDICCHIO A.C., La Vita come Paradigma, Ed. Dal Sud,
Modugno,Bari, 1999
2 Cfr.: F. FRABBONI, F. PINTO MINERVA, Manuale di pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari 2002 ;
FRABBONI F.; WALLNÖFER G., La pedagogia tra sfide e utopie, Franco Angeli, Milano, 2009
3 Cfr. BANNISTER D. , FRANSELLA F., L’uomo ricercatore. Introduzione alla psicologia dei costrutti personali,
Psycho, Firenze, 1986, pp. 64-65
2
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
teoretica e formazione empirica, considerando la competenza del fare ricerca scientifica come
“prassi anche interiore”4.
Per tali motivazioni, dunque, la formazione dei ricercatori che sono andati sul campo a
raccogliere dati, ad incontrare persone, per noi si è configurata in modalità molto più complessa,
rispetto alla mera fornitura di erudizione intorno alla metodologia scelta, ovvero quella
autobiografica. E, anzi, proprio per la peculiarità di tale metodologia, laddove non è possibile
ridurla ad un corpus di metodi e tecniche da applicare previo studio delle istruzioni per l’uso, essa
ha implicato, prima di tutto, una sosta intorno al senso stesso della ricerca nel campo delle scienze
umane:
«Come si deve interpretare la responsabilità di coloro che si occupano
dei sistemi viventi, della vasta ed eterogenea folla di entusiasti e di cinici, di generosi e di
avidi? Tutti costoro, individualmente o collettivamente hanno la responsabilità di un sogno »
Gregory Bateson, Mary Catherine Bateson5
Comprendere un fenomeno – ed un fenomeno umano – richiede, come da esortazione
husserliana6, l’habitus del ricercatore partecipe, immerso nel mondo-della-vita (Lebenswelt),
responsabile di un sogno e della realtà e consapevole che l’astrazione da essi – dalla realtà e dalla
propria visione del mondo - è un artificio, ed anche una perdita, non un valore aggiunto per la
ricerca; e comprendere un fenomeno nel campo della ricerca empirica in educazione implica che lo
stesso ricercatore non sia mero pensatore/produttore né mero applicatore/fruitore di teorie ed ipotesi
progettuali: il ricercatore empirico in pedagogia, indipendentemente dal tipo di tecnica e metodo per
il quale si sente personalmente di optare, è sempre formato alla intenzionalità pedagogica ed alla
opzione per la compromissione cognitiva e relazionale e, di conseguenza, riconosce che la chiave
dell'intero processo conoscitivo è custodita nella capacità non già del mero osservare ma altresì,
risiede nel saper “guardare”: inteso, sottolinea Dal Lago, come il saper relazionarsi all'altro con la
vista e con tutti gli altri sensi possibili7: laddove, primo fra tutti, il primo sia il senso dell’ascolto: il
senso della ragione che sa sospendersi ed aprirsi al non conosciuto.
Ecco perché, con Colombis, sentiamo di poter affermare che la ricerca qualitativa è una
forma della mente.8
2. EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DELL’IMPLICAZIONE
Il primo passo, dunque, della formazione erogata ai giovani ricercatori, ha visto offrire agli
stessi l’approfondimento intorno al paradigma problematicista9 ed alle sue derivazioni rispetto alle
opzioni metodologiche proprie della ricerca sul campo in educazione.
4 Cfr BALDASSARRE V. A., DI GREGORIO L., SCARDICCHIO A.C., op. cit.
5 BATESON G., BATESON M. C., Dove Gli Angeli Esitano. Adelphi, Milano, 1989, pag. 273
6 Cfr. HUSSERL E., Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie,
ediz. postuma, a cura di W. Biemel, Den Haag, M. Nijhoff, 1954; Ed. italiana: HUSSERL E., La crisi delle scienze
europee e la fenomenologia trascendentale: introduzione alla filosofia fenomenologica, a cura di Biemel W., trad. di
Filippini E., Il Saggiatore, Milano, 1968 7DAL LAGO A., DE BIASI R., a cura di, Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale, Laterza, Roma-
Bari, 2002, pag. XII 8 Cfr. COLOMBIS A., Fuori dal mito: la sociologia “qualitativa” è una forma della mente, in CIPOLLA C., DE
LILLO A., Il sociologo e le sirene. La sfida dei metodi qualitativi, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 179-241 9 Cfr. FRABBONI F., PINTO MINERVA F., op. cit.; BALDACCI M., Il problematicismo. Dalla filosofia
dell'educazione alla pedagogia come scienza , Milella, Lecce, 2003
3
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
L’analisi ermeneutica dei dati qualitativi, quali quelli raccolti durante la rilevazione negli
incontri narrativi con gli anziani del Parco, ha richiesto ai ricercatori accademici che hanno
interpretato gli stessi la medesima consapevolezza problematicista che essi stessi hanno contagiato
ai ricercatori rilevatori; i quali, seppur non coinvolti nella fase di analisi, hanno conosciuto ogni fase
ed ogni fine della ricerca stessa: tutti dunque, ascoltatori in diretta ed ascoltatori a distanza, hanno
approcciato i soggetti della ricerca e le informazioni da loro fornite con la coscienza accogliente
propria di una “doppia ermeneutica”, quella intesa da Melucci come la consapevolezza di poter
produrre non conoscenze assolute ma, soltanto, interpretazioni plausibili: ispirato
dall’etnometodologia di Garfinkel e dall’approccio interpretativo di Geertz, anche Melucci nella
sua teorizzazione nel merito del dibattito sul metodo nelle scienze sociali ha spodestato
l’epistemologia della verità con l’epistemologia della plausibilità10
: quanto mai pertinente nella
raccolta e nella analisi di dati non ordinati nelle maglie di griglie o di interviste rigidamente
strutturate ma libere e per molti versi ingovernabili .
Tale approdo, lungi dal confinare la ricerca nel relativismo, è altresì radicato nelle conquiste
epistemologiche ed empiriche della Cibernetica di second’ordine11
, del Costruttivismo12
, della
Teoria Sistemica13
, della Ecology of mind14
ed anche della Fisica Quantistica15
, che hanno sfibrato il
10
Cfr. MELUCCI A., Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura, Il Mulino, Bologna, 1998 11
Cfr.: WIENER N., Introduzione alla Cibernetica, Boringhieri, Torino, 1961; CECCATO S., Cibernetica per
tutti, voll. I-II Feltrinelli, Milano, 1968, 1970; ATLAN H., Complessità disordine e autocreazione di significato, in
BOCCHI G.L., CERUTI M., a cura di, La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1985; FOERSTER H.VON, Notes pour
une epistemologle des obJets vivants, Seuil, Paris, 1974; FOERSTER H.VON, Cibernetica ed epistemologia: storia e
prospettive, in BOCCHI G.L., CERUTI M., op. cit; FOERSTER H.VON, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma, 1987;
PORKSEN B., La verità è un'invenzione di un bugiardo. Colloqui per gli scettici, Meltemi, Roma, 2001; FRABBONI F.,
PINTO MINERVA F., op. cit.
12 Cfr.: BERGER P.L., LUCKMANN T., La realtá come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969;
WATZLAWICK P., La realtà della realtà, Astrolabio, Roma, 1976; PIATTELLI PALMARINI M., a cura di, Livelli di realtá,
Feltrinelli, Milano, 1984; MATURANA H., VARELA F., Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia, 1985; MATURANA H.,
VARELA F., The tree of knowledge, New Science Library, Boston, 1985; FOERSTER H.VON,. Attraverso gli occhi
dell'altro, Guerini, Milano, 1996; GLASERSFELD E. VON, Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning,The
Falmer Press , London & Washington , 1995; FOERSTER H.VON, GLASERSFELD E. VON, Come ci si inventa. Storia,
buone ragioni ed entusiasmi di due responsabili dell'eresia costruttivistica , Odradek, Roma, 2001; KELLY G., La
psicologia dei costrutti personali, Raffaello Cortina, Milano 2004.
13 Cfr.: BERTALANFFY L. VON., Teoria Generale dei Sistemi, ISEDI, Milano, 1971; BERTALANFFY L. VON,
Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, Mondadori, Milano, 2004; STROLLO M.R., Prospettiva
sistemica e modelli di formazione, Liguori, Napoli, 2003; FRABBONI F., PINTO MINERVA F., op. cit.;
14 Cfr.: BATESON G., Verso Un’ Ecologia della Mente, Adelphi, Milano, 1993; F G., Mente e Natura, Adelphi,
Milano, 1984; BATESON G., BATESON M. C., op. cit.,; BATESON G., Una Sacra Unità. Altri passi verso un'ecologia
della mente, Adelphi, Milano, 1997; MANGHI S. a cura di, Attraverso Bateson. Ecologia della mente e relazioni
sociali. Con un lavoro inedito di Gregory Bateson, Raffaello Cortina, Milano 1998 ; MANGHI S., La conoscenza
ecologica. Attualità di Gregory Bateson, Raffaello Cortina, Milano, 2004
15
Cfr. : BOHR N., I quanti e la vita, Bollati Boringhieri, Torino, 1984; GILMORE R., Alice nel paese dei quanti.
Le avventure della fisica , Raffaello Cortina, Milano, 1996; GILMORE R., Il quanto di Natale. Esplorando con Dickens i
misteri della fisica, Raffaello Cortina, Milano, 1999; CAVALLINI G., La costruzione probabilistica della realtà, CUEN,
Napoli, 2001CIANCHI L., LANTIERI M., MORETTI P., Determinismo, realismo e località in fisica classica e quantistica ,
Aracne, Roma, 2007; LINDLEY D., Incertezza. Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di indeterminazione, Einaudi,
4
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
“dogma della immacolata osservazione”16
, e che, dunque, hanno condotto la ricerca scientifica al
salto “dalla dicotomia osservatore/campo” verso la “connessione osservatore-nel-campo”17
: “tutto
ciò che è osservato nella realtà sociale è osservato da qualcuno che si trova a sua volta inserito in
relazioni sociali e in rapporto al campo che osserva”18
.
Pertanto, il ricercatore, poiché è parte – e non super partes – della realtà che va a studiare,
non può far nulla per sottrarsi alla sua materialità, alla sua implicazione, alla sua incidenza: non solo
parlando ma, anche restando in assoluto silenzio, soltanto il “semplice” osservare implica un
intervento nella realtà.
Questa consapevolezza – che nelle scienze naturali si è tradotta nella concezione
probabilistica della realtà e nello studio dei sistemi caotici e delle regole “fuzzy”19
- permette ai
ricercatori ed agli scienziati di sottrarsi al rischio di quella che Bateson definiva “follia
epistemologica” , da lui considerata una vera e propria patologia umana, e che egli, appunto,
identificava in una serie di “errori epistemologici” tra cui emergeva, in primis, la fiducia
nell’oggettività.20
All’ego cartesiano dunque, fideisticamente e dogmaticamente devoto alla visione
matematica – galileiana e newtoniana - della realtà, davanti all’evidenza quantistica – circa
l’inclusione dell’osservatore nella sua osservazione - , non resta che riconoscere che la sua pretesa
di una visione oggettiva della realtà gli è costitutivamente impossibile: egli non è spectator mundi
ma parte di quello stesso mondo che vuole descrivere ed osservare, tanto da poter affermare che,
sempre, ogni qualvolta, sta descrivendo il mondo e l’altro, sta, piuttosto, descrivendo se stesso: o,
meglio, la sua relazione con esso21
.
Ogni conoscenza è dunque, relazione.
E non esiste osservazione, neppure quella governata dai più rigidi protocolli, che non sia
“carica di teoria” (theory ladeness)22
: già dalla Krisis di Husserl invero, e poi fino per Einstein ed
Heisenberg, la visione ingenua – o “folle”, come la definiva Bateson, di una realtà conoscibile
oggettivamente, a prescindere dalla corporeità (Husserl), dalla singolarità biologica (Maturana,
Varela), storica (Kuhn, Ceruti) e passionale (Polanyi) di chi la conosce, ha da apprendere che, suo
malgrado, non esistono uno spazio ed un tempo neutri ed absoluti nei quali si possa guardare e
Torino, 2008; MACCONE L., SALASNICH L., Fisica moderna. Meccanica quantistica, caos e sistemi complessi , Carocci,
Roma, 2008; TARSITANI C., Dalla fisica classica alla fisica quantistica, Editori Riuniti, Roma, 2009 16 Cfr. KUHN T., La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza , Einaudi, Torino, 1985
17 MELUCCI A., op. cit., pag. 22
18 IVI, pp. 22-23
19 Cfr. : PRIGOGINE I., Le leggi del caos, Laterza, Roma-Bari 1994; GLEICK J., Caos, Sansoni, Milano, 1997;
GIVIGLIANO A., Teorema di Gödel, Logica Fuzzy, Pensiero Complesso:una lettura metodologica, Quaderni del C.S.S.
"A. Grandi", Livorno 1999; KOSKO B., Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Baldini & Castoldi,
Milano, 2000; VERONESI M. , VISIOLI A., Logica Fuzzy. Fondamenti teorici e applicazioni pratiche, Franco Angeli,
Milano, 2004 20
Cfr.: BATESON G., op. cit., 1993 21
Cfr.: CERUTI M., La danza che crea. Evoluzione e cognizione nell'epistemologia genetica, Feltrinelli,
Milano, 1989; CERUTI M., a cura di, Evoluzione e conoscenza, Lubrina, Bergamo, 1992; CERUTI M., a cura di, Il caso e
la libertà, Laterza, Roma-Bari, 1994 22
Cfr.: KUHN T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1962; HANSON N.R., I modelli
della scoperta scientifica. Ricerca sui fondamenti concettuali della scienza, Feltrinelli, Milano, 1978; FEYERABEND P., I
limiti della ragione, Il Saggiatore, Milano, 1983; POLANYI M., La conoscenza personale. Verso una filosofia post-
critica, Rusconi Libri, 1990.
5
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
conoscere il reale senza contaminazione alcuna: senza l’implicazione ed il coinvolgimento della
soggettività umana che è ininterrottamente fertile in interpretazioni.
La conoscenza è observer dependent (von Foerster), il guardato è intriso di chi lo guarda -
la neutralità non ci appartiene costitutivamente, l’assolutezza ci è preclusa biologicamente - e,
soprattutto, la conoscenza è embodied, incarnata23
. Al punto tale da poter essere sempre connotata –
e pur negli ambiti apparentemente più algidi della ricerca scientifica nel campo delle scienze
naturali - come “appassionata”:
“In ogni atto di conoscenza entra un contributo appassionato della persona che
conosce ciò che viene conosciuto e (…) questa componente non è un’imperfezione
bensì un fattore vitale della conoscenza”24
“La scienza viene considerata come oggettivamente fondata a dispetto delle sue
origini imbevute di emozionalità. Da questo momento dovrebbe essere chiaro che non
sono d'accordo con una tale convinzione; adesso sono giunto al punto in cui devo
parlare esplicitamente della passione che è presente nella scienza. Desidero mostrare
che le passioni scientifiche non sono affatto prodotti secondari puramente psicologici,
ma hanno una funzione logica che contribuisce con un elemento essenziale alla
costituzione della scienza.(…).
Le teorie del metodo scientifico che cercano di spiegare la determinazione della verità
scientifica mediante un procedimento formale puramente oggettivo, sono destinate al
fallimento. Ogni processo di ricerca che non sia guidato da passioni intellettive si
dissolve inevitabilmente in un deserto di banalità.”25
Michael Polanyi
Michael Polanyi era chimico e fisico: paradossalmente, difatti, gli approdi che hanno
rivoluzionato le fissità del Metodo “Forte” della Scienza Moderna sono giunti proprio dalle Scienze
naturali26
e non da quelle sociali - che nel frattempo dalle prime mutuavano il modello per fondare i
propri statuti epistemologici su paradigmi positivistici, adottati come inossidabili evidenze - :
proprio dalla fisica e dalla matematica e dalla geometria sono giunte quelle confessioni di
irrisolutezza che insegnano a chiunque si accinga a disegnare e realizzare una ricerca empirica,
23 VARELA F. J. THOMPSON E. , ROSCH, E., La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova
dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1992; MATURANA H., VARELA F., Macchine ed esseri viventi. L'autopoiesi e
l'organizzazione biologica, Astrolabio, Roma, 1992.
24 POLANYI M., op. cit, pag.70
25 IVI, pag. 248- 252
26 Cfr.: HEISENBERG W. , BORN M., SCHRODINGER E., AUGER P., Discussione sulla fisica moderna, Einaudi,
Torino, 1959; HOFSTADTER D.R. , Godel, Escher, Bach: un'Eterna Ghirlanda Brillante , Adelphi, Milano, 1984;
LUDOVICO A., Effetto Heisenberg. La rivoluzione scientifica che ha cambiato la storia, Armando, Roma, 2001;
LINDLEY D., Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di indeterminazione, Einaudi, Torino, 2007; BERTO F., 2007,
Logica da zero a Gödel, Laterza, Roma-Bari, 2007.
6
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
anche in educazione, che non è possibile dirsi ricercatori se non nella consapevolezza di una forma
debole27
, senza presunzione di definire-prevedere-controllare qualsivoglia fenomeno28
, assumendo,
indi, innanzitutto l’habitus interiore dell’ errante: appunto, ricercatore.
Questo limite della conoscenza umana, lungi dal configurarsi come una rinuncia, implica
altresì una sua risemantizzazione, un mutamento di paradigma non un impoverimento:
“Non dovremmo consentire all’imperfezione della nostra comprensione di alimentare la
nostra ansia e di aumentare così il bisogno di controllo. I nostri studi potrebbero piuttosto ispirarsi
ad una motivazione più antica, anche se oggi appare meno rispettabile: la curiosità per il mondo di
cui facciamo parte. La ricompensa per questo lavoro non è il potere ma la bellezza. ”
Gregory Bateson29
3. L’OPZIONE PER LA RICERCA AUTOBIOGRAFICA: TRA PARACADUTISTI
E CERCATORI DI TARTUFI
Nel campo della ricerca in educazione assume una rilevanza molto particolare l’utilizzo
dell’approccio autobiografico quale metodologia di ricerca. Esso infatti, implica, per la natura stessa
del metodo - e della filosofia che lo sottende – che ogni ricerca sì configurata non si esaurisca nella
mera raccolta dei dati e dunque, non si sostanzi nel perseguimento della sola valenza conoscitiva:
poiché l’utilizzo delle storie di vita implica inequivocabilmente un cambiamento in chi narra, in chi
ascolta ed in chi raccoglie le storie ne risulta che, accanto alla funzionalità conoscitiva, sempre esso
ne consegua una anche formativa.
Possiamo dunque, sostenere che la scelta di questo tipo di percorso nei disegni empirici della
ricerca pedagogica implichi necessariamente una scelta di formazione, non solo di descrizione. Una
scelta pedagogica per tutti gli attori del processo - per i ricercatori così come per i soggetti della
ricerca - e per il contesto: una scelta di cambiamento che nasce e muove proprio dalla possibilità -
così offerta di comprendere “sentendo il polso” ”30
persone, contesti e relazioni e, anche, processi
e teorie, modelli e weltaschaung dei ricercatori.
E dunque, una tale competenza non asserisce unicamente al curriculum definibile dai soli
titoli accademici per un Ricercatore: il “progetto di ricerca” non è solo quello confezionato
scientificamente per le riviste e l’alveo dotto e ristretto della cultura universitaria, ma anche, ed in
particolare, ogni progetto che, poiché educativo - cioè avente come obiettivo il cambiamento -
parta non da una risposta ma da una domanda alla realtà ed, in primis, a se stessi rispetto a quella
realtà.
E dunque questo modus è il primum requisito “scientifico” della ricerca, come
dell’educazione, dello scienziato come dell’educatore, e dell’educatore come di ogni persona che è
soggetto di una ricerca e che, dunque, proprio per questo è “in formazione”.
Ogni volta che un intervistato partecipa ad una ricerca autobiografica, l’atto del suo
raccontare sorvola la mera produzione di dati e giunge inevitabilmente a connotarsi
normativamente: nella misura in cui il narrarsi fa crescere in autoconoscenza, intesa come
consapevolezza, conferimento di nessi, appropriazione della propria storia. Ei allora qui possibile
27
Cfr. BERTOLDI F., Ipotesi epistemologiche sulla sperimentazione, in “Pedagogia e vita”, n.3/1994 28
Cfr. FRABBONI F., PINTO MINERVA F., op. cit. 29
BATESON G., op. cit., 1993 pag. 32. 30
La metafora, di Keats, è ripresa in TURNER V., Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna, pag. 180.
7
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
testimoniare come l’esperienza del narrare in questa ricerca si sia manifestata come momento
formativo, nella misura in cui, con la Formenti, riconosciamo alla narrazione autobiografica “potere
auto-formativo”31
: ovvero generatore di apprendimento e cambiamento, laddove la consapevolezza
generata, che in questo “metodo” trova la sua via privilegiata, fa della memoria e della narrazione
“il terreno su cui può cimentarsi la difficile impresa socratica del “conosci te stesso” ” 32
, nella
misura in cui “imparare a raccontare (a se stessi prima che agli altri), confidando sulla complicità
di un ascolto fluttuante e non giudicante …è fondamentalmente imparare a conversare con se
stessi...”33
.
Ne deriva, allora, che ogni soggetto intervistato per noi è stato più ed altro che parte di un
campione la cui rilevanza si giudica secondo fini statistici: egli ed ella sono stati considerati
innanzitutto come destinatari ed, insieme, essi stessi, erogatori di un intervento educativo: nella
misura in cui la condivisione della loro memoria diventa apprendimento per chi la riceve.
Per questo, anche quando anche un racconto autobiografico è considerato statisticamente
non valido, avendo apportato informazioni non sulla media ma solo su uno, e non essendo quindi
rappresentativo, generalizzabile, ripetibile, ecc...., il ricercatore - pedagogista ed educatore - non
valuta mai la sua ricerca inutile ed improduttiva, se questa è stata educativa: se, dunque, egli avrà
saputo cogliere della sua professionalità l’essere sempre educatore, anche nella veste del
ricercatore.
La connotazione squisitamente formativa della ricerca empirica in educazione dunque,
risemantizza anche la stessa aspirazione alla generalizzazione, a cui ambisce da sempre ogni esito
della ricerca sperimentale in strictu sensu, intesa come sovrano criterio di valutazione del merito di
una attività scientifica sul campo: queste memorie raccolte sono le memorie del Parco del Gargano,
le memorie di Maria, Carmela, Giuseppina, forse non estendibili al di fuori di smagriti confini, ma
anche, proprio perché non generalizzabili, particolarmente significative perché, con l’espressione di
Mounier, sono “ininventariabili”:
“Un’obiezione ricorrente che si muove all’uso delle storie di vita come
metodologia scientifica riguarda soprattutto la misurabilità del dato qualitativo, non
facilmente traducibile in termini numerici statisticamente elaborabili. Opera così una
sorta di “terrorismo metodologico” che mette in guardia di fronte alla scientificità
dell’elemento frammentario, isolato, singolare, non catalogato entro le categorie
predisposte secondo precisi items. Tale atteggiamento di riserva nei confronti di una
metodologia come la storia di vita manifesta in realtà una presunzione di legittimità
per l’unico criterio di riferimento campione: il sacro ètalon fatto di cifre percentuali,
scarti quadratici medi, coefficienti di correlazione. Con quest’ottica si ritiene di
soppesare anche valori e attività, ricompense e problemi, sempre con misure
quantitative. Il problema visto in una simile prospettiva è davvero mal posto, giacché
perpetua una dicotomia che è solo apparente e che produce come effetto immediato la
segmentazione dell’individuo sociale, costretto a perdere la sua fondamentale unità
biologica e comportamentale. La scorporazione del numericamente quantificabile dà
luogo ad un’ipertrofia dell’appariscente, lasciando invece in ombra gli stessi fattori
che tale evidenza superficiale hanno prodotto. In realtà aspetti qualitativi e
31
Cfr.: FORMENTI L., La storia che educa: contesti, metodi, procedure dell’autobiografia educativa, in
Adultità, n. 4/1996. 32
SMORTI A., Costruzione delle storie costruzione di sé, in Adultità, , n. 4/1996, pag. 71 33
GAMELLI I., , A scuola con la propria storia, in Adultità, , n. 4/1996, pag. 125
8
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
quantitativi sono inestricabilmente connessi tra loro, sicché la contrapposizione che
caratterizza l’attuale dibattito metodologico è fasulla...”34
Quale rilevanza ci chiediamo dunque, in termini di governance della ricerca accademica che
oggi più che mai deve rispondere a criteri di internazionalizzazione, può avere una ricerca sì
contestualizzata?
La medesima delle ricerche – e si perdoni l’ardito accostamento – delle ricerche di Bateson
sulla popolazione di Bali: ci sono parti che raccontano qualcosa sul tutto, ambiti dell’umano che ci
erudiscono sull’umano intero, per uguaglianze e per differenze..laddove l’universalizzazione dei
risultati non risiede nella loro possibilità di standardizzazione ma nel riconoscimento di un “umano”
che, ininterrotto, riscontriamo empiricamente nell’universalità di ogni particolare e che ciò è che ci
fa cogliere una laica trascendenza pur nella molteplicità di ogni umana immanenza: e che è il senso
della “ecologia della conoscenza” a cui Bateson ha dedicato una vita intera35
.
E dunque, sostenere la “valenza anche universale del singolare non comporta un
confinamento nel soggettivismo assoluto”36
: poiché persino una biografia soltanto…non racconta
la storia di una sola vita: essa narra infatti, non solo di chi la scrive ma anche di tutte le persone che
chi scrive ha incontrato: poiché “è dal microcosmo che si intravede il macrocosmo”.37
Nella sua creativa analisi metaforica, Stone38
definisce “paracadutisti” i ricercatori – nello
specifico egli si riferisce agli storici - che leggono i fatti alla luce di ipotesi macro e teorie generali e
che dunque, “scendono dalle nuvole e non sempre toccano il suolo”39
; ed altresì, identifica come
“cercatori di tartufi” i ricercatori appassionati del micro, che cercano i particolari e che quindi
“stanno col grugno a terra”40
: a noi piace pensare ad un ricercatore, pedagogista ed educatore, che
sia competente nelle questioni di cielo ed in quelle di terra, che sappia alzare lo sguardo ed, anche,
abbassarlo.
4. ERMENUTICHE: DELLA VERITA’ E DEL METODO
Riflettendo intorno alla ricerca pedagogica condotta col metodo autobiografico, che
configura come così delicati e pregnanti il momento della raccolta dei dati ed il momento della
analisi degli stessi – che, diversamente dalla ricerca nelle scienze naturali, si configurano entrambi
come momento di incontro, di relazione – ci sembra di poter e dover riprendere le osservazioni che
Ricoeur41
ha condiviso a proposito della relazione tra verità e metodo esplicitata da Gadamer42
.
34
Cfr. CIPRIANI R., Introduzione, in ID., a cura di, La metodologia delle storie di vita. Dall’autobiografia alla
life history, Ed. Euroma- La Goliardica, Roma., pp. 24-25
35 Cfr. nota 13.
36 “...Il dato biografico non ha mai in effetti un contenuto solamente personale, ma ha dei punti di aggancio
pure nella comunità locale e nella società più vasta”, CIPRIANI R., op. cit., pag. 21 37
IVI, pag. 26 38
Cfr.: STONE L., The past and the present, Routledge & Kegan; Boston, 1981 39
FERRAROTTI F., L’Italia tra storia e memoria. Appartenenza e identità, Donzelli, Roma, 1998, pag. 48 40
IBIDEM. 41
Cfr.: RICOEUR P., Dal testo all'azione: saggi di ermeneutica, Jaka Book, Milano, 2004 42
GADAMER, H. G. , Verità e metodo , Bompiani, Milano, 1990
9
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
Egli è giunto persino a sostenere che, considerata la visione gadameriana, forse sarebbe stato
più opportuno intitolare l’autorevole saggio “Verità o metodo”: ciò che Ricoeur non accetta è la
contrapposizione tra spiegazione e comprensione che Gadamer pone come autoescludentesi, al
punto tale da ritenere la verità extrametodica, cioè impossibilitata a percorrere le procedure di
metodo che per lui è solo quello delle scienze naturali nella loro accezione forte, propria della
modernità: per Gadamer epistemologia ed ermeneutica sono, pertanto, linguaggi irriducibilmente
diversi, un po’ come linguaggio scientifico e linguaggio narrativo in Bruner43
: due diverse modalità
di accedere al mondo ed a se stessi.
La riflessione intorno alle possibilità di incontro e non di autoesclusione tra verità e metodo
riteniamo assuma una connotazione precipua anche intorno proprio ai discorsi sulla ricerca empirica
in educazione: laddove si risemantizzino problematicisticamente le stesse espressioni di verità e di
metodo.
Laddove allora, la verità non sia religiosamente – nel senso di assolutisticamente – intesa ma
dalle lezioni della postmodernità – da Husserl a Godel - , sia intesa come continua approssimazione,
come processo e non come stato: laddove proprio dalle scienze esatte, e dalla fisica, invero quella
quantistica, abbiamo appreso che perturbazione, flessibilità e mutamento non sono sinonimi di
relativismo ma equivalenti di creatività e vita44
.
Verità fuzzy che non per questo ci rinnovi il peso della caducità e della fugacità e
dell’esistere umano. Verità che proprio nell’imprescindibilità della soggettività sappia
approssimarsi ad una oggettività fatta non di regolarità e leggi ma di condivisione, comunione,
trascendenza nell’immanenza: intersoggettività nell’elaborazione husserliana45
.
E laddove anche il metodo non sia più, cartesianamente, il protocollo deduttivamente
stabilito che diventa programma e procedura standardizzata come una monade inaccessibile
dall’esterno, ove lo scarto dal previsto è errore sia solo deviazione dalla norma, ma laddove la
scientificità sia garantita da un meta metodo : l’interrogazione continua.
Poiché il metodo è antimetodo quando voglia farsi teleologia ed ontologia.
E poiché, a lezione dall’anarchismo metodologico46
, abbiamo appreso che non esiste metodo
in sé che sia garanzia di scientificità..
La garanzia della scienza è la sua procedura di autocorrezione, intesa non tanto e non
soltanto popperianemente ma, anche e soprattutto, come possibilità di autoconoscenza, da parte di
chi ricerca, della propria epistemologia implicta47
, spesso inespressa48
e, dunque, per questo,
pericolosa49
: la soggettività dell’epistemologia imprescindibile di ognuno richiede allora, con le
parole di Bruner, il “prendere coscienza, in primo luogo, del nostro processo di formulazione della
conoscenza, e inoltre di divenire quanto più possibile consci dei valori che sono responsabili del
43
Cfr. BRUNER J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1993, pag. 75. 44
Cfr. bibliografie note 11,12,13 e 14 45
Cfr. HUSSERL E., op. cit 46
Cfr. FEYERABEND P., Dialogo sul metodo, Laterza, Roma- Bari , 1989 47
Cfr.: CERUTI M., Epistemologie implicite, in MASSA R., CERIOLI L., a cura di, Sottobanco. Le dimensioni
nascoste della vita scolastica, Franco Angeli, Milano, 1999 48
Cfr.: POLANYI M., The tacit dimension, Routledge & Kegan Paul, London, 1966
49 Cfr.: FEYERABEND P., op.cit. ; BATESON G., op. cit., 1993
10
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
nostro modo di vedere”50
: riconoscere che poiché anche il metodo, come l’epistemologia di un
ricercatore, è sempre biograficamente connotato, allora a fondamento della competenza
metodologica ne occorre una epistemologica: “pensare i presupposti del pensare”51
.
La verità senza metodo è folle ed il metodo senza la verità è sterile: l’una necessita dell’altro
ed entrambi necessitano della capacità del ricercatore di guardarsi allo specchio, non solo di
guardare fuori: l’aspirazione alla attendibilità e validità della ricerca, dunque, richiederà al
ricercatore l’impegno costante nella metavalutazione dei propri processi cognitivi ed emotivi, delle
proprie modalità di gestione del protocollo e di implementazione delle procedure della ricerca: un
impegnativo self-assestment, insieme al research-assestment.
A tal fine, riprendendo le sollecitazioni di Swartz e Perkins52
, possiamo identificare taluni
passaggi cruciali di meta analisi della ricerca e, soprattutto, del ricercatore:
1. Consapevolezza che si fa un uso tacito delle proprie procedure di pensiero: ove non si sia in
grado di identificare ed esplicitare il proprio stile cognitivo e la propria rappresentazione del
mondo, di se stessi, della propria professione ed anche: dell’oggetto della ricerca, delle
metodologie scelte e delle motivazioni, anche “scientifiche” per le quali esse, e non altre, sono
state scelte;
2. Autoconoscenza di quale tipo di procedura cognitiva ed emotiva si mette in atto in
situazione scientifica;
3. Consapevolezza strategica: ri-conosciute le proprie procedure cognitive ed emotive le si
organizza strategicamente, in modo da trasformarle da “limite” (ove tacite) in “risorsa” (poichè
esplicitate);
4. Consapevolezza riflessiva: il ricercatore non smette mai di fare ricerca innanzitutto su se
stesso, non per delirio narcisistico o per solipsismo ma proprio al fine di poter riconoscere che
in ogni sua analisi/intervento sulla realtà esiste una parte che gli appartiene irriducibilmente e
che riconoscerla – monitorarla e valutarla – è l’unica garanzia di veglia sulla scientificità della
ricerca.
5. FORME DELLA RICERCA SCIENTIFICA: IL DIALOGO ED IL LIBRO, IL TU
E L’IO.
“Feyerabend: Che ci vuoi fare, caro Imre: anche se è possibile esaminare
liberamente le buone idee in lettere, telefonate, fax e conversazioni conviviali, la
forma preferita dagli accademici resta quella del saggio o del libro. E qualsiasi
saggio ha un inizio, un centro e una fine. C'è un'esposizione, uno svolgimento, un
risultato. Dopodiché, l'idea è tanto chiara e ben definita quanto una farfalla morta
nella vetrina del collezionista.
50
BRUNER J., La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, pag. 44
51MORTARI L. Ecologicamente pensando, Unicopli, Milano, 1998, pag, 171
52 Cfr. SWARTZ R.J., PERKINS D.N., Teaching Thinking: Issues and Approaches, Midwest Publications, Pacific Grove,
1990
11
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
Lakatos: Platone pensava che l'abisso tra le idee e la vita potesse essere
attraversato dal ponte del dialogo — non il dialogo scritto, resoconto superficiale di
eventi passati, ma quello vivo, tra persone provenienti dalle esperienze più diverse.
Un dialogo è più rivelatore di un saggio: mostra gli effetti delle argomentazioni sia
sui profani sia sugli esperti, rende esplicita la vaghezza delle conclusioni...
Feyerabend: ... e, ciò che più conta, può indicarci la natura chimerica di
quelle che noi crediamo siano le parti più solide della nostra esistenza. Con questo
siamo già in argomento: vorrei parlare dell'abisso tra le varie immagini della scienza
e la "cosa reale". Osservando il distacco tra realtà scientifica e "castelli in aria"
epistemologici, non riesco a evitare l'impressione che questi ultimi abbiano qualcosa
in comune con le malattie mentali: un carattere di tali disturbi è la tendenza del
malato a staccarsi sempre più dalla realtà.”53
Il dialogo colma l’abisso tra le idee e la vita: la scelta autobiografica per colmare lo iato tra
ricerca teoretica e mondo empirico.
L’approccio biografico è, per antonomasia, metodologia di ricerca scientifica fondata sul
dialogo e sull’apologia, anziché sulla negazione, dell’idiografico, del micro, del soggettivo: poiché
esso
“implica uno statuto epistemologico all’interno del quale la soggettività non è un
elemento da neutralizzare a vantaggio dell’oggettività, ma nel quale, piuttosto, la
soggettività e l’intersoggettività sono le categorie dalle quali partire nel processo di
comprensione e di intervento rispetto all’esperienza e all’esperire”.54
“Il condizionamento esercitato dal ricercatore su colui che osserva non è una novità.
Al contrario, l’ “effetto ricercatore” è fonte delle maggiori difficoltà epistemologiche
delle scienze sociali. E del resto anche le scienze della natura non ne sono del tutto
immuni. Tuttavia – eco l’elemento di novità - nel metodo biografico l’intersoggettività
permea a tal punto i dati raccolti da dissolversi in quanto problema. essa non è più un
ostacolo, ma il locus della conoscenza.
Risiede qui la “specificità” dei materiali biografici: nell’impossibilità di mantenersi
nemmeno idealmente fedeli alle prescrizioni di un metodo scientifico fondato sul
concetto classico di oggettività”.55
Le interviste biografiche sono eventi autobiografici: eventi che sono relazioni, relazioni che
a paso doble di parole e di gesti e di sguardi dimostrano quanto teorizzato dalla Ong56
: l'oralità non
produce meramente testi ma vere e proprie perfomances e, dunque, con esse, transazioni simboliche
e corporee, slatentizza e comunica significati, visioni del mondo, epistemologie, emozioni e vissuti.
53
MOTTERLINI M., a cura di, Sull’orlo della scienza. Imre Lakatos, Paul K. : Pro e contro il metodo, Cortina,
Milano, 1995 54
GRANA M.,La presenza assente. La produzione di significati nella relazione educativa., in “Animazione
Sociale”, n. 12/1996, pag. 360. 55
C. CORRADI, Storie di vita: intersoggetività in prassi, in: CIPRIANI R., a cura di, op. cit., pag. 203. Corsivi,
tranne l’ultimo, nostri 56
Cfr. ONG W., Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna 1986
12
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
Per tali ragioni, il ricercatore biografo, che sul campo ascolta e raccoglie i racconti, le storie,
le narrazioni, configura la sua professionalità anche come quella di chi deve ineluttabilmente
formarsi al divenir “esperto di parole”: parole che suscitano altre parole oltre a se stesse, parole
creatrici, feconde, floride. Competenza che noi riconosciamo come decisiva per l’educatore come
per il ricercatore in pedagogia:
“ questo spazio di parole (uno spazio locutivo continuo anche nel silenzio, nell’esercizio
interiore della parola) è il più profondo (e appunto antico) ambito pedagogico che si conosca” 57
.
Laddove però, l’essere esperto di parola non si identifichi con l’incapacità di silenzio ma,
anzi, tratteggi un pattern di competenze che sono, scrupolosamente, le medesime che la Sclavi
identifica come quelle proprie dell’ascolto58
e che è possibile riassumere in una sola macro-
metacompetenza: saper uscire dalle proprie cornici:
“Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili”
Marianella Sclavi59
6. OGNI CONOSCENZA È RELAZIONE. OGNI RICERCA È UN INCONTRO.
“Non intratur in veritate nisi per charitatem”
S. Agostino
Alla luce di tali assunti di base, possiamo dunque, in sintesi, così delineare i tratti salienti
delle procedure di ricerca implementate ed ergo, le crucialità individuate nella formazione offerta ai
giovani ricercatori rilevatori sul campo:
1. Implicazione: La consapevolezza della imprescindibilità della
relazione tra intervistatori ed intervistati e delle sue ricadute in termini
epistemologici (costruttivismo, fenomenologia, interazionismo simbolico) e
metodologici (monitoraggio continuo, team feedback, supervisione costante delle
procedure e dei processi attributivi);
2. Opzione per l’eccezione: attenzione e presa in carico dello studio degli
aspetti micro, idiografici, connotati da dimensioni di significato individuale a
culturale, dalle connotazioni cognitive ed emotive, di contro alla ricerca di
generalizzazioni totalizzanti e di regole-formule-paradigmi ipostatizzati:
predilezione per l’Ininventariabile (Mounier) vs la media ed il calcolo statistico;
3. Ricerca come relazione: l’analisi, lo sguardo, la
“misura”/interpretazione della realtà, come anche da conforto proprio della fisica
quantistica, implica una relazione: affinché, dunque, la chimica delle soggettività
non infici l’attendibilità della ricerca, imprescindibile la formazione dei
57
DEMETRIO D., L’accanimento educativo, in Animazione Sociale, 1996, n.3, pp. 15-16 58 SCLAVI M., Arte di ascoltare e mondi possibili : come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Le vespe,
Pescara, 2000
59 IVI, pag. 115
13
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
ricercatori all'ascolto inteso come esercizio di decentramento (Pinto);
4. Monitoraggio e valutazione delle epistemologie: di chi conosce, non
solo di chi è conosciuto.
Queste le core skills del ricercatore che ci permettono di sottolineare l’isomorfismo
peculiare tra formazione degli educatori e la formazione dei ricercatori in educazione: come già
altrove ribadivamo, non sono i primi esperti di azione ed i secondi esperti di teoria, e, soprattutto,
non sono i primi meri fruitori ed i secondi produttori di conoscenza che gli altri debbono
implementare. Un ricercatore in pedagogia non può sottrarsi al compito – epistemologico,
metodologico, etico – di ritenersi in primis, e contestualmente, educatore, coltivando la teleologia
propria del suo essere esperto di scienze dell’educazione; analogamente riteniamo che ogni
educatore dovrebbe apprendere del ricercatore habitus e modus, poiché il senso dell’educazione
stesso trova nella ricerca – teoretica ed empirica – metafora e metodo del suo fine ultimo:
interrogarsi, problematizzare, sostenere l’inquietudine e la crisi non come errore/distorsione da far
rientrare, ma come unica possibilità reale di apprendimento60
.
6.1. COMPETENZE DEL RICERCATORE DEBOLE
“Una volta istituita la professione di “psicologo”, sembra sia stato necessario trovare dei
modi di vedere le persone che permettessero di mantenere una soddisfacente differenza tra lo
psicologo di professione e il suo oggetto di studio, “l’organismo” .
Ma se vogliamo salire in cattedra per fare generalizzazioni sul comportamento dell’uomo,
allora tali generalizzazioni dovrebbero spiegare chiaramente il comportamento di
salire in cattedra per fare generalizzazioni sul comportamento dell’uomo”
Donald Bannister, Fay Fransella61
L’opzione costruttivistica ci rende consapevoli del limite a cui ogni conoscenza e, dunque,
ogni ricerca approda. Il carattere micro, la prelazione - antropologicamente e pedagogicamente
orientata - per la situazionalità ci rende edotti circa l’ impossibilità di credere ed affermare che i
risultati della nostra analisi corrispondano alla chiave di lettura unica, univoca ed esaustiva del reale
indagato, svincolandoci dalla presunzione di averne eliminato o ridotto l'intrinseca opacità. La
consapevolezza problematicista ci guida e ci indirizza nel controllo della iperdilatazione dell'io del
ricercatore62
e ci permette di caratterizzare gli esiti della nostra indagine con uno dei contrassegni
precipui della scienza post.-moderna: l'umiltà della “doppia ermeneutica”63
che pone costantemente
in discussione non solo l'oggetto di studio ma il ricercatore stesso, in un ininterrotto ed in
interrompibile processo di riflessività e meta analisi dei prodotti così come dei processi, e che così
promuove nel ricercatore la maieutica del Sé , per apprendere a guadarsi non solo “ intorno”64 ma,
60 Cfr. BATESON G., FOERSTER H.VON.
61 BANNISTER D. , FRANSELLA F., op cit., pp. 21-22
62 Cfr. GEERTZ C., Opere e vite. L'antropologo come autore, Il Mulino, Bologna, 1990
63 Cfr. MELUCCI A., op. cit.
64 DAL LAGO A., DE BIASI R., a cura di, op. cit., pag. XII
14
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
anche, dentro, nell’ottica di quella auto-eco-conoscenza auspicata da Morin65
e nella
consapevolezza d’avere nel probabile, plausibile, possibile l’unica certezza:
“L’etica dell’essere indebolito è un’etica ecologica”66
.
6.2. UN MODELLO DI COMPETENZE PER IL RICERCATORE EMPIRICO IN
PEDAGOGIA
Thomas67
ha elaborato nel 2004 un quadro delle competenze strategiche ed imprescindibili
per qualificare l’efficacia dei ricercatori nel campo del management: benché fin’ora questo saggio
abbia tratto ispiratori piuttosto nel campo del teoretico, riteniamo che in linea con le medesime
ispirazioni, la check list che qualifica il management, che mescola conoscenze, capacità ed abilità di
livello teorico ed empirico, possa qualificare anche la ricerca empirica in educazione, laddove però,
noi la si legga come l’elenco dei requisiti necessari ma non sufficienti per il ricercatore in
pedagogia:
REQUISITI DI CONOSCENZA, CAPACITÀ E ABILITÀ DEI RICERCATORI EFFICACI68
Fonte: Thomas, 2004
• Conoscenza della specifica area tematica o disciplina
• Conoscenza degli argomenti di aree/ discipline collegate
• Consapevolezza dei problemi epistemologici
• Abilità di ricerca bibliografica
• Conoscenza delle strategie di impostazione e progettazione della ricerca e
capacità di applicarle
• Conoscenza dei metodi per ottenere dati qualitativi
• Conoscenza dei metodi per ottenere dati quantitativi
• Abilità nell’ottenere dati qualitativi
• Abilità nell’ottenere dati quantitativi
• Capacità di comprendere e applicare le tecniche di analisi qualitativa
• Capacità di comprendere e applicare le tecniche di analisi quantitativa
• Abilità di redazione dei testi: scrittura, sintesi, gestione dei testi
• Capacità retoriche: come creare un’argomentazione logica e persuasiva
• Abilità di presentazione orale
• Capacità di utilizzo del computer
• Capacità di pianificazione e gestione del tempo
• Capacità di lavorare efficacemente con un supervisore
• Capacità di ottenere collaborazione e sostegno da colleghi, soggetti di ricerca e
altre persone
65
MORIN E., Auto-eco-conoscenza, in CERUTI M., PRETA L., a cura di, Che cos’è la conoscenza, Laterza,
Roma-Bari, 1990 66
PRETA L., Prefazione, in CERUTI M., PRETA L.a cura di, op. cit., pag. XIV 67 THOMAS A. B., Research Skills for Management Studies, Routledge, London, 2004 68 Rielaborazione dalla traduzione italiana di G. Rebora, in : REBORA G., Ricerca senza qualità? Il caso delle
scienze aziendali e dal management, in “Liuc Papers” n. 209, Serie Economia aziendale 31, novembre 2007
15
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
• Capacità di inserirsi in reti di relazioni e sviluppare contatti
• Consapevolezza degli standard: cosa determina la buona o cattiva qualità della
ricerca
• Capacità auto-critica (ma senza auto-paralizzarsi)
• Consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza
• Abilità creativa, originalità, innovatività
• Resilienza emotiva: abilità di sostenere alti e bassi di motivazione e morale
• Resistenza: abilità di reggere l’impegno per periodi lunghi
• Abilità di problem solving,
A queste ci permettiamo di aggiungere, alla luce delle argomentazione sin qui addotte, le
seguenti altre:
• Conoscenza del dibattito sul Metodo in Filosofia della Scienza
• Conoscenza degli interstizi epistemici tra la propria disciplina ed anche quelle di
area non attigua
• Capacità di change management
• Capacità di crisis management
• Competenze comunicative e relazionali: ascolto, empatia, discrezione
• Competenze cognitive: analisi, sintesi, precisione, rigore
• Competenze meta cognitive: riflessività, decentramento, flessibilità
• Competenze educative: intenzionalità, progettualità, valutazione
A fondamento di questo pattern, l’identità salda e chiara intorno ad una opzione pedagogica
intesa come consocenza che muove all’azione, la chiara specificità della ricerca emirica in
pedagogia, che non mira alla mera analisi, né è mai paga della sola descrizione dell’umano :
“Il discorso pedagogico e quello sperimentale appaiono antitetici se si
accostano in modo superficiale. Il primo intende infatti avvalorare l’originalità e
l’unità dinamica differenziata della presenza; il secondo cerca invece di cogliere le
regolarità ed i principi generali sottesi alla varietà delle condotte e delle relazioni
umane. E’ compito della ricerca educativa superare tale dicotomia con uno sforzo
incessante di sintesi, per evitare che la scienza dell’educazione si riduca da un lato a un
discorso su modelli formativi astratti e, dall’altro, ad un empirismo di pratiche
disordinate.”
Renata Viganò
E, dunque, l’Autrice propone d’intendere la ricerca educativa “come domanda di senso
prima ancora che di conoscenza”69
: domande di senso intorno all’uomo, all’educazione, alla
conoscenza della realtà ma anche domande di senso intorno alla ricerca stessa: esprit non
esprimibile e riducibile in qualsivoglia check list o tabella, di cui, dunque, non neghiamo la
parzialità.
Esprit che corrisponde ad una risemantizzazione della scientificità stessa, batesonianamente
ispirata e che, così, si ritrovi nella apparente non-scientificità dell’esortazione di March che,
69
VIGANÒ R., Pedagogia e sperimentazione. metodi e strumenti per la ricerca educativa, Vita e Pensiero,
Milano, 1995, pag. 286
16
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
riflettendo intorno alla revisione degli obiettivi della ricerca accademica, che egli ritiene spesso
mediocre e, soprattutto, inutile, sostiene che, nel riconoscere di non poter prevedere il futuro e
governare il presente individuando regole e regolarità da standardizzare a scopo assicurativo, i
ricercatori debbano dunque apprendere a produrre piccoli frammenti di conoscenza, pezzi di un
mosaico che però, siano di qualità: qualità che egli connota ben diversamente rispetto agli standard
della quantofrenia di ispirazione laplaciana, definendo una buona ricerca come caratterizzata da :
“bellezza, rigore, persistenza, competenza, eleganza e grazia”70
James G. March
Nella medesima ottica, la proposta di una formazione dei ricercatori che sia salda
nell’epistemologia come nella metodologia e che, anche, offra la costruzione di meta competenze
(l’esprit di cui sopra) orientate ad una visione complessa della realtà, della ricerca e del ricercatore,
è orientata a superare il rischio della riduzione del ricercatore a semplice specialista, o meglio,
“iperspecialista”, così nelle parole di Chargaff, biochimico austriaco le cui ricerche sono state
fondamentali nella determinazione della struttura del DNA71
:
“poco dopo la fondazione delle scienze pure ci fu dato in dono lo specialista.
Ciascuno riceve una chiavetta d’accesso a un minuscolo ripostiglio in cantina, dove,
così gli dicono, troverà tutto quello che è necessario, per svolgere le sue ricerche. Se,
al momento in cui va via, il ripostiglio è un po’ più ingombro di prima, è un
grand’uomo (..)
Siamo così giunti all’assurdità per cui l’unica cosa profonda in una ricerca
siffatta è la tecnica. (…) si potrebbe quasi dire che oggi non ci sono più ricercatori ma
soltanto specialisti. Specialista è colui che ha ottenuto il permesso di trovare ciò che
cerca”.
Erwin Chargaff
7. “UN BUON FILOSOFO E’ ANCHE UN BUON CALZOLAIO” (ORAZIO)
OVVERO: LA PROFESSIONALITA’ DEL RICERCATORE 72
Ci sembra che la ricerca implementata abbia permesso di raggiungere una delle precipue
finalità della ricerca empirica in educazione: coniugare la teoria e la pratica, “riconciliare” il “luogo
della teoria” – L’Accademia, l’Università, il locus della Ricerca – e il “luogo della vita” – la
memoria viva e vissuta ed agita del Parco, locus della Azione -. Ma, soprattutto, ciò che di stra-
ordinario essa ha consentito, è che in essa la produzione di teoria e teorie non è avvenuta
nell’Accademia, non è stata opera degli accademici che poi l’hanno condivisa all’esterno ma ha
70
MARCH J.G., Explorations in organization, Stanford University Press, Stanford, CA, 2008, pag. 379.
Traduzione della sottoscritta. 71
CHARGAFF E., Mistero impenetrabile. La scienza come lotta pro e contro la natura, Scrinium, Catania, 1995,
pag. 184 72
Il titolo del paragrafo si ispira al titolo di un volume di Donata Fabbri, ove l'Autrice utilizza l’ aforisma
oraziano per caratterizzare la competenza del saper coniugare pensiero ed azioni propria dell’educatore: analogamente
qui si è cercato di argomentare quanto la medesima competenza sia fondamentale anche per un ricercatore. Cfr.: FABBRI
D., Un buon filosofo è anche un buon calzolaio (Orazio) ovvero: la professionalità dell’educatore, Quaderni di
aggiornamento n.4, Comune di Carpi – Assessorato alla pubblica istruzione, Carpi, 1990
17
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
altresì, seguito il movimento inverso: gli anziani del Parco sono stati produttori di teoria, narratori
e, dunque, epistemologi, a cui è stata riconosciuta dignità gnoseologica.
Epistemologo lo è ogni essere umano73
: ma di molte epistemologie si perde traccia,
memoria, persino ontologia, se esse restano inespresse, talora persino a chi le possiede, e non
legittimate.
L’ evento della ricerca vissuta ha allora permesso di non disperdere preziosi saperi che
altrimenti - non essendo mai prima d’ora trascritti - sarebbero forse diventati silenti perdendo i loro
narratori. Ma, soprattutto, l’evento della ricerca-dialogo-incontro si è trasformato in
apprendimento: per gli intervistatori e per gli intervistati. E per gli analisti-ermeneuti dei dati
raccolti. E’ stato monito e sollecitazione. Come ogni ricerca empirica in educazione: ci esorta a non
dimenticare che in quanto ricercatori dell'umano, abbiamo una responsabilità, che è sempre
educativa, nella misura in cui ad ogni nostra azione corrisponde un effetto e, insieme, un'aspettativa.
Come scriveva Bateson: poiché ci occupiamo di sistemi viventi… individualmente e
collettivamente abbiamo
“la responsabilità di un sogno, che è poi il modo di porsi di fronte alla domanda: “Che
cos’è un uomo, che può conoscere i sistemi viventi e agire su di essi, e che cosa sono questi sistemi
viventi che possono essere conosciuti?”74
E, dunque, questo sogno e questa responsabilità ci chiamano e ci implicano in quanto attori,
filosofi e calzolai, non solo pensatori e scrittori accademici, la cui qualità della ricerca possa essere
valutata non soltanto ingegneristicamente – come è ormai guisa contemporanea - ma anche e
soprattutto nella misura in cui l’Università incontri la quotidianità e la ricerca si imbatta nella vita.
E i ricercatori, di qualsivoglia settore disciplinare, possano essere “misurati” non soltanto
con la “vis compulsiva della quantità”75
: numeri, impact factor delle loro pubblicazioni ed
indicatori di efficienza delle loro performance; ma, innanzitutto, nella misura in cui essi possano
dirsi “esperti dell’umano”76
.
“Mi piacerebbe che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a oltranza su un punto:
ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o
neutro, o nocivo. (...) Non nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza neutra: sei
abbastanza dotto da saper valutare se dall'uovo che stai covando sguscerà una colomba
o un cobra o una chimera o magari nulla”.77
Primo Levi
73
Come da bibliografia costruttivista citata in nota 11, alla quale ci permettiamo di aggiungere i riferimenti
presenti nella bibliografia finale, con particolare riferimento alle opere di Bruner ed al volume di Bannister e Fransella. 74
BATESON G., BATESON M. C., op. cit., pag. 272 75
COLOMBIS A., op. cit., pag, 216 76
L’espressione si ispira al titolo di un articolo della Ducci, cfr. DUCCI E., I veri educatori: esperti del sacro e
dell'umano, in: Jesus, n.12/1996, pag. 85
77 LEVI P., Per non covare il cobra, in ID., Opere, Einaudi, Torino, 1984, pag. 993.
18
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
BIBLIOGRAFIA
ATLAN H., Complessità disordine e autocreazione di significato, in BOCCHI G.L., CERUTI M., op. cit;
BALDACCI M., Il problematicismo. Dalla filosofia dell'educazione alla pedagogia come scienza , Milella, Lecce, 2003
BALDASSARRE V. A., DI GREGORIO L., SCARDICCHIO A.C., La Vita come Paradigma, Ed. Dal Sud, Modugno, Bari,
1999
BANNISTER D., FRANSELLA F., L’uomo ricercatore. Introduzione alla psicologia dei costrutti personali, Psycho,
Firenze, 1986
BATESON G., G., Mente e Natura, Adelphi, Milano, 1984
BATESON G., BATESON M. C., Dove Gli Angeli Esitano. Adelphi, Milano, 1989
BATESON G., Verso Un’ Ecologia della Mente, Adelphi, Milano, 1993
BATESON G., Una Sacra Unità. Altri passi verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1997
BERGER P.L., LUCKMANN T., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969
BERTALANFFY L. VON., Teoria Generale dei Sistemi, ISEDI, Milano, 1971
BERTALANFFY L. VON, Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, Mondadori, Milano, 2004
BERTO F., Logica da zero a Gödel, Laterza, Roma-Bari, 2007
BERTOLDI F., Ipotesi epistemologiche sulla sperimentazione, in “Pedagogia e vita”, n.3/1994
BOCCHI G.L., CERUTI M., a cura di, La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1985
BOHR N., I quanti e la vita, Bollati Boringhieri, Torino, 1984
BRUNER J., La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1990
BRUNER J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1993
CECCATO S., Cibernetica per tutti, voll. I-II, Feltrinelli, Milano, 1968, 1970
CERUTI M., La danza che crea. Evoluzione e cognizione nell'epistemologia genetica, Feltrinelli, Milano, 1989
CERUTI M., PRETA L., a cura di, Che cos’è la conoscenza, Laterza, Roma-Bari, 1990
CERUTI M., Epistemologie implicite, in MASSA R., CERIOLI L., op. cit
CERUTI M., a cura di, Evoluzione e conoscenza, Lubrina, Bergamo, 1992
CHARGAFF E., Mistero impenetrabile. La scienza come lotta pro e contro la natura, Scrinium, Catania, 1995
CIPOLLA C., DE LILLO A., Il sociologo e le sirene. La sfida dei metodi qualitativi, Franco Angeli, Milano, 1996
CIPRIANI R., a cura di, La metodologia delle storie di vita. Dall’autobiografia alla life history, Ed. Euroma- La
Goliardica, Roma.
COLOMBIS A., Fuori dal mito: la sociologia “qualitativa” è una forma della mente, in CIPOLLA C., DE LILLO A., op. cit.
CORRADI C., Storie di vita: intersoggettività in prassi, in: CIPRIANI R., a cura di, op. cit.,
DAL LAGO A., DE BIASI R., a cura di, Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale, Laterza, Roma-Bari, 2002
DEMETRIO D., L’accanimento educativo, in Animazione Sociale, n.3/1996
DESCARTES R., Discorso sul metodo, Mondadori, Milano, 1993
DUCCI E., I veri educatori: esperti del sacro e dell'umano, in “Jesus”, n.12/1992
FABBRI D., Un buon filosofo è anche un buon calzolaio (Orazio) ovvero: la professionalità dell’educatore, Quaderni di
aggiornamento n.4, Comune di Carpi – Assessorato alla pubblica istruzione, Carpi, 1990
FERRAROTTI F., L’Italia tra storia e memoria. Appartenenza e identità, Donzelli, Roma, 1998
FEYERABEND P., I limiti della ragione, Il Saggiatore, Milano, 1983
FOERSTER H.VON, Cibernetica ed epistemologia: storia e prospettive, in BOCCHI G.L., CERUTI M., op. cit.
FOERSTER H.VON, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma, 1987
FEYERABEND P., Dialogo sul metodo, Laterza, Roma- Bari , 1989
FORMENTI L., La storia che educa: contesti, metodi, procedure dell’autobiografia educativa, in Adultità, n. 4/1996.
FORMENTI L., La formazione autobiografica. Confronti fra modelli e riflessioni tra teoria e prassi,
Guerini Scientifica, Milano, 2000
FORMENTI L., GAMELLI I., Quella volta che ho imparato, Raffaello Cortina, Milano, 1998
FRABBONI F., PINTO MINERVA F., Manuale di pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari 2002
FRABBONI F., WALLNÖFER G., La pedagogia tra sfide e utopie, Franco Angeli, Milano, 2009
GADAMER, H. G. , Verità e metodo , Bompiani, Milano, 1990
GILMORE R., Alice nel paese dei quanti. Le avventure della fisica, Raffaello Cortina, Milano, 1996
GILMORE R., Il quanto di Natale. Esplorando con Dickens i misteri della fisica, Raffaello Cortina, Milano, 1999
CAVALLINI G., La costruzione probabilistica della realtà, CUEN, Napoli, 2001
GLASERSFELD E. VON, Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning, The Falmer Press , London &
Washington , 1995
GLEICK J., Caos, Sansoni, Milano, 1997
GRANA M., La presenza assente. La produzione di significati nella relazione educativa, in “Animazione Sociale”, n.
12/1996
19
1. SCARDICCHIO A.C. (2011), La formazione dei ricercatori. Tra metodo, debolezza e passione, in PINTO F., a cura di, La memoria del parco. Il parco della memoria, BARI: Progedit (ITALY)
HANSON N.R., I modelli della scoperta scientifica. Ricerca sui fondamenti concettuali della scienza, Feltrinelli, Milano,
1978
HOFSTADTER D.R. , Godel, Escher, Bach: un'Eterna Ghirlanda Brillante , Adelphi, Milano, 1984
HUSSERL E., Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie, ediz. postuma, a
cura di W. Biemel, Den Haag, M. Nijhoff, 1954
KELLY G., La psicologia dei costrutti personali, Raffaello Cortina, Milano 200
KOSKO B., Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Baldini & Castoldi, Milano, 2000
KUHN T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1962
KUHN T., La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza , Einaudi, Torino, 1985
LINDLEY D., Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di indeterminazione, Einaudi, Torino, 2007
LINDLEY D., Incertezza. Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di indeterminazione, Einaudi, Torino, 2008
MACCONE L., SALASNICH L., Fisica moderna. Meccanica quantistica, caos e sistemi complessi , Carocci, Roma, 2008
LUDOVICO A., Effetto Heisenberg. La rivoluzione scientifica che ha cambiato la storia, Armando, Roma, 2001
MANGHI S. a cura di, Attraverso Bateson. Ecologia della mente e relazioni sociali. Con un lavoro inedito di Gregory
Bateson, Raffaello Cortina, Milano 1998
MANGHI S., La conoscenza ecologica. Attualità di Gregory Bateson, Raffaello Cortina, Milano, 2004
MARCH J.G., Explorations in organization, Stanford University Press, Stanford, CA, 2008
MARRADI A., Concetti e metodo per la ricerca sociale, La Giuntina, Firenze 1995
MASSA R., CERIOLI L., a cura di, Sottobanco. Le dimensioni nascoste della vita scolastica, Franco Angeli, Milano, 1999
MATURANA H., VARELA F., Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia, 1985
MATURANA H., VARELA F., Macchine ed esseri viventi. L'autopoiesi e l'organizzazione biologica, Astrolabio, Roma,
1992
MATURANA H., VARELA F., The tree of knowledge, New Science Library, Boston, 1985
MELUCCI A., Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura, Il Mulino, Bologna, 1998
MORIN E., Il Metodo, Feltrinelli, Milano, 1984
MORIN E., Auto-eco-conoscenza, in CERUTI M., PRETA L., op. cit.
MORIN E., Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano, 1993
MORTARI L. Ecologicamente pensando, Unicopli, Milano, 1998
MOTTERLINI M., a cura di, Sull’orlo della scienza. Imre Lakatos, Paul K. Feyerabend: Pro e contro il metodo, Cortina,
Milano, 1995
ONG W., Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna, 1986
PIATTELLI PALMARINI M., a cura di, Livelli di realtà, Feltrinelli, Milano, 1984
POLANYI M., La conoscenza personale. Verso una filosofia post-critica, Rusconi Libri, 1990.
POLANYI M., The tacit dimension, Routledge & Kegan Paul, London, 1966
PRIGOGINE I., Le leggi del caos, Laterza, Roma-Bari 1994
REBORA G., Ricerca senza qualità? Il caso delle scienze aziendali e dal management, in “Liuc Papers” n. 209/207
RICOEUR P., Dal testo all'azione: saggi di ermeneutica, Jaka Book, Milano, 2004
SCARDICCHIO A. C., Interrogarsi sul metodo. Implicazioni epistemiche e prassiche, in RESTA P., a cura di, Il vantaggio
dell'immigrazione. Un progetto per una cultura condivisa, Armando, ROMA, 2008
SCARDICCHIO A.C., Elogio della Ragion Pratica (debole), in BALDASSARRE V. A., DI GREGORIO L., SCARDICCHIO A.C.,
1999
SCARDICCHIO A.C., NONSOLOMETODO: "Ogni ricerca è un incontro" , in BALDASSARRE V. A., DI GREGORIO L.,
SCARDICCHIO A.C., 1999
SCLAVI M., Arte di ascoltare e mondi possibili : come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Le vespe, Pescara, 2000
SWARTZ R.J., PERKINS D.N., Teaching Thinking: Issues and Approaches, Midwest Publications, Pacific Grove, 1990
STONE L., The past and the present, Routledge & Kegan; Boston, 1981
STROLLO M.R., Prospettiva sistemica e modelli di formazione, Liguori, Napoli, 2003
THOMAS A. B., Research Skills for Management Studies, Routledge, London, 2004
TURNER V., Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna
VARELA F. J. THOMPSON E. , ROSCH, E., La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova
dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1992
VERONESI M. , VISIOLI A., Logica Fuzzy. Fondamenti teorici e applicazioni pratiche, Franco Angeli, Milano, 2004
VIGANÒ R., Pedagogia e sperimentazione. metodi e strumenti per la ricerca educativa, Vita e Pensiero, Milano, 1995
WATZLAWICK P., La realtà della realtà, Astrolabio, Roma, 1976
WIENER N., Introduzione alla Cibernetica, Boringhieri, Torino, 1961