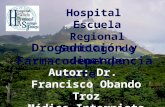FORMAZIONE CLINICA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Transcript of FORMAZIONE CLINICA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
FORMAZIONE CLINICA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Il progetto formativo del corso
Regione Lombardia pubblica un bando per corsi IFTS (Istruzione eFormazione Tecnica Superiore). Ente di Formazione Galdus proponeun progetto formativo che diviene un corso di Tecnico superioreper la selezione e lo sviluppo delle risorse umane a cuipartecipano la bicocca, un istituto commerciale, varie cooperativee associazioni del privato sociale.
Formazione tecnica e formazione clinica
Il progetto era interessante in quanto si doveva progettare unpercorso di formazione clinica da integrare in un progetto cheformasse la competenza professionale di una figura di tecnicodelle risorse umane. Questo progetto quindi avrebbe dovuto fardialogare dimensioni di formazione tecnica specifica ed elementidi formazione clinica.
La formazione clinica è stata la scelta ideale per più motivi:- non trasmette conoscenze e/o competenze, ma promuove la
rielaborazione della propria esperienza in modo che questadivenga testo di apprendimento e cioè nuova conoscenza equindi competenza.
- Tecnico delle risorse umane deve avere competenze relativealle relazioni, alla comprensione degli individui e deicontesti organizzativi
- Si occupa di sviluppare la consapevolezza di sé e del proprioruolo professionale e da la possibilità di interpretare isignificati interni ai gesti e alle procedure con cui siesplica il ruolo professionale.
La CdF, che è formazione sulla formazione (2° livello) promuove unatteggiamento di rielaborazione dell’esperienza formativa e latrasforma in possibilità di nuovo apprendimento. Il percorso con questo gruppo ha lavorato alla produzione diimmagini e modelli latenti della formazione, e si è creato unluogo di supervisione clinica cioè luogo in cui condividere edelaborare in gruppo la storia, le evoluzioni e gli apprendimentidel gruppo stesso.
La struttura e l’articolazione del testo1
La CdF ha uno sguardo polivalente e attento a vedere l’eventoformativo come una realtà che si trasforma continuamente e cheintercetta il bisogno di espandere la dimensione del senso comeoccasione che la formazione ha di parlare attraverso lerappresentazioni di chi la vive e di chi la fa.
La clinica è un contesto di ricerca trans-disciplinare e inter-culturale.
- Transdisciplinare perché ricorrendo a sguardi disciplinari“altri” è possibile rideclinare lo sguardo pedagogico comeuno sguardo obliquo, che arrivi al “centro” solo sostandonelle periferie, cioè nelle aree interstiziali.
- Interculturale perché valorizza la cultura individuale qualepatrimonio dell’esperienza unico ed irripetibile.L’esperienza deve infatti sempre connettersi alla teoria pernon salvaguardare l’autenticità.
IL PERCORSO DI CLINICA:Sguardi sull’esperienza e immagini dalla formazione
(Rezzara)
1.L’approccio clinico alla formazione
La formazione clinica si qualifica per alcuni aspettifondamentali:
1) Formatore è regista dei setting di formazione eaccompagnatore dei processi di apprendimento.
2) Al centro dell’azione formativa c’è da parte del formando unalettura, una comprensione e un’elaborazione della realtà.L’oggetto della ricerca della CdF è l’esperienzaprofessionale su cui ricadrà la conoscenza prodotta dallaformazione.
3) Carattere locale della CdF: cioè il sapere che scaturiscedalla formazione clinica è un sapere locale (non universale)cioè che nasce e si alimenta nelle particolari condizioni edesperienze di cui siamo protagonisti. Il formatore deve sapere individuare la particolareconfigurazione di un evento, coglierne gli impliciti, erileggere e rielaborare quella situazione. Apprendere significa in questo caso penetrare i significatiche quella situazione ha per quei protagonisti.
4) E’ attività interpretatativa: che non significa applicare uncorpo di saperi ai fenomeni osservati, ma interrogarsi sui
2
possibili significati di essi, cioè aprire nuovi modi divedere e di sentire.
5) Dimensione relazionale e interattiva nei processi dicostruzione di sapere e di competenze. La destrutturazione eristrutturazione delle proprie visioni promosse dall’incontrocon visioni altre, sono le risorse attraverso cui si accedead una comprensione più articolata e profonda.
La CdF si propone di trasformare l’esperienza vissuta in nuovaconoscenza; sono importanti capacità di esplorazione, lettura,interpretazione e apertura a nuove possibilità.
La scoperta e la comprensione sono la premessa più efficacedell’apprendimento autentico e della possibilità di cambiare larealtà. Chi si forma così è portato a conoscere i propri e altruimodelli di pensiero, a riflettere sulle situazioni e ad orientarecontinuamente il proprio lavoro non in base a modelli ma allariflessione continua su questi.
La CdF riconosce grande importanza agli aspetti relazionali(confronto, ascolto, scambio, discorso a più voci) e allacomunicazione sia perché è lo strumento di costruzione diconoscenza, sia perché il linguaggio costruisce relazioni.
La CdF si situa nell’intreccio tra dimensione cognitiva eaffettiva dell’esperienza. Inoltre ricompone la distanza tra conoscenza e azione, perchérielabora l’esperienza per ricavare nuove conoscenze.
2. CdF per lo sviluppo delle risorse umane
La CdF si rivolge alla formazione dei formatori, e alleprofessioni che hanno funzioni formative (servizi educativi e dicura) che perseguono il cambiamento delle persone e con lepersone.
La cdf propone loro un itinerario di riflessione critica e dielaborazione dell’esperienza professionale mirata a costruireconsapevolezza in ordine agli impliciti del lavoro, alledimensioni formative sommerse, e all’intreccio della dimensionevitale e professionale che producono quel modo di agire e viverequel tipo di lavoro.
3
Questi operatori dovrebbero avere competenze nel leggere edinterpretare gli intrecci tra individui e organizzazioni, nelcomprendere i motivi profondi dei modelli e delle ottiche cheguidano i comportamenti individuali e di gruppo, e la capacità diesplorare le diverse rappresentazioni della realtà di cui ognuno èportatore.
3. Un percorso per pensare la formazioneLa CdF è:
1.Un nuovo approccio : assume l’istanza di una pedagogiacritica (sguardo interrogante e problematico sull’esperienzaeducativa) sia l’istanza di rispondere all’esigenza peculiaredella pedagogia (equilibrare l’identità teorica e pratica). La CdF rappresenta una direzione di ricerca qualitativa che siesercita nella concreta realtà educativa e afferma il suoobiettivo nell’interrogare e interpretare criticamentel’educazione.
2. Una strategia di costruzione di un nuovo sapere pedagogicoperché ritiene come centrale la tensione conoscitiva einterpretativa dell’esperienza educativa, cioè si china sui fattidell’educazione per decostruirne le trame, per comprenderne lastruttura e apre lo spazio ad ipotesi interpretative da cui nascenuova teoria pedagogica desunta dalla pratica.
3. Una nuova via per progettare e realizzare interventi diformazione dei formatori perché istituisce situazioni formative incui l’esperienza professionale di formazione viene fatta dialogarecon quella personale di formazione e diventa cosi un libro ditesto da cui apprendere sulla formazione, su di se nellaformazione e su ciò che soggiace ed informa il nostro modo diessere e agire sulla scena educativa.
Approccio clinico - (termine deriva da “chinarsi su” e da “letto”e ricorda il gesto del medico e del paziente, rimanda ad una formadi relazione e di processo di conoscenza intima con il paziente,con i segni e i sintomi della sua malattia e della sua sofferenza,ma anche con la sua storia e il suo contesto di vita).
Tra malato e medico si sviluppa un discorso in cui pazienteracconta e medico chiede; poi il medico raccoglie un insieme disegni che interpreta alla luce del suo sapere medico e dellaparticolare situazione del paziente.
4
Il linguaggio del discorso e sia linguaggio verbale (chichiede e chi spiega) sia sguardo che da la possibilità di farpredominare l’ascolto, e il contatto fisico. Fondamentale èl’interpretazione cioè la lettura, decodifica, collocazione etraduzione dentro le categorie di un sapere di riferimento.
La clinica non si pone come obiettivo l’oggettività scientificache non è possibile quando si ha a che fare con le persone. La“verità” della diagnosi è la risultante dell’osservazione rigorosadei dati unita all’interpretazione della stuazione che emerge dalrapporto.
TRATTI DEL METODO CLINICO
1° Rapporto stretto con il caso che viene indagato e l’attenzionealla situazione nel qui ed ora, sospendendo la generalizzazione ela categorizzazione a priori. La teoria viene sospesa solo inizialmente perché poi, dopol’immersione nell’osservazione e nell’ascolto del casoindividuale, si interpretano i segni interrogando la teoria, perattribuire senso a ciò che si è osservato.
2° centralità dell’attività interpretativa, dove perinterpretazione si intende leggere, nominare, decodificare,tradurre, trascrivere, formulare ipotesi di senso, rendereesplicito, portare alla luce, dare consapevolezza, attribuire unsignificato possibile, e ricondurre a teoria. Si parla di modello debole di interpretazione, contrapposto aimodelli forti di altre discipline (psicoanalisi).L’interpretazione in clinica tende ad esplorare, a fare emergere,a offrire letture plurime, non fornendo verità chiuse ma possibilisignifcati.
3° il suo fondarsi su di una relazione tra soggetti e l’assegnareun ruolo essenziale alla comunicazione in particolare quellaverbale. Il “”chinarsi su” apre uno spazio di incontro, didialogo, di scambio.
4° considerare sempre il fenomeno osservato come parte e prodottodi una storia.
5° Sguardo che scende e penetra sotto alla superficie visibile emanifesta delle cose e che tale sguardo scruta ciò che si cela e
5
sta nascosto, ciò che non si offre direttamente all’osservaszione.Il tutto nell’ottica di una sua esplicitazione.
La CdF si propone di istituire un percorso e un setting di lavoro che hanno:
oggetto la formazione, procedura il metodo clinico, strategia di azione il pensare e l’esplorare in gruppo
l’esperienzamodalità conoscitiva apprendimento dall’esperienzascopo acquisizione di consapevolezza,
riflessività sulle proprie praticheformative e sul proprio ruolo di formatore
Presupposti pedagogici di un percorso di CdF:
1. Permettere al formatore di comprendere profondamente il suomodo di essere e di agire nella formazione, di elaborare lesue motivazioni profonde, i propri modelli inconsapevoli, ipropri significati personali e i propri modelli impliciti.
2. Comprendere come si agisce sulla scena formativa consente diriappropriarsi criticamente della propria esperienza e discegliere liberamente, valutare e controllare la propriaazione e di aprirsi all’apprendimento del nuovo, quindi ad unprofondo cambiamento.
3. Ogni processo formativo è guidato oltre che da elementioggettivi di contesto, anche dalle emozioni, dai movimenti diidentificazione e proiezione che si riattivano costantementenella pratica quotidiana di ogni formatore. Queste “latenze” possono essere scoperte tramite un lavoroclinico che dia loro voce e senso e che permetta aiprotagonisti di riconoscerli per riappropriarsi deisignificati più profondi della propria esperienza.
Il senso di un percorso di clinica della fromazione stanell’istituire uno spazio e un tempo in cui pensare la formazione,cioè esplorarne i significati e il suo accadere in un contestolibero dalla preoccupazione operativa (situazione protetta) in cuipoter riflettere sospendendo il giudizio e poter interpretarel’esperienza educativa attraverso un’elaborazione gruppale che hacome principale strumento il linguaggio.
6
La CdF è discorso, pensiero e azione ma è soprattutto il rimandocontinuo tra come è pensata, come è detta e come è agital’esperienza educativa.
4. Il dispositivo formativo
All’interno del progetto si è svolto un percorso di CdF siproponeva come obiettivi:
1. Istituzione di un gruppo di lavoro clinico2. Far sperimentare ai corsisti il setting e il metodo della CdF3. Promuovere un atteggiamento di ricerca e di elaborazione
collettiva della propria ed altrui esperienza.
Era necessario quindi fondare le condizioni per poter parlare diformazione e per poter pensare la formazione a partire dallapropria esperienza e apprendendo da essa.
La prima fase del percorso è stata un lavoro clinico di piccologruppo guidato da due conduttori. Il lavoro è stato di analisi,decostruzione, rielaborazione di vicende formative finalizzato afar emergere e riconoscere schemi di pensiero, immagini e vissutiemotivi, strategie educative, e quindi la struttura pedagogicaprofonda che soggiaceva all’esperienza formativa dei componentidel gruppo.
Si sono alternati momenti di lavoro individuale e gruppale,che nella CdF rispecchiano la particolarità e il caratterecostitutivo.
La circolazione dei significati individuali, il confronto disguardi e le elaborazione dei significati all’interno del gruppo,contengono e mediano le visioni dei singoli e permettono disperimentare una pluralità di comprensione e di interpretazionedella realtà educativa presa in oggetto. Infatti si apprende dall’esperienza perché essa diviene oggetto dianalisi, riflessione, rielaborazione affettiva e cognitiva delprotagonista ma anche del gruppo e ognuno legge e attraversal’esperienza altrui secondo i propri codici.
La richiesta iniziale fatta al gruppo è stata quella dinarrare un episodio della propria esperienza professionale chefosse ricordato come successo o insuccesso.La seconda fase è stata la visione del film “il sapore dell’acqua”(vicenda di trasformazione di un assistente sociale da rigido
7
burocrate ad appassionato educatore di una ragazza ridotta ad unavita animale e segregata in casa.Terza fase ha visto i corsisti impegnati nella rappresentazionedella propria visione del mondo della vita e del mondo dellaformazione con due disegni. Ciò voleva far produrre in un codicesimbolicodel materiale che rendesse visibili e percepibili lerelazioni di continuità e discontinuità, di vicinanza e distanzatra mondo vitale e mondo della formazione per ognuno.L’ultimo compito è stato quello di narrare un episodio ricordatovolentieri o malvolentieri, che fosse riferito alla propriaesperienza educativa personale.
Tutto il materiale prodotto all’interno del gruppo si è addensatoattorno ad alcune immagini ed idee che indicano nucleiparticolarmente significativi della struttura profonda del modoindividuale di rapportarsi alla formazione, cioè dello sguardo cheognuno ha sulla formazione, cioè del suo modo di pensarla,giudicarla, e probabilmente di viverla e gestirla.
Il ruolo dei conduttori in questo percorso è stato difacilitazione, promozione, sostegno dell’espressione individuale,di proposta di compiti e di lavoro, di presidio del lorosvolgimento, di raccolta, mostra e di dare forma ai materialiprodotti, di essere testimoni attivi della possibilità di pensarela valutazione di sospensione dell’atteggiamento valutativo neiconfronti degli altri e di attivazione della riflessione di gruppoe di interpretazione dell’esperienza.
5. Sguardi sull’esperienza formazione
La ricostruzione dei contenuti portati dai corsisti si èorganizzata su 4 aree diverse
1. Che storie sono le storie di formazione?2. Quali idee e quali modelli di formazione le guidano?3. Quali sono gli affetti e le emozioni prevalenti nelle vicende
di formazione?4. Qual è il dispositivo in atto che produce formazione in una
determinata situazione?
1.Rispetto al comprendere quali siano le storie di formazione si ètrattato di cogliere quali siano i contesti, le azioni, losvolgimento, i ruoli, le dinamiche, quale logica processuale estorica possiedano e a quale” genere letterario” appartengano.
8
In CdF tutto ciò è definito LATENZA REFERENZIALE che ci aiutaa comprendere come la formazione si collochi dentro gli scenaristessi della vita, ritagliando però in essa condizioni e assettiparticolari, quelli formativi appunto.
Le storie di formazione sono storie di coppie , centrate sulledimensione duale, in cui si intavede come prevalente un codicematerno. La vicinanza segna queste relazioni (fisica, affettiva,intellettuale) e l’intimità, la confidenza e l’affinità ne fannoda scenario. La vicinanza va sempre insieme al trovare la giustaditanza.Le storie di formazione narrano di un procedere lento, incerto,faticoso.
I contesti delle storie di formazione sono quelli dei servizidi cura, delle istituzioni deboli che hanno un mandato educativonon sempre esplicito e celato nelle pieghe di funzioni ufficialidiverse.
La formazione avviene dentro alla vita quotidiana e fa i conticon il caso e l’imprevisto e spesso registra grandi cambiamenticonseguenti a piccoli interventi.
L’altra faccia della formazione, che si rivela quando sievocano situazioni di insuccesso è legata alle istituzioniformative forti (scuola, familgia, università, esercito) dove sievince che il potere dell’educazione (trasformativo, impositivo,decisionale) sancisce forti differenze e ruoli. Le storie di formazione diventano allora storie di scontri,aggressività, violenze e ferite.
2. Quali immagini e modelli della formazione soggiaciono alleazioni e ai progetti educativi, partendo dal presupposto che ciòche accade nelle vicende educative è dipendente dallerappresentazioni, che gli attori della formazione hanno dellaformazione stessa. Questo è ciò che la CdF definisce LATENZE COGNITIVE, che vannoportate a consapevolezza se non si vuole essere agiti dai proprimodelli interni ma si vogliono scegliere e guidare le proprieazioni.Su questo versante le immagini di formazione si dispongono con unalogica dicotomica buona formazione/cattiva formazione , dove perbuona formazione ci sono immagini di rottura di schemi, diaccoglienza, accettazione, comprensione e condivisione, in cuil’educazione è legata ad un’immaginario di naturalità in cui lepotenzialità personali si esprimono liberamente (funzione materna:avere cura, abbracciare, contenere) mentre per la cattivaformazione si evincono immagini di lotta, scontro, imposizione,
9
impossibilità di comunicare, di stabilire legami, di riconoscerel’altro e di riconoscergli un ruolo o di far riconoscere ilproprio ruolo. Se il riconoscimento della persona e del proprioruolo non è possibile la formazione diventa un’escalation diviolenza, ricorso al potere, e si parla di punizioni, disciplina,autorità, ecc…
3.Altra dimensione è costituita dalle LATENZE AFFETTIVE cioè lamappa di affetti, emozioni, sentimenti che sono imprescindibili ineducazione; sono da tenere sempre sotto controllo consapevole.
La formazione è costellata da momenti di piacere e di dolore,di soddisfazione e di frustrazione, di illusione e di delusione….La relazione educativa ha sempre delle ambivalenze e l’irromperedi affetti negativi sulla scena educativa sembra rischiare spessodi pregiudicare la possibilità stessa dell’educazione e faintravvedere il limite dell’educazione. In educazione sono fondamentali i concetti di empatia connessialla condivisione, alla solidarietà e alla capacità diidentificarsi. Dall’altra parte anche i sentimenti di paura,rabbia, delusione che spesso portano a produrre disorientamento,corto circuito affettivo….
4. Capire quale sia il dispositivo in atto nelle situazioniformative significa far emergere ipotesi ed attribuzioni su qualeparticolare configurazione metodologica e su quale organizzazionerenda un’esperienza educativa.
Questa domanda viene definita dalla CdF RICERCA SULLA LATENZAPEDAGOGICA. Il lavoro di ricerca in pedagogia tende spesso asfumare però o nei modelli teorici a priori o nella meradescrizione degli eventi.
La CdF ha però una particolarità : è interessata alriconoscimento di un dispositivo formativo fortemente coincidentecon l’esperienza e la pratica di vita. L’esperienza vissuta, chediventa pratica trasformatrice (quando è animata da intenzioneformativa), risulta essere l’origine e la risorsa essenziale diogni processo formativo. Il dispositivo formativo assume i caratteri dell’esperienza vitalecioè il diaologo e lo scambio tra persone e tra persona esituazione e l’attivo e reattivo orientarsi al cambiamento fannola formazione.
L’apprendimento, motore del cambiamento, è apprendimentonaturale, legato alla rielaborazione dell’esperienza. L’azioneformativa è un lento e continuo lavoro di piccole trasformazioni e
10
conquiste che hanno più i tempi dell’esistenza che di unefficiente progetto a termine.
Il nucleo del dispositivo di formazione è l’esperienzacondivisa, la relazione interpersonale e attorno a questo nucleosi delineano i tratti dell’intervento educativo che rendel’esperienza e la relazione capaci di produrre formazione.
Elementi del dispositivo formativo:
- La formazione avviene con la comunicazione da parte delformatore del proprio modo di essere, cioè il formatore educacon il proprio esempio, la sua funzione poi è quella diproporre un modo di essere, disponibile, vicino.
- la sua funzione è quella di esserci, con la propria storia divita.
- Si apprende dalle emozioni e dai sentimenti (anche dolorosi)
- Norme e regole sono importanti perché stabiliscono i ruoli edefiniscono il campo di possibilità.
- Spazio fisico e simbolico sono importanti: la formazione è uncontinuo dislocarsi e ricollocarsi, avviene tra dentro efuori (entrare e uscire dal ruolo).
6. Il guadagno formativo
Il guadagno, in formazione, non è mai quantificabile, e definibileperché si deposita nelle persone e si evidenzia nel tempo, anche adistanza…
E’ impossibile valutare quanto una persona utilizzerà eintegrerà le nuove consapevolezze nel suo ruolo professionale equanto il lavoro innescato da un percorso di clinica diventerà unatteggiamento stabile di riflessione sulla propria esperienza equindi di apprendimentoi da essa.
La formazione clinica può essere profondamente modificatriceperché propone una modalità di costruzione di sapere, diconoscenza e di apprendimento che una volta sperimentata puòcostituire un possibile modello di elaborazione dell’esperienzapersonale e quindi di formazione e autoformazione.
11
LA CORNICE ESTETICA DEL SETTING DI SUPERVISIONEPratiche di conoscenza e di legame
(Ulivieri Stiozzi)
1. Introduzione: sguardi e posizionamenti
La trattazione seguente sarà la rielaborazione del lavoro disupervisione svolto con gli allievi del corso utilizzando la CdFcome riferimento teorico.
Questo modello non è stato spiegato, ma è stato fatto vivereai corsisti man mano che si dipanava il lavoro di supervisione;hanno avuto la possibilità di disegnare i contorni di un metodocon il procedere del corso.
In questo caso si doveva offrire ai corsisti sia un luogo diapprofondimento e di interrogazione dei propri modelli ma anche unluogo dove poter lavorare in una direzione formativa, cioè disviluppare competenze relazionali e organizzative.
Quindi è stato necessario un riposizionamento e ildispositivo formativo del corso ha promosso un percorso diinterrogazione del modello.
Interrogativi di fondo-
1.È possibile supervisionare un percorso di CdF che già di per séfa un lavoro di analisi e approfondimento, cioè di metavisione?
La clinica infatti è proprio centrata sull’interrogazione checostituisce, per chi la pratica, l’unica modalità autenticante. Lasupervisione con un approccio clinico ci porta a contatto con unlavoro basato sulla CdF e quindi ci si trova a dover rendereconto di un carattere doppio e paradossale in cui più che pensaresu un oggetto, il lavoro di clinica finisce per essere pensato.Quindi nel processo istituito dal dispositivo di CdF qualcosasfugge e denuncia l’impossibilità di controllare e padroneggiarefino in fondo i contenuti del poprio pensiero.
Questo limite ci porta anche in contatto con una peculiaritàdella CdF, in cui la messa a fuoco di un ogeetto non è solol’illuminazione di una zona quanto l’adombramento di molte altre,poiché il rapporto chiaroscurale nel lavoro di clinica è sempre afavore di ciò che si sottrae. In fatti ogni esperienza formativa èefficace se è in grado di suscitare un confronto con la quota diignoto che abita in ognuno di noi.
13
2. La metafora teatrale dell’educazione
Altro interrogativo di fondo-
2. Come poter pensare ad un progetto di CdF che potesse essere a servizio di una figura professionale che si profilava come tecnicodella formazione? Predisporre una tecnica al servizio di unprogetto umano o pensare ad un progetto umano al servizio dellatecnica?
La clinica è un dispositivo di secondo livello in quantoanalizza la dimensione formativa dell’esperienza, il suo obiettivoè infatti quello di complessificare e non di costruire competenzeoggettivabili.
La clinica inoltre tende ad attraversare le latenze e leideologie che sottostanno al registro tecnologico, quindi agiscead un meta livello, cioè interroga il rapporto che ciascuno ha conle proprie conoscenze.
Per progettare quindi un setting di secondo livello che avessecome oggetto un lavoro di secondo livello (clinica) è stata usatala metafora teatrale e il concetto di cornice. Sia la metafora delteatro che quella della cornice producono infatti movimenti dioscillazione tra i diversi livelli del conoscere e del pensare.
Massa ha molto scritto sulla metafora teatrale. Uno dei fuochicentrali del suo pensiero è stato quello della tecnica in ambitoeducativo, per lui infatti le tecniche poedagogiche hanno unvalore molto importante purchè siano inscritte in una cornicemetaforica che alluda ad un oltre la tecnica. Dice che il registrotecnologico è importante ma deve essere inteso in senso umanisticocioè parla di tecnologia teatrale. La metafora teatrale è per luiun luogo analogico per costruire relazioni educative in un campoaltro.Ogni dispositivo formativo ha il proprio apparato tecnologico mase si vuole che esso manifesti la sua forza propulsiva e nonomologante è necessario predisporre una cornice metaforica dialleggerimento che permetta di guardare al dispositivo in modoobliquo, indiretto, oltre uno specchio. Occorre metaforizzare ildispositivo cioè riposizionarlo in uno spazio virtuale/esteticoche permetta una sua manifestazione obliqua che restituiscadensità simbolica all’evento educativo come pratica dellacontaminazione.
La dimensione del contagio come elemento produttivo deiprocessi educativi è centrale per Massa. (Peste è una metafora
14
pedagogica che indica come l’educazione avvenga per contagio, subase sociale, emotiva e non per trasferimento intenzionale dinozioni intellettuali. Il contagio educativo (come la peste) èvisto come esperienza che fa venire meno le norme e le regoledelle strutture scolastiche e familiari, quindi rende possibilel’assunzione di comportamenti anche trasgressivi.)
L’utilizzo di una metafora teatrale permette di ipotizzare undispositivo finzionale-autenticante. (il teatro secondo Massadiventa un’esperienza che svolge una funzione autenticanterispetto alla vita L’essenza del teatro povero è la radicalità,esperienza di trasgressione, cioè esperienza di esplorazioneradicale dei significati più profondi. Quindi processo diAutenticazione. Il teatro svolge una funzione autenticanterispetto alla vita, la finzione ci rende autentici, attraverso lasimulazione si ha la possibilità di accedere ad una dimensione piùautentica di quella che caratterizza la vita quotidiana. Peranalogia, l’esperienza educativa ha carattere di finzione, che leconferisce autenticità. L’educazione è infatti un’esperienzaprotetta, che consente l’esplorazione e l’approfondimento deisignificati, l’esplorazione della realtà. L’educazione sospende ilfluire della vita e istituisce il tempo e lo spaziodell’esperienza educativa.)
La metafora teatrale permette anche di simulare un processoeducativo orientato verso pratiche di liberazione dagli effettialienanti che lo sguardo del potere del dispositivo stessoproduce.
La cornice artistica permette di ripensare il soggetto fuoried oltre il dispositivo, mentre la metafora del teatro consente dipensare ad una trasfigurazione del dispositivo che mentre siesibisce funziona al tempo stesso da istanza critica nei confrontidei dispositivi ordinari e dei loro ordini di latenze.
Uno di questi è sicuramente il linguaggio e il modo in cuiviene uitilizzato in educazione; l’ordine della metafora permettedi svolgere una critica radicale al linguaggio usato per sancirel’aderenza tra potere e sapere.
La metafora apre spazi contro-identificatori che possano divenireluoghi di riconfigurazione del sapere; ad esempio il corpo (spessorelegato a materia grezza, non verbale). Il corpo diviene puntozero dell’educazione, cioè una sorta di spazio che nell’aperturarelazionale è in grado di risperimentare quella fiducia equell’abbandono che consentono al pensiero di accedere ad una zona
15
di libertà creativa piuttosto che muoversi sulle orme di unpensato già noto.
Dal teatro di Grotowski massa prende l’idea di una nuovaprospettiva in cui la formazione non è più vista come l’atto diinsegnare qualcosa a qualcuno, ma è un atto che fa giungere,attraverso pratiche teatrali, alla liberazione di energiepsicofisiche di denudazione e quindi non si tratta di insegnarequalcosa ma di eliminare delle resistenze.
Emerge un’idea di educazione come processo di eliminazione delleresistenze dell’organismo . Questo può accadere solo in undispositivo a maglie larghe che permetta l’oscillazione tra varisaperi, piani differenti e ciò è possibile dove si sia istiuito unordine non prescrittivo e categorizzante ma teso a produrre unapartitura “estetica”.
Quindi la cornice si organizzerà a partire da un lavoro criticosulle condizioni materiali che presiedono l’evento formativo,inoltre può ipotizzare uno spazio del desiderio, un tempodell’alternanza tra pieni e vuoti, poiché non ha un’obiettivo diefficacia ma si propone una finalità di approfondimento e ditrasformazione dell’esperienza di ogni partecipante al gruppo.
La tecnologia della metafora teatrale di massa si pone al serviziodi un progetto di intensificazione umana riacquisendo la suanatura creativa e produttiva.
L’educazione è il luogo in cui si doppia la vita e in cui sidoppiano anche le domande di controllo. Il teatro è la metafora diquesto luogo e la metafora teatrale è utile perché permette dipensare l’educazione al di fuori del dispostivo puro senza perquesto negare la sua presenza perché il teatro non è vita, mariproduce, rielabora, ricostruisce i significati vitali.
3. Il setting della supervisione come cornice della formazione
Il setting di supervisione può doppiare l’esperienza di formazionein quanto può ritrascriverla oltre lo specchio, cioè puòrappresentare alcuni movimenti non tanto per interpretarli, maquanto per rimetterli in un gioco fluido che possa consentire aisoggetti di modificare i nessi e trovare spazi di approfondimentoe di traduzione.
Pensare ad una supervisione come teatro significa pensare adallestire una cornice che produca l’emersione della dimensionefinzionale-autenticante.
16
La supervisione è un luogo artificiale dove promuovere unavisibilità obliqua del dispositivo stesso a partire da uno spazioin cui vengono intensificati gli apprendimenti individuali erelazionali e dove non si fa leva sulle relazioni e sugliindividui ma sullo spazio simbolico che li contiene.
L’allestimento di una cornice formativa produce movimentiaffettivi e cognitivi intensi che generano immagini forti. Ilsupervisore deve sintonizzare la regia del luogo alle immaginiprodotte dal gruppo, ai vissuti espressi per promuovere sguardi diapprofondimento e risonanze affettive che permettano un’evoluzionedella mente del gruppo.
La relazione è una delle funzioni della cornice e la conduzionenon prevede un rapporto asimmetrico per cui scatta subitol’identificazione, ma il conduttore fa leva sulle potenzialità esulla mente del gruppo come luogo auto poietico (sistema che alproprio interno si ridefinisce, si sostiene e si riproduce).
La funzione del conduttore si dovrebbe porre come monitoraggio eregolazione cioè come una sorta di specchio che equilibri, senzapretese di ordine esaustivo, i movimenti di ombra e luce, chevaluti quando lasciare che il processo si svolga e quando è megliofare una fotografia del momento che ha un valore per il gruppo.
Lo spazio in cui si mette in scena la formazione serve adinterrogare la propria vita e il proprio sguardo su di essa. Laclinica preleva dalla vita perché osserva le curvature formative epermette di rintracciare le proprie consapevolezze circa laformazione. Dall’altra parte la supervisione custodisce l’altraparte della curvatura, cioè ritorna alla vita per illuminarla dinuovi significati e permette al gruppo di vedere l’offertaformativa come spazio di intensificazione autenticante
4. Riflessioni intorno allo statuto della cornice
La cornice può avere alcune funzioni:
- Delimitante e decontestualizzante – cioè suggella ciò che viè racchiuso come mondo a sé stante e dotato di proprie leggiinterne. Esclude l’ambiente circostante e distanzia ciò checontiene tanto quanto basta perché diventi fruibile. Collocal’opera in una zona insulare che ci consente di conservarequel sentimento di dono immeritato con cui l’opera ci rende
17
felici. La cornice chiude ed esclude, ma ha anche significatodi soglia, di passaggio, di confine, frontiera, allude apassaggi di stato e si istituisce tra ordine della ragione eordine della finzione.
- La cornice permette la leggerezza – la formazione non puòproporre percorsi contrassegnati dalla pesantezza, dallafatica come se solo attraverso questi segni si potessedichiarare il successo della proposta formativa. Laformazione dovrebbe assumersi la leggerezza come traccia diuna ricerca che parte dal peso come elemento incancellabiledell’esperienza umana, ma che possa anche liberarsene peralzarsi in volo! La formazione è contaminata con il potere,forse è interessante provare a ragionare su come indebolirela visione. Forse una visione più obliqua permetterebbel’istituzione di nuove configurazioni di senso.
La formazione richiede l’istituzione di un dispositivo di sogliache delinei una distanza dal mondo ordinario e permettal’emersione di nuovi discorsi e linguaggi. L’immagine artisticasvela potenzialità nascoste e la formazione come teatro si fadepositaria di uno spazio del possibile e permette di giocarlo insituazione per pervenire ad uno sguardo che si sottragga ad unalettura riduttiva ed omologante.
La supervisione del corso è quindi stata un’esperienza chepermettere di rilevare la quota di meraviglia che assale dopoun’esperienza perturbante e che prima di sottoporla alla ragioneviene semplicemente solo vissuta. La tensione ermeneutica non èstata volta allo scavo di significati ma a produrre un momento dioscillazione dei significati, cioè di contestualizzazione,decontestualizzazione e ricontestualizzazione che rende lievequesto movimento e ne sottolinea la matrice relazionale.
Nel gruppo si è pensato per storie, per immagini, che sonostate via via incorniciate e scaturivano contaminazioni generatetra i partecipanti, tra i loro immaginari e tra i reciprociprocessi di rispecchiamento.
5. Un rito come cornice: la maschera del Sileno
Il percorso è stato segnato da un’immagine che ha disegnato ilperimetro della cornice e che verrà usata come specchio perriflettere alcuni momenti dotati di particolare spessore.
18
L’immagine vede il Sileno che con il corpo è dentro la scena,nell’atto di porgere la coppa all’iniziando, ma con lo sguardo,guarda verso un altrove fuori dalla scena. Il movimento quindi èduplice: di concentrazione e di distrazione. Il Sileno guardandolontano e permette che quel luogo viva di vita propria perchéconsegna a quel luogo una sua autonomia e lo mette al riparo dalleproprie (del Sileno –regista-) aspettative e intenzioni.
In quest’immagine il formatore (Sileno) con il suo corpo cercadi far scattare nell’iniziando la passione nel prendere la coppa(sileno porge la coppa all’iniziando). Nella scena è presenteanche un satiro (anche lui formatore) che però pone la schiena,cioè ciò che di lui non è visibile, al cospetto del setting. Conquesto consegnare al setting ciò che del formatore non è visibilesi allude all’indebolire il controllo sugli effetti dellaformazione e immergersi nel proprio mondo fantasmatico per nonutilizzare il setting come cassa di risonanza delle proprieaspettative inconsce. Mettersi di schiena può voler dire metterein gioco la propria ombra.
Il potere del formatore quindi diviene potere del dispositivodella formazione che viene consegnato al luogo in cui laformazione avviene. Questo luogo necessita di una regia attenta anon modificare le asimmetrie formali a creare uno spazio vuoto dicontenuti e di forme pre-dette che sia quindi un luogo generativoin cui si verifichino co-costruzioni, riconoscimenti eassociazioni immaginative a servizio di una storia e una culturaterze.
L’immagine della maschera del Sileno allude ad un modo di fareaccadere la formazione e di intendere la supervisione attraversouna cornice che non promuove sguardi diretti sulle esperienze masempre modalità di visione decentrate, oblique, di margine.
Mettere un’immagine nelle mani del gruppo ha significato produrreun movimento desiderante che ha consentito ad ognuno e al gruppodi identificarsi e al tempo stesso di distanziarsi, quindi diriposizionarsi rispetto alla formazione.
L’immagine consente di fare connessioni tra la propria vita e lapropria formazione potendo anche custodirle in uno spaziosubliminale dove possono restare al riparo da sguardi altrui madove germinano e comunque modificano nel profondo la vita mentalepropria e del gruppo di cui si fa parte.
19
La supervisione nel corso La supervisione del corso voleva costituirsi come spazio di
sedimentazione del lavoro formativo, come luogo dove le esperienzevengono approfondite e possono essere scambiate per diveniresimboli.
Il gruppo ha giocato a mettere in scena e a mettere in scaccole proprie maschere attraverso registri dell’ironia, delparadosso, e dello stupore estetico. La capacità di giocare con lee proprie maschere e di alleggerire l’assolutezza di certisguardi, occupati dal peso di culture introiettate e assunte inmodo acritico e la capacità di stravolgere alcune letture delproprio ruolo professionale, sono competenze fondamentali per chivuole svolgere una professione in cui è centrale la dimensionedell’incontro umano.
Il movimento del gruppo ha proceduto ad una sempre maggioreleggerezza, man mano che l’esperienza prendeva forma, lo spessoredell’atmosfera si alleggeriva, i conflitti si sono fatti piùtollerabili e se ne è riconosciuta l’utilità, le differenze sonodiventate risorse…
Il percorso fatto non è stato di crescita ma di approfondimentoesistenziale, di immmersione nel proprio vissuto, diintensificazione della capacità di cogliere l’imprevisto e dielaborare im modo critico la fatica, il conflitto, lafrustrazione…
Nel gruppo si è prodotto un movimento lento che ha portato acreare quella fiducia di base necessaria perché un insieme dipersone diventi un gruppo. I partecipanti sono infatti passati dalvivere la conoscenza CON all’attraversare l’esperienza dellaconoscenza PER e TRA. Il percorso è stato quindi di una conoscenzache implica un riconoscimento cioè che presuppone che ci siariconoscimento si sé e dell’altro, che ci sia rsiposta alledomende dell’altro essendo non un testimone ma diventandointerlocutore implicato nel processo conoscitivo dell’altro. Laconoscenza è quindi pratica di riconoscimento che presuppone sipossa accedere agli altri tramite un ascolto denso, affettivo euna presenza fisica risonante.
Il riconoscimento diventa una pratica di significazione dellaconoscenza come “vita”: cioè il riconoscente e il riconosciuto sirivelano reciprocamente in un legame relazionale caratterizzatodalla responsività. Quindi ne scaturisce un processo che porta laconoscenza in un luogo che noi sentiamo caldo e accogliente. Qestoprocesso è possibilie nella vita cioè in quei momenti felici in
20
cui la vita si fa terreno fecondo di discorsi possibili ed è soloin questi momenti che si riesce a non eludere l’umanitàdell’altro.La conoscenza come riconoscimento è stata la corniceche che ha permesso a persone molto diverse di diventare ungruppo.
Nel gruppo sono stati fatti disegni che alludono sia ai primistati d’animo di distanza tra i membri, di distanza dall’enteformativo, che rimandano ad un inizio come ad uno stato didisorganizzazione. A distanza di tre mesi un allievo fa un disegnodi un muretto, basso, che ora è scavalcabile. Il gruppo haacquistio un’identità, è diventato consapevole del propriopotenziale e i muri tra le persone si sono fatti meno alti, sipossono scavalcare agilmente. Ciò che ha permesso al gruppo didiventare tale è stata la capacità del gruppo stesso di teneredentro, di far passare i pensieri da una mano all’altra peralleggerirli, di pazientare se la risposta tardava ad arrivare…tutto ciò ha permesso alle persone di scoprirsi reciprocamente,fuori dai propri ruoli ma dentro a nuove posizioni assegnate dalgruppo e dello scambio di storie, vissuti e immagini natiall’interno del gruppo.
6. Oscillazioni di cornice
Il percorso che il gruppo ha compiuto è stato la risposta a questadomanda: può un’equipe ritagliarsi una propria fisionomia e unproprio spazio al di la del mandato istituzionale?
In questo gruppo il “salto” qualitativo nella direzione deldivenire un gruppo autonomo è stato fatto quando una corsista haraccontato un momento di vita con una donna schizofrenica cui leifaceva da badante. In questo caso l’insieme di persone(operatori), attivando un processo gruppale, ha affrontato edelaborato un passaggio alla transdisciplinarietà ed è divenutogruppo.
I corsisti infatti hanno generato un sapere di qiualità nuova,che ha toccato le discipline per attraversarle alla ricerca diun’elaborazione critica e transdisciplinare. Il gruppo haelaborato preziose considerazioni sulle tematiche della cura incampo educativo che sembravano la traduzione teorica di un saperecontestuale, generato dalla contaminazione dei vissuti, delleemozoinie delle culture dei partecipanti.
Questo momento è stato uno di quei rari casi in cui ci si puòcontaminare (essendo protetti) con un dolore, si può stare in
21
contatto con una ferita e si può entrare in un luogo buio, senzaricorrere subito all’apporto della rassicurante teoria.
Inoltre quell’immersione esperienziale nella narrazione haprodotto un sapere “situazionale” generato da tutte le risonanzesensoriali, affettive ed emotive che la narrazione ha mobilitato.
Questo racconto ha prodotto un gruppo che si è riscopertoun’equipe, cioè un luogo mentale di elaborazione dei rimandiculturali e personali generati da un tessuto di esprienze che siintensificano per contaminazione, cioè grazie alla rete direlazioni vissute e partecipate.
22
RISORSE UMANEUn attraversamento clinico del dispositivo pedagogico tra effetti
materiali e simbolici (Barone)
1. La nozione di dispositivo e la sua declinazione pedagogica
Esiste sempre una relazione tra il dispositivo in atto nei servizie i soggetti che ne fanno parte, sia che abbiano un mandatoformativo esplicito sia che il maqndato rimanga implicito. Ilfunzionamento del dispositivo pedagogico può essere rintracciatoal di là dell’esplicitazione che ne può fare l’organizzazione.
La nozione di dispositivo trae origine dagli scritti di Focault.Il dispositivo può essere definito come la struttura portantedelle pratiche di potere che attraverso discorsi, elementimateriali e simbolici e pratiche procedurali ed effettuali, hannoportato alla costituzione, nelle diverse epoche, dellasoggettività in senso moderno.
Massa ha poi introdotto il concetto di dispositivo pedagogico, losvolgersi dell’accadere educativo è sempre da mettere in relazionecone le condizioni materiali e simboliche, esistenziali epsicologiche, culturali e sociali, e al loro intreccio.
L’accadere educativo ha una struttura complessa di cui appareessenziale sia la dimensione evidente dell’intenzionalitàpedagogica che la muove, sia la dimensione più implicita e latenteche ne attraversa la materialità.
La nozione di dispositivo pedagogico mette allo scoperto lafunzione irriducibile dell’educazione e della formazione neldeterminare l’individuo come soggetto appartenente a un tempostorico, biologico e ad uno scenario culturale e sociale.
Il dispositivo pedagogico si configura come un sistemaincorporeo delle procedure in atto che permette di cogliere lamaterialità educativa come sfonsdo esperienziale e concreto delprocesso di formazione individuale e collettivo.
Più precisamente nella meterialità educativa rintracciamo ilgioco, che sempre si da nell’accadere educativo, tra l’evidenzamateriale e la sua simbolizzazione e quindi tra la visibilitàdell’azione formativa e le latenze che ne sorreggono la tramaconcreta.
Materialità educativa: Sfondo esperienziale (vissuti, relazioni)che rende possibile l’accadere della formazione e al tempo stesso
23
è quella struttura storicamente determinata (storia sociale,culturale) all’interno della quale si da concretamentel’esperienza formativa.La materialità educativa è l’accadere educativo, cioè il reticolodi pratiche educative, relazioni, spazi, tempi, cultura in cui laformazione avviene.
2. La costituzione della soggettività come soggetto scientifico
In occidente, le scienze umane si sono organizzate attorno alsoggetto, che è stato pian piano elevato ad oggetto di scienza. Lapedagogia moderna quindi soggettivizza l’individuo.
Inoltre parlare di educazione implica quindi anche parlare diquale rapporto ci sia tra l’educazione e il potere.
La pedagogia va quindi analizzata nellasua duplice funzione:- Ideologica: cioè come sapere cinghia di trasmissione
culturale di valori dominanti della società - Ortopedagogica: cioè come scienza del raddrrizzamento fisico
e morale che produce pratiche di intervento puntive,terapeutiche e correttive nei confronti delle devianze.
Se si vuole capire gli elementi della materialità educativa,bisogna comprendere la relazione che esiste tra dispositivo,soggettività, educazione e potere.
L’educatore infatti utilizza il potere, ma è anche costrettoad utilizzarlo. Potere a livello di gerarchie e di ruoli, quindipotere formale, ma anche potere nell’organizzazione di tempi e dispazi.
3. L’importanza di uno sguardo clinico-formativo nell’intreccio tra dispositivo e soggetti
L’approccio clinico permette di tematizzare i modelli, i miti, inmodo da comprenderee le funzioni, i ruoli, far emergere i vissuti,e le percezioni che sottostanno alla pratiche educative. Quindil’attenzione si sposta alle latenze in quanto sfondo della scenaprincipale, ma di cui l’educatore deve essere consapevole perchésono fondative dell’azione educativa.
Il concetto di clinica nella ricerca pedagogica pone al centro laconoscenza dal di dentro del processo formativo che concretamenteavviene. La clinica pone quindi un’esigenza di concretezza che siaccompagna alla valorizzazione della singolarità,
24
dell’individualità, della soggettività, come dimensioni centralidella lettura dell’accadere educativo. Quindi assumono importanzal’ascolto e lo sguardo al processo formativo a partire dalcontesto e della situazione dati.In un percorso di tipo clinico quindi assumono importanza oltre ainon detti e quindi alle latenze, anche il modo con cui si parla diformazione, il modo con cui la si definisce. L’atteggiamento concui si opera è ermeneutico in quanto si rilancia la produzione dipossibili significati che vengono ridefiniti e scaturiscono dalprocesso in atto.
L’approccio clinico consente di ridurre lo scarto trateorizzazione, progettazione e azione della dimensione educativain quanto consente di fare piena luce sull’intreccio tra vita eformazione. Infatti il lavoro clinico permette di rielaborare ivissuti e le rappresentazioni degli operatori partendo da loro inprima persona e non da fredde teorie.
3.1. Dimensione affettiva e smascheramento dei miti nelle
professioni di aiuto
La dimensione affettiva è una delle grandi latenze in quanto ledimensioni emotive non vengono mai prese in considerazione nelleprogettazioni o nelle discussioni istituzionali.
La dimensione affettiva muove le azioni educative e deteminala difficoltà del gestire la relazione educativa in quanto nonrende chiaro il confine tra vita personale e e vita professionale.Le latenze affettive tra l’altro contribuiscono a creare immaginie miti di infanzia, adolescenza, aiuto, e regolano il rapporto cheogni educatore intrattiene con il dispositivo pedagogico in atto.
3.2. Il soggetto all’interno del dispositivo tra ruolo e ordine istituzionale
In ogni realtà istituzionale vi è un dispositivo di formazioneche contribuisce a costituire l’identità del soggetto che ne faparte. Il rapporto tra soggettività e dispositivo è legato alrapporto che esiste tra ruolo e l’ordine istituzionale in cui taleruolo viene giocato.
Esiste quindi un rapporto di dipendenza tra istituzione eindividuo perché l’istituzione esiste se vi sono dei soggetti chenell’incarnare un determinato ruolo, rendono possibile la sua
25
rappresentazione. Quindi sia l’istituzione sia gli individui chela abitano sono implicati in un rapporto di sapere/potere tradispositivo di formazione e soggettività, cioè tra mandatoprofessionale e interpretazione personale che viene fatta dalsoggetto in causa.
Forse è proprio questa capacità di reinterpretare il copioneda parte degli operatori ad essere il più delle volte disattesanelle riflessioni sul potenziamento delle risosrse umane oaddirittura a fare problema per le organizzazioni al punto dicostituire una latenza pedagogica.
26
LA CURA NELL’ESPERIENZA EDUCATIVA (Palmieri)
1. Il percorso di ricerca
La cura è una dimensione essenziale dell’esperienza educativa eall’interno del percorso è stato proposto uno spazio diriflessione in cui fosse possibile costruire un sapere della curae sulla cura congruente con l’esperienza perché da essa èoriginato.
La metodologia di ricerca utilizzata si è ispirata alla CdF.L’approccio clinico ha consentito di mantenere ambiguità econtraddizioni, ma anche di contaminare sguardi, posizioni, diattivare domande e di insinuare dubbi. Ha anche permesso al gruppoin questione di decostruire e ricostruire una mappa di significatiattribuibili al termine cura.
All’interno del percorso lo strumento principale è statol’attivare e l’interrogare il proprio immaginario e lerasppresentazioni di ciascuno riguardo la cura. In seguito lediverse immagini sono state confrontate tra i vari corsisti e poila cura è stata cercata all’esterno del gruppo guardando il filmil grande cocomero.
2. Le rappresentazioni della cura
Immagini che rappresentano la cura prodotte dal gruppo econfrontate in gruppo.
1)Il grembo materno o della generazione - La cura si mostra comepancia, utero che cresce, è associata alla vita e al concepimento,al nutrimento, è protezione della vita, calore, assenza dibisogno, condizione di pienezza.
La cura ha a che fare con il corpo, corpo che forma, si formae si trasforma, e la cura deve essere una situazione tantonaturale e diffusa quanto assolutamente unica.
La cura si colloca in una situazione a parte, centratasull’esistenza concreta di chi cura e di chi è curato.
2)La casa e la famiglia tra accudimento, educazione e memoria - Lacasa e la famiglia corrispondono ad un luogo di cura in cuiavviene una cura che alleva i più piccoli e insegna loro aprendersi cura degli altri. La cura è associata ad una casa,
27
chiusa ma non recintata, luogo aperto da cui poter uscire edentrare.
3)La natura tra crescita e coltivazione sapiente - La cura èrappresentata proprio come una mano che interviene a proteggere unelemento naturale, ad esempio un fiore, che è di per sé fragile.La cura è rivolta a chi si percepisce come debole, ma la mano cheripara dalla pioggia può essere anche la mano che filtraeccessivamente la luce del sole o che non da l’acqua necessaria.L’ambivalenza della cura è rappresentata dal fatto che non è puraaccoglienza ma accoglienza che avviene entro determinatecondizioni e che implica anche il conflitto.
Si cresce non solo perché si è accolti ma anche perché siresiste alla volontà altrui, ci si misura con i limiti impostidalla realtà: la cosa interessante è capire come si utilizzaquesta resistenza per essere effettivamente solo ciò che si può apartire da ciò che si è già.L’educazione è un ascolto e un fare sapiente che accompagni,accolga, protegga, tuteli e al tempo stesso tagli, imponga,pretenda, anche senza nessuna condivisione.
4) L’urgenza della cura o della sua ambiguità - La cura è azioneche attraversa la sofferenza individuale e l’incidenteesistenziale barcamenandosi tra la vita e la morte. Oscilla trale sue componenti assistenziali e promozionali, ma non è esente dauna componente mortifera, anzi questa componente la espone semprea dubbi, incertezze, sul proprio senso.
La cura nasce da una ferita, dai limiti di chi cura, e da comechi cura ha elaborato la propria ferita, e in base a quella si ècreato un particolare modello esistenziale, formativo e umano.Esiste infatti un rapporto imprescindibile tra cura degli altri ecura di sé e su questo poggia l’ambiguità della cura.
La cura ha una dimensione impositiva; la possibilità disviluppo è determinata unidirezionalmente, non tanto da chi curama dalla situazione organizzata materialmente e simbolicamente perla cura.
2.2 vedere altrove: il controverso rapporto tra cura e terapiaFilm Il grande cocomero
1- Un mondo a parte - La visione del film porta a riflettere sulladimensione terapeutica della cura. Questa esperienza di curaavviene in un mondo a parte, in un reparto, all’interno di confinitracciati tra un fuori e un dentro. La cura accade istituita da
28
quei luoghi, non belli, ma abitati; ripetitivi, lenti, che hanno itempi delle istituzioni. La cura avviene in questi luoghi ma èanche ciò che istituisce quei luoghi perché crea le condizioniistituzionali perché queli luoghi nascano e si sviluppino.
I luoghi di cura sono luoghi dai forti connotati affettivi enella cui cornice avvengono relazioni. In questi luoghi laseparazione dalla vita comune è essenziale, perché deve sancire laqualità di relazioni particolari, perché nel bene o nel male,hanno il potere di formare le persone, impedendo o facilitando lapropria conoscenza di sé, intesa come possibilità diriconoscimento e di progettazione esistenziale.
La terapia, nel film, ridimensiona il suo apparato tecnologicoper contaminarsi con bisogni, esperienze, e dedideri dei malati,che sono persone reali.
2-La tentazione della guarigione o della mania di salvezza - Chicura spesso tende ad assumere un ruolo salvifico o di tentare laguarigione dell’altro. Questo atteggiamento ha sia radicisoggettive, sia radici culturali, cioè che vengono da modalità diconcepire la malattia e la guarigione tipiche dell’occidente, incui la malattia assume sempre connotati solo negativi e laguarigione è un ritorno alla condizione precedente, come se ilcorpo non avesse inscritto su di sé il dolore attraverso cui si èpassati. Quindi chi guarisce, che restituisce chi era malato allavita, sente un potere inebriante su di sé.
Andrebbero rivisti i concetti di malattia, cioè comeinscindibile dall’esperienza e dal corpo delle persone il concettodi terapia, che non ha il potere di salvare le persone perchél’esistenza ha ha limiti e potenzialità che vanno oltre il saperemedico, e il concetto di guarigione, che potrebbe iniziare adessere vista come una ricerca di un nuovo equilibrio all’internodi una imperfezione che è costitutiva della vita umana.
E’ utile imparare a distinguere la terapia dalla cura; la curainfatti andrebbe intesa come cura dell’esistenza dei soggetti,impegnata nella ricerca del senso dell’esperienza e nel casospecifico nel senso di quella malattia.
3-La relazione pericolosa o del rischio del curare - Nella curadell’altro si cerca una ragione per alzarsi al mattino, si cercanole motivazioni per resistere ad un lavoro complesso e stremante,la possibilità di riparare, di riscattare gli altri dalla lorocondizione di bisogno, ma di riscattare soprattutto se stessi.
Occuparsi degli altri può servire ad iniziare ad occuparsi dise stessi, della propria malattia, del proprio essere sbafliati,
29
come se la relazione di cura ci desse la possibilità di sentire inostri bisogni senza renderli espliciti, come se la cura divenisseil terreno dove poterci occupare di noi stessi.
Si cura a partire da ciò che si è, da ciò che si sente, e ciòavviene anche quando la relazione si mostra con l’opposta facciatadel distacco, della vuota professionalità, della stanchezza edella fatica. Questi sentimenti non si possono incanalare inpratiche accettabili semplicemente fornendo le opportuneistruzioni professionali, ma questa (portarice di vissutinegativi) è una dimensione costitutiva delle professioni di curaed è quindi da assumere in tutta la sua criticità
La cura è una dimensione esitenziale perché si occupa dellevite di altri, ma anche perché la cura alberga nella prorpiaesistenza. Si tratta quindi di una relazione materiale, corporea,incarnata nell’intreccio di pensiero e affettività che rende gliindividui connessi al luogo in cui abitano ancheprofessionalmente.
4 -La ricerca dell’identità o della cura di sé - L’identificazionecon l’altro, il coinvolgimento professionale devono sempre esseremediati da un’attenzione sistematica al proprio rapporto con séstessi.
Il rischio di confusione tra la formazione della propria edell’altrui identità, tra il riconoscimento dei propri e deglialtrui desideri e bisogni, è sempre molto forte.
La cura di sé come pratica di ricerca pedagogica necessita diessere portata avanti tramite dispositivi di elaborazionedell’esperienza professionale che aprono la dimensioneintrospettiva ad un confronto con gli altri, sentito comenutrimento indispensabile compreso nel lavoro di cura.
3. Sulla cura educativa, per non chiudere
Curare ovvero esistere - La cura è la struttura dell’esistenza inquanto gli individui esistono perché possano crescere esvilupparsi per diventare chi devono diventare.
La cura è esperienza concreta attraverso cui l’assitenzaprende forma.
Cura autentica: possibilità di poter diventare ciò che ognunonella sua unicità debba essere e non essere costretti ad esserequalcun altro.
Curare ovvero sapere - Curare implica sapere cioè conoscere qualisiano l’unicità e la specificità di un altro. Questa è sapienzamaterna fatta di connubio tra l’essere in contatto con sé stessi e
30
con l’altro che all’interno della relazione con noi sta prendendoforma, la sua forma.
E’ un sapere che non si apprende dai libri e che ha a che farecon il qui ed ora, che è radicato nel rapporto che ogni individuoha con il mondo e con i suoi significati. E’ sapere che traeorigine anche dalla cultura, cioè dai modelli culturali che ognunodi noi ha appreso in famiglia e nella società.
Curare ovvero potere - il potere della cura è potere di disporredi persone e di cose in modo da creare recinti in cui farsperimentare sé stessi che oscilla tra libertà e costrizione, èpotere di riconoscere l’altro attraverso l’attribuzione diun’identità originale o stereotipata, è giocare il potere traautoritarismo e autorevolezza.
Questa ambivalenza tra cura autentica (lasciare diventarel’indivuduo ciò che è ) e inautentica (sostituirsi all’individuoin ogni sua scelta) è costitutiva della cura e non può essererisolta.L’importante è porsi sempre domande di senso che ciaiutino a rintracciare la strada per un’educazione autentica
Curare ovvero errare - L’ambivalenza della cura si muove anche indue direzioni: quella dell’errare inteso come vagabondare dellaricerca che trova risposte minuto dopo minuto interrogandol’esperienza e dell’errare come sbagliare, cioè come movimento chedall’errore crea nuovo sapere e che viene opposto alle certezzeassolute di un’educazione rigida. Dall’errore si può trarreun’esperienza nuova, l’errore esiste perché esiste la vita, edall’errore può nascere un nuovo sapere che alimenta la vita.
31
ELABORAZIONE DELLA FERITA (Mottana)
1. Ferita
Il termine ferita viene usato per fare riferimento ad un tipo disofferenza non banale ma che sia possibile riconoscere sotto laforma di un segno e perché questo termine gravita attornoall’esperienza di dolore e di danno.
La ferita dona una speciale sensibilità e una capacità di faremergere nuove e profonde consapevolezze.
E’ anche la condizione necessaria perché l’eccesso di potenzache ha chi cura sia messo in crisi e la ferita consente a chi laelabora un approfondimento psichico.
2. Ermenutica immaginale
Il percorso proposto da Mottana ai partecipanti al corso è statodi tipo ermeneutico e immaginale, quindi ha invitato i corsisti adosservare le opere mantendo fedeltà all’immagine e decentrandosida sé, cercando di comprendere il messaggio dell’opera piuttostoche le proprie reazioni. La sospensione del giudizio in questicasi, aiuta la ricettività dell’opera e fornisce la massimaesplorazione.
Dapprima c’è stata una riflessione ed elaborazione individualepoi esplicitate e discusse in gruppo, dove la materia immaginativapuò liberare il suo potenziale semantico, e infine la restituzioneche ha portato ad alcune sintesi delle principali aree disignificato emerse.
3. Opere La leggenda del re pescatore - Il film ha permesso di trattarevari temi: la colpa, l’elevazione e la caduta, l’esposizione altragico (tipica di chi sta al mondo e non è ancora stato segnatodalla ferita) rapporto tra parola e immagine (il deejay si senteonnipotente finchè non visto, al programma in tv sarà uno deitanti) dell’ossessione autobiografica come tamponamentodell’avanzare del nulla.
Uno sguardo immaginale su questo film fa di questa opera uncorso di riflessioni sulla formazione attraverso la ferita. (Parry(personagggio sotterraneo che ha perso la moglie. Oggi vive diimmaginazione letteraria che prima gli dava da vivere comedocente, si mette a seguire il Graal e cerca il suo Parsifal cheglielo recuperi. Jack (ex deejay caduto negli abissi a causa di
32
un’uomo che ha compiuto una sparatoria dopo avere ascoltato la suatrasmissione) incontra Parry e i loro destini si incrociano dandoil via ad un viaggio di guarigione reciproca.)Noi non siamo gli ultimi - Il pittore Music dopo essere statodeportato a Dachau dipinge uomini denudati, prosciugati, sul puntodi dissolversi e afferma che “noi non siamo gli ultimi” cioè non èvero che dopo di loro nessun uomo avrà un destino così crudelecome quello degli ebrei nei campi di concentramento.
Il pittore getta il suo sguardo nei lati più oscuri dellaferita. Le sue tele restituiscono tutto il sale che la ferita,quando è davvero profonda e abita per parecchio tempo il corpo ela mente di un essere umano, può secernere. Lui sostiene cheDachau gli ha permesso di trovare la sua verità e gli ha conferitopeso e baricentro.Il cuore pulsante della baracca - La scrittirce Hillesum ci offrela sofferta discesa di una giovane di buona famiglia nel baratropiù profondo del secolo scorso. La ragazza deceduta ad Auschwitzscopre un dio interiore che le da il coraggio di seguire ilproprio destino di morte. I suoi scritti costringono a misurarsicon una ferita che permette di scavare nella propria interiorità;lei afferma che da ogni esperienza si può ricavare qualcosa dipositivo, ma dice anche che non si deve afuggire a nessunacircostanza.
4. Elaborazione L’ingresso nella ferita è salvifico, perché nella ferita si troval’anima.Una necessità della formazione di oggi è proprio quella diispessire un immaginario spesso povero, denominato da stereotipi.
Sarebbe importante incontrare il dolore non solo sotto formadi casi, ma di persone significative, che lo portano addosso.Il dolore è un’esperienza che non si lascia comprimere in nessunoschematismo, è esperienza abissale e intollerabile, ma che puòessere vissuta e abitata e può produrre forme di revisione dellosguardo al proprio interno e all’esterno da sé.
33
DIFFERENZA DI GENERE: I DUE LATI DELLA FORMAZIONE(Marcialis)
1. Questioni inattuali?
La differenza di genere è una dimensione originaria del nostromodo di essere al mondo: si nasce maschi e femmine e si è educatida maschi e da femmine.L’aspetto della differenza di genere è abbastanza in ombra equindi è un oggetto preferenziale per la CdF.
La Irigaray studiando l’inconsio femminile agli inizi del 900afferma l’impossibilità del mondo occidentale di poensare ildiverso perché il nostro pensiero poggia sul predominio dell’Unorispetto al molteplice e sul principio dell’identità, perciò noipensiamo all’altro solo sotto forma di mancanza e di sottrazione.
La differenza sessuale è una dimensione fondativa della nostraesperienza di vita
in che modo questa differenza marchia l’esperienza educativa di ciascuno di noi?
Come la differenza di genere si incrocia con la struttura simbolica del linguaggio?
La ricerca sul campo
Percorso di ricerca impostato su 3 indicazioni comunicative(deissi) e il lavoro si è strutturato in piccoli gruppi.
1.Deissi interna: riflessione su un episodio significativoaccaduto ai corsisti. La differenza di genere viene incontratacome dimensione non pacificata. Episodio dell’ambulanza (costituire una squadra con autista e caposquadra). Questo episodio ci fa riflettere su come si diano perscontate certe regole che stannoa alla base di alcuneorganizzazioni e su cui non c’è possibilità di riflessione, ledonne in questo caso possono solo subire la consuetudine. Episodio del c.a.g. ( l’educatore maschio e l’educatrice femminachiedono di abbassare il volume dello stereo). Le risposte deiragazzi sono molto diverse. Nei confronti dell’educatore maschioci si pone in un clima di sfida, mentre nei confrontidell’educatrice femmina scatta il rispetto, legato al gesto di
34
cura e al gesto erotico, che in questo caso smorzanol’aggressività. In questo caso il sesso dell’educatore è undispositivo educativo.
La donna può convivere creativamente nei meandri di un doppiovincolo? A questi, le donne dovrebbero rispondere con modalità dilinguaggio performativo e creativo (educatrice che abbassa ilvolume dello stereo.)
Episodio di gruppo di ragazzini ed un educatore sullaspiaggia. (L’ed. non li porta a giocare a biliardo perché c’è unaragazzina e non vuole essere frainteso). L’assenza di un contestoeducativo formalizzato non protegge l’educatore che si fa prenderedalla sua visione da maschio.
Il linguaggio sessuato e la presenza sessuata delle donne nelmondo dell’educazione devono fare i conti con codici non scritti econ ambienti poco strutturati che caratterizzano questi mondieducativi.
2.Deissi esterna: film l’albero di Antonia (albero genealogicodella protagonista). Antonia da una parte usa un linguaggio fattopiù di gesti per incoraggiare, insegnare, valorizzare, rispettare.
Dall’altra parte usa poche parole per maledire l’uomo che haviolentato la sua nipotina, non riuscendo ad ucciderlo pronunciaparole di fuoco e con queste parole riesce ad esprimere tutta lasua rabbia senza essere violenta.
Viene ribadita l’importanza del gesto educativo comelinguaggio segnato dalla differenza di genere. Il tema delledifferenze di genere si annida nelle rappresentazioni socialiveicolate da un linguaggio che si propone come neutro. Semprenelle pieghe del linguaggio scopriamo che la donna vieneselezionata, non privilegiata, ma nemmeno sempre penalizzata.
La classe insegnante è fortemente femminilizzata, quindi lascuola può essere un contesto attento alla differenze di genere?
3.Deissi simbolico proiettiva : composizione di 3 collages diimmagini da riviste e giornali 1- lavoro per opposizione, cioè ad ogni luogo comune di uomo èstato associato quello comune di donna. 2- scultura di uomini edonne che si mescolano e si rincorrono, per rappresentare unapossibile zona di pacificazione dei sessi. 3- lavoro sul bianco esul nero come possibilità di rappresentare le emozioni e isilenzi, il lavoro manuale e quello di memoria, sulle tracce di unfemminile che però tiene dentro anche il maschile.
35
LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PROFESSIONALE(Varani)
La scelta della propria professione è legata sia all’immaginepersonale sia all’immagine sociale di sé. Il lavoro costituisceuna fonte di identità e di senso di valore personale e in questastrada si colloca ogni percorso formativo, anche in età adulta.
L’approccio usato nel corso è stato improntato al costruttivismo,che afferma che l’interazione di un individuo con la realtàavviene attraverso personali processi di costruzione disignificato in continua interazione con la conoscenza dellacomunità sociale.
L’orientamento è finalizzato a sviluppare l’empowerment(accrescimento spirituale, politico, sociale, o della forzaeconomica di un individuo o di una comunità. Spesso tale concettofa riferimento allo sviluppo della fiducia nelle propriecapacità.) promuovendo una azione diretta nella scelta delpercorso formativo e professionale e l’orientatore diventaascoltatore attivo che aiuta il cliente a reinterpretare la suavita e ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte.
Nell’approccio socio-costruttivista viene negato il rapportodiretto tra insegnamento e apprendimento quest’ultimo viene vistocome risposta possibile al dispositivo formativo che il docentedispone. Quindi ci si è posti partendo dall’immaginario e dalle attese cheogni corsista proiettava sulla professione. E’ stato fatto unasorta di brain storming per confrontare e negoziare nel gruppo lediverse concezioni sulla figura del tecnico delle risorse umane.
E’ stato poi fatto un lavoro di conoscenza del mercato del lavoroe dei percorsi formativi. E’ stato costruito un iper testodigitalizzato e attraverso la co-costruzione di questo prodotto ènata una piccola comunità di pratica. Ogni membro ha nellacomunità una diversa partecipazione e un diverso grado diidentificazione e tutti hanno una conoscenza che è inferiore aquella del gruppo; le dinamiche di collaborazione tra i membripermettono a tutti di migliorare le proprie conoscenze atraversola pratica.
L’adulto impara solo se ciò che impara si connette a ciò che sagià. L’apprendimento di un adulto è frutto di una ricerca attiva e
36
autonoma, suggerita da un docente facilitatore, ma maicompletamente guidata. L’adulto in formazione è sempre co-autoredel suo processo di apprendimento. Chi lavora con gli adulti devequindi creare e favorire le condizioni perché i soggetti informazione apprendano ad apprendere, cioè favorire lo sviluppo diun apprendimento autonomo in modo da costituire la base per lafutura autoistruzione permanente.
37
RIASSUNTO LIBRO
La formazione clinica condivide scelte con altri approccieducativi come la formazione degli adulti, presentandocaratteristiche e categorie attive, euristiche, costruttive,interattive nel complesso dell’acquisizione del sapere e dellerelative e rispettive competenze, ripercorrendo la centralitàdella dimensione apprenditiva e la priorità nella conoscenza deiprocessi di attribuzione del significato e dell’acquisizione deisaperi.
I modelli del pensiero e dell’azione si rivelano comestrategie mentali e operative. Nella zona residuale del processodi dispositivo della clinica qualcosa sfugge e denuncial’impossibilità di controllare i contenuti del pensiero di ogniindividuo. La cornice artistica è la metafora teatrale nellapratica di trasfigurazione del dispositivo per restituire e donareal mondo, con portato narrativo, elaborazione creativa, conoscenzaed eticità, il palcoscenico della formazione nella suacomplessità.
Dall’opera di Focault il dispositivo rappresenta la strutturaportante delle pratiche di potere che conducono alla costituzionedella soggettività in senso moderno. Il dispositivo indica losvolgersi dell’accadere educativo rispetto a condizioni materiali,culturali, simboliche e sociali con reciproci intrecci e stantiesedimentazioni.
La ricerca sul campo è un percorso euristico impostato suindicazioni comunicative, quali deissi (dal greco deiktnain =indicare). La deissi può essere interna con valore emblematico econ discussioni in sottogruppi e esterna con la proposta di unfilm o un argomento da discutere. La deissi simbolico/proiettivasi sviluppa con laboratori di elaborazioni fantastiche eimmaginative creatività.
Mediante questi complessi processi, tramite dinamicherelazionali forti e pregnanti di senso, si formano l’autostima,l’autoefficacia e il locus of control, principi educativiessenziali per lo sviluppo di comportamenti e aspettative.
La CdF è una pratica di ricerca, consulenza e supervisione cheesplicita dimensioni latenti di esperienza educativa e formativa aqualunque età e contesto in cui narrare, esplorare modelli
38
cognitivi, sperimentare dinamiche affettive nell’ambito didispositivi pedagogici.
DEISSI
Vocabolo che significa indicare, far conoscere, mostrare. La deissi rappresenta una parte didattica all'interno di un percorso di CdF e prevede la consegna al coordinatore pedagogico di esercitazioni di riflessioni e spunti autobiografici interiorizzati dopo la condivisione e l'assimilazione dialogica, tramite discussione collettiva, nell'ambito dei gruppi di studio.
Le deissi costituiscono in senso lato delle stanze di elaborazione attenta e sistematica delle esperienze rievocate dal gruppo che collettivamente e individualmente analizza i vissuti riportati in sede di discussione e propone anche delle risoluzioniin base a esperienze ricavate dallo studio della pedagogia e dellapsicologia, dando vita alla CdF, ossia all'analisi clinica in ambito pedagogico.
Le fasi consequenziali del setting di CdF sono caratterizzate daescursioni esplorative, vale a dire DEISSI, termine per indicareuna zona della personale,individuale e soggettiva esperienza.
1) Deissi interna ( o anafora), vale a dire un indice puntatoverso la nostra esperienza individuale
2) Deissi esterna (o catafora), vale a dire l'indice dellatensione interrogante è verso l'esterno, usando la trama diun film.
3) Deissi simbolico-proiettiva o fantasmatica (o diafora), valea dire l’indice è rivolto a ciò che non è presente, al campoimmaginario dell’artista, pittore o attore, che presentificauna realtà che non è presente, ma che si inserisce nel nostrocampo percettivo.
La deissi è un gesto legato all’apprendimento tramite la praticaesperienziale di vita.
39