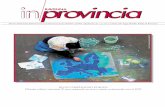Piero Treves: tradizione italiana e cultura europea
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Piero Treves: tradizione italiana e cultura europea
« Storiografia » · 16 · 2012
studi
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea*
Carlo Franco
“Il grande travaglio della cultura classica italiana per tutto l’arco del nostro secolo è stato un travaglio correlativo, convergente, dialettico di storicizzazione del passato e di raccordo alla tradizione del passato. Né l’un processo sta senza l’altro. Già il Burckhardt nel volume pro-fetico delle Weltgeschichtliche Betrachtungen definiva in termini di “barbarie” la rottura della tradizione. Questa, d’altronde, in tanto è una realtà ed una fonte, in quanto non rappresenti né un modello accademico né un’idea pseudo-platonica, ma lo specchio medesimo del no-stro passato, e suggerisca, pertanto, la consapevolezza del nostro retaggio. Werner Jaeger, il suo Terzo Umanesimo, cui credette l’Italia migliore degli anni Trenta come ad uno stru-mento, quantunque fragile, per arginare l’imbarbarimento dell’Europa, e quanto più contro gli uomini e i metodi del Terzo Umanesimo insorgevano gli uomini e i metodi del Terzo Reich, li ritengono oggi tramontati i vari filologi, tecnocrati, marxisti, gli uomini dello storici-smo populista che mareggia qua e là, e soprattutto vorrebbe distruggere l’antropocentrismo e l’eurocentrismo della storia. Può essere, può non essere. È dubbio, infatti, se gli storici, massima gli storici dell’Antico, possano mai consentire a non essere eurocentristi. L’Europa comunque, ed è Europa quanto è umana civiltà, conobbe, a fondamento del suo essere e a
* Il saggio qui pubblicato con alcune modifiche e integrazioni è apparso originariamente come in-troduzione a P. Treves, “Le piace Tacito ?”. Ritratti di storici antichi, Torino, Aragno, 2011, pp. vii-liii (v. C. F. Russo, « Belfagor » lxvii, maggio 2012, p. 366 ; G. Bandelli, « Rivista Storica Italiana » c.d.s. : ringra-zio l’A. per avermi messo a disposizione il testo, e per i molti suggerimenti). Su Treves in generale v. M. Gigante, Piero Treves (1911-1992), Napoli, Istituto Italiano Studi Storici, 1992 (= « Annali Istituto Italiano Studi Storici », xii, 1991/1994, pp. 681-708) ; su cui C. Franco, « Rivista di storia della storiografia », xv, 1994, pp. 227-31 ; v. già M. Gigante, « Atene e Roma », xxxii, 1987, pp. 52-57 ; R. Pertici, Piero Treves storico di tradizione, « Rivista Storica Italiana », cvi, 1994, pp. 651-733 (poi in Id., Storici italiani del Novecento, « Sto-riografia », iii, 1999, pp. 199-257, con un’appendice su Treves in Inghilterra 1938-1955 : un osservatore politico, pp. 259-64), entrambi qui presupposti ; D. Musti, s.v. Treves, Piero, in Enciclopedia Italiana, Appendice 2000, vol. **, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 2000, p. 895. Importante A. Cavaglion, Prefazione, in P. Treves, Scritti novecenteschi, a cura di A. Cavaglion, A. Gerbi, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. vii-xxiii ; l’elenco delle pubblicazioni in Piero Treves. Dal 1930 al 1996, a cura di C. Franco, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1998.
Carlo Franco24
segnacolo del suo divenire, una parola, una parola greca e platonica, divenuta, per merito di Werner Jaeger, universalmente popolare : paideia. E il primo libro delle Leggi platoniche insegna tuttavia perennemente che paideia apporta anche la vittoria”...”
Con queste parole Piero Treves concludeva, negli anni ’60 del secolo scorso, una serie di conversazioni radiofoniche (inedite) su temi della cultura classica : e so-
no parole emblematiche, da cui traspaiono con grande chiarezza le caratteristiche dello studioso, il suo stile, le sue posizioni culturali, anche la sua programmatica ‘inattualità’ di storico, di interprete del mondo antico e, soprattutto, dell’eredità classica nella tradizione italiana e quindi europea.
Piero Treves era nato a Milano il 27 Novembre 1911 da Claudio e Olga Levi : come amava ricordare, il giorno prima, nel teatro di Barga, il Pascoli aveva letto il suo discorso sulla guerra di Libia (La grande proletaria si è mossa) ; l’indomani la sede del quotidiano socialista Avanti !, diretto allora da Claudio Treves, fu assalita dalla ca-nea degli studenti nazionalisti che operarono la prima strumentalizzazione politica del discorso, attaccando l’atteggiamento antilibico del giornale : il cui direttore non poté quindi essere al fianco della moglie in occasione della nascita del secondoge-nito. 1
In questa coincidenza si può ben vedere il segno di un destino, o meglio ancora di un radicamento in un ambiente e in una cultura a cui Piero Treves nel corso della sua vita sempre restò, e sempre più divenne, fedele. Il primo ambito da ricordare è quello del riformismo socialista, che caratterizzò l’esperienza della famiglia sotto la guida carismatica del padre Claudio : 2 alla figura paterna il giovane Piero dovette una intensa formazione culturale, morale e politica. La mediazione familiare, in cui fu significativa anche la presenza dello zio materno Alessandro Levi, lo portò ad una partecipata e vasta conoscenza della tradizione culturale italiana (come mostra la passione totale per Carducci), ma anche a significative aperture europee, soprat-tutto di area anglo-francese. 3 In gioventù conobbe figure molto importanti della politica italiana, come Francesco Saverio Nitti, Giacomo Matteotti, Filippo Turati e Anna Kuliscioff, e altri. Tutto ciò consentì a Treves, come anche al fratello Paolo 4 (1908-1958), futuro studioso del pensiero politico europeo, di formarsi una precoce coscienza politica, divenuta particolarmente chiara con il delitto Matteotti.
Dopo gli attentati a Mussolini, l’indurimento repressivo del regime e l’esilio di Claudio Treves, Olga Levi e i figli rimasti in Italia patirono un lungo periodo di sorveglianza speciale da parte della polizia, con pedinamenti e controlli : il clima
1 P. Treves, Nel centenario di Claudio Treves, « Critica Sociale », lxi, 1969, pp. 681-85 (= Scritti novecen-teschi, cit., pp. 17-26).
2 Su Claudio Treves (1869-1933) deputato dal 1906 e direttore dell’Avanti ! dal 1910 al 1912 v. A. Casali, Socialismo e internazionalismo nella storia d’Italia. Claudio Treves 1869-1933, Napoli, Guida, 1985 ; Id., Claudio Treves. Dalla giovinezza torinese alla guerra di Libia, Napoli, Guida, 1989, part. pp. 17ss. sulla formazione.
3 A. Cavaglion, s.v. Levi, Alessandro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 64, 2005, pp. 746-49.4 Paolo Treves (1908-1958), già collaboratore di Filippo Turati, svolse negli anni ‘30 attiva militanza
antifascista, subendo anche arresti. Pubblicò numerosi studi di storia del pensiero politico, su Campa-nella, Guicciardini, Sarpi, De Maistre. Emigrato in Gran Bretagna nel 1938, svolse nell’esilio un’intensa attività politica. Docente di Storia delle dottrine politiche a Firenze, eletto alla Costituente, fu poi de-putato socialdemocratico e sottosegretario al commercio estero (1954-1957).
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 25
di quegli anni difficili fu poi rievocato da Paolo Treves con accenti accorati. 1 Piero proseguiva intanto la formazione culturale : gli studi liceali presso il “Manzoni” di Milano lo portarono ad alcuni incontri importanti : notevole soprattutto quello con Antonio Maria Cervi, insegnante di latino e greco. 2 Ma la frequenza scolastica fu interrotta a causa di un decreto di espulsione, quando il giovane evitò di salutare romanamente a scuola la lapide dei caduti. 3 Treves concluse gli studi da privatista, conservando però una forte amicizia per un’altra allieva di Cervi, la poetessa Anto-nia Pozzi. 4 Dal 1927 al 1931 frequentò l’Università prima a Torino, poi a Roma, dove si era trasferito il suo maestro, Gaetano De Sanctis. 5
L’atmosfera dell’ateneo torinese in quegli anni è stata rievocata più volte : 6 vi si formò un’intera generazione di intellettuali italiani, destinati a lasciare segni fon-damentali nello sviluppo del paese. Nell’ambito degli studi sull’antichità la figura dominante era appunto quella di De Sanctis, allievo di Julius Beloch a Roma, ap-prodato a Torino come professore di Storia Antica nel 1900. Alla fine degli anni ‘20 la sua scuola aveva già espresso allievi di notevole spessore, come Enrico Pozzi (scomparso giovanissimo nel 1912), Aldo Ferrabino, Luigi Pareti, Mario Attilio Levi e, di poco più vecchio di Treves, Arnaldo Momigliano. A Torino De Sanctis dirige-va anche dal 1923 insieme ad Augusto Rostagni, suo allievo voltosi poi agli studi di letteratura, l’importante “Rivista di Filologia ed Istruzione classica”, divenuta in quegli anni una autorità di metodo e ricerca. 7
L’incontro con questo ambiente fu particolarmente significativo : la lezione di De Sanctis, che era passato dal tecnicismo positivista dei primi lavori ad una ri-flessione etica, corrispondeva allo spirito inquieto di Treves, sollecitato contem-poraneamente dalla ricerca filologica di Rostagni. Da questi stimoli egli fu spinto anche a meditare l’esempio di Benedetto Croce, il cui contributo estetico e critico si faceva allora sentire anche nel campo degli studi classici. Naturalmente il magi-stero del cattolico De Sanctis e quello del ‘laico’ Croce discendevano da due cul-ture diversissime per impostazione e finalità della ricerca, che si trovarono spesso in conflitto prima di riunirsi nell’opposizione al regime fascista : nella formazione
1 Paolo Treves, Quello che ci ha fatto Mussolini, Torino, Einaudi, 1945 (rist. Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1996). 2 Per cui v. Pertici, Piero Treves, cit., pp. 674 ss.
3 L’episodio è rievocato in http.//www.liceomanzoni.it/didattica/SintesiOltrelamemoria2005.pdf, p. 3.
4 Sulla figura v. G. Bernabò (cur.), “E di cantare non può finire...”. Antonia Pozzi (1912-1938). Atti del Convegno, Milano, 24-26 novembre 2008, Milano, Viennepierre, 2009.
5 Sulla cui figura Treves tornò in più occasioni : v. la voce De Sanctis, Gaetano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 39, 1991, pp. 297-309 ; particolarmente importanti Gaetano De Sanctis, « L’osservatore poli-tico-letterario », iii, 1957, pp. 49-65, (riproposto con modifiche in Tradizione classica e rinnovamento della storiografia, Milano-Napoli, Ricciardi, 1992, pp. 439-57), e Nel centenario di Gaetano di Sanctis, « Il Veltro », xiv, 1970, pp. 217-55 (= Scritti novecenteschi, cit., pp. 27-72). Un ripensamento molto acuto ha proposto E. Gabba, Riconsiderando l’opera storica di Gaetano De Sanctis (1971), in Id., Cultura classica e storiografia moderna, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 299-322, con bibliografia ulteriore.
6 Soprattutto da C. Dionisotti, Ricordo di Arnaldo Momigliano, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 12ss. ; 65ss ; Pertici, Piero Treves, cit., pp. 679ss. ; L. Cracco Ruggini, Gli anni d’insegnamento a Torino, in Ar-naldo Momigliano nella storiografia del Novecento, a cura di L. Polverini, Roma, Edizioni di Storia e Lette-ratura, 2006, pp. 77-123.
7 E. Gabba, Il secondo cinquantennio della “Rivista di Filologia e di Istruzione Classica” (1972), in Id., Cultura classica, cit., pp. 237-86.
Carlo Franco26
dei più giovani, come Treves e Momigliano, questo incontro ebbe esito travagliato ma fecondo. 1
Appunto all’intersezione tra storia, letteratura e magistero crociano si collocano, nel 1930 (dunque prima della laurea) i primi saggi a stampa di Piero Treves, dedicati al teatro di Sofocle ed Euripide. 2 Anche Momigliano studiava nello stesso periodo, pure su influsso di Croce e di Rostagni, la cultura ateniese del quinto secolo : fu questo, così, il primo ambito di confronto tra i due studiosi, destinati a un difficile dialogo per quasi sessant’anni. 3 Entrambi consapevoli del dibattito contemporaneo sul mondo antico, essi saggiarono in questi giovanili lavori l’applicazione ai testi del teatro greco di categorie crociane. Per Momigliano tali studi, forse originati da seminari universitari, furono un passaggio verso una considerazione storica della cultura greca ; per Treves invece l’interesse letterario, in una intensa circolarità tra antico e moderno, rimase sempre vivo, quale sua peculiare caratteristica. Le sue scritture giovanili dimostrano cultura vasta e aperta in molte direzioni, e una perso-nalità spiccata, in qualche caso esuberante : anche sull’esempio delle prose paterne, Treves fin dai suoi primi lavori esibì uno stile ispirato, alto, spiritualistico, ricco di accostamenti, di metafore suggestive e talora azzardate, ma anche di spunti polemi-ci. Ciò lo espose a fraintendimenti e soprattutto a critiche : le sue note su Euripide suscitarono la reazione di Momigliano, 4 le note su Sofocle un attacco di Gennaro Perrotta, rintuzzato seccamente da De Sanctis. 5 Al di là di un dibattito oggi supe-rato, conta notare nei due giovani studiosi, nel decisivo confronto con la lezione autorevole di Croce, il problematico tentativo di superamento dello storicismo. In questo senso merita attenzione anche la precoce polemica su Euripide, preludio di più importanti scontri : il gruppo vicino a De Sanctis dialogava con franchezza su te-mi affini, trasferendo senz’altro il dibattito interno nelle pubblicazioni a stampa. Ne risultava un dialogo vivacissimo ed intenso, il cui modello non troppo remoto era il confronto (non esente da durezze) tra De Sanctis e il più anziano allievo Ferrabino sul problema della libertà in Grecia.
Nel 1931, anno in cui pubblicò tra l’altro il suo primo lavoro di argomento pro-priamente storico, 6 Treves conseguì la laurea, il 19 novembre. Il momento era par-ticolarmente significativo. Gaetano De Sanctis, a causa del suo rifiuto a prestare il giuramento al fascismo, fu poco dopo costretto a lasciare il magistero universitario,
1 Dionisotti, Ricordo, cit., pp. 30ss. 2 Le “Fenicie di Euripide”, « Atene e Roma », xi, 1930, pp. 171-95 ; Interpretazioni dell’arte e del teatro di
Euripide, « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lviii, 1930, pp. 306-10, e anche le recensioni, ivi, pp. 356-58, e « La Nuova Italia » i, 1930, pp. 470-72.
3 C. Franco, « Athenaeum », xcvi, 2008, pp. 431-39. 4 A. Momigliano, Il mito di Alcesti in Euripide, « La Cultura », ii, 1931, pp. 201-13 (= Quarto contributo
alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969, pp. 167-80, part. pp. 178s.).
5 G. Perrotta, L’arte di Sofocle, « La Nuova Italia », ii, 1930, pp. 139-47 ; P. Treves, Interpretazioni so-foclee, « Civiltà Moderna », iii, 1931, pp. 70-83 ; G. Perrotta, Sofocle Cristiano, ivi, pp. 357-62 ; P. Treves, Sofocle cristiano, ovvero il fantasma del Prof. Perrotta, ivi, pp. 563-67 ; G. De Sanctis, Cerberi della banalità contro le interpretazioni sofoclee di P. Treves,« Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lix, 1931, pp. 276-77 (= Scritti Minori, vi/2, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1972, pp. 819-21) : v. Dionisotti, Ricordo, cit., p. 35s.
6 P. Treves, Dopo Ipso, « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lix, 1931, pp. 73-92, 355-76.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 27
sicché la discussione del lavoro di Treves su Demostene fu tra i suoi ultimi atti di professore. 1 La fase più intensa di attività scientifica per Treves iniziò dal 1932. A quell’anno appartengono tra l’altro due lavori destinati a suscitare discussioni accese che andarono oltre il dissenso metodico interno alla scuola di De Sanctis e approdarono (come allora accadeva per i temi dell’antico, ben più di oggi) alla cultura italiana.
Origine del dibattito fu un saggio di Momigliano su Annibale politico. In esso, prendendo le distanze dall’interpretazione di De Sanctis, la sconfitta del condottie-ro cartaginese era vista come sconfitta del mondo ellenistico. 2 Replicava pochi mesi dopo il De Sanctis in un saggio dei Problemi di storia antica, il volume di scritti pub-blicato dopo che la decadenza dall’insegnamento universitario : 3 vi si contestavano l’interpretazione ‘ellenistica’ di Momigliano e le critiche rivolte all’azione politica di Annibale, dando un notevole riconoscimento alla maturità scientifica dell’allievo, ma anche alla sua precoce indipendenza di giudizio. Si inserì nel dibattito anche Tre-ves, con uno studio su Le origini della seconda guerra punica. 4 In esso ribadiva, contro Momigliano e anche contro De Sanctis, la responsabilità di Roma nella violazione del trattato con Cartagine e il merito del vinto Annibale, contro ogni tentazione di finalismo storico. La questione giuridica e il giudizio su Annibale erano ormai superati da un dilemma di fondo sul senso della storia. Benedetto Croce segnalò l’intervento su “La Critica”, 5 valorizzando in tal modo l’opera di un giovane storico emarginato per ragioni politiche ; ma la querelle faceva emergere anche la frattura interna alla scuola di De Sanctis. 6
Vi erano anche altri risvolti : Croce poté criticare De Sanctis per l’implicito razzi-smo dei suoi ripetuti accenni ad Annibale “semita”, 7 mentre da parte fascista Treves fu accusato simmetricamente di essere uno storico “cartaginese” ossia antiroma-no. 8 L’attacco era esplicitamente politico : il figlio dell’esule era un ribelle al regime e il suo rigetto scientifico della greve romanità fascista era appunto il segno chiaro di
1 Scriveva De Sanctis a Plinio Fraccaro il 27 Dicembre 1931, nei giorni dolorosi della crisi seguita al mancato giuramento : « Il giovane P[iero] T[reves] è uno de’ miei migliori scolari e si è laureato di recente con molto onore in Roma. Se la mia vita accademica dovrà chiudersi, è bene che si chiuda con una tale laurea » : L. Polverini, Fraccaro e De Sanctis, « Athenaeum », lxiii, 1985, pp. 68-113, a p. 112.
2 A. Momigliano, Annibale politico, “La Cultura”, iii, 1932, pp. 61-72 (= Quinto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, 333-45) : v. Dionisotti, Ricordo, cit., pp. 38ss.
3 G. De Sanctis, Problemi di storia antica, Bari, Laterza, 1932 : il capitolo vii, Annibale e la « Schuldfrage » d’una guerra antica (pp. 161-86) era inedito ; altri saggi erano già apparsi altrove.
4 « Atene e Roma », xiii, 1932, pp. 14-39.5 B. C. « La Critica », xi, 1933, 44-45, poi in Conversazioni Critiche, v, Bari, Laterza, 19512, pp. 186-88.6 Nel dibattito era entrato anche Luigi Pareti, direttore di “Atene e Roma”, prendendo le distanze
dalla valutazione di Treves (« Atene e Roma », xiii, 1932, pp. 39-43 = Studi Minori di Storia antica, iii, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, pp. 141-45). Gli replicò tagliente De Sanctis, « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lx, 1932, pp. 426-27 (= Scritti Minori, vi/2, cit., pp. 846-47), in difesa di Treves (e di Momigliano, a proposito di un altro lavoro). Sulla questione v. Dionisotti, Ricordo, cit., 41s. ; sulla posizione di Pareti v. E. Lepore, Luigi Pareti (1885-1962), in Praelectiones Patavinae, a cura di F. Sartori, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1972, pp. 43-74, a p. 67.
7 L’antisemitismo di De Sanctis veniva anche da Beloch o dalla tradizione del Trezza, come Treves più volte ripeté, anche contro Momigliano : per esempio nella voce De Sanctis del Biografico, cit.
8 Ebreo, per di più. C. Scano, Uno storico cartaginese, « Historia », vii, 1933, pp. 331-37.
Carlo Franco28
una alterità politica. Una vicenda analoga, alcuni anni dopo, riguardò una rassegna di studi su Cesare che Treves pubblicò nel 1935, ironicamente avversa al culto della romanità : il fascicolo della rivista che l’ospitava fu sottoposto a sequestro. 1
Assai più rilevante, per l’aperto carattere politico e per le dimensioni storico-culturali, fu un altro dibattito che dalla storia greca e dalla scuola desanctisiana approdò alla scena culturale italiana : varie ne sono state le ricostruzioni. 2 Nel 1929 Aldo Ferrabino, professore a Padova, aveva manifestato ne La dissoluzione della li-bertà nella Grecia Antica il suo senso pessimistico e le sue riserve antiliberali circa il senso della storia greca, soprattutto in relazione al confronto con Roma. L’analisi era assai lontana dalle posizioni di De Sanctis, che replicò difendendo il carattere della libertà greca. 3 Il dibattito poi si allargò a seguito di un autorevole intervento di Croce, 4 sul quale si espressero in termini opposti, a riprova dell’urgenza del pro-blema, Momigliano e Ferrabino. 5 Questi sottolineò, entro il quadro delle proprie convinzioni, la necessità di distinguere (come Croce non faceva) Grecia e Roma ; Momigliano invece pose il tema della libertà al centro del proprio ripensamento della storia antica, soprattutto per l’età ellenistica e l’impero di Roma. 6 Lo si nota dal successivo sviluppo contenuto nei Contributi alla caratteristica di Demostene, 7 la-voro che superava il dilemma dell’esaltazione o della critica, per approdare ad una analisi storica : il politico ne usciva ridimensionato, la sua azione giudicata frutto di una radicale incomprensione dell’avversario Filippo e di una debole ideazione poli-tica generale, entro un concetto pur sempre limitato di libertà.
Il saggio, contemporaneo all’elaborazione della tesi di laurea di Treves discussa a fine del 1931, 8 segnò una forte spaccatura tra i due giovani allievi di De Sanctis. Al
1 Interpretazioni di Giulio Cesare, « La Cultura », xiii, 1935, pp. 129-32, ripubblicato in « Quaderni di Sto-ria », xxxvii, 1993, pp. 119-26, con introduzione di C. Franco (pp. 115-18) che ricostruisce la vicenda.
2 G. Sasso, Il Contributo di Arnaldo Momigliano, in Il guardiano della storiografia. Profilo di Federico Cha-bod e altri saggi, Napoli, Guida, 1985, pp. 189-256, alle pp. 222ss. ; Gabba, Cultura classica, cit., pp. 253ss, 272ss. e 394ss. ; H. Bracke, Il problema della libertà nella vita e nel pensiero di Arnaldo Momigliano, « Ancient Society », xxiii, 1992, pp. 297-323, in part. pp. 300ss. ; E. Gabba, Riflessioni storiografiche sul mondo antico, Como, New Press, 2007, pp. 197ss. Il contesto del dibattito è discusso in F. Tessitore, Il problema delo storicismo in Italia, in Federico Chabod e la “nuova storiografia” italiana, 1919-1950, a cura di B. Vigezzi, Mi-lano, Jaca Book, 1984, pp. 313-47, pp. 328ss., (= Id., Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000, pp. 9-40).
3 « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lviii, 1930, pp. 230-45 (= Scritti minori, vi/1, cit., pp. 439-55).
4 Constant e Jellinek intorno alla differenza tra la libertà degli antichi e quella dei moderni, Napoli, Sangio-vanni, 1930 ( = Etica e politica, Bari, Laterza, 1931, pp. 294-301).
5 Rispettivamente « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lix, 1931, pp. 262-64 (= Quinto Contribu-to, pp. 906-07) e « La Nuova Antologia », lxvi, 1931, pp. 386-91 (= Scritti di filosofia della storia, Bologna, Za-nichelli, 1962, pp. 89-95). Sulla relativa vicinanza delle due posizioni v. Dionisotti, Ricordo, cit., p. 37s.
6 Un passo verso le successive indagini : v. A. Momigliano, Pace e libertà nel mondo antico. Lezioni a Cambridge : gennaio-marzo 1940, a cura di R. Di Donato, Firenze, La Nuova Italia, 1996 (= testo originale inglese in Decimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 3-105).
7 « Civiltà Moderna », iii, 1931, pp. 711-44 con la postilla di chiarimento, ivi, pp. 975-76 (= Quinto Contri-buto, cit., pp. 235-66). Sul dibattito v. M. Cagnetta, Demostene, i simboli e la muffa, « Eikasmos », v, 1996, pp. 277-95.
8 Importante dunque la sequenza cronologica degli interventi : v. M. Cagnetta, Antichità classiche nell’Enciclopedia Italiana, Bari-Roma, Laterza, 1990, pp. 121ss.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 29
profilo demostenico di Momigliano, Treves replicò contestando il giudizio severo espresso sull’azione storica e ideale di Demostene in rapporto a Filippo e la lettura del panellenismo in prospettiva ellenistica : 1 la prospettiva di Momigliano veniva polemicamente accostata alle posizioni di Mario Attilio Levi e Aldo Ferrabino. Il giudizio era politico, più ancora che scientifico : Treves riteneva ineludibile fare del-la storia antica uno strumento di pensiero contro il regime, 2 mentre Momigliano non era toccato dal pensiero che il proprio percorso potesse apparire politicamente ambiguo e quindi inopportuno, e che la negazione di ogni accostamento con i di-fensori della libertà degli antichi sminuisse l’azione degli antifascisti. 3 Così le strade si erano definitivamente divaricate.
Nel 1933 Treves stampò presso la “Biblioteca di Cultura moderna” di Laterza (la stessa collana in cui De Sanctis aveva pubblicato i Problemi) il suo Demostene e la libertà greca, che studiava l’azione di Demostene da Cheronea alla guerra Lamiaca e alla morte. Anche in questo caso Treves rivendicava il valore di una victa causa at-traverso vivaci suggestioni del presente. L’Alessandro a cui l’oratore si oppose non era (ancora) il fondatore ellenistico, bensì un autocrate antigreco : la lotta di De-mostene per la libertà rappresentava anche il diritto-dovere di Atene all’egemonia, secondo la tradizione. Per questo la guerra Lamiaca fu una guerra ‘greca’, coerente allo spirito demostenico. 4 La rivendicazione paradigmatica dell’ultimo Demostene come simbolo eterno (pur con le incertezze, le ambiguità, gli errori) viene fondata soprattutto sul valore della sua memoria, che in epoche diverse seppe risvegliare l’ardore della libertà.
Del valore morale e politico del libro molti hanno detto. Il gusto per i ‘perden-ti’, gli emarginati dal “ritmo razionale della storia” fu costante nella personalità di Treves. Dedicato a Paolo “più che fratello”, il Demostene appare ispirato anche dalla fervida passionalità politica paterna, nell’energica rivendicazione delle scelte minoritarie e oppositive. 5 La forza ideale ed ideologica del libro fu colta da molti recensori, favorevoli e negativi, di area filo- o antifascista : Carmen Scano condannò sulla fascista “Historia” 6 il dannoso influsso di un “tradizionalismo fuori dal pen-siero attuale, per cui libertà è volontaria disciplina delle parti al tutto, delle Regioni alla nazione, degli individui allo Stato”. Altre prese di posizione non mancarono, e anche all’estero il sottinteso politico non passò inosservato. 7 E che il libro avesse un
1 Per uno studio su Demostene, « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lx, 1932, pp. 68-74.2 Ciò valeva anche la storia romana : vd. P. Treves, Sertorio, « Athenaeum », x, 1932, pp. 127-47.3 P. Brown, « Proceedings of the British Academy », lxxiv, 1988, pp. 405-42, a p. 411.4 Diversamente E. Lepore, Leostene e le origini della guerra lamiaca, « Parola del Passato », ix, 1955, pp.
161-85, che nega trattarsi di una guerra di orizzonti “demostenici”.5 Un accenno agli attacchi volgari di Mussolini a Claudio Treves, che causarono il famoso duello, a
p. 87s. : “E della cronaca scandalistica, dal pettegolezzo sconcio, che par debba sempre contaminare i politici, segnatamente gli uomini di « sinistra », Eschine deriva...”. Una frase ad intenzionale effetto, p. 49 : “La morte del tiranno può, dunque, segnare l’inizio dell’insurrezione per la libertà”.
6 « Historia », ix, 1935, pp. 120-22 : l’attacco si inseriva nella lotta promossa dallo storico Ettore Pais contro De Sanctis e la sua scuola. V. Caioli, « Leonardo », v, 1934, pp. 369-70, recensì il libro sottolinean-do l’importanza per lui di scrivere “nell’anno xii”.
7 V. A. Puech, « Journal des Savantes », 1934, p. 181 : “ses jugements, si l’on songe surtout qu’ils vien-nent d’un Italien du 1933, sont intéressants et équitables”. V. anche G. Radet, « Revue des Études An-ciennes », xxxvi, 1934, pp. 259-60, e G. Mathieu, « Revue des Études Grecques », xlviii, 1935, pp. 156-58.
Carlo Franco30
impatto forte è provato da un episodio di alcuni anni successivo. Nel 1942 uscì per i tipi di Einaudi la traduzione italiana del Demostene di Werner Jaeger, proposta pro-prio da Treves all’editore ma poi realizzata da altri date le difficoltà a corrispondere con un esule. 1 Ebbene, in una recensione al volume apparsa nientemeno che sul “Primato” di Bottai, Gennaro Perrotta liquidò con tardivo e sprezzante il lavoro di Treves su Demostene come “uno sconclusionato libretto”. 2
La lettura più profonda e critica del libro era venuta, prevedibilmente, da Momi-gliano, che ne parlò, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione (febbraio 1933), in un saggio uscito in Germania nel 1934. Insieme a De Sanctis e Ferrabino, Treves venne criticato per l’accostamento inopportuno tra la libertà degli antichi e la liber-tà dei moderni : “se anche evita con forza e giustamente di parlare di unità nazio-nale ed esalta il significato politico di Demostene, nell’identificare il suo concetto di libertà con quello moderno, radicalmente inteso, ritorna alle posizioni di Grote. Il libro è per altro notevole per il diligente confronto con la migliore storiografia europea e per la partecipazione con cui sono affrontati i problemi dell’esistenza e non solo della dottrina ; d’altra parte la ricerca filologica è carente e non è offerta al-cuna conoscenza dei problemi economici e sociali”. 3 Con spirito mutato, il giudizio ritornò nella recensione pubblicata in “Athenaeum” del 1935. Qui il libro di Treves fu discusso insieme a Ottaviano Capoparte di Levi, con accostamento polemico e volu-tamente offensivo. 4 Premessa la difficoltà a discutere con obiettività opere maturate
Sui contatti francesi di Treves v. Pertici, Piero Treves, cit. p. 664-65. Per la Gran Bretagna v. A. Pickard-Cambridge, « Classical Review », xlvii, 1933, pp. 149-50, per la Germania F. Hampl, « Gnomon », x, 1935, pp. 384-86.
1 L. Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Torino, Borin-ghieri, 2009, p. 41 n. 140 (v. anche L. Ginzburg, Lettere dal confino, a cura di L. Mangoni, Torino, Einaudi, 2004, p. 136). Il Demostene di Jaeger, apparso nel 1938, era stato subito apprezzato da Treves : v. « Les Étu-des Classiques », ix, 1940, pp. 289-93. Per i contatti fra Treves e l’Einaudi in periodo bellico v. Mangoni, Pensare, cit., pp. 192 n.1 e 196 con n. 119.
2 G. Perrotta, Demostene, gli antichi e i moderni, « Primato », iii, 1942, pp. 417-18. Sulla vicenda vd. L. Canfora, Il mondo di Atene, Bari-Roma, Laterza, 2011, pp. 48-50. V. anche S. Accame, « Studium » xxxix, 1943, pp. 258-61 (= Scritti minori, iii, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1990, pp. 1430-37).
3 Studien über Griechische Geschichte in Italien von 1913 bis 1933, « Italienische Kulturberichte », i, 1934, pp. 163-95 (= Contributo alla storia degli studi classici, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1955, pp. 299-326, a p. 306), traduzione mia. Sulla stessa linea il riduttivo giudizio di L. Perelli, Sul culto fascista della romanità, « Quaderni di Storia », v, 1977, pp. 197-224, alle pp. 210-11.
4 « Athenaeum », xiii, 1935, pp. 137-45 (= Quinto Contributo, cit., pp. 937-46) : v. Dionisotti, Ricordo, cit., p. 40. L’accostamento al Levi poteva rispondere all’analoga scelta polemica di Treves in « Rivista di Filologia e Istruzione Classica » 60, 1932, p. 17. Levi, benché camicia nera della prima ora, non era sempre riuscito gradito in ambienti fascisti : la sua voce Cesare per la Treccani non piacque al Duce (Cagnetta, Antichità, cit., pp. 160ss.), il suo Ottaviano Capoparte non piacque alla fascisteggiante Scano (“Historia”, ix, 1935, pp. 296-98) perché troppo attento all’Oriente e riduttivo della gloria di Azio. In A. Casali, Storici italiani fra le due guerre. La « Nuova Rivista Storica » (1917-1943), Napoli, Guida, 1980, p. 146, il Demostene è giudicato : “uno dei frutti più significativi e ragguardevoli dell’antichistica italiana dei primi anni Trenta ; ciononostante, nell’immediato e nel futuro, il suo destino sarà affidato ad una sostanziale quanto singolare sfortuna storiografica : causa principale l’acritica assunzione, da parte di coloro che se ne occuparono, di un datato e non proprio simpatetico giudizio del condiscepolo Momigliano, ispirato più all’insofferenza per il tono di battaglia e per certo generoso giovanile comparativismo presente nel volume, che da effettivi dissensi di fondo verso le linee direttive del volume stesso”. La pagina risente dell’ispirazione di Treves [v. p. vii]. Va aggiunto che il Demostene non contiene accenni polemici a Mo-migliano, ma in genere fa poco ricorso alla sua opera.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 31
entro una stessa scuola, Momigliano lodava le qualità del libro, attaccandone però a fondo la “impostazione complessiva” : superato l’errore di chi ricostruiva l’ascesa della Macedonia in termini di unità, il volume presenterebbe una generosa ma ge-nerica rivendicazione di libertà, con toni a-storici prossimi al “vaniloquio” 1 e senza un vero ripensamento del problema, anzi con scarsa attitudine filologica all’analisi minuta, tecnico-giuridica.
In effetti il giudizio storico sulla Grecia nel iv secolo a.C. era per Treves soprat-tutto un problema etico-politico, che si nutriva certo di suggestioni storiografiche, ottocentesche e non, e richiamava la polemica di Drerup contro l’Atene democra-tica, 2 ma teneva conto anche della situazione italiana. Per Momigliano invece il problema era e restava storico, e l’afflato etico risultava un elemento, seppur nobile, di disturbo. Il severo giudizio sul Demostene di Treves maturò in un complesso ripen-samento. Ciò ben traspare dalla Avvertenza che Momigliano premise al suo volume su Filippo il Macedone. Saggio sulla storia greca del iv secolo a.C., apparso nel 1934, con ritardo di due anni rispetto alla stesura effettiva e con alcuni aggiornamenti legati alla febbrile evoluzione del pensiero dell’autore : 3 l’opera interpretava Filippo nella prospettiva dell’ellenismo, cioè del successivo sviluppo della storia dei Greci en-tro la dimensione dei regni nati dalla dissoluzione dell’impero di Alessandro. Una lettura dunque che esplicitamente guardava più a Droysen che a Beloch e a Grote (riferimenti invece centrali, e positivo il secondo, per il Demostene) : anche per il tono rigoroso il libro riuscì dunque molto diverso da quello di Treves (a cui è riservato un cenno riduttivo 4), ma forse in fondo complementare, più che opposto.
Secondo la pratica consueta di discussione Treves replicò con due diverse e con-cordi recensioni. Quella apparsa su “La Critica” respingeva esplicitamente l’inter-pretazione di Filippo come anticipazione dell’ellenismo e richiamava il problema etico sotteso alla crisi della polis greca, rivendicando (in toni più sfumati che nel Demostene) la validità della libertà greca pre-ellenistica. 5 Diverso, più ampio e più critico, il secondo intervento, uscito su “Athenaeum” con data al settembre ‘35 e un poscritto del novembre ‘36. 6 L’invito a precisare la cronologia è nello stesso Treves, che sottolineava in apertura come il volume di Momigliano patisse un mancato ag-giornamento rispetto alla continua rielaborazione delle idee da parte dell’autore, e quindi una certa contraddittorietà. A parte la discussione sui rapporti tra Isocrate e Teopompo, Treves criticò la struttura del libro, più disteso a narrare la storia greca
1 L’accostamento tra Demostene e Mazzini (p. 176), tanto criticato da Momigliano, era già in De Sanctis, Problemi, cit., p. 185, che pure avvicinava, in analogo spirito, le battaglie di Sentino e di Solfe-rino.
2 E. Drerup. Aus einer Advokatenrepublik, Paderborn, Schöningh, 1916 : un libro nato nel clima anti-parlamentare della guerra : v. L. Canfora, Engelbert Drerup (1871-1942), « Eikasmos », v, 1994, pp. 419-28.
3 Firenze, Le Monnier, 1934 (= Milano, Guerini e Associati, 1987, trad. fr. Combas, Editions de l’éclat, 1992), con importante Prefazione alla ristampa alle pp. xv-xvi. Il ritardo del volume comportò qualche sfasatura, notata poi da Treves in sede di recensione. Il libro era stato originariamente proposto all’edi-tore Laterza nel 1932 : v. Cagnetta, Demostene, cit., p. 294.
4 P. xv n. 2. Momigliano non ritiene di modificare il proprio punto di vista “anche dopo il recente molto notevole” libro di Treves, si dichiara “molto più vicino, invece, alle belle pagine di Berve, Griechi-sche Geschichte ii (Freiburg, 19331), specialmente pp. 145-46”. Sul carattere secondario di questa aggiunta v. Cagnetta, Antichità, cit., p. 123 n. 86. 5 xxxiv, 1936, pp. 65-68.
6 xiv, 1936, pp. 192-208.
Carlo Franco32
del IV secolo che ad analizzare Filippo e il suo conflitto con Atene, quindi spesso rigido nel ripercorrere la storia di quegli anni fatali, apodittico su molti aspetti. Nel fascicolo successivo comparve la replica nervosa di Momigliano, 1 che smentiva l’ac-cusa di incoerenza ; quindi seguì la controreplica di Treves, 2 in apparenza concilian-te, con un appello alla tradizione della scuola di De Sanctis.
Le divergenze emerse in quegli anni chiariscono la prospettiva adottata dai due studiosi. Momigliano si muoveva in autonomia rispetto al percorso culturale dei suoi maestri, sforzandosi di andar oltre i loro risultati, ripensandone nel profondo le radici ; in Treves invece vi era un forte senso etico-politico, per cui l’adesione al per-corso dei maestri significava pure il ripensamento del loro percorsi, ma per così dire dall’interno, entro una critica ma sostanziale fedeltà. Dietro alla diversa valutazione del problema della libertà greca c’era fra i due studiosi un diverso modo di intende-re la ricerca storica : entrambi, per così dire, storicizzavano i loro problemi, ma l’uno guardando ‘avanti’, agli sviluppi del problema, l’altro guardando ‘indietro’, alla tra-dizione del problema nel dibattito dell’Ottocento o del primo Novecento. Perciò Treves poteva rivendicare l’attualità perenne della libertà greca in senso metastorico e politico, trascurandone il suo contenuto giuridico effettivo, mentre Momigliano non poteva tacere, nonostante la sgradevolezza della cosa, che la celebrata libertà di Demostene era inadeguata. Il suo giudizio fermissimo e per certi aspetti ingeneroso sul volume di Treves non dipese infatti da polemica personale, e in un contesto più pacato fu meno feroce. 3 Del resto Momigliano espresse critiche ferme e radicali anche nei confronti del Maestro, come già sul problema di Annibale, ancora nel già citato profilo tedesco del 1934 : 4 De Sanctis replicò seccamente a difesa del proprio concetto di libertà. 5 Queste polemiche nascevano da una profonda ricerca intellet-tuale : l’urgenza estrema o (con una parola cara a Treves) la Angst di quel lavoro non si trasmise ai continuatori e successori della antichistica italiana. Quella degli anni ‘30 appare una stagione estrema del classicismo, definitivamente e traumaticamen-te spezzata dalla guerra.
Ma questo passaggio non deve far perdere di vista il percorso culturale di Tre-ves che fu, come anche per Momigliano, più vasto e complesso. Entro una pro-duzione giovanile abbondantissima (un dato rilevante, e che pure implica una relazione ‘agonale’ con Momigliano) si trovano indirizzi di ricerca molteplici. Domina un’opzione quasi totale per la storia del iv e del iii secolo a.C., con una particolare cura per la fase iniziale del periodo ellenistico. Un impegnativo saggio storiografico su Antigono Dosone del 1934-35 fu segnalato da De Sanctis 6 che pure notò il disinteresse per questioni tecniche come la cronologia, materia controver-
1 Ivi, p. 279 (= Decimo contributo, cit, pp. 492-93). 2 Ivi, pp. 279-81, datata gennaio 1937.3 V. Gli studi italiani di storia greca e romana dal 1895 al 1939, in Cinquant’anni di vita intellettuale italiana.
1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce, i, Napoli, Ricciardi, 1950, pp. 84-106 (= Contributo, cit., pp. 275-97, a p. 291s. su Treves). V. anche la citata Prefazione alla ristampa del Filippo.
4 Studien, cit., pp. 305s.5 « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lxiv, 1936, pp. 97-99 (= Scritti Minori, vi/2, cit., pp. 937-
40).6 Il saggio di Treves è Studi su Antigono Dosone, « Athenaeum », xii, 1934, pp. 348-411 e xiii, 1935, pp.
22-56 ; la segnalazione di De Sanctis in « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lxiii, 1935, pp. 418-27 (= Scritti Minori, vi/2, cit., pp. 927-28).
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 33
sa su cui Treves non impostava un completo ripensamento, ricorrendo invece a risultati altrui. 1
Altro aspetto importante è la pubblicistica scolastica : a partire dal 1932 Treves commentò i principali testi dell’oratoria greca di IV secolo, sfruttando i materiali approfonditi durante il lavoro di tesi : dopo Isocrate con il Panegirico (1932) e il Filippo (1933) vennero l’orazione di Demostene Per la Corona (1933) e la Contro Leocrate di Licurgo (1934). Seguirono in anni successivi ancora Demostene con la Filippica II e la Filippica III (1936, poi in versione francese, 1938) e Polibio, Il libro II delle Storie (1937), nonché alcune traduzioni demosteniche. Le ricchissime note ai testi andavano ben oltre le necessità scolastiche : ampio era il richiamo alla bibliografia fondamentale, aggiornati i riferimenti al dibattito recente italiano e straniero, disteso e partecipato il commentario, pur con qualche svista e qualche digressione. 2
Numerosissime poi furono, per tutti gli anni ‘30, le recensioni a ricerche di storia antica, soprattutto greca ed ellenistica, ma anche a lavori di storia letteraria italiana e di storia degli studi classici. 3 Sedi privilegiate di pubblicazione per gli interventi di antichistica furono ancora la “Rivista di Filologia” e il pavese “Athenaeum” diretto da Plinio Fraccaro. Anche questo era periodico molto autorevole nel settore delle recensioni, giacché tutte le più importanti pubblicazioni estere erano segnalate e adeguatamente discusse. Di certo, Treves recensore non poteva tenere il confronto con Momigliano : gli difettava non già la competenza, quanto il gusto dell’analisi metodica e tecnicamente spietata. Redatte con esibito gusto letterario, le sue recen-sioni però erano sempre animate da personale e originale prospettiva. In esse Tre-ves ebbe modo di mostrare la propria erudizione, di chiarire le proprie prospettive metodologiche, nel rifiuto di ogni filologismo fine a se stesso e nella rivendicazione dei valori fondanti una ricerca veramente degna del nome di storia. Discussioni no-tevoli egli dedicò alle ricerche moderne su Alessandro Magno (Radet, Strasburger, Mederer) e sugli oratori greci (Durrbach, De Falco, Cloché, Walz), ma un valore e un significato particolare ebbero le sue riflessioni sulla Griechische Geschichte di Hel-mut Berve e su Paideia di Werner Jaeger.
Della recensione a Berve 4 colpisce il tono entusiastico, che sottolinea la conso-nanza totale di spiriti e di intenti, nelle valutazioni di fondo come nelle scelte di
1 La notazione, ripresa anche da Momigliano, rileva una tendenza profonda : ancora negli ultimi anni, discutendo in « Giornale Storico della Letteratura Italiana », clxv, 1988, pp. 280-87 l’edizione critica Pagliai-Folena-Scotti delle Poesie e Carmi di Foscolo, Treves ribadiva che se il problema è “saper leggere”, la costituzione del testo è solo un avviamento.
2 Notata da numerosi recensori : v. A. Passerini, « Athenaeum », xiii, 1935, pp. 139-40. All’estero i commenti furono segnalati da G. Mathieu, “Revue des Études Anciennesh, xxxv, 1933, pp. 251 e 351-52 (Isocrate, Panegirico e Filippo) ; ivi, xxxvi, 1934, pp. 100-01 e 417 (Demostene, Per la Corona e Licurgo) ; xxxix, 1937, pp. 59 e 410-11 (ii e iii Filippica, Polibio, Libro ii) ; M. L. W. Laistner, gClassical Reviewh, xlvii, 1933, p. 137 (Isocrate, Panegirico) ; A. Pickard Cambridge, ivi, xlviii, 1934, pp. 131-32 (Demostene, Per la Corona) ; ivi, xlviii, 1934, pp. 239-40 (Licurgo) ; ivi, liii, 1939, p. p. 145 (iii Filippica) ; H. H. Scullard, ivi, lii, 1938, pp. 125-26 (Polibio, Libro ii). “Ben più che scolasticih definì questi lavori Momigliano nella recensione al Demostene : ma il complimento pare agrodolce.
3 V. soprattutto Il carteggio Mommsen-Wilamowitz, « Nuova Rivista Storica », xx, 1936, pp. 126-36, sulla cui importanza Gigante, Piero Treves, cit., pp. 55ss.
4 « Athenaeum », xi, 1933, pp. 378-92 ; v. anche nella stessa annata, pp. 90-95 (a segnalazione della Grie-chische Geschichte di U. Wilken).
Carlo Franco34
dettaglio, pur nel riconoscimento di forzature notevoli (come la contrapposizione schematica tra Dori e Ioni o l’esplicita statolatria). E davvero dovette essere forte l’impatto di quel libro tra i giovani desanctisiani, suggestionati in più dal magistero di Croce. Anche Momigliano non lesinò negli anni ‘30 gli elogi a Berve : 1 solo la pre-sa di coscienza legata alla persecuzione razziale nazista lo indusse nel dopoguerra a condannare con forza l’opera, quando ne uscì la traduzione italiana. 2 Per Momi-gliano la valutazione dell’opera era ormai inseparabile, dopo la Shoah, dalle scelte ideologiche dell’autore ; per Treves invece, l’adesione di Berve al nazismo dopo il 1933 non mutava il significato positivo che la Griechische Geschichte aveva avuto nella formazione intellettuale sua. (seppure egli, già negli anni ’30, avesse già denunciato con consapevolezza l’incombere anche sulla scienza del rischio nazista). 3 Dunque torna ancora la divisione tra Momigliano, che nel progresso dei suoi pensieri lascia-va duramente alle spalle il passato, e Treves che al valore del passato riteneva, entro una specchiata coerenza, di potersi sempre richiamare.
Analoga evoluzione (per Momigliano) ed analoga continuità (per Treves) si ri-scontrano nel giudizio sopra l’opera di Werner Jaeger. Oggi Paideia è un libro poco letto, studiato al più come testimonianza storica. Ma ben diversa era la situazione negli anni ‘30, quando in Italia l’uscita del primo volume venne segnalata da Gior-gio Pasquali. 4 L’opera impostava una rilettura complessiva dell’esperienza cultura-le greca nel segno della “formazione dell’uomo”, facendone il fondamento di un moderno umanesimo. Valutazioni molto positive (moderate da qualche riserva) vennero espresse da Treves, 5 ancora una volta su influsso della metodica di Croce : ma attraverso Paideia egli analizzava soprattutto l’evoluzione della cultura classica tedesca di fronte all’ascesa del nazismo. Nell’esperienza del Terzo Umanesimo, de-stinata a tramontare ancor prima della guerra, Treves vide un tentativo di salvaguar-dare i valori umanistici e il senso dell’eredità classica, minacciata in modo opposto dal tecnicismo filologico e dalla evoluzione della politica. Di qui il suo consenso immediato e la memore fedeltà, ancora nel dopoguerra, a quanto le ricerche di Jae-ger avevano rappresentato : in opposizione, anche su questo punto, alla liquidazione formulata in diversa prospettiva da Momigliano. 6
1 V. la pagina introduttiva a Filippo il Macedone, cit., p. xv n. 2, dove Berve è contrapposto proprio a Treves.
2 H. Berve, Storia Greca, trad. it. Bari, Laterza, 1959, con la recensione di A. Momigliano, « Rivista Storica Italiana », lxxi, 1959, pp. 665-72 (= Terzo Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1966, pp. 699-708). Sullo studioso v. K. Christ, Neue Profile der Al-ten Geschichte, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, pp. 125-87 ; per una valutazione po-litica v. L. Canfora, Helmut Berve (1983), in Le vie del classicismo, Bari-Roma, Laterza, 1989, pp. 169-220.
3 Per una tardiva fase della polemica v. P. Treves, « Athenaeum », xliii, 1965, p. 246 ; A. Momiglia-no, Chiarimento, ivi, pp. 441-43 (= Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp. 837-40) ; P. Treves, Chiarimento e conferma, ivi, xliv, 1966, pp. 152-54 (con la precisazione di Canfora, Berve, cit., p. 209, n.86).
4 « Pan », i-ii, 1933-34, p. 477 (= G. Pasquali, Scritti filologici, ii, Firenze, Olschki, 1996, p. 941). Sul pro-blema v. C. Franco, Werner Jaeger in Italia. Il contributo di Piero Treves, « Quaderni di Storia », xxxix, 1994, pp. 173-93 e Pertici, Piero Treves, cit., pp. 685ss., con altra documentazione.
5 « Athenaeum », xxiii, 1935, pp. 258-69 ; v. anche « Religio », xi, 1936, pp. 532-35 e « Athenaeum », xxv, 1937, pp. 310-12.
6 V. soprattutto Prospettiva 1967 sulla storia greca, in Sui fondamenti della Storia Antica, Torino, Einaudi, 1980, pp. 429s.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 35
Altre recensioni di Treves uscirono su periodici di cultura quali “La Nuova Italia”, “Civiltà Moderna” e “La Cultura”. 1 Come mostrano i casi analoghi di Pasquali e Mo-migliano, in quegli anni non era raro che i classicisti affidassero a quelle o analoghe sedi di pubblicazione contributi scientifici di più largo interesse e leggibilità, perché meno rigidamente tecnici. Questa attività metteva così in contatto gli antichisti con figure importanti della cultura italiana contemporanea (Luigi Russo, Ernesto Codi-gnola, e altri) : il giovanissimo Treves intrattenne in quest’ambito notevoli rapporti personali, pur con le note difficoltà politiche. 2 Tramiti diversi, familiari e politici, lo portarono in relazione anche con esperienze ‘marginali’ come “Religio”, diretta da Ernesto Buonaiuti e la “Nuova Rivista Storica” di Gino Luzzatto, cui collaborò con discreta intensità fino agli anni della guerra : 3 anche dopo che la persecuzione razziale impedì l’uscita di pubblicazioni opera di ebrei, sui due periodici Treves poté stampare brevi note -alcune siglate P.T.- fino al 1940. 4
Il più importante contatto, naturalmente, fu quello con Benedetto Croce e con “La Critica”. Insieme al fratello Paolo, Treves conobbe il Senatore alla fine degli anni ’20, conservando in seguito un rapporto di devozione fortissima. Per interessamen-to di Croce il Demostene fu accolto nella biblioteca laterziana, e recensito favorevol-mente da Adolfo Omodeo su “La Critica”. 5 Sulla stessa rivista Treves pubblicò poi tra il 1935 e il 1936 alcune recensioni (tra cui quella, citata, al Filippo di Momigliano) : fu un segno importante per il giovane storico, escluso dalla carriera accademica per la sua posizione politica. Tuttavia la collaborazione fu ridotta nel tempo e nella consistenza : il sostegno di Croce fu infatti significativo, ma non particolarmente caloroso, 6 probabilmente per riserve di ordine culturale. Infatti, quando nel 1939 Treves, ormai esule in Inghilterra, chiese a Croce di poter riprendere la collabora-zione a “La Critica”, il filosofo rispose negativamente, richiamando tra l’altro lo sconcerto provato anni addietro di fronte a certi confusi lavori di argomento “re-ligioso” e la persistente “fermentazione giovanile” in cui si trovava a suo giudizio Treves. Il riferimento andava certo ad un misticheggiante lavoro su Renan del 1935, testimonianza di un travaglio etico-religioso (impensabile in chi consideri il sereno
1 V. in generale S. Giusti, Una casa editrice nella storia del fascismo. La Nuova Italia (1928-43), Firenze, Olschki, 1983 ; Una casa editrice tra società, cultura e scuola. La Nuova Italia 1923-1986, a cura di A. Piccioni, Firenze, La Nuova Italia, 1986, part. pp. 38ss. per le prime due riviste ; per l’altra G. Sasso, Variazioni sulla storia di una rivista italiana. « La Cultura » (1882-1935), Bologna, Il Mulino, 1992, part. pp. 161ss.
2 Sui contatti con Eugenio Colorni vd. S. Gerbi, Tempi di malafede. Guido Piovene ed Eugenio Colorni. Una storia italiana tra fascismo e dopoguerra, Milano, Hoepli, 20122, p. 73. I nomi di Paolo e Piero Treves ricorsero spesso nei verbali degli interrogatori di Colorni, dopo l’arresto a Trieste nel settembre ‘38 (G. Vassallo, gEurostudiumh, aprile-giugno 2009, on-line all’indirizzo http ://www.eurostudium.uniroma1.it/rivista). 3 A. Casali, Storici italiani, cit., part. pp. 137, 146s., 150s.
4 Sul problema v. G. Fabre, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani, 1998, part. pp. 384 ss. sulle sigle e pseudonimi adottati per aggirare la censura razzistica ; sul caso della « Nuova Rivista Storica » v. p. 430.
5 « La critica », xxxi, 1933, pp. 305-06 (= Il senso della storia, Torino, Einaudi, 1955, pp. 43-44). Sul valore ideale di quello e altri consensi v. P. Treves, Omodeo studioso di storia antica, « Annali Istituto Italiano Studi Storici », xi, 1989/90, pp. 615-33, a p. 633 n. 31.
6 Sul favore di Croce verso Treves v. Dionisotti, Ricordo, cit. 35ss ; sulla segnalazione del Demostene all’editore Laterza v. Cagnetta, Demostene, cit., p. 294 ; ampia ed approfondita trattazione in Pertici, Piero Treves, cit., pp. 682ss (la lettera a p. 704).
Carlo Franco36
laicismo del Treves postbellico) in cui ebbe forse qualche l’influsso lo spiritualismo cattolico di De Sanctis. 1 La simpatia umana e politica non fece ombra a Croce sul giudizio culturale : né questo disconoscimento limitò in Treves la profonda gratitu-dine morale, la devozione memoriale e l’adesione culturale al magistero di Croce. Ad esso egli richiamò, in modo ancor più esplicito, nei lavori del dopoguerra, quan-do il riferimento a Croce significava non certo una fronda o una moda, quanto una programmatica inattualità, pervicacemente rivendicata.
Alla feconda attività di studi espressa da Treves nel corso del decennio corrispon-deva una radicale incertezza sul futuro, Data la situazione politica, una carriera accademica (quale invece, e trionfale, compì Momigliano, cattedratico di Storia Romana dal 1936 a Torino) era impensabile : oltre che dei lavori scolastici retribuiti egli visse in quegli anni lavorando come precettore privato dei Casati a Milano e collaborando all’Enciclopedia Italiana, per la quale redasse una trentina di voci, non tra le principali, che apparvero a partire dal 1933. 2 A bilanciare la difficoltà in ambito accademico stavano alcuni contatti in Italia, ma soprattutto la prospettiva euro-pea, maturata anche per la peculiare situazione familiare : alcune borse ottenute per soggiorni esteri (già nel 1931 : alle motivazioni di studio s’univa anche l’esigenza di incontrare il padre in esilio) gli consentirono fecondi rapporti personali, ad esem-pio, con Gustave Glotz, e contatti con Victor Ehrenberg, Werner Jaeger e altri. Ne derivarono alcune pubblicazioni. 3 Maturava intanto, nell’incupirsi della situazione interna italiana, la decisione dell’esilio : nel prolungarsi dei soggiorni all’estero, l’al-lontanamento dall’Italia, effettivo dal 1937, divenne definitivo nel 1938. 4 A seguito delle leggi razziali antiebraiche (di cui, come antifascista e come ebreo, aveva vedu-to e denunciato il minaccioso precedente tedesco), Treves trovò rifugio a Cambrid-ge, ivi raggiunto poi dalla madre e dal fratello.
L’allontanamento dalla patria e l’impedita l’attività pubblicistica sancirono la chiusura di un ciclo : 5 il disagio dell’adattamento, la condizione di nemico dopo il giugno ’40, l’urgenza dell’attività politica nell’ambiente dei fuoriusciti italiani con-dussero Treves verso i problemi del presente, allontanandolo per il momento dalla ricerca. Agli anni di guerra risalgono tuttavia alcuni lavori legati a precedenti indagi-
1 La ‘Preghiera’ di Ernesto Renan, “Nuova Rivista Storica”, xix, 1935, pp. 474-505, il cui tono attirò la critica anche di A. Cajumi, Pensieri di un libertino, Torino, Einaudi, 1965, p. 66 (v. Casali, Storici italiani, cit., p. 179).
2 Sugli antichisti nella Treccani, il ruolo di De Sanctis, il rapporto con il fascismo, v. Cagnetta, Anti-chità, cit.
3 Oltre alla Treccani Treves collaborò in quegli anni anche alla Pauly-Wissowa (voci apparse nel 1938, e ancora nel 1940, poi nel 1948-52), quindi negli anni inglesi all’Oxford Classical Dictionary.
4 Nel giugno del 1937 aveva partecipato a Parigi ai funerali dei fratelli Rosselli, come risulta dalle fotografie dell’evento.
5 A seguito della persecuzione antiebraica Treves fu tra gli autori ‘vietati’. Il Demostene fu coinvolto nel sequestro di libri ‘ebraici’ alla Laterza, poi revocato anche per intervento di Croce : v. Fabre, L’elenco, cit., pp. 286ss. Anche sulle riviste meno controllate (ivi, p. 153 e n. 3) la pubblicazione divenne impossibile con la guerra : “Religio” fu soppressa con il fascicolo settembre-ottobre 1939 (F. Parente, Ernesto Buo-naiuti, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1971, p. 93) e allora Buonaiuti trasmise a Luzzatto per la « Nuova Rivista Storica » una recensione del “caro e apprezzato amico Piero Treves” : così da una lettera conservata nell’Archivio Luzzatto, presso la Biblioteca di Area Economica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Busta viii, Epistolario i, 38, da Roma, senza data).
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 37
ni 1 e altri contributi in lingua inglese. 2 Ma l’impegno principale fu dedicato, insieme al fratello Paolo, alla redazione di Radio Londra e all’azione del movimento “Libera Italia”, in una attività di riflessione culturale e di battaglia politica in qualche modo memore di quella condotta dal padre Claudio, giornalista antifascista in esilio. 3
Terminato il conflitto, Treves rimase in Inghilterra ma non si radicò, a differenza da Momigliano, nelle locali Università. Iniziò invece, e proseguì con varia intensità fino agli anni ’50, una notevole attività di pubblicista. Collaboratore per breve tem-po del locale Istituto Italiano di Cultura, lavorò per la BBC, svolse revisioni edito-riali, fu corrispondente dall’Inghilterra del “Corriere della Sera” (dal 1946 al 1950), poi del “Resto del Carlino”, e collaborò assiduamente a periodici italiani tra cui “La Nuova Europa”, “Idea”, “Il Mercurio”, “Relazioni Internazionali”, “Il Mondo”. Molti dei suoi articoli erano legati alla contingenza (cronaca locale, politica inglese e internazionale, prospettive dell’economia postbellica, problema del trattato di pa-ce italiano) ; ma certo più interessanti e significative appaiono le note di storia e di cultura, le recensioni e i ritratti dedicati a vicende e personalità inglesi, in cui sono le premesse delle ricche e numerose voci stese, con partecipata acribia, per la seconda Appendice della Treccani (1948-49). 4
All’intenso lavoro sul contemporaneo si affiancava la ripresa di contatti politici con ambienti socialisti. 5 Ciò non significava però un abbandono dell’impegno sto-rico : alcuni brevi saggi degli anni inglesi dimostrano che lo studio continuava, pur tra molte difficoltà e altre urgenze. 6 Il ritorno di Treves, su basi certo diverse, alla storia del mondo antico avvenne nel 1953 con la pubblicazione dell’importante volu-me su Il mito di Alessandro e la Roma di Augusto. 7 La ricerca mosse dall’excursus in cui Livio (ix 16 19-19 17) si interroga su che cosa sarebbe successo se Alessandro, vinto l’Oriente, avesse attaccato Roma. Dalla esegesi del passo Treves ricavò la storia di un tema fondamentale nella storia greco-romana, cioè la consistenza e il ruolo della leggenda di Alessandro, estesa poi fino al mondo moderno. La ricerca rivendicava innanzitutto il carattere impegnato e non retorico della pagina di Livio : essa era tesa a ribaltare l’uso anti-romano del mito di Alessandro (un tema di urgente attua-lità nella Roma di Augusto, impegnata nel confronto con l’Oriente partico). Ma il
1 Per esempio Demosthène d’après M. Werner Jaeger, « Les Études Classiques », ix, 1940, pp. 270-93. Un inedito di quegli anni su The Party Background of Young Demosthenes si conserva alla Biblioteca del Dipar-timento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Roma (Misc. DS Sto 465).
2 The Meaning of consenesco and King Arybbas of Epyrus, « American Journal of Philology », lxiii, 1942, pp. 129-53 ; gli articoli recensitivi sul Filippo V di Walbank (« Journal of Hellenic Studies », lxiii, 1943, pp. 117-20) e sulla storia della Messenia (« Journal of Hellenic Studies », lxiv, 1944, pp. 102-06).
3 Un episodio ne rievoca R. Di Donato, Da Seneca a Tacito. Aspetti del pensiero politico romano in un inedito di Arnaldo Momigliano, « Archivio di Storia della Cultura », xx, 2007, pp. 217-45, pp. 233-34. Vd anche l’articolo memoriale della cugina E. Heger Vita, London Calling Italy. Memorie dall’Italian Section della BBC, « Keshet » 12, nov.-dic. 2008 (on-line all’indirizzo http.///www.keshet.it.).
4 La voce Inghilterra, apparsa in Enciclopedia Italiana, Appendice ii (1938-48), vol. ii, Roma 1949, pp. 36-45 ora in Scritti novecenteschi, cit., pp. 1-16 : v. al riguardo L. Cesa Valla, Cronache e schermaglie inglesi con Piero Treves, « Belfagor », lxii, 2007, pp. 603-11.
5 V. per es. il carteggio con G. Faravelli in P. C. Masini, S. Merli, Il socialismo al bivio. L’archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, Milano, Feltrinelli, 1990 (v. P. Treves, La morte di Giuseppe Faravelli. Un socia-lista scomodo della vecchia guardia, « La Stampa », 19 giugno 1974).
6 Ricordo di Giorgio Pasquali, « Idea », iv, n. 28, 1952 ; Ritratto inglese di Benedetto Croce, ivi, iv. n. 40, 1952. 7 Milano-Napoli, Ricciardi, 1953.
Carlo Franco38
ripensamento ideologico e politico del mito di Alessandro restò vivo anche successi-vamente : per tutta l’età imperiale, infatti, esso implicò il problema del ruolo univer-sale di Roma, ma anche in seguito rimase, come Treves documentò con suggestivi accenni, elemento forte del confronto con il mito di Roma, fino alla storiografia moderna. Una appendice tacitiana, incentrata soprattutto sul dibattuto problema della imitatio Alexandri in Germanico (Annales, ii 73) chiude il volume, corredato di dotte allusioni e di note ricchissime sulla storia della tradizione classica (da meritare un indice di alcuni punti) ma per molti aspetti atipico, per la sua peculiare fusione tra storia e tradizione antica e moderna e per la tentacolare struttura. 1
Da quest’opera più citata che letta sono derivate le molte ricerche sulla imitatio Alexandri nel mondo romano : ma questo libro, tra storia e storiografia, non rappre-sentava una integrale novità rispetto alla produzione prebellica. I legami di conti-nuità, seppur sottili e non evidenti, non mancano, circa alcuni aspetti particolari, 2 ma anche circa le linee di fondo. Lo scavo sul tema ambivalente (ma fondamental-mente antiromano) del mito di Alessandro è in fondo un’altra indagine su una victa causa : quella dei Greci di fronte a Roma. L’insistito richiamo al tema dell’equilibrio ellenistico è sulla linea del saggio sulle cause della II guerra punica, che discuteva la positività del Gleichgewicht mediterraneo nel III a.C. anche (o proprio perché) senza Roma, e richiamava la necessità di evitare il finalismo storico. In questa tenace con-tinuità ideale, dunque, sta uno degli aspetti caratteristici di Treves storico (e uno di quelli che nel profondo lo distaccano dall’inquieta ricerca di Momigliano).
Nonostante la sua oggettiva importanza il libro ebbe scarsa fortuna. In Italia fu segnalato da Italo Lana sulla “Rivista di Filologia”. Il periodico, prima della guerra, aveva ospitato tanti lavori di Treves (e di Momigliano) ed era ancora condiretto da De Sanctis e Rostagni : 3 la recensione affiancò agli apprezzamenti alcune riserve sensibili. Di maggior rilievo la discussione di Ettore Lepore sulla “Rivista Storica Italiana”, 4 che rilevava la struttura complicata e poliedrica del libro, la sua acuta e ricca informazione nell’indagare le molteplici rifrangenze della pagina di Livio : nella stimolante produttività dell’indagine il recensore per altro osservò che la se-zione dedicata al Fortleben di Alessandro in età imperiale storicizzava sempre come ideologicamente pregnanti, ma con qualche genericità, testi che erano legati forse da sintonie di tradizione letteraria. Il gusto di Treves per gli accostamenti e per le continuità era giudicato talvolta azzardato, perché esponeva al rischio, espresso in conclusione, “del « mito » classicistico o di un confuso neo-umanesimo, al di qua irrimediabilmente di ogni esperienza storicistica”. 5 Una diagnosi che dice molto sul
1 Come provano le difficoltà dei redattori della Année Philologique, il fondamentale repertorio biblio-grafico degli studi classici, nel collocare il libro in una sezione : finì in Mythographie et folklore (1953), in Alexandrum (ad) quae referuntur (1954), in Histoire Romaine (1955).
2 Ad esempio circa la storicità delle ambascerie occidentali ad Alessandro, già rivendicata nel Demo-stene, cit., p. 149 e n. e in varie recensioni degli anni ‘30.
3 « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lxxxii, 1954, pp. 322-25. Pur vivo, ma cieco e vecchissi-mo, il De Sanctis, era Rostagni di fatto il responsabile della linea scientifica.
4 « Rivista Storica Italiana », lxvi, 1954, pp. 286-94.5 La segnalazione di A. H. McDonald, « Journal of Hellenic Studies », xlv, 1955, pp. 176-78, legata
certo a contatti degli anni inglesi, elogia il libro, pur rilevandone taluni sviluppi troppo ipotetici e re-spingendo, come Lepore, la cronologia compositiva dell’excursus liviano.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 39
modo in cui vennero accolte da allora in poi nell’Italia dei classicisti ‘impegnati’ le ricerche di Treves.
Il rilievo del libro emerse soprattutto sulla distanza, quando esso divenne, fosse pur discutibile per alcune prese di posizione, termine di confronto per la riflessione storiografica. 1 Perché davvero la ricerca apriva nuovi orizzonti : in un contributo rilevante (e trascurato) sul Romanzo di Alessandro, in contrasto con la tendenza a ricostruire le genesi testuale dell’opera nella sequenza delle redazioni e nell’inter-vento di un compilatore ‘inconsapevole’, Treves rivendicava la profonda storicità ellenistica della leggenda di Alessandro : 2 anche in questo caso la riflessione sarebbe stata compresa più tardi. 3
Il libro che pur segnava il ritorno di Treves alla storia antica comportava anche l’abbandono quasi totale della histoire bataille a favore di un percorso lato sensu sto-riografico : riemergono in esso le insofferenze per i tecnicismi filologici, già riscon-trabili nella produzione prebellica e segnalate da taluni critici, e la predilezione per una riflessione di livello più generale, dominata nettamente dal problema dell’el-lenismo e dell’incontro tra mondo greco e mondo romano. Sul punto la linea di Treves fu assai diversa da quella di Momigliano, pensosamente consapevole del pro-blema giudaico : egli indagò invece l’incontro tra Grecia e Roma di preferenza attra-verso le fonti letterarie, le allusioni, i miti storici. Dopo che si era presso che chiusa la riflessione su Demostene e l’oratoria greca, 4 Treves sviluppò un ripensamento storico, culturale e ideale del mediterraneo antico secondo la chiave dell’equilibrio ellenistico, spezzato poi da Roma : l’esito più tardo di questo percorso sarebbe stato, nel 1976, l’impegnativo saggio su Posidonio, 5 prova ulteriore della sostanziale unità di concepimento della ricerca.
La riflessione sull’eredità di Alessandro proseguì nel volume dedicato a Euforione e la storia ellenistica (Milano-Napoli, Ricciardi, 1955) : esso ricostruiva intorno agli scarni resti dell’opera del poeta una stagione culturale e politica del medio elleni-smo, affiancando al quadro biografico un ripensamento della storiografia di Trogo. Esempio pur sempre notevole dello sforzo di esegesi ‘totale’, di quell’oraziano po-nere totum che fu in effetti il credo critico di Treves, l’Euforione fu ancora un libro
1 V. soprattutto C. Questa, Studi sulle fonti degli Annales di Tacito, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 19632.
2 Il problema storiografico del Romanzo di Alessandro, « Rivista di Filologia e Istruzione Classica », lxx-xiii, 1955, pp. 250-75, a proposito di R. Merkelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderroman, Mün-chen, Beck, 1954 [19772, con contributo di J. Trumpf] ; C. Franco, Introduzione, a Vita di Alessandro il Macedone, Palermo, Sellerio, 2001, pp. 15-75.
3 Verso le ricerche di Treves su Alessandro e il suo mito mostrò consenso S. Mazzarino Il pensiero storico classico, Bari-Roma, Laterza, 1966, part. ii/1, pp. 540-42 ; ii/2, pp. 314-15 e passim.
4 Ma v. almeno Demade postumo, « Rendiconti Istituto Lombardo », xcii, 1958, pp. 327-80 ; il profilo di Demostene per la serie I Protagonisti della Storia universale, Milano, Compagnia Editrice Internazionale, 1968, vol. ii, pp. 197-224 ; Gli oratori greci, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1981, vol. i, pp. 421-61.
5 La cosmopoli di Posidonio e l’impero di Roma, in La filosofia greca e il diritto romano, Atti del Convegno, Roma, Accademia dei Lincei, 1976, pp. 27-65, parzialmente ripreso in La storiografia greca. Guida storica e critica, a cura di D. Musti, Bari-Roma, Laterza 1979, pp. 159-70. È l’unico lavoro di Treves ricordato nella rassegna di M. Mazza, La storia romana, in La storiografia italiana degli ultimi vent’anni, i. Antichità e medioevo, a cura di L. De Rosa, Bari-Roma, Laterza, 1989, pp. 67-126, a p. 85. Nessun lavoro per la storia greca, esaminata da D. Musti (pp. 35-66).
Carlo Franco40
atipico, e forse non felice. Gli storici della letteratura lo trovarono troppo esterno e divagante rispetto alla mera interpretazione dei frammenti del poeta, mentre gli storici dell’ellenismo non potevano seguirne la dispersiva dottrina. Emblematici, tra le varie recensioni e segnalazioni, 1 i duri giudizi di Pierre Levêque, fortemente critico del carattere ipotetico di molte asserzioni, e di Peter M. Fraser, che ritenne il libro “obscure and intricate”, troppo speculativo, senza contributi alla comprensio-ne né di Euforione né del III secolo a.C., e per di più proposto in una “highly ornate, tortuous, and allusive manner” da risultare quasi incomprensibile. 2 Da parte di un lettore straniero era obiezione giustificata : troppe volte la scrittura accademica ita-liana (non solo quella ardua di Treves) è risultata presso che illeggibile all’estero. E certo chiunque abbia avuto per le mani uno scritto soprattutto postbellico di Treves ha sperimentato il disagio di fronte a uno stile davvero ornato e programmatica-mente inattuale, ottocentesco e ricco di caratteristiche tournures e allusive nuances. Si trattava di una scelta precisa, anzi di uno degli aspetti più vistosi del Treves storico “di tradizione” di cui ha parlato Roberto Pertici : anche per questo aspetto il percor-so fu contrario a quello di Momigliano, che negli scritti del dopoguerra adottò uno stile secco e sobrio, diversamente caratteristico. 3
Per il loro stesso taglio, le ricerche sul mito di Alessandro e sull’attività di Eu-forione implicavano, più che l’indagine evenemenziale, il prevalente interesse per la storia della tradizione classica : ma proprio mentre si compiva questo trapasso problematico (quasi un ‘superamento’ della storia greca), l’attività di Treves come professore inserito nell’accademia stava per iniziare. Nel 1955 infatti, con il decisivo sostegno di Raffaele Mattioli, egli rientrò in Italia per lavorare all’Ufficio Studi della Banca Commerciale : l’accolse, accanto al cugino Antonello Gerbi, l’ambiente pre-zioso della “Ricciardi”. 4 Dopo l’esito negativo del primo concorso a cattedra tentato nel 1953, dal 1955 Treves poté per la prima volta darsi all’insegnamento universitario come incaricato di Epigrafia Greca alla Statale di Milano e per qualche tempo anche come professore di Storia Antica, in sostituzione del titolare Mario Attilio Levi : in anni successivi, dopo altre travagliate vicende concorsuali, fu nominato professore straordinario di storia greca a Trieste (1963), passando poi a Firenze (1965), quindi a Venezia (dal 1970). 5
1 Notevole quella di A. Barigazzi, « Athenaeum », xxxiv, 1956, pp. 372-76. Amicale e positiva quella di M. Gigante, « Parola del Passato », xi, 1956, p. 400 (= Piero Treves, cit., pp. 50ss). V. anche F. Cássola, « Nuova Rivista Storica », lxi, 1957, pp. 512-13.
2 P. Levêque, Euphorion, la reine et les rois, « Revue des Études Grecques », lxxi, 1958, pp. 433-37 ; P. M. Fraser, « Gnomon », 1956, pp. 578-86. V. anche J. Oost, « Classical Philology », lii, 1957, pp. 269-70 : “a style at once abstract and verbose, parenthetical and enamoured of hyphenated pleonastic com-pounds”, contrapposto alla “easy clarity” di De Sanctis. Una replica di Treves, che rivendica il senso del libro, « Maia », xvii, 1965, pp. 158-62. Il volume è ignorato da B. A. van Groningen, Euphorion, Amster-dam, Hakkert, 1977.
3 Dionisotti, Ricordo, cit., p. 20s.4 Profilo di Antonello Gerbi, in A. Gerbi, La disputa del nuovo mondo. Storia di una polemica : 1750-1900,
Milano-Napoli, Ricciardi, 19832, pp. xix-lxxii, dove è vivissima la ricostruzione degli anni prebellici (= P.T., Scritti novecenteschi, cit., 131-74) ; R. Pertici, s.v. Gerbi, Antonello, in Dizionario Biografico degli Italiani, 53, 1999, pp. 385-88.
5 Sul “sostanziale insuccesso” dell’insegnamento fiorentino di Treves per il contrasto tra il suo an-tifilologismo e la tradizione di quella sede v. A. Marcone, « Storia della storiografia », xxvii, 1995, pp.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 41
Per lo studioso che approdava allora alla cattedra l’esilio, la guerra e le attività pubblicistiche del dopoguerra non avevano rappresentato solo un impedimento, ma l’occasione per sviluppi importanti e profondi. Ne era seguita quasi una scis-sione, per usare parole care a Treves medesimo, tra il Fach del professore e la Frage dello studioso. Il suo approccio all’antico era ormai di taglio decisamente storio-grafico, con uno spostamento netto dalla ricostruzione e interpretazione dei fatti e delle fonti alla ricostruzione diacronica della loro presenza idealmente e storica-mente feconda nella tradizione culturale europea, ma soprattutto italiana. Tale, significativamente, l’impostazione della prolusione triestina, che ripercorreva Un secolo di storie della storia greca partendo da Niebuhr, per poi passare al ‘politico’ Grote, al rivalutato Curtius, al razzista Beloch. Dal magistero tutto ‘tecnico’ di quest’ultimo Treves faceva discendere la crisi degli studi di storia greca al principio del Novecento : una crisi esplosa con la catastrofe della prima guerra mondiale. Donde il successivo ripensamento etico di De Sanctis ma anche di Jaeger, del cui Terzo umanesimo Treves sentiva di poter ancora confermare la validità profonda, se non l’attualità. 1 Nel ripensare le vicende dei maestri della storia greca, fino alla soglia della ii guerra mondiale, l’antico allievo di De Sanctis ripercorreva i pilastri della propria formazione : in questo senso il saggio può essere utilmente affiancato ad un’altra prolusione, quella londinese di Arnaldo Momigliano, che pure muoven-do da Grote ripensava l’intero sorgere e svilupparsi della riflessione storica europea sulla Grecia antica. 2
L’istanza storiografica sembrava dunque prevalere, in modi e per ragioni diffe-renti, su entrambi gli allievi di De Sanctis. E anche quando tornò a considerare i testi antichi direttamente, Treves collegò sempre la loro interpretazione al ruolo da essi svolto nella cultura italiana ed europea. Ciò spiega il taglio di alcuni profili che egli dedicò tra il 1958 e il 1966 ad autori antichi come Plutarco, Svetonio, Tacito, Tucidide, prendendo costantemente le mosse dal Fortleben dell’autore e desumendo così, dal contributo storicizzato dei moderni, la via per l’interpretazione. Questi lavori rimasero del tutto ignorati, forse per la sede in cui furono pubblicati. L’erudi-zione, pur abbondante, non è di ostacolo ad un approccio partecipato : degli storici e dei periodi considerati Treves evidenzia con forza la portata esemplare e la vitalità moderna. I suoi riferimenti sono come sempre, in prevalenza, ottocenteschi, e i giu-dizi talora idealizzati (come quelli sulla polis o sugli intellettuali greci nell’impero romano), ma con forte senso del dibattito storico, evocato per scorci e senza ansie di regesti bibliografici. Il taglio talvolta imprevisto dei saggi è motivo ulteriore di in-teresse, in quanto rievoca orizzonti oggi meno familiari, legati alla cultura comune europea ottocentesca, dove la presenza dell’antico era centrale.
158-61, a p. 160. V. anche il cenno di E. Narducci, Cicerone e i bsuoi interpreti. Studi sull’opera e la fortuna, Pisa, Ets, 2004, 349-50. Dal febbraio 1968 al gennaio 1969 Treves fu Visiting professor a Austin (Texas).
1 V. Studi di storiografia antica in memoria di Leonardo Ferrero, Torino, Bottega di Erasmo, 1971, pp. 1-24 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 3-33) : essa è valorizzata in particolare da C. Ampolo, Storie greche. La formazione della moderna storiografia sugli antichi Greci, Torino, Einaudi, 1997. Al Niebuhr come interprete della storia greca e precursore del Droysen, Treves dedicò l’ampio saggio Niebuhr e la storia greca, in Gibbon, Niebuhr, Ferrabino, Roma, Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 285-96.
2 A. Momigliano, George Grote and the Study of Greek History (1952), in Contributo, cit., pp. 213-31 (= Studies on Modern Scholarship, Berkeley-Los Angeles-London, Univ. of California Press, 1994, pp. 15-31).
Carlo Franco42
Così, l’opera di Plutarco è indagata a partire dalla autorevole presenza nella cul-tura del xviii secolo e dalla successiva svalutazione positivista, per poi rivendicarne la forza di testimone del mondo greco in età imperiale. 1 Più inatteso è l’approccio all’Atene di Pericle, accostata a partire dalla Roma di Pio VI e dalla Prosopopea di Vincenzo Monti, e di là analizzata nella sua ambigua grandezza : le biografie di Plu-tarco dedicate agli eroi del Quinto secolo a.C. vengono sondate poi nel ripensamen-to della storiografia moderna (soprattutto dell’Ottocento e del primo Novecento) su Pericle e la polis ateniese, e sull’idea di stato, con una vibrante difesa della ‘reli-gione’ della città antica. 2 Svetonio, muovendo da una pagina di Croce su caratteri e limiti del genere biografico, è visto come l’interprete della crisi dell’età adrianea e quindi come il mediatore di tante immagini di Roma alla tradizione europea. 3 Ta-cito è ripensato a partire dal cesarismo (o anticesarismo) dell’età napoleonica, e poi caratterizzato per il suo lucido pessimismo sul destino dell’Impero e più in generale dell’Occidente, rivendicandone quindi implicitamente l’attualità nell’Europa post-bellica. 4 Quanto a Tucidide, egli è inaspettatamente accostato attraverso i critici ottocenteschi dell’opuscolo di Dionigi di Alicarnasso Su Tucidide, e poi attraverso alcuni studiosi moderni, a culminare nel De Sanctis : e se ne rivendica, oltre e più della scientificità, la volontà di guidare verso una “speranza” futura. 5
Traspare chiaramente da questi saggi, ricchi di riferimenti a studiosi talora poco noti, il lavoro erudito che Treves stava conducendo in quegli anni in vista delle ope-re maggiori sulla storia degli studi classici in Italia. Ma ancora più evidente appare la preoccupazione per la minacciata fine della civiltà dell’umanesimo europeo, travol-to dalle guerre mondiali e spezzato nel dopoguerra come continuità di tradizione culturale. Da questa percezione acuta, certo anche personale, nasceva lo sforzo di richiamare il senso profondo dello studio dei classici, uno studio radicato in ragioni ideali, non congelato in questioni tecniche : è questo a rendere suggestiva la rilet-tura di questi contributi, quand’anche la prospettiva dala quale si guardano alcuni temi (per esempio la città antica) non corrisponda all’attuale. Centrale e saldissima (e certo degna di riflessione oggi) è la fede nella validità del paradigma classico, nonostante tutto. La si ritrova con evidenza anche in un lavoro di qualche anno più tardo, dedicato alla congiura antineroniana e alla morte di Seneca. Qui colpisce non solo la solidarietà con gli avversari di Nerone, ma ancor più il parallelo con i promotori della congiura antihitleriana del luglio 1944, “che attende ancora il suo Tacito”. 6 Il richiamo all’evento, per altro, rinvia alla linea di frattura della guerra
1 Introduzione a Plutarco, Prefazione a Plutarco, Il tempo di Giulio Cesare, Milano, Club del Libro, 1958, pp. 3-22 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 81-100).
2 Il secolo di Pericle nella storiografia moderna, Prefazione a Plutarco, Il secolo di Pericle, Milano, Club del Libro, 1960, pp. 1-32 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 101-35).
3 Biografia e storia in Svetonio, Prefazione a Svetonio, Vite dei Cesari, Milano, Club del Libro, 1962, pp. 5-26 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 201-25).
4 Speranza e disperazione in Tacito, Prefazione a Tacito, Annali, Milano, Club del Libro, 1965, pp. v-xxxix (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 157-200).
5 Tucidide o la storiografia dell’ottimismo, Prefazione a Tucidide, Storie, Novara, Club del Libro, 1966, pp. 1-42 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., 35-80).
6 Il giorno della morte di Seneca, in Studia Florentina Alexandro Ronconi oblata, Roma, Edizioni dell’Ate-neo, 1970, pp. 507-524 (= P.T., “Le piace Tacito ?”, cit., pp. 137-55).
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 43
mondiale, che segnò in modo definitivo la prospettiva di Treves storico, sempre più proiettato verso l’Ottocento, e progressivamente estraneo (o piuttosto avverso) agli sviluppi degli studi sul mondo antico dopo il conflitto : nel ritorno alla ‘tecnica’ egli vedeva la rinuncia alla considerazione di un ruolo attivo dell’antico nella cultura (e nella politica), mentre si andavano affermando correnti ideologiche e mode critiche nelle quali non poteva riconoscersi. 1
In questi saggi di gusto e scrittura ottocenteschi, ricchissimi di spunti, sta il nesso con gli ampi studi che Treves dedicò allo studio dell’eredità classica nella storiogra-fia e nella letteratura italiana del XIX secolo. Già alcuni lavori prebellici mostravano un interesse per le radici storiche dello studio dell’antico, 2 sviluppato anche in lavo-ri pubblicati successivamente. 3 Ma la guerra aveva segnato una frattura fortissima rispetto alla cultura italiana d’inizio secolo, sospinta verso l’oblio a causa della to-tale perdita di senso storico. Per questo Treves ritenne necessario un ripensamento complessivo, (incompiuto ancora al momento della sua morte) sul senso degli studi classici in Italia tra Ottocento e Novecento. Egli ricostruì il senso del proprio essere antichista, ripensando la formazione propria e soprattutto quella dei suoi maestri : quelli scientifici, come De Sanctis e Croce, e quelli culturali, come il padre Clau-dio. Di qui anche l’impegno a ridisegnare la storia degli studi italiani di antichità, per capire le domande che avevano guidato quelle indagini, per rivendicare contro l’emarginazione contemporanea e contro il tecnicismo filologico il ruolo dell’ere-dità classica nella formazione dell’identità culturale nazionale, entro la tradizione europea.
Dalla fine degli anni ’50 quest’ambito divenne il tema si ricerca principale (e ne-gli ultimi anni quasi esclusivo). Giovandosi assai di una sterminata erudizione e sfruttando estesissime letture di autori spesso poco noti, Treves seppe riannodare con prodigiosa coerenza e simpatetica partecipazione le forme del dibattito italiano sull’antico a partire dall’età della Restaurazione fino al primo dopoguerra. Il primo prodotto rilevante fu nel 1958 l’importante saggio su Ciceronianesimo ed anticicero-nianesimo nella cultura italiana del secolo xix. 4 Indagando il giudizio espresso dalla cultura italiana su Cicerone, sia nel dibattito seguito alla scoperta del De re publica, sia poi nel confronto con le posizioni riduttive del Mommsen, Treves ricostruiva su di un campione significativo diversi aspetti della cultura ottocentesca, con parti-colare attenzione a figure ed opere minori, nell’intento di delineare un clima fatto di rapporti personali, scambi epistolari, notizie biografiche, polemiche provinciali. Prendeva così forma la sua peculiare immagine degli studi classici in Italia. In essa sul giudizio tecnico o metodologico prevaleva l’interpretazione ideologica e poli-
1 Nel maggio 1976 Treves sottoscrisse il Manifesto degli intellettuali in difesa della libertà, promosso dal quotidiano « Il Giornale » : S. Gerbi, R. Liucci, Montanelli. L’anarchico borghese, Torino, Einaudi, 2009, p. 122 n. 9.
2 Si pensi ai profili di Manara Valgimigli (« L’Italia che scrive », xix, 1936, pp. 135-36) e Augusto Rostagni (ivi, xx, 1937, pp. 267-71).
3 Così negli incisivi ritratti di Manara Valgimigli (« La Nuova Antologia », xci, 1956, fasc. 1865, pp. 41-62), di Concetto Marchesi (« L’osservatore politico-letterario », iii, giugno 1957, pp. 38-52), e soprattutto di Gaetano De Sanctis (ivi, marzo 1957, pp. 49-65, e “Itinerari”, iii, 1957, pp. 174-82).
4 « Rendiconti Istituto Lombardo », xcii, 1958, pp. 403-64 ; v. anche Un dimenticato critico lombardo del Mommsen, « Nuova Rivista Storica », xlii, 1958, pp. 185-204.
Carlo Franco44
tica : nodi principali, destinati a trovare sviluppo nelle successive opere maggiori, erano la categoria del ‘neoguelfismo’ (ossia dello sfondo spiritualistico, moralistico e antiromano di molti intellettuali italiani di area genericamente cattolico-liberale, in cui si ritroverebbero le radici più proficue della riflessione sull’antico) e il contro-verso rapporto rispetto allo storicismo filologico tedesco. 1
L’indagine proseguì, con più ambizioso intento, nei due volumi, strettamente collegati tra loro, dedicati a L’idea di Roma e la cultura italiana del secolo xix e a Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento, apparsi entrambi nel 1962 presso Ricciardi. Il primo volume esaminava il ruolo dell’eredità classica nella cultura e nella politica italiana attraverso tre grandi fasi : il problema di Roma nel pensiero del risorgimen-to, il ruolo delle culture regionali (Toscana e Lombardia), la riflessione degli storici. Il percorso analitico, che muoveva dichiaratamente da spunti di Croce e di Federico Chabod, 2 fu ancora una volta suggestivo e personalissimo. Partendo dalla situazio-ne culturale di Roma nell’età di Pio VI e poi di Napoleone, Treves mostrò quanto l’immagine di Roma antica gravasse, e fosse però anche produttiva, sull’atteggiarsi degli intellettuali italiani di fronte al presente, guidando la loro riflessione sull’Italia moderna. Era così possibile così rivendicare, a cominciare dal Foscolo “antiroma-no”, il carattere politico o ideale, e non pur antiquario, della riflessione antichistica, cercando non già di indagare la qualità scientifica degli studiosi, quanto la radice profonda del loro sguardo sull’antico. Perciò Treves dedicò ampie pagine a dimen-ticati e non professionali eruditi locali, preferendoli ad altri, come Bartolomeo Bor-ghesi, perché la loro ricerca, a suo avviso, era meno rappresentativa delle idealità di quel tempo. Se dagli intellettuali dell’età napoleonica Roma era stata pensata in rapporto al cesarismo di Bonaparte, nel ripensamento dell’Italia pre-romana es-sa era contrapposta alla Roma dei Cesari e dei Papi. Tale intensa attualizzazione dell’antico aveva un carattere “ambivalente”, perché il pensiero dell’eredità classi-ca poteva condurre sia all’acquiescenza passatista sia al pensiero rivoluzionario, e perché il problema di Roma era urgente questione in rapporto alla nuova Italia : il Risorgimento di Gioberti o Mazzini nasceva anche da radici classiche, così come dal ripensamento dell’antico muovevano gli intellettuali lombardi e toscani senza la cui opera (pur caduca) sarebbero incomprensibili gli sviluppi dell’Italia post-unitaria.
La spinta al “realismo”, in storia e in politica, e le polemiche antiromane giova-rono certo alla liberazione dell’Antico dal classicismo retorico : 3 pure dopo il 1870 l’avvento della Methode filologica portò l’antichistica italiana a dover in qualche mo-do ricominciare il proprio cammino, rinnegando (ad esempio in Girolamo Vitelli) l’apporto della tradizione nazionale. Questo passaggio secondo Treves aveva signifi-cato sia un innegabile progresso tecnico-scientifico, sia uno iato tra cultura classica e cultura civile. Il doveroso recupero di questa frattura si sarebbe avuto nella figura
1 Su pregi e limiti del lavoro, che prelude a successive ricerche, v. le critiche di Momigliano, che la-mentò, entro un panorama critico e biografico ricchissimo, omissioni e sproporzioni e la mancanza di giudizi “tecnici” : « Rivista Storica Italiana », lxxi, 1959, pp. 131-32 (= Sesto Contributo, cit, pp. 768-69).
2 Rispettivamente per la Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, Bari, Laterza, 19473, da cui deriva anche il concetto di ‘neoguelfismo’, e per la Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, Laterza, 19622.
3 Ossia la “scoturnizzazione”, come Treves disse rifacendosi ad una pagina di Mommsen : v. L’idea di Roma, cit., p. 82.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 45
unica ed emblematica di Gaetano De Sanctis, in cui la filologia (cioè la tecnica) era tornata farsi storia proprio per la presenza fecondatrice di altissime istanze ideali e politiche e morali. Assieme a lui Treves collocava non solo due storici-sociologi, gli emarginati Ciccotti e Ferrero, ma anche, per il diversissimo sforzo di ricupero vivo dell’antico, l’antistorico Pascoli, che chiude in modo inatteso (ma oggi ciò suona meno strano) l’arco ideale e storico del libro. 1
Nella sua recensione Momigliano, pur riconoscendo la dottrina e i contributi importanti, fu molto critico soprattutto verso l’impostazione del lavoro, giudicato farraginoso e non lucido, squilibrato su figure peregrine o secondarie, viziato da giudizi personali, troppo netti nell’elogio e nel biasimo (come nel caso di Vitelli), mentre si sarebbe desiderata una definizione più tecnica e meno generica dell’og-getto. 2 Il tono complessivo appare sprezzante : solo una postilla ricorda, rinviando ad un’analisi specifica mai pubblicata, l’uscita del complementare volume su Lo Stu-dio, dove molte delle carenze lamentate da Momigliano (ad esempio su Borghesi o su Angelo Mai), trovavano adeguata e profonda trattazione.
Il libro sulla Idea di Roma infatti non era e non voleva essere una storia degli studi classici italiani lungo il XIX secolo. La costruì invece, attraverso una ricca antologia di testi commentati, il secondo volume del 1962, dedicato alla riflessione italiana sull’antico dall’età della Restaurazione (soprattutto Visconti, Monti, Foscolo, Mi-cali, Mai, Giordani, Leopardi) all’apporto del neoguelfismo (soprattutto Manzoni, Vannucci Centofanti), dall’opera dei “tecnici” (Borghesi, Peyron) alla crisi e all’av-vento della filologia, fino al “ritorno alla storia” (soprattutto Ferrai, Comparetti, Vitelli, Pais, De Sanctis). La scelta dei testi, aperta agli epistolari e alla saggistica, ora riportando sezioni di opere, ora proponendone la ripubblicazione integrale, fu accompagnata da importanti profili biografici, da ricche bibliografie e da ampi commenti : per molti dei personaggi considerati si trattò di contributi fondamentali, che colmarono lacune gravi della ricerca, e che comunque fornivano anche per le figure più note utilissime raccolte di dati, sorrette da una prodigiosa erudizione. Come nell’altro volume, la ricchezza dei profili e la gerarchia d’importanza sottesa al taglio stesso del lavoro (ed esplicitata nei giudizi sparsi nell’opera) amplificarono il carattere molto personale delle scelte e delle categorie d’analisi : questo l’appunto essenziale mosso dai recensori, che però unanimemente avvertirono l’importanza del lavoro. Marino Raicich 3 riconobbe che Treves aveva costruito un quadro ricchis-simo e ricavato spunti significativi da una produzione sconosciuta ai più, ma segnalò anche il gusto per l’accostamento peregrino, certe forzature di prospettiva e talune
1 Sul ruolo di Pascoli negli studi classici italiani un cenno significativo in Momigliano, Classical Scholarship for a Classical Country : the Case of Italy in the Nineteenth and Twentieth Century (1986), in Ottavo Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1987, pp. 73-89 (= Studi classici per un paese “classico”. Il caso dell’Italia nel xix e nel xx secolo, « Atene e Roma », xxxi, 1986, pp. 115-32).
2 « Rivista Storica Italiana » lxxxv, 1963, pp. 399-402 (= Terzo Contributo, cit., pp. 781-84) con le osserva-zioni di Gabba, Cultura classica, cit., pp. 101s, 111ss. Notazioni critiche ha espresso in varie occasioni sugli scritti di Treves, ottocentisti e non, A. La Penna : v. Gigante, Piero Treves, cit., pp. 34s.
3 Gli studi classici nell’Ottocento, « Belfagor », xix, 1964, pp. 229-34 : v. anche la rassegna critica di E. Sciacca, « Rassegna Storica del Risorgimento », li, 1964, pp. 99-101 ; F. Cássola, « Nuova Rivista Stori-ca », lxviii, 1964, pp. 190-92.
Carlo Franco46
asprezze nei giudizi. Particolarmente importanti le note di Sebastiano Timpanaro, studioso con cui Treves ebbe un dialogo sempre produttivo, pur nel dissenso. A suo giudizio il volume antologico appariva superiore agli altri lavori, perché avvantag-giato nella struttura di commentario ai testi, e valorizzato nel suo retroterra ideolo-gico e non puramente erudito. Con riserve invece egli accoglieva l’accezione estesa in cui era usata la categoria di neoguelfismo, in cui Treves riuniva studiosi differenti tra loro, e criticava la sottovalutazione del lavoro dei “classicisti-illuministi” Monti, Giordani e Peyron, Leopardi e Cattaneo, nonché la visione riduttiva della filologia e degli studiosi, come il Vitelli, ansiosi di far propria la metodica tedesca. 1
Scarsa la ricezione all’estero del libro, così incentrato sull’Italia : vanno registrate la breve scheda di E.J. Kenney, che lamentò le asperità dello stile ma riconobbe la “imposing erudition” e lo “sharp critical judgement” 2 e l’ampia rassegna di Vito Reno Giustiniani che, pur notando che il volume esclude o quasi dalla discussione gli studi di filologia, linguistica, epigrafia e archeologia, ne apprezzò la profondità e la dottrina. 3 Molte delle osservazioni dei recensori sono condivisibili : inoltre la di-spositio e la elocutio di Treves non vengono incontro al lettore (né aiuta la mancanza di indici). Al di là delle giustificazioni possibili di alcune scelte personali, 4 va ribadito che il discorso muoveva da un punto di vista interno alla percezione ottocente-sca, quindi ancora una volta retrospettivo e non prospettivo. Treves non cercava l’emergere del ‘buon’ metodo in Italia (con o senza l’apporto germanico), sicché poteva meditare pagine confuse metodicamente di ingegni locali dimenticati, se esse consentivano di cogliere un rapporto vivo, ideologico con l’antico e di valutare questo rapporto nella formazione di una coscienza italiana. Anche sull’opera dei predecessori dunque i giudizi di Treves e Momigliano erano molto diversi : a Treves non interessava il raffinarsi del metodo quanto il senso profondo e storico del lavo-ro, perché di là, non dal metodo o dalla tecnica, egli riteneva scaturissero le ragioni dell’interesse per l’antico. In questa prospettiva egli valutava le dinamiche culturali dell’Italia prima e dopo l’Unità, riconoscendo sulla scorta di Chabod il senso della svolta del 1870 e del successivo cammino dell’Italia unita : per questo poteva ritene-re la Roma umbertina una capitale di livello europeo, non attardata e nemmeno precorritrice, e poteva rivendicare non solo il senso dell’antichistica italiana pre-filologica, ma anche valorizzare in analisi penetranti la figura di storici ‘marginali’, come Ciccotti, Barbagallo e Ferrero, severamente giudicati, anni addietro, anche da Gaetano De Sanctis. 5
1 Il contributo di S. Timpanaro, « Critica Storica », ii, 1963, pp. 603-11, è ristampato con il titolo di Classicismo e « neoguelfismo » negli studi di antichità dell’Ottocento italiano, in Aspetti e figure della cultura ottocentesca, Pisa, Nistri-Lischi, 1982, pp. 371-86 ; sul volume v. la replica di Treves, L’ultimo « Ottocento » di Timpanaro, « Giornale Storico della Letteratura Italiana », clx, 1983, pp. 280-89, ove è ribadita tra l’altro la concezione strumentale della filologia e difesa la categoria di neoguelfismo ; v. quindi le considerazio-ni ultime di Timpanaro in La filologia di Giacomo Leopardi, Bari, Laterza, 19873, part. p. 240. Ai dissensi corrispose sempre stima : a Treves il Timpanaro dedicò Il socialismo di E. De Amicis, Lettura del “Primo Maggio”, Verona, Bertani, 1983.
2 E. J. Kenney, Odia philologica, « Classical Review », xiv, 1964, pp. 206-07.3 V. Reno Giustiniani, « Gnomon », xxxviii, 1966, pp. 508-15.4 Per il giudizio su Vitelli, ad esempio, v. M. Gigante, Classico e mediazione. Contributi alla storia della
filologia antica, Roma, nis, 1989, pp. 156ss.5 Per la scienza dell’antichità. Saggi e polemiche, Torino, Bocca, 1909, pp. 273ss., 461ss. su Ciccotti e Fer-
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 47
La ricostruzione del cammino italiano verso la ‘storia’ si approfondì nel trenten-nio successivo, ampliando il quadro delineato nei due volumi del 1962. Appunto per la volontà di rendere conto di ogni aspetto, nesso, lettura dell’antico, Treves superò l’ambito degli studi classici, aprendosi a testi ‘di cultura’. Va ricordata anzitutto l’im-pegnativa raccolta degli Scritti Letterari, di Carlo Cattaneo, 1 dichiaratamente legata alla memoria carissima dello zio Alessandro Levi, nel quadro del comitato catta-neano italo-svizzero : essa propone una riflessione culturale e politica sull’autore, insieme a una ricostruzione dell’ambiente lombardo sondato sia nei gusti letterari sia nelle inclinazioni ‘pratiche’. Quindi vengono le notevoli raccolte di Carducci e Pascoli.
L’antologia carducciana 2 rientra a pieno titolo nel percorso memoriale così carat-teristico nella ricerca di Treves : il richiamo alla propria educazione è esplicitamente segnato come il movente primo del lavoro. Ancora una volta legata al magistero di Croce, l’esegesi dei testi si propose di ricollocare l’uomo e l’opera nella rete ‘oriz-zontale’ dei rapporti personali (onde l’apporto dell’epistolario) e in quella ‘verti-cale’ della tradizione poetica italiana. Benché infatti sempre avverso alla metodica “fontaniera”, Treves ritenne imprescindibile per la comprensione reale della poesia carducciana una considerazione ampia e competente della suo base classica, antica e moderna. Per Treves infatti Carducci fu innanzitutto “poeta di tradizione”, ma di una tradizione ormai spezzata, che il critico sentì come dovere storico e personale rimettere insieme, prima che fosse troppo tardi.
Non molto diversa, per le premesse di metodo, la successiva antologia pascolia-na. 3 Essa presenta diverse peculiarità : la prima, e più vistosa, è il fatto che è unita a un volume di immagini che certo richiama le specifiche qualità dell’editore Ali-nari, ma soprattutto correda i testi pascoliani del loro referente iconografico e di gusto entro la pittura e scultura prevalentemente italiane degli anni 1857-1911, tra Macchiaioli e Preraffaelliti, tra Simbolisti e primi affacci della modernità. È que-sto un correlativo visivo della particolare storicizzazione realizzata nell’antologia poetica dell’a-storico e antistorico Pascoli. Le linee portanti dell’interpretazione si fondavano ancora una volta su Croce, ma poi minutissimo e proficuo è l’impegno a definire il clima di ogni testo : contro varie letture modernistiche, Treves pose alla base della produzione (e della poesia) di Pascoli non solo il superamento dell’ere-dità carducciana, ma anche il costante richiamo al mondo e alle ideologie della nativa Romagna. Di qui, accanto alla puntuale indagine sulle presenze classiche, soprattutto nei Conviviali, la dismissione del Pascoli ‘cosmico’ e vate, ed invece la
rero. Il volume è ripreso in G. De Sanctis, Scritti Minori, iii, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1972.
1 Firenze, Le Monnier, 1981, 2 voll. 2 G. Carducci, Poesie scelte, a cura di P. Treves, Novara, De Agostini, 1968. L’introduzione è ristam-
pata con modifiche in Tradizione classica, cit., pp. 3-62. Sull’opera, v. P. Mandrillo, L’antologia carduc-ciana di Piero Treves « Rassegna Pugliese », v, 1970, pp. 60-67, e soprattutto M. Fubini, Le “Poesie scelte” del Carducci a cura di Piero Treves, « Giornale storico della letteratura italiana », cxlix, 1970, pp. 576-84 (= Foscolo, Leopardi e altre pagine di critica e di gusto, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1992, pp. 766-76).
3 G. Pascoli. L’opera poetica, scelta e annotata da P. Treves, Firenze, Alinari, 1980, con un volume di immagini a cura di C. Sisi. L’introduzione è ristampata con modifiche in Tradizione classica, cit., pp. 63-118. Sul carattere emblematico del “disadattamento” di Pascoli v. Pertici, Piero Treves, cit., pp. 720 ss.
Carlo Franco48
rivendicazione costante dei tratti socialisteggianti sui temi dell’emigrazione e del colonialismo italiano, ed insieme lo sforzo di ricostruire attraverso epistolari e me-morialistica i forti legami familiari e il brulicante mondo di rapporti personali in cui sempre si avviluppò l’uomo Pascoli. Delle cui debolezze, compresa la torbida per-cezione dell’eros, Treves è interprete fermo ma senza concessioni psicologistiche o sovrastrutture ideologiche : e non di meno il ‘disadattamento’ pascoliano è davvero la chiave del volume.
Il progressivo spostamento in avanti dell’indagine veniva a toccare i primi decen-ni del secolo, quelli della formazione stessa di Treves. La volontà di non disperdere quel fecondo momento spiega il frequente ricorrere alle testimonianze di memoria, proposte in cenni fugaci, in commemorazioni di impegno storiografico, in profili da elzeviro. Negli anni giovanili Treves aveva avuto opportunità di conoscere o avvici-nare molti esponenti importanti della politica, soprattutto di ambiente socialista, e della cultura italiana : a distanza di vari decenni, quando il ripensamento del fasci-smo (e dell’antifascismo) era particolarmente intenso, Treves li rievocò in numerosi interventi, con attenta consapevolezza e ampi richiami alla propria testimonian-za, soprattutto con le note del “Taccuino della memoria” (1973-77) uscite su “La Stampa” diretta allora da Arrigo Levi. 1 Tali scritti, come in genere la produzione pubblicistica, chiariscono oltre ogni dubbio (impossibile per altro, in chi lo abbia conosciuto) che Treves non era un erudito libresco, pensoso solo del proprio lavoro intellettuale : la sua vastissima dottrina non gli impedì di essere uomo vivacemente attento al contatto con le persone.
Lo provano le sue lettere, anch’esse segno di una civiltà ormai scomparsa : quelle più recenti, redatte a macchina con spaziatura fittissima, raccontavano con minuti particolari e abbondanza di indicazioni, ricordi, giudizi. Erano talora dei piccoli saggi. 2 All’umana attenzione del Treves adulto non sfuggiva il senso e il gusto di tanti rapporti di ambito sociale. 3 Da giovane aveva appreso a valutare lo spessore morale delle personalità incontrate, e seppe poi rievocarne intensamente la ricchez-za umana, travolta prima dalla violenza repressiva fascista e poi dalla guerra. 4 Nella maturità, e oltre, conservò una immediata cordialità e una grande semplicità di modi (pur in una non casuale cura dello stile, davvero d’altri tempi), che spiegano il suo piacere per incontri, cene, serate musicali, contatti familiari e culturali, viaggi e convegni in Italia e all’estero. Questa ricchezza di esperienze si rifletteva in scritti d’occasione, in commemorazioni, in molte sue lettere : il côté scientifico di questa attenzione umana si rivelò nelle numerose e informatissime voci pubblicate a par-tire dal 1961 per il Dizionario Biografico degli Italiani, quindi per la Enciclopedia Virgi-liana (1984-88) e ancora, postume, per la Enciclopedia Oraziana (1998) : notevoli per la
1 Interessanti cenni a relazioni familiari e memoriali in A. Levi, Un paese non basta, Bologna, Il Mu-lino, 2009, pp. 48-49.
2 Da una lettera infatti deriva la nota su De Sanctis e il partito popolare, « Quaderni di Storia », xxxvii, 1993, pp. 127-28. Una pagina dattiloscritta di Treves (l’inizio della voce Gaetano De Sanctis per il Dizionario Biografico) è riprodotta in relazione alla voce Enciclopedia Italiana, in Enciclopedia Italiana, Appendice v**, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, tav. xiii. 5.
3 V. il ricordo di G. Spadolini, « La Nuova Antologia », cxxvii, ott.-dic. 1992, pp. 420-22 a recensione di G. Matteotti, Scritti sul riformismo, con Premessa di P. Treves (pp. 9-13), Pisa, Nistri-Lischi, 1992.
4 V. ad esempio Ritratto privato di Francesco Nitti, « Rassegna Pugliese », iv, 1969, pp. 483-95.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 49
nettezza dei giudizi (ad esempio su Ettore Bignone), ma anche per il loro equilibrio (come i profili di De Sanctis e Ferrabino). 1
In coerente sviluppo con questo ripensamento si pongono anche i contributi di storia della politica italiana e le riflessioni sul problema ebraico : anche qui l’arco cronologico prediletto fu quello tra le due guerre, soprattutto con le riflessioni sul fascismo. 2 Sicché pur nell’apparente marginalità questi saggi sono consustanziali al ripensamento che Treves condusse sulla storia italiana. Particolarmente intensi, pur lontani da ogni tono di ortodossia, sono i contributi degli anni ‘80 sul tema dell’ebraismo in Italia. Fu soprattutto il fascismo, con le leggi razziali del ‘38, a sol-lecitare Treves : sottolineò, di fronte alla campagna razzistica, l’impreparazione dei più, fiduciosi tuttavia nella Chiesa o nel Re, rifletté sull’operato dei pochi antifascisti ebrei, a fronte dell’adesione al regime di non pochi, osservò (autobiograficamente) che la coscienza ebraica fu piuttosto conseguenza e non causa della scelta antifasci-sta ; quindi rivendicò il profondo valore del suicidio di Formiggini e il senso, tutto politico, dell’antifascismo prebellico. 3
Nell’anno accademico 1980/81 Piero Treves concluse a Venezia il suo insegna-mento universitario, dedicando il corso di Storia Greca all’interpretazione del Fi-lippo di Isocrate e quello di Storia Romana al De re publica di Cicerone : una sintesi del proprio percorso il primo, un aggancio alle sue coeve ricerche sul cardinale Mai il secondo. 4 E fu certo coerente con il suo sottile understatement la scelta di tenere nel maggio del 1981 l’ultima lezione del corso di Storia Romana, alla presenza dei colleghi della Facoltà veneziana, esattamente come tutte le altre e secondo l’antico metodo, facendo leggere e tradurre il testo agli allievi e quindi commentandolo, senza concessione alcuna a bilanci e a sintesi.
Lasciato l’insegnamento, Treves proseguì una intensa attività di ricerche. La no-tevole produzione di questa fase estrema fu tutta volta alla storia degli studi classici : il numero e la qualità degli interventi mostrano a sufficienza il suo vigore intellet-tuale. 5 Certo, sedi e modalità di pubblicazione patirono una scarsa visibilità. Alla base poté essere il rapporto non del tutto risolto con il mondo universitario, e la
1 V. le voci Bignone, Ettore, in Dizionario Biografico degli Italiani, 10, 1968, pp. 439-42 ; De Sanctis, cit ; Ferrabino, Aldo, ivi, 46, 1996, pp. 385-92. Anche alcune voci del Biografico sono apparse postume.
2 Una biografia di Vittorio Emanuele III, « Rassegna Pugliese », vi, 1971, pp. 564-70 ; Dittico per la storia del fascismo, « Il Veltro », xix, 1975, pp. 209-28 (= Scritti novecenteschi, cit., pp. 93-104).
3 Antifascisti ebrei od antifascismo ebraico ?, “Rassegna Mensile di Israel”, Gennaio-Giugno 1981, pp. 138-49 ; Formiggini e il problema dell’ebreo in Italia, in Angelo Fortunato Formiggini. Un editore del Novecento, Bo-logna, Il Mulino, 1981, pp. 55-72 (= Scritti novecenteschi, cit., pp. 119-29 ; 105-117) ; Prefazione a A. Cavaglion, G.P. Romagnani, Le interdizioni del Duce. A cinquant’anni dalle leggi razziali, Torino, Albert Meyer, 1988, pp. 7-12 (= 20022). Sulla controversa questione v. S. Levis Sullam, Arnaldo Momigliano e la “nazionalizza-zione parallela”, « Passato e Presente », xxv, 2007, pp. 59-82, rist. in P. Bernardini, G. Luzzatto Voghera, P. Mancuso (curr.), Gli Ebrei e la destra : nazione, stato, identità e famiglia, Roma, Aracne 2007, pp. 61-93.
4 V. Angelo Mai, Prolusione al Convegno di Bergamo del 1981, in Angelo Mai e la cultura del primo Ot-tocento, Bergamo, Istituto Universitario, 1985, pp. vii-xxiii (= Omaggio (critico) al cardinale Angelo Mai, in Ottocento italiano tra il nuovo e l’antico, I. Alle prese con la storia, Modena, Mucchi, 1992, pp. 85-99).
5 Uno dei suoi ultimi interventi sull’antico fu dedicato a Un secolo di studi sulla Politeia Athenaion, in G. Maddoli (cur.), L’ Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi, Ac-quasparta, 27-29 Maggio 1991, Napoli, Esi, 1994, pp. 8-18. Al Convegno era presente anche Mario Attilio Levi. V. anche il ricordo di G. Maddoli, in G. Maddoli (cur.), L’Athenaion Politeia dello pseudo-Senofonte, Napoli, Esi, 1997, pp.7-8.
Carlo Franco50
fedeltà a istituzioni culturali ‘marginali’, come le Accademie : 1 ciò in analogia con i temi, spesso anch’essi marginali, della sua ricerca. All’opposto rispetto agli ambizio-si ripensamenti di un Momigliano, Treves si impegnò nel recupero, attraverso una fittissima trama di riferimenti ad autori minori o ad aspetti meno noti dei maggiori, di intere stagioni della cultura italiana. In questo percorso egli trovò, come già per i volumi maggiori del 1962, alcuni interlocutori attenti, che di volta in volta discus-sero, criticarono, svilupparono il suo punto di vista (in modi e con accenti diversi si possono ricordare lavori di Luciano Canfora, Emilio Gabba, Marcello Gigante, Arnaldo Momigliano, Sebastiano Timpanaro 2), ma l’impressione che lasciano le pagine più recenti è che soprattutto egli dialogasse con se stesso. 3 Le sue scelte tematiche erano assolutamente refrattarie alle barriere accademiche non pure dei ‘raggruppamenti’, ma anche delle discipline (onde i suoi scritti coinvolgono filologi dell’antico e del moderno, così come storici dell’antico e del moderno : è l’esigenza oraziana del ponere totum, da lui più e più volte riproposta con forza). Così erano anche le sue scelte espressive (quel suo stile caratteristico, ornato, arduo e allusivo) : in entrambe si è giustamente letto il segno di un isolamento :
“non si sfugge all’impressione che la scelta ottocentista sia stata per Treves, in qualche modo, anche la via del rifugio, la risposta ad un disadattamento culturale [...] che egli dovette vivere (e soffrire) negli ultimi decenni, a un’incapacità (o a un’indisponibilità) di inserirsi completa-mente nel nuovo clima affermatosi in Italia, anche nelle discipline in cui era accademicamen-te impegnato, dal dissolvimento dell’atmosfera culturale in cui si era formato”. 4
Il senso di questo isolamento si può misurare considerando il momento finale dell’itinerario di Treves, con la ristampa nel 1992 dei più importanti lavori dell’ulti-mo trentennio 5 (con esclusioni per altro importanti, soprattutto i profili stesi per il Dizionario Biografico degli Italiani, che formano in alcuni casi il pendant documenta-rio dei saggi ‘ideologici’). Da essi conviene muovere per un riesame complessivo. A Treves la riproposta di lavori precedenti non richiedeva palinodie, al più correzioni di dettaglio e integrazioni : non solo perché alcuni dei suoi temi non erano stati né prima né dopo affrontati da altri, ma anche per il suo caratteristico e determinato impegno a mantenere una salda continuità di vedute. Lavori nati separatamente si ricomponevano così senza sbalzi di tono e prospettiva, senza mutamenti del percor-so o delle scelte di fondo.
Un primo tratto che accomuna i suoi profili degli scrittori italiani è la rivendica-zione costante di un radicamento storico contro schematismi (spesso ideologici) sovrapposti a posteriori. Così contro il Leopardi “progressivo” egli ricostruiva un intellettuale quasi del tutto astratto dagli sviluppi della cultura che conducevano al
1 Socio dell’Istituto Veneto, dell’Arcadia e dell’Accademia di Napoli, come ricorda il profilo biografico nel risvolto di Ottocento Italiano.
2 In tempi recenti i giudizi di Momigliano sui lavori storiografici di Treves mutarono : v. soprattutto « German Romanticism and Italian Classical Studies » (1986), in Ottavo Contributo, cit., pp. 58-72 ; Classical Scholarship, cit., ivi, pp. 73-89.
3 V. in particolare la Introduzione a Ottocento Italiano tra il nuovo e l’antico, i, cit., pp. 7-9.4 Pertici, Piero Treves, cit., p. 721.5 Ottocento Italiano, cit. ; Tradizione classica, cit. Su quest’ultimo vd. M.L-Chirico, « Atene e Roma » 37,
1992, pp. 204-06.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 51
Risorgimento ; contro la lettura di Manzoni come uomo di apoliticità rinunciata-ria richiamava, attraverso una pagina di Turati e un attento spoglio di testi minori come l’epistolario, la profonda coscienza storica e civile dello scrittore ; contro le apologie municipalistiche o le accuse polemiche al Mai, egli ricostruiva del monsi-gnore un’immagine storicamente attenta all’evoluzione della cultura nell’Italia del-la Restaurazione ; contro la visione solo politica di Mazzini riscopriva il suo interesse per la tradizione e l’Antico, il frequente richiamo al modello di Roma nel pensiero dell’unità, lo sforzo di porre l’umanesimo al centro della civiltà italiana e ancora una volta il radicamento nella cultura italiana. Il tutto nella consueta, inattuale for-ma espositiva : ciò che Momigliano esponeva con rapidi tratti, Treves delineava con scorci arditi ed eruditissimi, letture desuete, accostamenti inattesi, e memorie fa-miliari.
La necessità di una storia degli studi classici su base regionale era prefigurata da Treves, sulla scorta del progetto crociano-gentiliano di studi di storia culturale delle regioni d’Italia, già nelle ricerche degli anni ‘50 e ‘60 (Milano, Toscana, Roma) : il percorso negli anni conobbe notevoli arricchimenti, pur senza giungere a coprire, nemmeno per assaggi, l’intero territorio nazionale. Soprattutto il Sud fu da Treves poco indagato, perché ritenuto sostanzialmente estraneo alle linee più feconde del-lo studio dell’antico. Ricerche successive su Napoli 1 e sulla Sicilia 2 hanno chiarito l’importanza delle esperienze di studio là svolte : ma in effetti quelle da Treves in-dagate erano le sue regioni, quelle che più e veramente conobbe, perché sede sua o delle sue radici.
Tra gli ambiti con maggior partecipazione rievocati fu certo la Toscana, tra Gran-ducato e Italia unita. Nella poliedrica figura del “neoguelfo” Gino Capponi si rico-nosceva la validità di una stagione di studi colta e civilmente impegnata, cancellata dalla prevalenza del positivismo filologico ma invece fondamentale a capire il nesso tra apporti locali e senso unitario della cultura italiana nel XIX secolo. Quindi la Romagna dove, da Vincenzo Monti a Renato Serra, fiorì con impegno culturale e politico una ‘scuola’ classica, da cui Treves considera separato Carducci ma non il post-carducciano e amato Manara Valgimigli. E ancora il Veneto, diviso tra l’ere-dità greco-dalmatica della Serenissima, da Foscolo a Tommaseo, e le forme di una letteratura d’occasione e di una storiografia erudita : nel corso del secolo si perse lo slancio ‘europeo’ del classicismo canoviano, approdando o ad esiti provinciali o ad una erudizione poco storicamente avvertita, e che fu prevalentemente emarginata dalla crescente vocazione “pratica”, una volta il Veneto unito all’Italia. 3
1 La cultura classica a Napoli nell’Ottocento, i-ii, Napoli, Università degli Studi, 1987, iii, ivi, 1991, a cura di M. Gigante. Sulla prima opera v. P. Treves, « Giornale Storico della Letteratura Italiana », cvi, 1989, pp. 137-43.
2 In generale, e per la Sicilia in particolare, G. Salmeri, L’antiquaria italiana dell’Ottocento, in Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell’Ottocento, a cura di L. Polverini, Napoli, ESI, 1993, pp. 265-98, con ulteriore bibliografia. Per l’Umbria v. Erudizione e Antiquaria a Perugia nell’Ottocento, a cura di L. Polverini, Napoli, esi 1998.
3 Sulle Venezie v. D. Nardo, Minerva Veneta. Studi classici nelle Venezie fra Seicento e Ottocento, Vene-zia, Il Cardo, 1997 ; C. Franco, Lo studio dell’antichità a Venezia nell’Ottocento, in Seminari Piero Treves 1995/6, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 1999, pp. 173-193 ; Id., L’archeologia e immagine di Venezia tra xix e xx secolo, Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, cxiii, 2001, pp. 679-702 ; Id.,
Carlo Franco52
Il respiro storico più ampio si coglie nei profili di Carducci, D’Annunzio e Pascoli. Nelle trasformazioni subite da Roma nel periodo 1870-1900 egli riconobbe, contro le consuete svalutazioni, l’importante tentativo della nuova Italia di darsi strutture culturali nuove, di formarsi una identità compiuta e sprovincializzata, di emulare in una prospettiva europea (e più anglo-francese che tedesca) le forme culturali valide soprattutto per la borghesia, nuova classe arrivata alla dirigenza o alla buro-crazia : erano gli anni della formazione di De Sanctis. Nell’accostarsi ai grandi poeti dell’Ottocento italiano Treves poté riscoprire o ridefinire aspetti ancora trascurati : Carducci, dopo il commento del 1968, fu indagato nel suo rapporto antinomico con la tradizione letteraria e civile legata a Pietro Giordani, ancora presente in Toscana, e quindi ripensato come maestro universitario attraverso le figure dei suoi allievi. D’Annunzio fu letto, con il Trionfo della Morte, come intellettuale radicato in Abruz-zo ma di coscienza italiana e prospettiva europea, quindi nei richiami classici (di sapore nietzschiano, ma legati più alla formazione scolastica) del Fuoco. Di Pascoli riscoprì con intuito storico il senso del discorso libico del 1911, rivendicando le radici sinistrorse di quel moto filo-colonialista.
La vastità dei temi non deve trarre in inganno : in realtà, la ricerca storica presenta, all’interno dei due volti di storico del mondo antico e della tradizione classica, una solida unità di fondo. 1 Lo stesso mondo ottocentesco rievocato con partecipazione nei profili letterari ritorna con più specifico richiamo alla storia antica nei saggi ristampati e riuniti nel volume ricciardiano. Esso si apre ancora nel segno della lette-ratura, con i profili di Carducci e Pascoli (già preposti alle antologie poetiche com-mentate) ; un Carducci ripensato anche attraverso le memorie personali e quindi rivalutato nella sua scelta di essere ‘tradizione’, nella funzione sua centrale entro la cultura italiana tra i due secoli ; il Pascoli d’altronde è rivisitato nella sua formazione classica ed italiana, nel suo antistoricismo ed antifilologismo, nel suo disadattamen-to di uomo e però nel suo integrarsi peculiare dentro la tradizione (contro le letture moderne in chiave simbolistica) ; nel D’Annunzio infine si valorizza la formazione al “Cicognini”, legata all’estrema stagione della Toscana neoguelfa.
Attraverso le “tre corone” Treves ricostruiva la formazione dei suoi maestri, cercando di capire quali aspetti del mondo antico avessero influito sulla loro sen-sibilità e sul loro gusto. Si spiega così la riflessione sulla funzione dell’Antico in Croce. Notevole l’osservazione, certo legata alla storia personale di Treves me-desimo, che “l’indifferenza ai Classici del pur classicista Croce pesò, e non po-co, sull’avviamento o sviamento degli studi antichistici nell’Italia novecentesca”, perché non sollecitò la filologia classica a superare in termini di humanitas il fatto tecnico-ecdotico. Solo tra il ‘20 e il ‘30 si sarebbe avuta, ma con vari limiti, una fase ‘crociana’ di studi classici, ma la lezione del maestro, più che nella critica svolta in termini di poesia-non poesia, sarebbe consistita soprattutto nell’aver alimentato il
Antiquaria e studi classici nel Friuli ottocentesco, in M. Buora, A. Marcone (curr.), La ricerca antiquaria nell’Italia nordorientale. Dalla Repubblica Veneta all’Unità, Trieste, Editreg, 2007, pp. 1-37 ; Id., Dalla « Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto » al cil, in A. Buonopane, M. Rebaudo, A. Marcone (curr.), La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età napoleonica all’Unità, Firenze, Le Monnier, 2007, pp. 336-51.
1 Quella che gli meritò la dedica da parte di G. Devoto de Il linguaggio d’Italia, Milano, Rizzoli, 1974 : “A Piero Treves, maestro di storia”.
Piero Treves : tradizione italiana e cultura europea 53
dibattito (ad esempio con il ‘nemico’ Pasquali) per una autentica comprensione storica dell’antico.
Su queste premesse, a favore di una concezione non tecnica della filologia, Treves rivisitava poi alcune figure dell’antichistica italiana come Francesco Acri, dai cui studi delineò le vicende del platonismo nell’Italia del xix secolo, oppure Girolamo Vitelli, severamente giudicato come studioso grandissimo nel magistero tecnico (della lingua, ad esempio), ma programmaticamente estraneo all’esigenza dell’in-terpretazione ‘totale’ del testo. Esplicito e provocatorio appare così l’accostamento entro la cornice della “antifilologia” tra i profili di Vitelli e di Ettore Romagno-li : di quest’ultimo Treves evidenziava, a fianco delle note spinte irrazionalistiche e estetizzanti e nazionalistiche, il non precario contatto con la pur avversata cultura tedesca e lo sforzo imponente ma “vano” di diffusione popolare della cultura clas-sica. Il percorso è allargato poi a studiare il “ritorno alla storia”, ancora una volta attraverso autori anche marginali ed emarginati, come Ettore Ciccotti, lo storico e politico socialista che contribuì a rendere meno ignoto agli italiani il lavorio degli storici sociali tedeschi e fu oggetto di aspre critiche da parte di De Sanctis, oppure Corrado Barbagallo, storico di vasti interessi che dalla “Nuova Rivista Storica” e in numerosi volumi diffuse anche durante il ventennio fascista la metodica della storia economico-giuridica, applicata anche in chiave sociologica ed istituzionale alla storia antica. L’esperienza degli studi classici italiani nel xix secolo precedette l’equazione crociana di critica e storia della critica, e fu quindi contributo caduco, ma importante. Nella stessa prospettiva anticonvenzionale e idiosincratica si pone il ritratto di Concetto Marchesi, intellettuale difficile da inquadrare entro le catego-rie ideologiche e che nell’opera sua mostrò sollecitazioni incoerenti e non troppo avvertite nell’aggiornamento culturale, onde né filologo né storico ma “letterato” appare il termine che meglio (e riduttivamente) lo definirebbe. E come nel volume antologico del 1962 (ancora a ribadire la validità di un percorso), la serie si chiude nel nome di Gaetano De Sanctis. A giudizio di Treves, la sua vicenda culturale e me-todica segnò il passaggio dalla radice italiana ottocentesca all’influsso della Methode germanica, e l’approdo ad una storiografia nutrita di problemi risorgimentali e di tensioni morali, capace pur tra grandi scosse di tentare l’ultima lettura ‘integrale’ del mondo antico prima della catastrofe dittatoriale e poi bellica.
Che il dopoguerra non fosse oggetto possibile di analisi, e non solo per evidenti problemi di giudizio sulla contemporaneità, risulta chiaro da uno scritto apparso postumo. 1 In esso Treves tracciava il suo personalissimo profilo della cultura anti-chistica italiana del nostro secolo, concentrandosi in prevalenza sulla produzione del primo quarantennio : data lo scarso interesse suo per le questioni filologiche, e la lontananza dalle tendenze della ricerca post-bellica, il quadro risulta piuttosto sbilanciato. Il saggio, omaggio all’amato Istituto per gli Studi Storici, 2 riprendeva il taglio di una comunicazione presentata anni prima ad un convegno romano. In
1 Gli studii classici nell’Italia del Novecento, « Annali Istituto Italiano Studi Storici », xii, 1991/94 [Studi per Ettore Lepore], pp. 625-38.
2 Al quale fu destinata, alla morte della moglie Janet nel 1994, una parte della biblioteca (divisa con la Biblioteca Querini-Stampalia di Venezia) : vd. A. Trama, M. Tarantino, I libri di Piero Treves, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1998.
Carlo Franco54
quella sede l’intervento aveva suscitato le aspre reazioni di quanti erano restati de-lusi dai giudizi espressi (e dai silenzi sopra l’opera propria) : 1 anche quei contrasti confermano il carattere privato del percorso culturale dell’ultimo Treves. Tuttavia la sua rivendicazione della necessità di un movente profondo e ideale nello studio dell’antico appare più che mai importante oggi, mentre i tramontano i fasti del-la ‘tecnica’ e della filologia e l’antico pare condannato all’emarginazione, quindi all’estinzione culturale. Per questo mette conto ribadirne il senso, e a chiarirlo in sintesi vale la frase emblematica di Nietzsche, che Treves propose a conclusione della sua prolusione triestina, e che riassume il senso della sua ricerca :
“Ad attestare di essere senza colpa, il filologo deve comprender tre cose : l’antico, il presente, se stesso. Ed egli non è senza colpa se non comprende o l’antico o il presente o se stesso”. 2
1 Gigante, Piero Treves, cit., pp. 13ss. Negli Atti del Congresso Internazionale su La Filologia greca e la-tina nel secolo xx, Roma, 17-21 settembre 1984, Pisa, Giardini, 1989, vol. ii, pp. 1065-1140, comparve invece della relazione di Treves un contributo, molto importante, di E. Degani, La filologia greca nel secolo xx (Italia), ora in Id., Filologia e storia. Scritti di Enzo Degani, Hildesheim, Olms, 2004, vol. ii, pp. 1046-1120. A campione delle polemiche contro Treves v. l’Editoriale della Direzione, « Quaderni Urbinati di Cultura Classica” », xvii, 1984, pp. 191-92 (con l’Addendum, ivi, xviii, 1984, p. 19), ove Treves è definito : “vecchio boy-scout con lo sguardo rivolto al passato, incapace di comprendere qualsiasi esperienza culturale che esuli dagli schemi della dittatura idealistica”. La rivista era (ed è) diretta da Bruno Gentili (già allievo di Perrotta).
2 F. Nietzsche, Richard Wagner a Bayreuth. Considerazioni inattuali, iv. Frammenti postumi (1875-76), a cura di G. Colli, S. Giametta, M. Montinari, Milano, Adelphi, 1967, p. 186, 7 [7] : la traduzione riportata è di Treves.