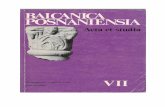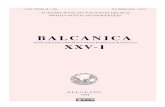L'area nord-lucana nella Prima Età del Ferro: formazione e struttura degli insediamenti
A. Cazzella, M. Cultraro, G. Recchia, Relazioni tra l'Italia centro-meridionale, la Sicilia e l'area...
Transcript of A. Cazzella, M. Cultraro, G. Recchia, Relazioni tra l'Italia centro-meridionale, la Sicilia e l'area...
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA
ATTI DELLA XLIII RIUNIONE SCIENTIFICA
L’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
dedicata a Gianni Bailo Modesti
Bologna, 26-29 novembre 2008
FIRENZE 2011
Sede della riunioneAlma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di ArcheologiaPiazza S. Giovanni in Monte 240124 Bologna
Comitato SCientifiCoAlberto Cazzella, Daniela Cocchi Genick, Raffaele Carlo de Marinis, Enrico Procelli, Giuseppa Tanda
Coordinatori delle SeSSioniAnna Paola Anzidei, Maurizio Cattani, Alberto Cazzella, Brunetto Chiarelli, Daniela Cocchi Genick, Alfredo Coppa, Massimo Cultraro, Raffaele Carlo de Marinis, Ivana Fiore, Alessandro Guidi, Giovanni Leonardi, Roberto Maggi, Francesco Mallegni, Domenico Marino, Emanuela Montagnari, Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Annaluisa Pedrotti, Patrizia Petitti, Antonio Salerno, Mara Silvestrini, Maurizio Tosi, Annalisa Zarattini
CoordinamentoDaniela Cocchi Genick
Comitato organizzatoreMaurizio Cattani, Antonio Curci, Elisabetta Govi, Luigi Malnati, Cristiana Morigi Govi, Giuseppe Sassatelli, Maurizio Tosi, Daniele Vitali
SegreteriaAntonio Curci, Annachiara Penzo
redazione e impaginazione attiDaniela Cocchi Genick, Antonio Curcicon la collaborazione di Noemi Brugnettini, Ivano Devoti
© Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2011Via S. Egidio, 21, 50122 Firenzewww.iipp.it , e-mail: [email protected]
iSBn 978-88-6045-096-8
Volume pubblicato con il contributo di:alma mater Studiorum univerSità di Bologna, dipartimento di arCheologia
XLIII Riunione Scientifica - L’età del rame in Italia
premeSSa
Affrontare il problema delle relazioni con l’area egeo-balcanica durante l’Eneolitico implica anche tenere conto del dibattito relativo al signi-ficato storico da dare a tali relazioni e del qua-dro teorico-metodologico contemporaneo in cui tale operazione si inquadra. Non pensiamo che sia necessario prendere nuovamente in esame la differenza tra diffusionismo, come impostazione legata a un definito momento storico della ri-cerca ormai ampiamente superato, e diffusione, come fenomeno che non può essere negato nei casi in cui ci siano dati sufficienti per attestarlo e che non può, quindi, essere considerato il “pa-rente povero del diffusionismo” (Dolfini 2004, p. 135). La confusione tra i due termini appare assolutamente da evitare: se la parola diffusione non piace, si può sostituire con l’espressione
contatto culturale, ma va ricordato che in molti casi è riconoscibile l’area di origine di un deter-minato elemento e quella in cui viene accolto, eventualmente modificandolo e adeguandolo alla realtà locale. È forse inutile ripetere che una maggiore consapevolezza critica acquisita negli ultimi decenni nei confronti della diffusione (o contatto culturale) comporta da un lato una par-ticolare prudenza nell’accettare correlazioni che non siano sufficientemente caratterizzate o di cui non si riesca a seguire adeguatamente il percorso, ma che appare comunque importante segnalare, dall’altro l’impegno a interrogarsi, al di là della constatazione del fenomeno, sul significato che tali correlazioni possono aver avuto e sull’im-patto riscontrabile sui gruppi coinvolti.In relazione al tema in esame, a livello di pre-messa ci limitiamo a constatare che uno dei principali problemi che si incontra è quello cro-
(1) Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità - Università di Roma “La Sapienza”, Via Palestro 63, 00184 Roma; e-mail: [email protected](2) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Via Biblioteca 4, 95125 Catania; tel. 095/311981; e-mail: [email protected](3) Dipartimento di Scienze Umane - Università di Foggia, Via Arpi 155, 71100 Foggia; e-mail: [email protected]
RIASSUNTO - relazioni tra l’italia Centro-meridionale, la SiCilia e l’area egeo-BalCaniCa durante l’eneo-litiCo - Gli Autori prendono in esame il problema dei rapporti tra l’Italia centro-meridionale, la Sicilia e l’area egeo-balcanica, con alcuni riferimenti anche a Malta, durante l’Eneolitico alla luce dei più recenti dati. Le aree che entrarono in contatto variarono nel tempo e i dati a nostra disposizione sono scarsi. Rimane ancora difficile, dunque, dare un quadro unitario delle diverse sfere di interazione che si attivarono, delle motivazioni alla loro base, dei meccanismi di contatto e dei percorsi seguiti nella circolazione dei modelli culturali.
SUMMARY - relationShipS among Central and Southern italy, SiCily and the area inCluding aegean and BalkanS - Authors discuss the subject of relationships among Central and Southern Italy, Sicily and the area including Aegean and Balkans. On the light of the most recent research some new hypotheses about the connection during the Cop-per Age are pointed out, also taking in account the Maltese Archipelago. Since the regions that were in contact changed throughout the time and data remain lacking, it is still difficult to have a complete framework of these interactions. We have to find out the reasons of establishing connections, the mechanisms of interaction and the way cultural models cir-culated among the Eastern and Central Mediterranean.
alBerto Cazzella(1) - maSSimo Cultraro(2) - giulia reCChia(3)
Relazioni tra l’Italia centro-meridionale, la Sicilia
e l’area egeo-balcanica durante l’Eneolitico
158 a. Cazzella - m. Cultraro - g. reCChia
nologico. Nelle attuali indagini sui fenomeni di diffusione, infatti, questi non possono più essere utilizzati in modo prioritario come strumento di datazione per contesti meno conosciuti a partire da quelli meglio documentati, ma al contrario la compatibilità cronologica deve essere acquisita a priori, possibilmente sulla base di sistemi di data-zione esterni come il radiocarbonio calibrato o la dendrocronologia. Nel caso specifico si può no-tare che, quando riscontrabili, i collegamenti con la penisola balcanica non creano in genere pro-blemi di datazioni compatibili, mentre quelli con l’Egeo implicano in alcuni casi inquadramenti cronologici che, sulla base delle datazioni attual-mente accettate, rendono più difficili i rapporti con i contesti italiani: questi, infatti, risultano ap-parentemente più antichi. Si tratta quindi di ve-rificare se le affinità ipotizzate siano verisimili o se non ci sia la necessità di portare ancora avanti una revisione della cronologia di quest’ultimo ambito, argomento che non è possibile affron-tare in questa sede.
A.C.
italia Sud-oCCidentale, eolie e SiCilia
Grazie al contributo di L. Bernabò Brea e M. Cavalier sono oramai ben note le linee di svi-luppo dell’Eneolitico in Sicilia e nell’arcipelago eoliano (Bernabò Brea 1958, 1968-69, 1988). Si deve agli stessi studiosi il primo tentativo orga-nico di inquadrare lo sviluppo delle varie facies archeologiche all’interno di una vasta rete di re-lazioni e correlazioni con l’area egeo-balcanica e il Mediterraneo orientale (Id. 1953-54; Cavalier 1960). A distanza di anni il quadro di riferimento proposto dai due studiosi può ritenersi ancora valido nella sua impostazione generale, ma oc-corre meglio definire i meccanismi di sviluppo del fenomeno, ricorrendo all’ausilio di sistemi di datazione esterna, quali il radiocarbonio calibrato o la dendrocronologia.La fase di transizione dal Neolitico all’Eneolitico, nota come facies di Spatarella nelle Eolie, risulta oggi documentata anche in alcuni siti nella regione pedemontana dell’Etna (Catanzaro et alii 1975-76) e lungo la costa agrigentina (Piano Vento presso Palma di Montechiaro e Casalicchio Agnone,
presso Licata) (Castellana 1995; Gnesotto 1982). Benché il repertorio vascolare di questo oriz-zonte presenti una forte matrice tardo-neolitica riconducibile alla facies di Diana, compaiono due elementi di novità, la ciotola troncoconica con de-corazione a linee orizzontali a zig-zag sotto l’orlo e l’olla a colletto con decorazione a cuppelle. En-trambe le fogge contraddistinguono la fase finale del Neolitico Recente della Grecia settentrionale, in particolare Sitagroi IIIB-C, che presenta strette affinità con il Calcolitico Antico dell’Albania me-ridionale (Maliq IIa-b) e della Macedonia greca (Mandalo I-II) (Johnson 1999).Un altro elemento dalla forte valenza cronolo-gica è l’ansa “a testa di elefante” che, sia nelle Eolie che in Campania (Mulino di S. Antonio di Avella, Avellino), compare nella fase di Spa-tarella e perdura nelle fasi iniziali dell’Eneolitico siciliano. Ampiamente diffusa in contesti del Neolitico Tardo/Calcolitico Antico della Grecia settentrionale (Mandalo I-II; Rachmani; Sitagroi III-IV; Kritsana), nell’Egeo insulare (Kephala) e nella Troade (livelli di Kumtepe Ib/c, anteriori a Troia I) (Renfrew 1972, pp. 68-80), questa varietà di ansa offre un ulteriore aggancio in termini di cronologia relativa con l’orizzonte di Spatarella (Speciale in questo volume). All’Egeo del Nord potrebbero rinviare anche altri elementi, oltre le “prese a testa di elefante”, quali l’uso della pittura bianca su fondo scuro e la brunitura disegnativa che contraddistinguono una fase non certo ini-ziale dell’Eneolitico nella Sicilia occidentale (Caz-zella 1972, pp. 254-258).Non è ancora chiaro il sistema di relazioni - in termini stratigrafici e di fenomeni culturali - tra la ceramica del tipo Spatarella e la fase più an-tica dell’Eneolitico siciliano, che prende i nomi dai siti di San Cono e Piano Notaro, con varia-zioni locali che contemplano produzioni dipinte (stile del Conzo) e con decorazione excisa (con-testi sud-occidentali: Castellana 1995, pp. 82-84; Maniscalco 1994, p. 325, fig. 6). Il repertorio vascolare trova buoni riscontri nell’arcipelago maltese (Cazzella 2000; Cultraro 2008), nell’am-bito dell’aspetto Zebbug e dello stile Mgarr probabilmente coevo al primo, orizzonte per il quale oggi disponiamo di varie datazioni radio-metriche a partire almeno dall’inizio del IV mil-lennio cal. BC (Trump 2004a, p. 230; 2004b, p.
159relazioni tra l’italia Centro-meridionale, la SiCilia e l’area egea...
256). Un’ansa tubolare a margini tagliati obliqua-mente riconducibile a tipi noti a Zebbug è stata di recente segnalata in un contesto da Casalicchio Agnone, in un deposito con materiali della classe di San Cono-Piano Notaro, in corso di edizione da parte dello scrivente.Nel distretto nord-orientale della Sicilia, e forse anche in parte nella fascia ionica del Messinese, alla diffusione della ceramica di tipo Spatarella segue l’introduzione della ceramica Piano Conte, in piena analogia con l’evidenza offerta dalle isole Eolie. Questa classe, anche se con variazioni lo-cali, registra un’ampia diffusione in diversi con-testi peninsulari, dalla costa tirrenica calabra (Salerno e Vanzetti 2004, pp. 210-213) fino alla Puglia garganica (Vigliardi 1982). Ceramiche con decorazioni a solcature orizzontali sono dif-fuse in ambito balcanico nella facies di Proto-Nakovan e Nakovan (Chapman et alii 1996, pp. 205-209; Tasic 1995, pp. 38-42) e in numerosi siti della Grecia continentale, comprese le isole ioniche, in un momento di transizione tra il Ne-olitico finale e l’antica età del Bronzo (Cultraro 2001, pp. 217-219).La stratigrafia della grotta Chiusazza (liv. inf. IV, tgl. 17-18) (Tinè 1965) e quella di recente ricon-trollata nel sito di Casalicchio-Agnone di Licata (str. VI), indicano la diffusione, dopo la fase di Spatarella, di un orizzonte con ceramiche inqua-drabili nell’ambito della facies di San Cono-Piano Notaro. Una più attenta rilettura del deposito stratificato di Casalicchio offre la possibilità (ma è solo al momento un’ipotesi di lavoro) di distin-guere due momenti per il San Cono-Piano No-taro. Il livello più recente è rappresentato da una classe di ceramiche dipinte in bruno su fondo giallino (stile Conzo), mentre la tradizionale ce-ramica excisa registra l’introduzione del decoro a “rosette” impresse. La diffusione di questo par-ticolare sistema decorativo coinvolge non solo la parte centro-meridionale della Sicilia, ma anche il distretto delle Madonie e la costa tirrenica del palermitano, area per la quale sarebbe necessa-rio rivedere i complessi della c.d. Cultura della Conca d’Oro I (Bovio Marconi 1944). Anche in questo caso sono i richiami a contesti esterni ad offrire alcune interessanti concordanze: in tutta la Calabria, ad esempio, la ceramica a ro-sette impresse ricorre in contesti di Piano Conte
evoluto/Gaudo iniziale (Grotta della Madonna di Praia, tgl. 21-16) per i quali le date calibrate da Vopa (Cosenza) offrono il 4570 BP, una data assai vicina alle datazione del fossato di Conelle E-D, dove è presente la ceramica a “rosette” (Sa-lerno e Vanzetti 2004, p. 213).Il vaso a barilotto dal sito eponimo di Piano No-taro presso Gela (Orsi 1908, fig. 10) ha chiari e indubbi confronti con il mondo egeo-balcanico, come è stato di recente sottolineato (Cazzella e Maniscalco cds), e con molta probabilità si tratta di un contenitore specializzato nella pro-duzione del burro. Tuttavia i richiami proposti a suo tempo con Poliochni del Periodo Rosso e Thermi II (Bernabò Brea 1964, tav. CXLVIII a-b; Seferiades 1985, p. 218), deponevano a favore di una recenziorità cronologica degli esemplari ana-tolici rispetto al vaso siciliano. La questione del décalage cronologico appare oggi definitivamente risolta, grazie ad una recente acquisizione dal sito di Kaklik Mevkii, nella regione di Afyon (Turchia occidentale), dove un vaso del tipo a barilotto compare in un livello correlabile con Poliochni Azzurra e Troia I early, orizzonte che, grazie alle ultime radiocronologie calibrate, si colloca intorno al 3000-2900 a.C. (Efe et alii 1995, fig. 25.87).Nella Sicilia occidentale, e in particolare nel di-stretto tra i fiumi Platani e Salso, la ceramica bru-nita del tipo Piano Conte si accompagna con la diffusione della classe dipinta di Serraferlicchio. Per questa classe rimangono ancora validi i con-fronti proposti anni addietro (Cassano e Manfre-dini 1975, pp. 208-210), in particolare per il tipo dell’olletta ansata a collo stretto (talvolta prov-vista di beccuccio di versamento), con la classe Dark on Light della Palestina del Bronzo Antico I, riferibile alla seconda metà del IV millennio a.C. (Blackham 2002, pp. 82-88, 100-101). L’af-finità viene estesa anche alla saliera e al boccale, in genere realizzati in Sicilia in ceramica incisa dello stile S. Cono-Piano Notaro, ma è utile sot-tolineare che i vasi gemini compaiono nel Pe-loponneso nord-occidentale (Olimpia e Elis) in contesti dell’Antico Elladico II, che si collocano intorno al 2600-2400 a.C. (Alram-Stern 2004). Non escluderei anche un eventuale ruolo giocato da Creta come intermediario, che deve essere ancora meglio definito anche alla luce delle più recenti definizioni delle classi ceramiche dell’An-
160 a. Cazzella - m. Cultraro - g. reCChia
tico Minoico I-III (Caruso in questo volume). Pertanto, un approfondimento nello studio del patrimonio formale della Grecia continentale e insulare potrebbe risultare di grande utilità a ri-durre non solo l’eventuale gap cronologico tra il Bronzo Antico palestinese e la facies siciliana di Serraferlicchio, ma soprattutto l’ampia distanza geografica che separa i due ambiti culturali.Un problema simile si pone anche per l’orizzonte finale dell’Eneolitico siciliano, e in particolare per la classe monocroma rossa di Malpasso e per quella bicroma dello stile di S. Ippolito, classi per le quali sono stati proposti possibili confronti con il panorama culturale del Bronzo Antico II dell’Anatolia nord-occidentale e di Poliochni del Periodo Rosso (Bernabò Brea 1968-69, p. 32; Ca-valier 1960). Se il richiamo al mondo anatolico trovasse un interessante elemento di supporto nella produzione metallurgica relativa alla Sicilia dell’Eneolitico finale (utile in tal senso è lo spillone a doppia capocchia dalla grotta del Vecchiuzzo; Fontebrera in questo volume), anche in questo caso si pone il problema della lunga distanza tra le due aree, che potrebbe essere colmata dall’isola di Creta, area nella quale L. Bernabò Brea aveva identificato possibili confronti per il vaso con becco cilindrico di versamento attestato in con-testi S. Ippolito (Bernabò Brea 1968-69, p. 35).Il quadro che emerge dai dati esposti e dalle con-siderazioni formulate spinge ancora una volta a sottolineare il ruolo centrale svolto dalla Sicilia nel sistema di rapporti, a lungo e breve raggio, tra diversi comprensori culturali del Mediterra-neo. Tuttavia, nel caso dell’area egeo-balcanica, il problema maggiore è quello di ricostruire la possibile concatenazione dei probabili rapporti a breve distanza, compresi gli eventuali sposta-menti di gruppi umani, ma questa operazione non è al momento realizzabile perché presuppor-rebbe un’organica rivalutazione della griglia delle cronologie assolute che, nel caso dell’Eneo litico siciliano, sono ancora assai limitate. Una buona base di partenza per reimpostare il discorso potrebbe essere quella di spostare l’attenzione sull’arcipelago maltese, un’area che, oltre a di-sporre di un’ampia gamma di datazioni radiome-triche (Trump 2004a), registra nel corso del III millennio a.C. la presenza di numerosi elementi culturali riconducibili in parte al mondo egeo-
anatolico e soprattutto alla regione nord-afri-cana, spesso dimenticata nell’analisi delle culture dell’Eneolitico siciliano.
M.C.
parte orientale della peniSola italiana
Rapporti con la penisola balcanica e la Gre-cia sono ben documentati dal Neolitico: non è certo questo un elemento di novità specifico dell’Eneo litico per l’area in esame. Anche il pro-blema di un’eventuale cesura fra Neolitico ed Eneolitico non si risolve considerando tali rap-porti. Si tralascia, quindi, la fase iniziale dell’Ene-olitico o finale del Neolitico, secondo le diverse terminologie adottate, corrispondente con il pe-riodo di sviluppo delle facies di Macchia a Mare, Paterno, Attiggio 6: tale fase ha forti legami con i momenti precedenti, anche se si manifesta qual-che innovazione come l’uso sporadico (in base ai dati attuali) di tombe a grotticella artificiale (atte-stato ancora prima ad Arnesano) con presenza di qualche manufatto metallico nel sito garganico di M. Pucci presso Peschici (Cuda 1990).Come avviene già per le facies sopra ricordate, anche nel primo momento per cui viene in genere concordemente utilizzato il termine “Eneolitico” si ha qualche elemento di correlazione tra le di-verse regioni che compongono l’area in esame, ma non mancano specificità locali. L’aspetto al momento meglio riconoscibile è quello di Piano Conte - Malanotte (Vigliardi 1982), ben atte-stato in Puglia. La presenza dello stile ceramico che lo contraddistingue è indiziata in Abruzzo in modo non sicuro (grotta S. Angelo, con pre-senza anche della brunitura disegnativa: Di Fraia e Grifoni Cremonesi 1996, pp. 191-192, 195, figg. 39.6,8-10; 40.7; S. Clemente: Radi 1986-87, p. 163, fig. 3.6,7,9), mentre nelle Marche, accanto a un frammento decorato a scanalature dall’abi-tato di Fontenoce - area Guzzini (Silvestrini et alii 2000, fig. 10.1), si possono forse ricollegare a tale aspetto alcuni vasi dalla necropoli del medesimo sito, quali scodelle e un vaso a fiasco decorati con scanalature (tt. 3, 6, 8, 12: Silvestrini e Pi-gnocchi 1997). Le datazioni radiometriche sono poche e talora imprecise (Cazzella e Silvestrini 2005, tab. 1): si può indicativamente pensare a
161relazioni tra l’italia Centro-meridionale, la SiCilia e l’area egea...
un inizio del fenomeno nella prima metà del IV millennio. Le facies extraitaliane cui in genere si è fatto riferimento (Moscoloni 1990-91, p. 260; Cazzella 1994, pp. 9-10) sono quelle di Protona-kovan e Nakovan (Tasic 1995, pp. 41-42), per quel che riguarda l’ex-Yugoslavia, e un aspetto ancora mal documentato in Grecia e nelle aree adiacenti, posto tra la fine del Neolitico e l’inizio del Bronzo Antico, datato da Johnson (1999) a livello di proposta tra 3700 e 3400 cal. BC. La brunitura disegnativa (sopra ricordata per grotta S. Angelo e attestata anche a Conelle da un fram-mento sporadico: Cazzella e Moscoloni 1999, tav. 69.22) può rinviare al Neolitico Finale dell’Egeo (uno dei pochi siti datati con il radiocarbonio è quello di Kephala, riferibile alla prima metà del IV millennio BC: Coleman 1977).L’uso delle scanalature contraddistingue la ce-ramica solo di alcune tombe della necropoli di Fontenoce - area Guzzini, al cui interno ci sono, come è noto, differenze tipologiche non ricolle-gabili in modo evidente a scansioni tipologiche (Silvestrini et alii 2005). In altre tombe dello stesso sito e in necropoli vicine non si trova l’uso delle scanalature: tali contesti a loro volta si suddivi-dono (bisogna comunque tenere conto del fatto che gli altri contesti funerari eneolitici marchi-giani non sono molto consistenti) tra quelli che utilizzano i vasi a fiasco (in genere con presine forate verticalmente, come ad es. Camerano: Ba-roni e Recchia 2005; Baroni et alii 2006) e quelli che non sembrano utilizzarli (ad es. Recanati - cava Kock: Carboni et alii 2005).L’uso dei vasi a fiasco, soprattutto se muniti di presine forate, riporta ad altri contesti del Pe-loponneso (Elis: Cazzella e Moscoloni 1993), dell’Attica e delle Cicladi (Cultraro 2006, pp. 406-407), ma in relazione ad essi si pone uno dei problemi accennati nella premessa. Gli ipo-tetici modelli sembrerebbero infatti più recenti degli esemplari marchigiani: nel caso di Elis, la tomba è stata attribuita all’Antico Elladico II, ma potrebbe forse essere più antica (Koumou-zelis 1980, pp. 55-63); nel caso dell’Attica e delle Cicladi i vasi a fiasco si affermano nel Bronzo Antico 1 avanzato, che in genere non si fa ri-salire a prima degli inizi del III millennio BC (Broodbank 2000, fig. 1). La documentazione e le datazioni radiometriche sul periodo di passag-
gio tra Neolitico e Bronzo Antico in Grecia e nelle isole adiacenti sono ancora molto carenti e non si può quindi escludere che questa appa-rente contraddizione possa essere risolta in fu-turo. M. Cultraro (2006, p. 408) ha recentemente richiamato l’attenzione su rinvenimenti di vasi a fiasco dall’Epiro cronologicamente compatibili con le più antiche manifestazioni marchigiane, ma appare ancora difficile stabilire se possa es-sere considerata questa la loro area di origine. Il vaso a fiasco, in particolare con scanalature sul corpo e 4 presine forate verticalmente, è attestato nell’Egeo orientale (grotta di Ayos Bartholoma-ios a Lesbo: Papathanassopoulos 1996, p. 281, n. 156) durante il Neolitico Finale, ma resta problematico tracciare un ipotetico percorso di trasmissione del modello verso occidente. In quest’area già dal Neolitico tardo sono presenti anche i coperchi a corpo sub-cilindrico (Myrina a Lemno: Papathanassopoulos 1996, p. 281, nn. 157, 158), di cui è documentato un esemplare a Conelle (fase D: Cazzella e Moscoloni 1999, tav. 20,4), con analogo problema di distanza. A tale proposito si può solo ricordare che entrambe le categorie sono attestate nel Neolitico finale a Creta (Papathanassopoulos 1996, p. 283, n. 163), in posizione più vicina all’Italia.Un altro elemento di difficile collegamento spe-cifico è costituito dai vasi askoidi. Le datazioni radiometriche di alcune tombe di Fontenoce - area Guzzini li collocano immediatamente dopo la prima comparsa dei vasi a fiasco (Cazzella e Silvestrini 2005, tab. 1), ma va anche tenuto presente che il sistema ha oscillazioni statistiche che potrebbero in realtà annullare questa im-pressione di leggera recenziorità. Al momento appare ancora difficile conciliare i tre criteri di vicinanza geografica (sembrano mancare nella fascia costiera adriatica), affinità stilistica (tra gli esemplari meglio confrontabili si hanno quelli da Ezero, in Bulgaria) e cronologia (i contesti greci e delle isole Ionie con gli esemplari più simili a quelli dell’Italia orientale risultano troppo re-centi) (Misch 1992).Ulteriori indizi di un possibile collegamento esterno delle regioni centrali della penisola che in-teressano i due versanti dell’Appennino sono co-stituiti dalle testimonianze di uso di asce-martello a pomo distinto e del cavallo almeno negli ultimi
162 a. Cazzella - m. Cultraro - g. reCChia
secoli del IV millennio. Nel caso delle Marche per il primo elemento si possono ricordare le tombe a fossa (in particolare di Osimo: Annibaldi 1951-52) e i possibili morsi di cavallo di Conelle (Caz-zella cds a; due denti di cavallo sono stati segnalati a Berbentina di Sassoferrato: Azzaroli 1979).In Abruzzo si conoscono pochi elementi relativi a questa fase che possono rimandare a contesti extraitaliani, ma in questo caso non c’è problema di datazioni precoci in Italia; si può ricordare il probabile peso da telaio a base piana da grotta dei Piccioni (e forse Conelle: Cremonesi 1976, fig. 57; Recchia 2003, tav. 3), che può rinviare a Maliq IIb e Suplevec (Cazzella 2008), e il fram-mento di scodella da grotta Maritza, che trova confronto nella facies di Kostolac in ambito bal-canico (Cazzella 2003, pp. 221-222).Sia nelle Marche che nell’Abruzzo le facies che coprono gran parte del III millennio non sono ancora ben documentate: solo nella seconda metà del millennio compaiono produzioni cera-miche che possono ricordare il Campaniforme, la facies di Laterza e quella di Cetina, accanto ad altre forse di tradizione locale, come la ceramica di Ortucchio decorata a pettine trascinato (Caz-zella 2003, pp. 225-226, con bibliografia prece-dente; Cazzella e Silvestrini 2005, pp. 381-383; Manfredini et alii 2005).Per quel che riguarda l’Italia sud-orientale, tra-lasciando gli elementi Gaudo che sono qui at-testati in misura limitata (da ultimo i recenti rinvenimenti di F. Radina, in questo volume), si può ricordare che l’inizio della facies di Laterza è ancora mal definito. Si ha un chiaro sviluppo nel corso del III millennio e al momento c’è una sola datazione nell’ambito degli ultimi secoli del IV millennio, dal sito campano interno di Castel-baronia (Gangemi 1988; non lontano è il sito di S. Maria ‘a Peccerella, presso Foglianise, che ha fornito una datazione radiometrica che ricade nella prima metà del III millennio: Langella et alii 2008): non si può, tuttavia, escludere che que-sta impressione derivi da una carenza di dati. Le correlazioni esterne dell’aspetto di Laterza sono difficili da individuare, dal momento che non c’è una buona corrispondenza con altre facies bal-caniche od egee. M. Primas, oltre a stabilire un possibile nesso tra la tomba a cista di Tursi e i tumuli con cista del Montenegro degli inizi del
III millennio (Primas 1996, pp. 124-125, fig. 9.2), ha anche proposto una correlazione tra uno dei vasi più caratteristici di Laterza, la patera, e i vasi a vasca bassa sia dei Balcani sia delle Cicladi/Grecia (padelle), per lo stesso periodo (Ibid., pp. 58-64, fig. 5.6,8). Il confronto appare significa-tivo più sul piano della funzionalità (da porre verosimilmente in un ambito simbolico) che su quello dello stile. Un carattere di vera e propria importazione, probabilmente dalle isole Ionie, durante la prima metà del III millennio sembra avere, invece, il tubetto in osso inciso da San Se-vero (Cazzella 1999, p. 398, fig. 1; molti anni fa Evans e Daniel notarono la presenza di un ma-nufatto simile nel dolmen di Cabut, Dipartimento della Gironde: Evans 1953, p. 83, n. 1).Nella seconda metà del III millennio alcuni elementi potrebbero rappresentare una deriva-zione dalla sfera campaniforme (pochi sono i frammenti ceramici nettamente campaniformi), mentre gli elementi di origine balcanica (a loro volta in parte ispirati dal Campaniforme) e forse anche greca sono più chiari, soprattutto in Pu-glia. Si tratta dei ben noti elementi tipo Cetina, relativi sia a scodelle che a boccali, per i quali ci potrebbe essere una scansione interna, attual-mente non del tutto certa. Per quel che riguarda Olimpia, Rambach (2004) ha definitivamente risolto il problema della successione tra i rinve-nimenti che hanno preso il nome dall’area del Nuovo Museo e quelli dell’Altis, confermando l’ipotesi della Koumouzelis (1980, pp. 132-133), e ha posto in evidenza l’affinità tra questi ultimi e quelli di Rutigliano - Le Rene (Radina 1989; Cazzella 1992, p. 557; Maran 1998, p. 370; Ram-bach 2004, pp. 1231-1232). Questi a loro volta sembrerebbero collegarsi più direttamente con i reperti da Laterza e dall’area di Altamura (Ca-taldo 1996), mentre i primi ricordano maggior-mente i rinvenimenti della Puglia settentrionale e dell’area abruzzese-marchigiana (Cazzella 1999; Recchia 2002). In questa ipotesi l’area più setten-trionale sarebbe stata coinvolta prima di quella più meridionale da tali contatti, ma l’apparente corrispondenza diretta tra la differenziazione ge-ografica e quella cronologica lascia spazio al dub-bio. D’altra parte non è sicuro che la sequenza proposta per Olimpia valga per la Dalmazia, che è probabilmente la principale regione di origine
163relazioni tra l’italia Centro-meridionale, la SiCilia e l’area egea...
di tali influssi per quel che riguarda la parte orien-tale della penisola italiana.Anche l’uso dei tumuli nel Salento, datati con il 14C tra 2500 e 2300 cal. BC (Ingravallo et alii 2007 e in questo volume), è di probabile origine balca-nica, ma non si può escludere che la loro prima realizzazione sia stata più antica, in base anche alla presenza di ceramica che ricorda quella della facies campana di Taurasi (Ingravallo et alii 2007, fig. 5.4-5; Talamo e Recchia 2004).In sintesi per quel che riguarda l’Italia peninsu-lare orientale si può notare che con l’affermarsi degli aspetti eneolitici, accanto ai contatti transa-driatici di tradizione neolitica, si affermano rela-zioni, ancora non ben definibili, con regioni più lontane, facendo pensare a piccoli gruppi umani con forme di elevata mobilità, sia marittima che terrestre. Anche se non è rintracciabile con cer-tezza l’area di origine di elementi come i vasi a fiasco e gli askoidi, al momento non documentati lungo la fascia adriatica orientale, appare impro-babile una loro “reinvenzione locale” italiana, in presenza di testimonianze nei Balcani centro-orientali e nell’area greca ed egea. Si è accennato anche a deboli indizi di collegamento con l’Eu-ropa attraverso l’Italia nord-orientale.I rapporti verso oriente sembrano divenire meno evidenti nella prima metà del III millen-nio: mentre nell’Egeo si sviluppano intense at-tività di scambi materiali e immateriali, riassunte da Renfrew (1972, pp. 451-455) sotto la sugge-stiva espressione di “spirito internazionale”, e la penisola balcanica viene interessata dalle trasfor-mazioni apportate da piccoli gruppi di origine pontica (Harrison e Heyd 2007, pp. 193-203), l’Italia peninsulare orientale appare toccata in modo molto marginale da questi fenomeni.I contatti riprendono in modo più evidente nella seconda metà del millennio e costituiscono pro-babilmente la base su cui si forma un forte inte-resse per l’organizzazione di attività di scambio nell’Italia sud-orientale agli inizi del millennio successivo.
G.R.
riferimenti BiBliografiCi
alram-Stern e. 2004, Die Ägaische Frühzeit, Wien.anniBaldi g. 1951-52, Rinvenimento di tombe eneolitiche in territorio di Osimo, BPI 60-61, pp. 108-111.azzaroli a. 1979, Su alcuni resti di cavalli protostorici dell’Italia cen-trale, SE 47, pp. 231-236.Baroni i., reCChia g. 2005, Comportamenti funerari durante l’Eneo-litico nelle Marche, AttiIIPP XXXVIII, pp. 445-456.Baroni i., reCChia g., SilveStrini m. 2006, La necropoli eneolitica di Camerano (Ancona), AttiPPE VII, pp. 329-339.BernaBò Brea l. 1953-54, La Sicilia prehistorica y sus relaciones con Oriente y con la Peninsula Iberica, Ampurias 15-16, pp. 137-235.BernaBò Brea l. 1958, La Sicilia prima dei Greci, Milano.BernaBò Brea l. 1964, Poliochni, città preistorica nell’isola di Lemnos I, Roma.BernaBò Brea l. 1968-69, Considerazioni sull’Eneolitico e sulla prima età del Bronzo della Sicilia e della Magna Grecia, Kokalos 14-15, pp. 20-58.BernaBò Brea l. 1988, L’età del rame nell’Italia insulare: la Sicilia e le isole Eolie, RassA 7, pp. 469-506.BlaCkham m. 2002, Modelling Time and Transition in Prehistory: The Jordan Valley Chalcolithic (5500-3500 BC), BAR 1027, Oxford.Bovio marConi J. 1944, La cultura tipo Conca d’Oro della Sicilia nord-occidentale, MAL 40, coll. 1-170.BroodBank C. 2000, An Island Archaeology of the Early Cycla-des, Cambridge.CarBoni g., Conati BarBaro C., manfredini a., Salvadei l., SilveStrini m. 2005, La necropoli eneolitica di Fontenoce - Cava Kock (Recanati, Macerata): nuovi dati per l’inquadramento cronologico-culturale, AttiIIPP XXXVIII, pp. 949-954.CaSSano S.m., manfredini a. 1975, Recenti ricerche nelle necro-poli eneolitiche della Conca d’Oro. Scavi nella necropoli di Uditore e pro-spettive di inquadramento cronologico delle più antiche facies della Conca d’Oro, Origini IX, pp. 153-217.CaStellana g. 1995, La necropoli protoeneolitica di Piano Vento nel territorio di Palma di Montechiaro, Palermo.Cataldo l. 1996, La tomba di Casal Sabini e i rinvenimenti fune-rari tra Eneolitico ed età del Bronzo nel territorio di Altamura (Bari): le facies culturali indigene e i contatti transadriatici e con il Mediterraneo orientale, Origini XX, pp. 109-164.Catanzaro C., maniSCalCo l., pappalardo g., ruSSo p., vin-Ciguerra d. 1975-76, La stazione preistorica di Poggio Monaco nel territorio di Paternò, Cronache di Archeologia 14-15, pp. 9-49.Cavalier m. 1960, Les cultures préhistoriques des iles éoliennes et leur rapport avec le monde égéen, Bulletin de Correspondance Hellenique LXXXIV, pp. 319-346.Cazzella a. 1972, Considerazioni su alcuni aspetti eneolitici dell’Italia meridionale e della Sicilia, Origini VI, pp. 171-298.Cazzella a. 1992, Sviluppi culturali eneolitici nella penisola ita-liana, in Cazzella a., moSColoni M. 1992, Neolitico ed Eneo-litico, Popoli e civiltà dell’Italia antica 11, Bologna, pp. 349-643.Cazzella a. 1994, Dating the Copper Age in Italy and adjacent islands, EJA 2, 1, pp. 1-19.Cazzella a. 1999, L’Egeo e il Mediterraneo centrale fra III e II mil-lennio: una riconsiderazione, in la roSa v., palermo d., vagnetti L., a cura di, Simposio Italiano di Studi Egei dedicato a L. Bernabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma, pp. 397-404.Cazzella a. 2000, Sicilia e Malta durante l’età del Rame, SicA XX-XIII, 98, pp. 87-96.Cazzella a. 2003, Aspetti e problemi dell’Eneolitico in Abruzzo, At-tiIIPP XXXVI, pp. 221-238.Cazzella a. cds, The (possible) Tursi tumulus burial (Matera) and the relationships between southern Italy and the Aegean - Balkan area in the first half of the 3rd millennium BC, in müller-Celka S., Borgna
164 a. Cazzella - m. Cultraro - g. reCChia
e., a cura di, Ancestral Landscapes. Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages.Cazzella a. 2008, I manufatti semilunati della cultura di Cucuteni e il problema dei rapporti culturali su lunga distanza, in urSuleSCu d., kogalniCeanu r., Cretu C., a cura di, Cucuteni. Tesori di una civiltà dei Carpazi, Iasi, pp. 71-82.Cazzella a., maniSCalCo l. cds, L’età del Rame in Sicilia, AttiIIPP XLI.Cazzella a., moSColoni m. 1993, La cultura di Rinaldone e l’Eneolitico delle Marche, AttiPPE I, pp. 45-52.Cazzella a., moSColoni m., a cura di, 1999, Conelle di Arcevia. Un insediamento eneolitico nelle Marche, Roma.Cazzella a., SilveStrini m. 2005, L’Eneolitico delle Mar-che nel contesto degli sviluppi culturali dell’Italia centrale, AttiIIPP XXXVIII, pp. 371-386.Chapman J., SChiel r., BatoviC S. 1996, The Changing Face of Dalmatia, London.Coleman J.e. 1977, Keos I: Kephala, Princeton.CremoneSi g. 1976, La Grotta dei Piccioni di Bolognano nel quadro delle culture dal Neolitico all’età del Bronzo in Abruzzo, Pisa.Cuda m. t. 1990, Revisione del complesso archeologico di Monte Pucci (Peschici). Ricerche U. Rellini 1929-31, AttiDaunia 10°, pp. 79-97.Cultraro m. 2001, Aspetti dell’Eneolitico dell’Italia centrale nel quadro dei rapporti con la penisola balcanica e l’Egeo, AttiIIPP XXXIV, pp. 215-233.Cultraro m. 2006, La cultura di Rinaldone nel quadro delle relazioni con il mondo egeo-balcanico: un aggiornamento, AttiPPE VII, pp. 405-420.Cultraro m. 2008, Domesticating islandscapes: Sicily and Maltese Islands in the Later Neolithic and Eneolithic Ages (IV-III millennium BC), in Bonanno a., militello P., eds., Interconnections in the Central Mediterranean: the Maltese Islands and Sicily in History, Pro-ceedings of the Conference, Palermo, pp. 5-20.di fraia t., grifoni CremoneSi r. 1996, La Grotta S. Angelo sulla Montagna dei Fiori (Teramo), Pisa.dolfini a. 2004, La necropoli di Rinaldone (Montefiascone, Viterbo): rituale funerario e dinamiche sociali di una comunità eneolitica in Italia centrale, BPI 95, pp. 127-277.efe t., ilali a., topBaS a. 1995, Salvage Excavations of the Afyon Archaeological Museum, Part 1: Kaklik Mevkii. A site Transitional to the Early BronzeAge, Studia Troica 5, pp. 357-399.evanS J.d. 1953, The prehistoric culture-sequence in the Maltese Archi-pelago, PPS XIX, pp. 41-94.gangemi g. 1988, Un insediamento tipo Laterza a Castelbaronia (Avellino), RassA 7, pp. 570-571.gneSotto f. 1982, Il sito preistorico di Casalicchio-Agnone in ter-ritorio di Licata (Agrigento), in AA.VV., Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, Como, pp. 195-220.harriSon r., heyd v. 2007, The transformation of Europe in the third millennium BC: the example of “Le Petit-Chasseur I + III” (Sion, Valais, Switzerland), PZ 82, pp. 129-214.ingravallo e., tiBeri i., lonoCe n., faBBri p.f. 2007, Te-stimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce), Origini XXIX, p. 7-31.JohnSon m. 1999, Chronolog y of Greece and South-east Europe in the Final Neolithic and Early Bronze Age, PPS 65, pp. 319-336.koumouzeliS m. 1980, The Early and Middle Helladic Period in Elis, Tesi Ph.D., Brandeis University, microfilm 8024537, Ann Arbour.
langella m., andaloro e., BoCCi m., BoSCaino m., Coppa a., CurCi a., de franCeSCo a. m., Senatore m. r., rampa r., vargiu r. 2008, Foglianise (Benevento), loc. S. Maria ‘a Peccerella: un insediamento di tipo Laterza, RSP LVIII, pp. 165-190.manfredini a., CarBoni g., Conati BarBaro C., SilveStrini m., fiorentino g., Corridi C. 2005, La frequentazione eneolitica di Maddalena di Muccia, AttiIIPP XXXVIII, pp. 433-444.maniSCalCo l. 1994, La ceramica dell’età del rame nel territorio di Milena, Atti del Convegno La preistoria del basso Belice e della Sicilia Meridionale nel quadro della preistoria siciliana e medi-terranea, Palermo, pp. 323-338maran J. 1998, Kulturwandel auf dem griechischen Festland und den Kykladen im spaeten 3. Jt. v. Chr., Bonn.miSCh p. 1992, Die askoi in der Bronzezeit, Jonsered.moSColoni m. 1990-91, Conelle di Arcevia e i suoi rapporti con la penisola balcanica, Origini XV, pp. 255-265.orSi p. 1908, Sepolcri protosiculi di Gela, BPI 3, pp. 155-168.papathanaSSopouloS g.a., a cura di, 1996, Neolithic Culture in Greece, Athens.primaS m. 1996, Velika Gruda I, Bonn.radi g. 1986-87, Scavo preliminare a Fonti S. Callisto (L’Aquila), RassA 6, pp. 143-170.radina f. 1989, Insediamenti della prima età dei metalli in territorio di Rutigliano (Bari), in CianCio A., a cura di, Archeologia e territorio: l’area peuceta, Putignano, pp. 15-27.ramBaCh 2004, Olympia im ausgehenden 3. Jahrtausend v. Chr.: Bin-deglied zwischen zentralen und östlichem Mittelmeerraum, in alram-Stern E., a cura di, Die ägäische Frühzeit 2, Wien, pp. 1199-1244.reCChia g. 2002, I siti costieri garganici e i loro rapporti transmarini tra Eneolitico ed età del Bronzo, AttiPPE V, pp. 331-342.reCChia g. 2003, Manufatti in ceramica non vascolari, in Cazzella a., moSColoni m., reCChia G., a cura di, Conelle di Arcevia. Tec-nologia e contatti culturali nel Mediterraneo centrale fra IV e III millennio a.C., Roma, pp. 503- 519.renfreW C. 1972, The Emergence of Civilisation, London.Salerno a., vanzetti a. 2004, L’Eneolitico e il Bronzo antico in Calabria, AttiIIPP XXXVII, I, pp. 207-234.SeferiadeS m. 1985, Troie I. Materiaux pour l’étude des sociétés du nord-est égéen au début du Bronze Ancien, Paris.SilveStrini m., Carlini C., pignoCChi g. 2000, L’insediamento di Fontenoce - Recanati (MC) alla luce dei nuovi dati sul complesso cera-mico, in SilveStrini M., a cura di, Recenti acquisizioni, problemi e prospettive della ricerca sull’Eneolitico dell’Italia centrale, Atti dell’In-contro di Studio, Ancona, pp. 51-72.SilveStrini m., Cazzella a., pignoCChi g. 2005, L’organiz-zazione interna della necropoli di Fontenoce - area Guzzini, AttiIIPP XXXVIII, pp. 457-467.SilveStrini m., pignoCChi g. 1997, La necropoli eneolitica di Fon-tenoce di Recanati: lo scavo 1992, RSP XLVIII, pp. 309-365.talamo p., reCChia g. 2004, Taurasi. Un nuovo aspetto dell’Ene-olitico in Campania, Salerno.taSiC n. 1995, Eneolithic Cultures of Central and West Balkans, Belgrade.tinè S. 1965, Gli scavi nella Grotta Chiusazza, BPI 74, pp. 123-248.trump d. 2004a, Dating Malta’s prehistory, in Malta, pp. 230-241.trump d. 2004b, The prehistoric pottery, in Malta, pp. 243-267.vigliardi a. 1982, La ceramica di alcune stazioni del territorio di Peschici e di Vieste, AttiDaunia 2°, pp. 27-46.