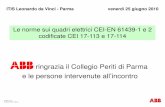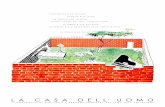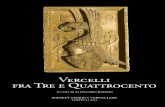Gio Antonio Sauli e una lettera di Giovanni Battista Manzini. Su dieci quadri di Guido Reni...
Transcript of Gio Antonio Sauli e una lettera di Giovanni Battista Manzini. Su dieci quadri di Guido Reni...
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
ANNALIDELLA FACOLTÀ DI
LETTERE E FILOSOFIA
LIV-LV2011-2012
CACUCCI EDITORE
ISSN 0394-0020A
NNA
LI
DE
LLA
FA
CO
LTÀ
DI
LE
TTER
E E
FIL
OSO
FIA
LIV
-LV
- 201
1-20
12
337
Andrea Leonardi
Gio Antonio Sauli e una lettera di Giovanni Battista Manzini.
Su dieci quadri di Guido Reni acquistati da Anton Giulio I Brignole-Sale*
ABSTRACT
The essay proposes a focus on the relationships between Genoa and Bologna in the middle of the 17th Century. The topic is a letter written in May 1641 by Giovanni Battista Manzini (1599-1664) to Gio Antonio Sauli (1596-1661) about ten pictures of Guido Reni bought by Anton Giulio I Brignole-Sale (1605-1662). The quality of the paintings mentioned in the letter, especially four ‘Sibille’, was questioned. Anton Giulio Brignole-Sale wrote to Manzini: “de quadri le quattro Sibille (...) sono sicuramente stimati copie, in alcuna delle quali Guido, al più, al più, habbia data qualche pennellata”. Later, Manzini wrote to his friend Sauli for an help in this difficult diplomatic relationship, to re-establish his honor. This is not surprising. The noble Genoese Gio Antonio Sauli is known for his interests in art and patronage. Especially, he loved the works of Orazio Gentileschi. The unknown letter written by Manzini to Gio Antonio Sauli in 1641 is an important new element to understand the complexity of the phenomenon of collecting.
Elemento fondante della ‘vita privata’ di un clan è la cifra o ambizio-
ne intellettuale che il gruppo oggetto d’indagine ha la forza di esprimere attraverso le scelte di gusto, le iniziative di committenza, le relazioni co-struite nelle diverse epoche dai suoi esponenti ‘alfa’. È quanto successo con la famiglia di Gio Antonio Sauli (1596-1661) la cui leadership econo-mico-culturale si è dipanata dal XV secolo, per procedere ininterrotta si-no al pieno Settecento, producendo testimonianze di grande valore, sem-pre impostate su una linea coerente di citazioni, di connessioni e di ri-mandi policentrici. Il senso della vanitas per le cose terrene e il desiderio di perpetuare nel modo migliore la propria immagine è intuibile in prima battuta scorrendo gli studi che dei Sauli si sono occupati finora, indagini di volta in volta attente a proporre un binomio originale e accurato, come i
* L’autore desidera ringraziare i marchesi Cattaneo-Adorno per la sempre generosa disponibiltà nel rendere accessibile il loro archivio, nonché Maddalena Giordano respon-sabile del complesso documentario Durazzo-Giustiniani. Si ricordano inoltre Piero Boc-cardo e Margherita Priarone, direttore e conservatrice dei Musei di Strada Nuova, per l’attenzione dedicata durante la ricerca.
338
Sauli e Sebastiano del Piombo, i Sauli e Galeazzo Alessi, i Sauli e Ora-zio Gentileschi, i Sauli e Rembrandt, i Sauli e Pierre Puget1.
L’occasione per proporre una lettura aggiuntiva è offerta in questa occasione muovendo da un carteggio rinvenuto presso il fondo Sauli dell’Archivio Durazzo-Giustiniani a Genova2. Uno splendido inventario topografico la cui stesura iniziò nel 1735 e proseguì sino al 1736 (con ag-giornamenti al 1760) descrive la collocazione del suddetto fondo archivi-stico, ubicato in quegli anni nelle «mezzarie fra li piani nobili inferiore e superiore» della domus magna dei Sauli in piazza San Genesio a Genova, a poca distanza dalla gotica cattedrale di San Lorenzo3. L’ambiente in cui i Sauli scrivevano, studiavano, lavoravano, era dotato di pareti percorse da «scanzie di legno bianco dipinto con armarij sotto di esse», cui si aggiun-gevano semplici arredi, come la «tavola coperta con arbaggio e tela tur-china con piede di legno bianco», il «tamburino coperto di vacchetta», per sedersi, una «cassa tutta di ferro per conservar denari» e una «lampa-da d’ottone con suo parafumo»4. Molti gli oggetti destinati a semplificare
1 Cfr. A. GHIA, Il cantiere della basilica di Santa Maria Assunta di Carignano dal 1548
al 1602, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXIX (1999), pp. 263-380; M. CATALDI GALLO, The Sauli collection, two unpublished letters and a portrait by Orazio Gentileschi, in «The Burlington Magazine», CXLV (2003), pp. 345-353; EAD., Le collezio-ni Sauli e due lettere inedite di Orazio Gentileschi, in «Ligures. Rivista di Archeologia, Sto-ria, Arte e Cultura Ligure», II (2004), pp. 155-204; L. MAGNANI, Pierre Puget, uno scultore barocco tra Genova e la Francia, in Genova e la Francia. Opere, artisti, committenti e colle-zionisti, a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio, P. Sénéchal, Silvana Editoriale, Cinisello Bal-samo, 2003, pp. 109-123; ID., Alessi, Cambiaso, Castello: un dibattito tra architettura e pit-tura alla metà del Cinquecento a Genova, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, me-dievale e moderna, a cura di G. Ciotta, atti del convegno (Genova, 5-8 novembre 2001), De Ferrari, Genova, 2003, pp. 520-527; ID., 1666. Un’inedita committenza genovese per Rembrandt, in «Annali di Critica d’Arte», II (2006), pp. 568-584; ID., 1666. Een onbekende opdracht uit Genua voor Rembrandt, in «Kroniek van het Rembrandthuis», 2007, pp. 3-17; H. HYDE, Cardinal Bendinello Sauli and Church Patronage in Sixteenth-Century Italy, The Boydell Press, Suffolk, 2009. Da ultimo, la vicenda Sauli è stata indagata in A. LEONARDI, Genoese Way of Life. Vivere da collezionisti tra Seicento e Settecento, Gangemi Editore, Roma, 2013.
2 Sull’archivio e il suo contenuto si veda M. BOLOGNA, a cura di, L’archivio della fa-miglia Sauli di Genova. Inventario, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XL, 2000, numero monografico.
3 ADGG [=Archivio Durazzo-Giustiniani, Genova], AS [=Archivio Sauli], Inventa-rio di tutti li mobili dell’illustrissimo signor Domenico Sauli principiato in settembre 1735 e terminato a 25 genaro 1736 sino a 19 marzo 1760, n. 399, c. 86v.
4 Ibidem. Delle carte d’archivio esistono anche dettagliati inventari. Il primo, diviso per armadi, compilato all’epoca di Gio Antonio e di suo figlio Francesco Maria. ADGG, AS, Libro d’inviatarii de scritture, 9 settembre 1656, n. 406. Il secondo, sempre diviso per armadi, contrassegnati con lettere che vanno dalla A alla N, stilato al tempo di Domenico Maria Ignazio Sauli (1675-1760), figlio di Francesco Maria e nipote di Gio Antonio. ADGG, AS, Inventario di scritture, 1714 ca., n. 407.
340
sciuto sulle piazze liguri e veneziane per vendere opere di Reni, in verità non sempre autografe, assecondando così l’enorme richiesta per i prodotti del maestro bolognese da parte del mercato locale10. Un rapporto di lun-go corso quello tra Manzini e il Brignole-Sale. Nel 1630, l’intellettuale fel-sineo presentò un componimento, I tre concorrenti amorosi, nella villa posseduta dal nobile genovese nel sobborgo orientale della città ligure, Albaro; nel 1631, fu la volta della dedica ad Anton Giulio I (definito «ca-valiere incomparabile») nel Sant’Eustachio martire; sino al 1632, anno di edizione dei Furori della Gioventù che il Brignole-Sale citò poi ne Le in-stabilità dell’ingegno pubblicato a cura del Manzini nel 163511. La notizia dell’acquisto in un colpo solo di «dieci quadri di mano di Guido Reni di Bologna» (1641)12, è perfettamente coerente con la testimonianza di Carlo Cesare Malvasia, quando ricordò come Genova fosse al terzo posto (ac-
10 Cfr. E. RAIMONDI, La letteratura a Bologna nell’età del Reni, in Guido Reni 1575-1642, a cura di D. Mahon, A. Emiliani, catalogo della mostra (Bologna, 5 settembre-10 novembre 1988; Los Angeles, 11 dicembre 1988-14 febbraio 1989; Fort Worth, 10 marzo-10 maggio 1989), Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1988, pp. CXXIII-CXLII: CXXXIV-CXXXVI. L’attività di rivenditore di opere del Reni esercitata dal Manzini è ricordata in C.C. MALVASIA, Felsina pittrice. Vite de’ pittori bolognesi, Guidi all’Ancona, Bologna, 2 voll., 1678 (1841), II, p. 16. A Genova Manzini proponeva opere di Guido Reni a volte realizzate da Simone Cantarini detto il Pesarese, questo perché egli approfittava del fatto che l’artista marchigiano fosse noto per essere un «grandissimo imitatore di Guido, anzi un altro Guido». Cfr. F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua… dall’edizione del 1681-1728, edizione a cura di P. Barocchi, 7 voll., Studio per Edi-zioni Scelte, Firenze, 1974-’75, IV, p. 48. Si veda inoltre M. CELLINI, La biografia di Simo-ne Cantarini nei documenti e nelle fonti, in Simone Cantarini detto il Pesarese 1612-1648, a cura di A. Emiliani, catalogo della mostra (11 ottobre 1997-6 gennaio 1998), Electa, Mila-no, 1997, pp. 397-418: 410. Sul problema del mercato di copie e falsi è intervenuto recen-temente L. PUPPI, Copie, falsi, pastiches. Riflessioni preliminari intorno al mercato dell’arte come economia del gusto, in Tra committenza e collezionismo. Studi sul mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal Pozzolo, L. Teobaldi, atti del convegno (Verona, 30 novembre-1 novembre 2000), Terra Ferma, Vicenza, 2003, pp. 23-34. Per lo specifico di Reni, si veda R. SPEAR, The ‘Divine’ Guido. Religion, Sex, Money and Art in the world of Guido Reni, Yale University Press, New Haven-London, 1997, pp. 269-271. Cfr. M. MIGLIORINI, A. ASSINI, Pittori in tribunale. Un processo per co-pie e falsi alla fine del Seicento, Ilisso, Nuoro, 2000, sulla situazione genovese.
11 Circa l’ambiente letterario genovese si veda F. VAZZOLER, Letteratura e ideologia aristocratica a Genova nel primo Seicento, in La letteratura ligure. La Repubblica aristocrati-ca (1528-1797), Costa&Nolan, Genova, 1992, pp. 217-316. Di Anton Giulio I Brignole-Sale traccia un profilo Q. MARINI, Anton Giulio Brignole-Sale, in Ivi, pp. 351-389. Le In-stabilità sono introdotte da una lettera del Manzini in cui il Brignole-Sale, insieme a Ferdi-nando Melini, è definito «riguardevole soggetto che si riverisca da chi ha cognitione della vera virtù e del valor vero». Cfr. Il signor Giovanni Battista Manzini al signor conte, in A.G. BRIGNOLE SALE, Le instabilità dell’ingegno, Per Giacomo Monti e Carlo Zenero, Bo-logna, 1635. Genova, Biblioteca Civica Berio, Fondo Brignole-Sale, XVII.B.181.
12 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini a Gio Antonio Sauli, 4 maggio 1641, n. 1447.
341
canto a Bologna e Roma) per il numero di opere dell’artista al centro della questione13. Già Laura Tagliaferro ebbe modo di servirsi dei registri con-tabili Brignole-Sale per acclarare la transazione sui «quadri dieci di mano di Guido», comprati a Bologna dal «commendator Giovanni Battista Manzini»: dato scarno ma utile per porsi delle domande sugli orientamen-ti dell’Anton Giulio I collezionista, attento compratore di tappezzerie, se-die dorate e concerti di viole per trattenimenti nella villa di Albaro, però acquirente di un numero apparentemente esiguo di quadri, comunque sempre scelti con cura tra l’area bolognese e veneziana14. Ora, attraverso la ricordata lettera del 4 maggio 1641, inoltrata dal Manzini al Sauli, in-sieme ad altre due missive correlate (del 16 maggio e del 1 giugno)15, è possibile aggiungere nuovi elementi sulla vicenda forse iniziata in occa-sione di una rapida tappa a Bologna combinata sulla strada per Loreto nel settembre del 1640. Particolare di non poco conto visto che il periodo coincide con la legazione del cardinale Stefano Durazzo (1640-’42), figlio di Pietro doge a Genova nel 1619-’21, nonché nipote di quell’Agostino committente della pala dell’Assunzione dipinta da Guido per l’altare del transetto destro nella chiesa genovese del Gesù16.
13 C.C. MALVASIA, Felsina pittrice, cit., II, p. 65. 14 ASCG, ABS, Registro 47, 1641, c. 42. Cfr. L. TAGLIAFERRO, La magnificenza privata.
“Argenti, gioie, quadri e altri mobili” della famiglia Brignole-Sale secoli XVI-XIX, Marietti, Genova, 1995, p. 156, nota 40. In P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni. Il tormento e l’estasi: i san Sebastiano a confronto, catalogo della mostra (Genova, 6 ottobre 2007-20 gennaio 2008), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 79, nota 55, si ren-de nota anche una fattura per l’imballaggio dei quadri in questione all’interno di sei casse.
15 ADGG, AS, Lettere di Giovanni Battista Manzini a Gio Antonio Sauli, 16 maggio 1641, 1 giugno 1641, n. 1447. Le lettere del 16 maggio e del 1 giugno 1641 riportano con-ferma dell’avvenuta soluzione della crisi. In particolare, la missiva del 16 maggio 1641 mo-stra un Manzini deciso a perdonare il torto patito. Riferendosi ad Anton Giulio I, Manzini scrisse: «troppo altamente si è lasciato ingannare e troppo preponderatamente è corso a mal trattarmi, ma purch’egli il conosca m’apagherò, et purch’io il possa fare, son sempre ad ogni minima soddisfatione capace di scordarmi ogni offesa da lui, et non m’havrà mai offeso, quando n’habbia havuta intenzione di farlo».
16 Anton Giulio I fece il viaggio in compagnia della moglie e dei signori Cesare e Ma-ria Giovanna Durazzo. Cfr. P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 73-74. Cesare Durazzo era il fratello maggiore del legato in carica dal 1640 al 1642. Cfr. L. NUOVO, Cure pastorali e giurisdizionalismo: il Seicento, in Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai giorni nostri, a cura di D. Puncuh, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 1999, pp. 329-359; P. BOCCARDO, a cura di, Genova e Guercino dipinti e disegni delle civi-che collezioni, catalogo della mostra (Genova, 21 maggio-23 agosto 1992), Nuova Alfa Edi-toriale, Bologna, 1992, p. 20. La tappa bolognese fu prevista per un cambio di carrozze e durò una sola notte. Cfr. ASCG (=Archivio Storico del Comune di Genova), ABS (=Archivio Brignole-Sale), Copialettere, 1640-1642, 6 settembre 1640. Rifacendosi a questa notizia, Boccardo ha ipotizzato un incontro del Brignole Sale con Guido Reni a Bologna sia sulla scorta dell’analogo episodio che ebbe per protagonista Gio Vincenzo Imperiale circa venti anni prima e per cui si rimanda a G.V. IMPERIALE, Viaggi, con prefazione di
342
La lettera più densa, di sei pagine, risalente al 4 maggio 1641, poteva contare su un prezioso allegato: si tratta di una copia della ricevuta con cui, il 22 aprile dello stesso anno, Anton Giulio I aveva messo in dubbio la qualità di alcuni dei dipinti procuratigli dal Manzini17. Quadri pagati dal Brignole-Sale 346 doppie d’oro di Spagna, ovvero 5.086 lire genovesi alla data dell’8 febbraio 164118. Scrisse Anton Giulio I: «de quadri le quattro Sibille et il san Gio Battista sono sicuramente stimati copie, in al-cuna delle quali Guido, al più, al più habbia data qualche pennellata. La ringrazio dell’havermi liberato da un inganno in cui sono vissuto più di dieci anni»19. Parole taglienti. Forse anche dettate dalla delusione per una frequentazione, appunto più che decennale, da considerare ormai finita, in coerenza con quanto espresso dal Brignole-Sale solo il giorno prima in un’altra lettera spedita ad Antonio Maria Garofolini, suo agente a Bolo-gna, dove lamentava che i quadri erano stati «non stimati qua come lo son stati costì»20. In altre parole il Brignole-Sale contestava la sopravvaluta-zione ottenuta dai quadri a Bologna, smentendo l’interpretazione di quan-ti avevano ritenuto di leggere in questa testimonianza una manifestazione di apprezzamento per la qualità degli stessi21. La nota di Anton Giulio I del 22 aprile reca inoltre l’importantissima indicazione di una parte dei soggetti ricevuti (quattro Sibille e un San Giovanni Battista), altrimenti ignoti attraverso le carte d’archivio sin qui considerate dagli studiosi. In particolare, le quattro Sibille sono da ricondurre agli esemplari conservati presso i Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso (dimora dei Brignole-Sale A.G. Barrili, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXIX (1898), p. 218, sia ba-sandosi sulla testimonianza di Malvasia, secondo il quale «mai passò per questa città sog-getto per grande che fosse che conoscerlo di vista e vederlo operare a sommo favore non si recasse». Cfr. C.C. MALVASIA, Felsina pittrice, cit., II, p. 60.
17 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 18 ASCG, ABS, filza XII, n. 599. Cfr. P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido
Reni, cit., pp. 74, 79, nota 55. 19 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 20 ASCG, ABS, Copialettere, 1640-1642, 21 aprile 1641. Cfr. P. BOCCARDO, X.F.
SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., p. 74, per la qualifica di ‘agente’ del Garofolini al servizio di Anton Giulio I.
21 Alla luce di quanto scritto dal Brignole-Sale in ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447, il senso delle parole in ASCG, ABS, Copia-lettere, 1640-1642, 21 aprile 1641, è diverso da quello proposto in P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 75, 79, nota 57. In realtà, l’intuizione di L. TAGLIAFERRO, La magnificenza, cit., p. 156, nota 40, vale a dire il carattere di occasione a buon prezzo colta da Anton Giulio I, è confermata dalla versione offerta dal Manzini in ADGG, AS, n. 1447, 4 maggio 1641. P. BOCCARDO, a cura di, L’Età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi, catalogo della mostra (Genova, 20 marzo-11 luglio 2004), Skira, Milano, 2004, p. 482, nota 24, si mostrava ancora scettico circa la presenza delle Sibille all’interno del lotto composto da dieci dipinti di Reni menzionato nel Registro dei conti Brignole-Sale.
343
prima di diventare museo), modernamente ascritte a Gio Andrea Sirani, col-laboratore di Guido, o alla figlia Elisabetta, ma sostanzialmente mai entrate a far parte (per lo meno sino a oggi) del circuito espositivo elaborato da Fran-co Albini e Caterina Marcenaro negli anni Cinquanta del Novecento22; que-sto nonostante la relativa fortuna dei dipinti in questione nelle guide sette-ottocentesche e la limpida attribuzione del De Limore che ne rilanciò l’esistenza dalla prima pagina de «La France Illustrée» (1912), sulla scia del ricordo di una reiterata presenza degli stessi a Parigi nelle dimore Brignole- Sale (1836, 1867, 1874)23. Le Sibille, a eccezione del San Giovanni Battista (su cui si avrà modo di tornare), erano quasi certamente affiancate dal Cristo e da una Madonna orante sempre nelle disponibilità della casa-museo genovese, dove le tele arrivarono imballate all’interno delle citate sei casse24.
Le Sibille, il Cristo e la Madonna orante, insieme al notissimo San Sebastiano (anche lui nelle raccolte dei Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso), sono tutti documentati in collezione Brignole-Sale entro il 1684, ter-mine ante quem Gio Francesco I (1643-1694), figlio di Anton Giulio I e Pao-la Adorno, stilò un inventario della raccolta (poi ritrovato dopo la sua morte nel 1694) che attribuiva ai sette pezzi un valore complessivo di 8.900 lire ge-novesi25. Gli stessi dipinti compaiono anche in un secondo repertorio, privo di riferimenti cronologici ma inerente l’«eredità del quondam signor Anton Giulio [II, 1673-1710] Brignole» dove, in modo significativo, furono raggruppati il «Nostro Signore, la Madonna e quattro Sibille di Guido
22 Sulla storia e l’allestimento di Palazzo Rosso, nell’ambito di una vasta bibliografia, si vedano: P. BOCCARDO, Palazzo Rosso dai Brignole-Sale a Caterina Marcenaro: luci e om-bre di un caposaldo della museologia italiana, in Abitare la storia, a cura di L. Leoncini, F. Simonetti, atti del convegno (Genova, 20-22 novembre 1997), Allemandi, Torino, 1997, pp. 103-114; F. BUCCI, A. ROSSARI, I musei e gli allestimenti di Franco Albini, Electa, Mila-no, 2005, pp. 50-57.
23 Cfr. L. TAGLIAFERRO, La magnificenza, cit., p. 157, nota 43, che riporta della pri-mitiva attribuzione ricordata anche in P. BOCCARDO, a cura di, L’Età di Rubens, cit., p. 482, nota 24. B. DE LIMOR, Sybille, in «La France illustrée», MCMXL(1912), p. 146, pub-blica in copertina la foto di una delle Sibille Brignole-Sale come opera di Guido Reni. L’immagine, recante la sigla ‘J&R 6732’, è una variante di quella posseduta dall’Archivio Fotografico del Comune di Genova (n. inv. s 24981). Sulle Sibille restaurate si veda P. BOCCARDO, I Brignole-Sale prima di Palazzo Rosso. Dimore e dipinti (1573-1662), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, pp. 46-49.
24 ASCG, ABS, filza XII, n. 599. Cfr. P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., p. 75; P. BOCCARDO, I Brignole-Sale prima, cit., pp. 42-44.
25 ASCG, ABS, Inventario de quadri fatto dal signor Gio Francesco e scritto di sua ma-no e ritrovato tra le sue scritture, scatola TA. Vedi anche L. TAGLIAFERRO, La magnificenza, cit., p. 298 e sgg. L’inventario fu ritrovato alla morte di Gio Francesco I (1643-1694). Ai quadri furono attribuiti i seguenti valori: 2.500 lire il San Sebastiano, 800 lire il «Nostro Signore mezza figura», 800 lire la Vergine, 1000 lire le Sibille contrassegnate dai numeri 1 e 2, 600 lire le altre due recanti i numeri 3 e 4.
344
di palmi 3½ e palmi 4¾»26. Da notare come questo secondo documen-to tenesse a parte l’aitante martire trafitto dalle frecce (750 lire), la cui datazione al 1615-’16 rende poco plausibile un acquisto così tardo da parte di Anton Giulio I (1641); senza tralasciare la qualità dei pigmenti impiegati (blu lapislazzulo e azzurrite), tale da far pensare a una commit-tenza alta ma purtroppo ancora ignota, sebbene sia stata affacciata in mo-do non definitivo una relazione con Giovanni Battista Pallotta, originario di Caldarola nelle Marche, divenuto cardinale nel 162927.
Per ritenere una patacca la proposta del mercante felsineo è probabi-le che Anton Giulio I si fosse servito di buoni consigli, quasi certamente dispensati da quegli artisti come Gio Andrea Ansaldo o Luciano Borzone con cui il nobiluomo genovese intratteneva stretti rapporti, rispettivamen-te, dal 1623 e dal 163328. Le cinque righe al curaro di Anton Giulio I (quelle del 22 aprile 1641), forse appunto ispirate da esperti consulenti, bastarono a scatenare la reazione del Manzini, il quale scrisse al Sauli per provare a ricomporre una situazione potenzialmente esplosiva perché metteva a repentaglio non solo il suo rapporto con il Brignole-Sale, ma anche la sua attività sulla piazza genovese e, soprattutto, la possibilità di riavere indietro i famosi quadri. Il 4 maggio Manzini esordì manifestando al Sauli un forte disagio: «io sono in un gran travaglio et nel maggior che mai di mia vita io mi fu ritrovato et si tratta di sradicarmi dal cuore un af-fetto (...). Hora senta il mio signor Gio Antonio [Sauli] nella cui sola di-strezza e magnanimità spero trovar compassione e sollievo ad una disgra-tia che non trovando qualibet riparo, ben presto minaccia precipitarmi ne maggiori impacci in che possa cadere la mia casa che per altro era ridotta nel miglior stato in ch’ella sapesse desiderarsi»29. Stando sempre alla stes-sa lettera, Manzini si era inizialmente attivato su sollecitazione di Anton Giulio I per l’acquisto di un solo quadro di Reni. A tale richiesta, egli aveva risposto comperando i «dieci pezzi di pittura», da lui pagati «a prezzo di mille ducatoni», cioè tra 5.000 e 8.000 lire bolognesi, calcolando un cambio di 5-8 lire contro 1 ducatone, cifra interessante anche proiet-
26 ASCG, ABS, Inventario dell’eredità del quondam signor Anton Giulio [II] Brignole,
scatola TA. 27 P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 82-87; P. BOCCARDO
in V. SGARBI, a cura di, Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Mattia Preti. Le stanze del car-dinale, catalogo della mostra (Caldarola, 23 maggio-12 novembre 2009), Silvana Editoria-le, Cinisello Balsamo, 2009, scheda 44, p. 160.
28 L. TAGLIAFERRO, La magnificenza, cit., pp. 138, 155, nota 33. Si vedano inoltre: F. BOGGERO, a cura di, Un pittore genovese del Seicento Andrea Ansaldo, 1584-1638, restauri e confronti, catalogo della mostra (Genova, 25 gennaio-3 marzo 1985), Sagep, Genova, 1985, pp. 65-68; M. PRIARONE, Andrea Ansaldo, Sagep, Genova, 2011, p. 260.
29 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447.
345
tandola sul singolo pezzo (500-800 lire contro 100 ducatoni), specie se si compara con gli emolumenti riconosciuti a Reni per alcune delle sue opere afferenti gli stessi anni o subito prima30. Non tutti però erano di «Guido», contrariamente a quanto venne annotato nel Registro delle spese Brignole-Sale reso noto da Tagliaferro. Di questi, scrisse Manzini al Sauli, otto erano del Reni, uno del Francia e un altro del Guercino31. Sulla bontà finanziaria dell’investimento il mercante espresse una valutazione sicura: «stimo non so-lo d’haver comprato bene, ma d’haver comprato utilmente perché in poc’anni da quattro soli di quei pezzi si caverebbe et abbondantemente il prezzo che ho già speso e che il rimanente de quadri lo stimo un sopramerca-to e che gli si mantengo io del mio et a mie spese originali»32. Inoltre, circa il carattere autografo delle opere – almeno per otto di esse viste le attribuzioni evidenziate dal mercante – Manzini avrebbe affermato di poter ricevere ga-ranzia dall’artista in prima persona e cioè da Guido. Dato tutto sommato co-erente con il fatto che, rispetto alla lettera ricevuta dal Sauli, Reni morì solo l’anno successivo (1642): «sono originali, ma havendone indubitata et infalli-bile sicurezza, si perché gli cavo da quella casa per la quale sono stati fatti a posta da Guido, come perché sendo anche vivo il pittore troppo facil-mente et in arbitrio d’ogni huomo l’assicurarsene da lui medesimo»33.
Nella ricostruzione del Manzini è Anton Giulio I a mancargli di ri-spetto: «il buon signore [Anton Giulio I Brignole-Sale] manda i denari e scrive ch’io avvertisca bene a non mandar copie per originali perch’egli se ne offenderebbe più che della perdita di dieci milla scudi»34. Ciò che lasciò in-terdetto Manzini fu proprio questo passaggio della lettera, tanto da ritenere utile mostrarla ad esponenti della comune cerchia di conoscenze, l’agente Garofolini, padre Antinori e Gio Battista Raggi (di cui si dirà oltre): «io che lo haveva assicurato in la mia lettera, che sotto la fede d’huomo honorato l’accertavo della sicurezza dell’esser originali, me ne offesi non poco e parti-cipando a diversi suoi e miei conoscenti la lettera di lui»35. A questo punto Manzini, esasperato e invelenito, si lasciò andare a un giudizio lapidario sulle competenze artistiche del compratore: «fui consigliato a non manda-re i quadri per non soggiacere a qualibet mala sodisfattione perché trat-
30 Ibidem. Reni fu pagato, ad esempio, 5.000 lire per l’Assunzione della Vergine de-
stinata alla chiesa del Gesù di Genova (1617). Per questo e altri confronti di tipo econo-mico si veda R. MORSELLI, Bologna, in Painting for profit. The economic lives of Seven-teenth-Century Italian Painters, a cura di R.E. Spear, P. Sohm, Yale University Press, New Haven-Londra, 2010, pp. 145-122: 148-150.
31 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 32 Ibidem. 33 Ibidem. 34 Ibidem. 35 Ibidem.
346
tandosi di chi havea potuto far meno un atto tale di diffidenza, potrebbi cor-rer pericolo e massime non s’intendendo egli [Anton Giulio I Brignole-Sale] di pittura che stando alla relatione di qualibet maligno o ignorante se ne tra-esse qualibet disgusto»36. Manzini ammise con il Sauli che «i quadri non era-no tutti della istessa perfettione, sendosi comprati i manco buoni per haver i migliori a prezzo de peggiori». Anzi. Egli fu anche «vicinissimo» a tenerli per sé, «essendo innamorato di tre dei dieci pezzi», ma, alla fine, con «fiducia cieca» e non volendo che «alcuna cosa del mondo mai» lo «rompesse con quel Brignole», decise, «bevendo grosso», di mandargli i quadri37. Le va-lutazioni di Anton Giulio I sui dipinti avuti da Bologna durarono un paio di mesi, tanto «il buon cavaliere» attese per «accusar ricevuta» delle ricordate sei casse giunte a Genova nel febbraio del 1641. Alla fine il Brignole-Sale scrisse una seconda lettera (quella allegata in copia dal Manzini al Sauli datata 22 aprile 1641)38, inviandola per conoscenza anche al Garofolini in modo che, presentandola «in mano propria» per provare a incassare il dovuto, Manzini non potesse «negare la ricevuta né dissimulare l’offerta»39.
Le lamentose righe successive del Manzini, «mi ha condannato et intac-cato nell’honore», oltre a riportare nota della procedura corretta di autenti-cazione che a suo dire il Brignole-Sale avrebbe dovuto intraprendere («ri-mandare i quadri e farli riconoscer individualmente ai pittori che gli han fatti pubblicamente»), esplicitava la richiesta per il Sauli: «humilmente nela sup-plico, perché il signor marchese [Anton Giulio I Brignole-Sale] rimandi i quadri in mano o del (...) cardinale legato che gli riceverà od altri ad artificio suo»40. Al Sauli, in altre parole, Manzini chiedeva di prelevare i dipinti dalla casa del Brignole-Sale e di rispedirli indietro a Bologna all’attenzione di quel cardinale legato Durazzo che Anton Giulio I aveva incontrato nel settembre del 1640. Aspetto, quest’ultimo, in grado di stemperare l’immagine severa del prelato41, invece anche lui al centro di vivaci dinamiche artistiche sulla scia, da un lato, dei legami Genova-Reni (come già era avvenuto con lo zio Ago-stino committente della pala per il Gesù genovese), dall’altra, delle rela-zioni con il Guercino alle cui opere si era ripetutamente accostato attra-verso acquisti in prima persona o doni42.
36 Ibidem. 37 Ibidem. 38 ADGG, AS, n. 1447, 22 aprile 1641. ASCG, ABS, filza XII, n. 599, per la ricevuta
del Brignole-Sale. 39 ADGG, AS, n. 1447, 4 maggio 1641. 40 Ibidem. 41 Ne parlano in questi termini sia L. NUOVO, Cure pastorali, cit., pp. 329-359, sia P.
BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., p. 66. 42 C.C. MALVASIA, Felsina pittrice, cit., II, pp. 263, 313, 314, 315, 316, 343, per i con-
tatti con Guercino.
347
I silenzi del Brignole-Sale, «io ne scrivo a lui medesimo più di cento lettere (…) a questo fine, ne pur una men à voluta uscir dalla penna», non impedirono al Manzini di delineare i dettagli di una lucida exit strategy: «mandi i quadri perché siano e giuridica e giudicialmente visitati e rico-nosciuti dai pittori che gli han fatti et io farò la spesa della condotta e sta-rò a tutto mio danno (…) dinanci a tutti i pericoli di perdita o di fattura, che purché l’honor mio resti quale egli si professa immaculato et illeso, son pronto poi a scordarmi ogni offesa ricevuta da persona alla quale per altro devo tanto. Ma l’honor mio signor Gio Antonio [Sauli] mio signore lo voglio per me, se ci andassero mille e cento milla vite»43. La lettera pro-segue fornendo altri particolari. Innanzitutto, reca interessanti valutazioni sulle modalità operative di Guido: «i quadri negati originali sono originali sopra l’honor mio e non ritoccati da Guido ma cominciati col gesso e finiti col pennello da Guido et così li mantengo»44. In seconda battuta, è svelato per chi questi dipinti erano stati davvero eseguiti, così come del resto prean-nunciato in filigrana qualche riga addietro, quando Manzini ebbe ad assicu-rare di averli ‘cavati’ dalla casa per cui erano «stati fatti a posta da Guido»45.
La «casa» in questione era quella di suo padre Geronimo Manzini che certo doveva possedere uno spiccato fiuto e un discreto patrimonio, co-me dimostrano tanto gli agi in cui visse Gio Battista sin dagli esordi della sua vita adulta, quanto gli studi intrapresi dagli altri due fratelli46. Gio Battista, in effetti, scrisse di averli lui stesso «veduti fare perché furono già da Guido fatti per mio padre medesimo»47. Manzini propose spiegazioni non molto di-verse anche per il dipinto del Guercino, un San Giovanni Battista che, nella ricevuta del Brignole-Sale, non venne considerato giustamente autografo del Reni (ma per il quale comunque non si azzardarono no-mi). Come già in apertura della lettera del 4 maggio, quando con il Sauli era stata specificata la paternità quantitativa delle opere fornite al Brignole-Sale (otto del Reni, una del Francia, un’altra del Guercino), Manzini tirò nuovamente in ballo l’artista di Cento – delle cui opere fu attento collezionista48 – collegandolo in modo inequivocabile al suddetto
43 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 44 Ibidem. 45 Ibidem. 46 I due fratelli del Manzini, più giovani, erano Carlo Antonio e Luigi. Il primo, si
dedicò a studi di astronomia e ottica e fu vicino (sebbene in modo prudente) all’esperienza di Galileo Galilei; il secondo, fu benedettino a San Michele in Bosco a Bologna compien-do studi di filosofia e teologia. Cfr. L. MATT, Manzini Carlo Antonio, in Dizionario Biogra-fico degli Italiani, ad vocem, Roma, 2007; ID., Manzini Luigi, in Ivi, ad vocem.
47 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 48 L. SALERNO, I dipinti del Guercino, Bozzi Editore, Roma, 1988, p. 288, per il ruolo
di collezionista del Manzini interessato alle opere del Guercino.
348
tema iconografico del San Giovanni Battista. Al pari dei quadri forniti da Guido, anche il San Giovanni Battista sarebbe stato venduto da Guercino a suo padre Geronimo senza necessità d’intermediazioni: «et quello del Guercino, cioè il san Gio Battista, il signor Gio Battista [Guercino] farsi mercante qui principale, lo vendette a mio padre medesimo [Geronimo Manzini]»49. In virtù di questa facilità nell’accedere agli ateliers dei due artisti, Manzini promise nuovamente una rapida e pubblica autenticazio-ne: «farò constare giudicialmente subito che i quadri sono arrivati e rico-nosciuti e da Guido amorevol mio disamorevole e dal Guercino quale fa-rò venire a Bologna a posta»50.
Assente tanto dall’inventario del 168451, quanto da quello dell’«ere-dità del quondam signor Anton Giulio [II, 1673-1710] Brignole»52, un San Giovanni Battista del Guercino fu invece censito nel molto più tardo repertorio del 1748, quello inerente la «Descrizione della galleria de quadri» del doge Gio Francesco II Brignole-Sale (1695-1760), figlio di Anton Giulio II e pronipote dell’Anton Giulio I ormai ex amico ed ex cliente del Manzini53. Pare inoltre interessante rilevare come il cardina-le Durazzo – cioè il personaggio incontrato a Bologna dal Brignole-Sale nel 1640 e al pari del Manzini grande estimatore dell’opera di Barbieri – avesse lasciato nel suo testamento del 1665 un «quadro di san Giovanni Battista al presente in cappella dipinto per mano del pit-tore detto il Guercino da Cento» all’«eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Francesco Barberino»54. Anche quest’ultimo un dato di contesto, dal momento che il Barberini rimase direttamente coinvolto nella scelta dell’iconografia e nella supervisione al lavoro di Guido sul Ratto di Elena oggetto della celebrazione letteraria orchestrata da Manzi-ni55. Il dono del Durazzo al Barberini, secondo Malvasia e Jacopo Ales-sandro Calvi, fu pagato cento ducatoni nel 1637, limite cronologico che riporta l’episodio al tempo in cui il prelato genovese si trovava ancora a
49 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 50 Ibidem. 51 ASCG, ABS, Inventario de quadri fatto dal signor Gio Francesco, cit., scatola, TA. 52 ASCG, ABS, Inventario dell’eredità del quondam signor Anton, cit., scatola TA. 53 ASCG, ABS, Descrizione della galleria de quadri esistenti nel palazzo del serenissmo
doge Gio Francesco [II] Brignole Sale col loro merito et autori, scatola TE. Lo stesso inven-tario reca nota delle quattro Sibille, tutte di «mezza figura», di «una mezza figura di No-stra Signora di Guido Reni» e di un’altra «mezza figura del Guidoreni del Salvatore». An-cora, come «mezza figura», sono riportati sia il San Sebastiano, sempre di Reni, sia il San Giovanni Battista del Guercino.
54 D. PUNCUH, Collezionismo e commercio di quadri nella Genova sei-settecentesca. Note archivistiche dai registri contabili dei Durazzo, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIV (1984), pp. 164-218: 213, nota 199.
55 D. MAHON, A. EMILIANI, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 146-147.
349
Ferrara56. Pertanto, il dipinto sembra rientrare a pieno titolo nel novero delle suggestioni derivanti dal circuito di quelle legazioni di marca ligure attive negli stessi anni tra Bologna, Ravenna e, appunto, la città estense57. Una data così alta per il pagamento porterebbe però a escludere una coincidenza con il quadro proposto dal Manzini nel 1641, a meno di non valutare la possibilità di un refuso nella segnalazione del momento del pa-gamento da parte di Malvasia e di Calvi che – qualora risultasse diverso – consentirebbe di collegare il San Giovanni Battista del Durazzo poi Bar-berini a quello offerto al Brignole-Sale e forse da lui messo in discussione. Va anche notato, a onor del vero, come nei depositi dei Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso sia presente un San Giovanni Battista (a mezzo busto come le Sibille ma di dimensioni più ridotte) che, se da un lato, non permette di pensare alla mano del Guercino, dall’altra, certo consente di immaginare i dubbi di Anton Giulio I qualora il dipinto avesse mai fatto parte del gruppo di dieci quadri sottoposti alla sua attenzione.
Sulla qualità traballante di almeno tre delle quattro Sibille, inoltre, a detta del Manzini il Brignole-Sale non poteva non sapere viste le numero-se lettere inviategli. Oltremodo Manzini dichiarò di aver segnalato chia-ramente la loro appartenenza non alla «prima maniera», fase in sostanza conclusa con la serie dedicata a Ercole e con la tela di Nesso e Dejanira per il duca di Mantova (1617-’21), bensì all’ultimo momento di Guido, quello della rarefazione formale, durante il quale l’artista lasciò i dipinti in una forma che poteva apparire di ‘non finito’58. Guardando alle sei tele ancora a Palazzo Rosso è un’idea, questa di una disomogeneità qualitativa, che emerge osservando la Madonna orante, migliore, affiancata dal Cristo di cui è pendant; soprattutto per le Sibille, invece, Manzini avrebbe fatto be-ne a ricordare anche l’attività della bottega di Reni dove il suo intervento era piuttosto limitato sebbene sufficiente per ritenere tali opere autogra-fe59: «copia di quadri c’ho mandato al detto marchese tre delle quattro Sibille sieno di lega inferiore agli altri suoi compagni, questo è certo, ne io il nego, ne il detto Anton Giulio potrà dire ch’io (veggansine le mie lettere
56 C.C. MALVASIA, Felsina pittrice, cit., II, p. 315; J.A. CALVI, Notizie della vita e delle
opere del cavaliere Gio Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento, Marsigli, Bologna, 1808, p. 78.
57 J. SOUTHORN, Power and display in the Seventeenth Century. The arts and their patrons in Modena and Ferrara, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p. 110; P. BOCCARDO, a cura di, Genova e Guercino, cit., p. 17.
58 S. PEPPER, Guido Reni. L’opera completa, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1988, passim; D. MAHON, A. EMILIANI, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 146-147.
59 R. SPEAR, The ‘Divine’ Guido, cit., pp. 210-274; R. MORSELLI, Collezioni e quadrerie nel-la Bologna del Seicento. Inventari 1640-1707, in The Provenance Index of The Getty Information Institute, a cura di A. Cera Sones, J. Paul Hetty Trust, Los Angeles, 1998, pp. 18-23.
350
che gli ne ho scritto) non gli significhi che non mi piacciono tanto quanto quelli della prima maniera, non havendo come quelli, tanto finimento»60. Abbandonati i toni più diplomatici, Manzini accusò il Brignole-Sale di bassa speculazione: «ma che si credeva il signor marchese, di spendere cento ducatoni al pezzo in quadri da trecento e quattrocento?»61. Alla stoccata se-guì la sfida. Egli avanzò un’offerta di cambio per uno dei dipinti migliori della quadreria Brignole-Sale, sin qui mai menzionato nella lettera del 4 maggio, cioè il Gesù Bambino vegliato dagli Angeli, ritenuto da Andrea Emiliani la risposta di Guido alla prova sostenuta da Caravaggio nel-l’Amore dormiente (1608)62: «veda il signor marchese se vuol dare il Chri-sto Bambin che dorme, vegliato da gli angeli et gli ne farò dar io trecento ducatoni e gli li farò dare a mercante che compra per guadagnarci sopra almeno dugento ducatoni. Et s’egli si risolvesse a farlo, mi honori vostra signoria illustrissima d’avvisarlo subito, che ne pur un’hora tarderà la let-tera di cambio a venire»63.
L’invito non fu accolto da Anton Giulio I, tanto è vero che il Gesù Bambino vegliato dagli Angeli, datato per ragioni stilistiche al 1610-’20, rimase sempre a Genova dove conobbe ampio rilievo nella letteratura ar-tistica locale64. La critica ne ha peraltro evidenziato l’acquisto compiuto dalla famiglia direttamente presso il pittore, in particolare da Gio Battista, figlio di Antonio Brignole e fratello minore di Gio Francesco65. È anche vero, però, che lo stesso dipinto potrebbe essere stato comprato sempre
60 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 61 Ibidem. 62 Sul dipinto si vedano: A. EMILIANI, Per Guido Reni, in «Atti e memorie Accade-
mia Clementina», XXV (1990), pp. 87-109: 101; M. HILAIRE, L’Amour endormi, in Corps et Ombres. Caravage et le caravagisme européen, a cura di M. Hilaire, A. Hémery, catalogo della mostra (Montpellier-Toulouse, 23 giugno-14 ottobre, 2012), 5Continents, Milano, 2012, scheda del dipinto n. 7, pp. 88-90.
63 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 64 Il quadro è menzionato per la prima volta in C.G. RATTI, Istruzione di quanto può
vedersi di più bello in Genova in pittura, scultura ed architettura, Scionico, Genova, 1780, p. 246, al tempo di Giacomo Brignole (1724-1801), rimarcando che era stato dipinto «espressamente per questa casa». In tali termini è segnalato anche da F. ALIZERI, Guida artistica per la città di Genova, Presso Gio Grondona, Genova, 1846-’47, p. 336; ID., Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue adiacenze, Sambolino, Genova, 1875, p. 132.
65 F. DUFOUR, M. FRANZONE, Gesù Bambino vegliato dagli angeli, in El siglo de los genoveses e una lunga storia di arte e splendori nel palazzo dei dogi, a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio, catalogo della mostra (Genova, 4 dicembre 1999-28 maggio 2000), Electa, Milano, 1999, scheda XI.13, p. 331. Sull’individuazione del committente in Gio Battista Brignole (1580-1641), cognato di Agostino Durazzo committente dell’Assunta al Gesù, solleva dei dubbi Piero Boccardo, in P. BOCCARDO, X.F. SALOMON, a cura di, Guido Reni, cit., p. 77, nota 2.
351
da Gio Battista in una fase anteriore al 1641, non direttamente dal Reni, bensì dal nipote Anton Giulio I, lasciando intendere per quest’ultimo un’attività di commerciante-intermediario di quadri (condivisa con altri membri del patriziato genovese) che pone in una diversa prospettiva tanto la sfida lanciatagli dal Manzini proprio sul Gesù Bambino, quanto la di-mensione del lotto oggetto della diatriba66.
Nei passi successivi della sua lettera di maggio, Manzini, a giustifica-zione dei prezzi richiesti, portò poi a modello due delle più recenti tran-sazioni da lui condotte a buon fine, inerenti, da un lato, un San Gerolamo andato in Germania, e, dall’altro, una Lucrezia offerta anche a una delle personalità a conoscenza della vertenza in corso con il Brignole-Sale, cioè Gio Battista Raggi, cognato di Anton Giulio I, in quanto sposato con la sorella di quest’ultimo, Aurelia Brignole-Sale67. La Lucrezia era analoga per dimensioni e per bellezza della cornice alle contestate Sibille: «et forse questi prezzi sono novità nelle cose di Guido? Saranno da sei anni che io hebbi ordine del signor duca di Modena [Francesco I d’Este] d’offerir cinquecento ducatoni al sarto Fancini [?] di un san Girolamo di Guido che pur era una sola figura. Costui non volle dare, ed hebbe ragione et lo mandò poi al signor conte Dolabella Ghislieri et lo comprò per un princi-pe tedesco e gli diede seicento ducatoni d’argento. Il signor Gio Battista Raggio cognato del medesimo signor Anton Giulio non ha egli voluto comprar da me una mezza figura, cioè una Lucretia dell’istesso Guido e compagna in grandezza e nella cornice di quell’istesse Sibille di che si vuole il signor Anton Giulio; e potrà far fido al signor Anton Giulio se a contanti io mi sia mai lasciato persuadere a darla per un soldo meno di cento doble. Sarà egli degno di fede questo testimonio che pure è suo cognato?»68.
66 Per l’attività di commercianti-intermediari svolta da alcuni genovesi intorno a ope-
re di Guido Reni, si pensi a campione alle lettere di Silvestro Grimaldi e di Pier Maria Gentile circa alcuni dipinti che il duca di Modena voleva acquistare (marzo-giugno 1638). Cfr. A. VENTURI, La Regia Galleria Estense in Modena, Modena, 1882, pp. 186-187; D. MAHON, A. EMILIANI, a cura di, Guido Reni, cit., pp. 206-207. Il duca era intenzionato a comprare una Giuditta e Oloferne di proprietà di Pier Maria Gentile come si evince dalla lettera del suo «oratore» in Genova Silvestro Grimaldi. Il Gentile, in una lettera al Gri-maldi (15 maggio 1638), afferma di aver intenzione di vendere, segnalando contempora-neamente altri dipinti del Reni: si trattava di informazioni riguardanti un Giudizio di Pari-de e una Erodiade che il Grimaldi passò poi al duca. Il duca, cioè Francesco I d’Este, è lo stesso interlocutore al quale Manzini cercherà di procurare senza successo un San Gerolamo come ricordato nella lettera al Sauli.
67 L. TAGLIAFERRO, La magnificenza, cit., p. 42, nota 34. 68 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. Un
conte Ettore Ghislieri è ricordato in C.C. MALVASIA, Felsina pittrice, cit., II, p. 186, per via dell’Accademia del Nudo da lui aperta nel suo palazzo bolognese (1646); una scuola dove
352
In chiusura la missiva avrebbe confermato sì la quantità dei dipinti segnalata nel Registro delle spese Brignole-Sale69, ma non la ripartizione attributiva indicata in precedenza. Si ricorderà come Manzini avesse par-lato di otto quadri del Reni, di uno del Francia e di un altro del Guercino. A questo punto, invece, i dieci elementi risultavano tutti di Guido Reni (permettendo così di introdurre nella vicenda anche l’idea di un cambio riparatore), accompagnati dal caustico consiglio sul migliore utilizzo per quelli ancora ritenuti sgraditi al Brignole-Sale: «hora io ho fatto havere al signor marchese dieci figure di Guido per ottocento ducatoni de quali ne van sotratti cento almeno, che ne vaglino le cornici, che pur sono ricchis-sime e nobilissime e si duole che fra questi ve sieno tre di minor finimento per fortune degli altri. Se non segli vede volentieri in casa gli doni»70. Contando i quadri menzionati dagli inventari sin qui presi in considera-zione, ed escludendo in primo luogo il San Giovanni Battista del Guerci-no (apparso chiaramente nelle carte solo dal 1748), in seconda istanza il quadro del Francia (probabilmente tornato indietro), ancora il San Seba-stiano (forse davvero acquistato dalla collezione che fu del cardinale Pal-lotta insieme ad altri due quadri di Mattia Preti71), oltre al Gesù Bambino vegliato dagli angeli (pervenuto in un momento diverso), i dipinti di Gui-do ascrivibili con sicurezza alla compravendita intercorsa tra Manzini ed Anton Giulio I ammontavano e ammontano tuttora a sei pezzi (quattro Sibille, un Cristo e una Vergine), con questo segnalando l’assenza di quat-tro unità che, se non furono donate dal collezionista, così come aveva consigliato il Manzini per almeno tre di loro, forse presero la via della Spagna.
Anton Giulio I, infatti, di lì a poco, cioè nel 1644, ebbe un importan-te incarico pubblico come ambasciatore presso Filippo IV. Dalle cedulas de paso spagnole è risaputo che con sé portò «30 quadros de pinturas» e che al suo rientro a Genova, due anni dopo, ne avrebbe rispediti dalla Spagna solo ventiquattro72. Forse durante il soggiorno iberico Anton Giulio I alienò davvero i tre Reni di «minor finimento», oltre ad una
artisti come Francesco Albani e Alessandro Tiarini si ritrovarono, assieme a Guercino e a Giovanni Desubleo, per dedicarsi all’insegnamento sulla scia dell’omonima istituzione fondata alla fine del Cinquecento dai Carracci.
69 ASCG, ABS, Registro 57, 1641, c. 42. 70 ADGG, AS, Lettera di Giovanni Battista Manzini, cit., 4 maggio 1641, n. 1447. 71 Cfr. P. BOCCARDO, San Sebastiano, in Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Mattia
Preti, cit., scheda del dipinto, p. 160; ID., in Ivi, schede 38 e 40, pp. 148, 152, per i quadri di Mattia Preti.
72 M. MORÀN TURINA, Importaciones y esportaciones de pinturas en el siglo XVII a travès de los registros del los libros de pasos, in Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimeientos, Universitad Complutense, Madrid, 1994, pp. 543-560.
353
quarta unità non meglio esplicitata, cedendoli magari a Juan Alfonso Enriquez de Cabrera (1597-1647), nono Almirante di Castiglia, dal quale poi ne tornarono a Genova due perché a sua volta li rivendette a Francesco Maria Balbi. Si trattava di una Cleopatra e di una Lucrezia, quest’ultima da ritenere la stessa che era stata offerta da Manzini a Gio Battista Raggi, co-gnato di Anton Giulio I. Entrambe furono rese note nella loro nuova ubi-cazione genovese dal marchese di Segnalay nel 1671 ed elencate nei do-cumenti a partire dal 168273. Dipinti dalle caratteristiche corrispondenti a quelli transitati in casa Brignole-Sale, rintracciati da Stephen Pepper con provenienza dalla quadreria Balbi74. Va però anche considerata la circo-stanza per cui l’attuale quadreria Brignole-Sale, donata al Comune di Genova da Maria Brignole-Sale (1811-1888), consorte di Raffaele de Ferrari, non corrisponde per intero a quella dell’antenato Anton Giulio I, questo per effetto della divisione verificatasi alla sua morte (1662) tra i due figli, Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole-Sale. Quanto è possibile vedere a Palazzo Rosso, infatti, corrisponde alla parte toccata al secondogenito di Anton Giulio I, Gio Francesco I, poi implementata dai suoi discendenti, parte che solo in rari casi ha visto riportare entro il perimetro originario dipinti dell’altro ramo. Dunque, nel novero dei pezzi mancanti per motivi ereditari potrebbero celarsi anche alcune delle problematiche opere che Giovanni Battista Manzini provò a recuperare da Anton Giulio Brignole-Sale attraverso i buoni uffici di Gio Antonio Sauli.
73 P. CLÉMENT, a cura di, L’Italie en 1671. Relation d’un voyage du marquis de Seigne-
lay, Didier, Parigi, 1867, p. 117. 74 S. PEPPER, Guido Reni, cit., p. 293, nota 170. Cfr. P. BOCCARDO, L. MAGNANI, La
committenza della famiglia Balbi: residenze e collezioni tra XVI e XVIII secolo, in Il palazzo dell’Università di Genova: il Collegio dei Gesuiti nella Strada dei Balbi, Università degli Studi di Genova, Genova, 1987, pp. 47-88: 84, nota 100, per l’inventario Balbi del 1682.
354
APPENDICE DOCUMENTARIA - ADGG, AS, LETTERA DI GIOVANNI BATTISTA MANZINI
A GIO ANTONIO SAULI, 4 MAGGIO 1641, n. 1447 Carta 1 recto Io sono in un gran travaglio e nel maggior che mai di mia vita io mi fu ritro-
vato et si tratta di sradicarmi dal cuore un affetto, non solo invecchierei, ma (...) dentro. Hora senta il mio signor Gio Antonio nella cui sola distrezza e magnani-mità spero trovar compassione, e sollievo ad una disgratia, che non trovando qua-libet riparo, ben presto minaccia precipitarmi ne maggiori impacci in che possa cadere la mia casa che per altro era ridotta nel miglior stato in ch’ella s’apesse de-siderarsi.
Il signor Anton Giulio Brignole con reiterati ordini mi ammette che io invi-gli a comprar per lui qualche quadro di Guido [Reni]. Gli avviso che ho compra-ti dieci pezzi di pittura a prezzo di mille ducatoni de quali otto ve n’ha di Guido [Reni], uno del Francia e l’altro del Guercino. E che stimo non solo d’haver comprato bene, ma d’haver comprato utilmente perché in poc’anni da quattro soli di quei pezzi si caverebbe et abbondantemente il prezzo che ho già speso e che il rimanente de quadri lo stimo un sopramercato e che gli si mantengo io del mio et a mie spese originali e che conservi quella lettera per potersene valere in ogni occasione quando nol fossero, perché io e non altri (...) resti mallevadore in questo punto, non solo conoscendo che sono originali, ma havendone indubitata, et infallibile sicurezza, si perché gli cavo da quella casa per la quale sono stati fatti a posta da Guido [Reni], come perché sendo anche vivo il pittore troppo facilmente et in arbitrio d’ogni huomo l’assicurarsene da lui medesimo.
Carta 1 verso Il buon signore manda i denari e scrive ch’io avvertisca bene a non mandar
copie per originali, perch’egli se ne offenderebbe più che della perdita di dieci milla scudi. Io che lo haveva assicurato che la mia lettera, che sotto la fede d’huomo honorato l’acertavo della sicurezza dell’esser’originali, me ne offesi non poco e participando a diversi suoi e miei conoscenti la lettera di lui cioè al Garo-falini, al Padre Antinori, ch’allhora era in Bologna, al abbate (...), al signore Gio Battista Raggi et ad altri, fui consigliato a non mandare i quadri per non sogiacere a qualibet mala sodisfattione perché trattandosi di chi havea potuto far meno un atto tale di difidenza, potrebbi correr pericolo e massime non s’intendendo egli di pittura, che stando alla relatione di qualibet maligno, o ignorante, se ne traesse qualibet disgusto e tanto più che i quadri non erano tutti dell’istessa perfettione, sendosi comprati i manco buoni, per haver i migliori a prezzo de peggiori, oltre che d’un solo di essi si sarebbe cavato quasi mezzo il prezzo che si spendeva in tutti; onde io fui vicinissimo a farlo, come quello al quale quella lettera difidente havea penetrato le viscere e come quello che essendo inamorato di tre dei dieci pezzi, potevo così ben come Brignole spender di si poca somma com’erano mille ducatoni.
355
Risiolti finalemte con fiducia cieca, di non voler che alcuna cosa del mondo mai mi rompesse con quel Brignole che tanto vivamente sempre era regnato nel mio cuore e, bevendo grosso, dissimulai l’offerta e mandai i quadri. Il buon cava-liere è stato quasi due mesi ad accusar la ricevuta e poi finalmente scrive una let-tera (della quale qui agiunta mando la copia non perchè io diffidi del mio signor Gio Antonio ma per non privarmi dell’originale per quando sia potrà occorrere) e la manda al signor Antonio Maria Garoffalino che me la presenti in mano pro-pria, sichio non possa negare la ricevuta, ne dissimulare l’offerta.
Carta 2 recto Io sono huomo da bene et atto a far toccar con mano (...) et al mondo tutto
et io son tale. E sebene ho professato e professo particolare partialità et obbliga-tione a questo signore nulla di meno sono molto più obbligato all’honor mio et a nissiun altra cosa del mondo. Questo cavaliere (come forse è parsa amara al detto cardinale legato al quale subito ho participato il fatto, e letta la lettera) è corto assai, poco maturamente ponderando quel che risolveva di farmi. Mi ha condan-nato et intaccato nell’honore, senza prima ascoltar me e senza informar prima se medesimo della esistenza e verità del fatto, il che (...) della sua prudenza e giusti-tà, prima che si risolvono di rinonciar ad un’amicitia si vecchia e d’intaccar una reputatione così ben conosciuta come la mia. Doveva rimandare i quadri e farli riconoscer individualmente ai pittori che gli han fatti, pubblicamente (...) e quel ch’è più miei chiarimenti ben restava egli sicuro d’haver a restar informato, in modo che l’attione ch’egli era per fare (...) restar giustificata quanto conviersi. Così, nel stando alla relatione di gente, et ha mentito malignamente di quanto ha detto a lui contro l’originalità de quadri (quando non l’habbia asserito per ingan-no d’intelletto) havrebbe chiarita la verità et havrebbe non precipitato tanto l’honore d’un suo per alto si stretto, e si partiale come (…) pur io.
Interpongasi vostra signoria illustrissima et humilmente la supplico, perché il signor marchese rimandi i quadri in mano o del sudetto cardinale legato che gli riceverà, od altri ad artificio suo perché restino riconosciuti giudicialmente e compiacciersi di darne quelle giuste suddisfattioni, che si devono ad un huomo d’honore, a cui persone, (...), si sia fatto pregiudicio nella riputatione, altrimenti non si haverà da dolere di vedermi spender la vita, la robba e la penna per restar sollevato da si profonda
Carta 2 verso piaga, ch’egli mi ha aperta nelle viscere più dilicate e più vitali. Io ne scrivo a lui medesimo più di cento lettere c’ho fatto a questo fine, ne
pur una men à voluta uscir dalla penna e habbia potuto contenersi quanto si (...) delle speranze ed io ho nella equità del signor marchese che non s’aggraverà di reintegrarmi di quel che inavedutamente m’ha tolto, tocando senz’occasione nell’honore un servitore tanto suo partiale e la consideratione che in ogni luogo e tempo ed occasione devo havere all’affetto et alle obbligationi et per altro con-servo a questo cavaliere.
356
Mandi i quadri perché siano e giuridica e giudicialmente visitati e ricono-sciuti dai pittori, che gli han fatti et’io farò la spesa della condotta e starò a tutto mio danno (e vostra signoria illustrissima ne impegna, che ne la suplico, ne la pa-rola), dinanci a tutti i pericoli di perdita, o di fattura, che purchè l’honor mio re-sti quale egli si professa immaculato et illeso son pronto poi a scordarmi ogni of-fesa ricevuta da persona alla quale per altro devo tanto. Ma l’honor mio signor Gio Antonio mio signore lo voglio per me, se ci andassero mille, e cento milla vite.
I quadri negati originali sono originali sopra l’honor mio e non ritocati da Guido ma cominciati col gesso e finiti col pennello da Guido et così li mantengo e posso dire (tanto ne sono sicuro) che, fattone quello del Guercino, io stesso gli habbia veduti fare perché furno già da Guido fatti per mio padre medesimo. Et quello del Guercino, cioè il san Gio Battista, il signor Gio Batta farsi mercante qui principale, lo vendette a mio padre medesimo, dal quale mio padre sono usci-ti e pervenuti alle mani di chi megli ha venduti, come farò constare giudi-cialmente subito che i quadri sono arrivati e riconosciuti e da Guido amorevol mio disamorevole e dal Guercino quale farò venire a Bologna a posta.
Copia di quadri c’ho mandato al detto marchese tre delle quattro Sibille sieno di
Carta 3 recto lega inferiore agli altri suoi compagni, questo è certo, ne io il nego, ne il det-
to Anton Giulio potrà dire ch’io (veggansine le mie lettere che gli ne ho scritto) non gli significhi che non mi piacciono tanto quanto quelli della prima maniera, non havendo come quelli, tanto finimento. Ma che si credeva il signor marchese di spen-dere cento ducatoni al pezzo in quadri da trecento e quattrocento? Che il bisogno et la carne habbia la sua giunta seco. Veda il signor marchese se vuol dare il Christo Bambin che dorme, vegliato da gli angeli et gli ne farò dar io trecento ducatoni, e gli li farò dare a mercante che compra per guadagnarci sopra almeno dugento ducatoni. Et s’egli si risolvesse a farlo, mi honori vostra signoria illustrissima d’avvisarlo subito, che ne pur un’hora tarderà la lettera di cambio a venire.
Et forse il questi prezzi sono novità nelle cose di Guido? Saranno da sei anni che io hebbi ordine del signor duca di Modena d’offerir cinquecento ducatoni al sarto Fancini (?) di un san Girolamo di Guido che pur era una sola figura. Costui non volle dare ed hebbe ragione et lo mandò poi al signor conte Dolabella Ghi-slieri et lo comprò per un principe tedesco e gli diede seicento ducatoni d’argento. Il signor Gio Battista Raggio cognato del medesimo signor Anton Giu-lio non ha egli voluto comprar da me una meza figura, cioè una Lucretia del-l’istesso Guido e compagna in grandezza e nella cornice di quell’istesse Sibille di che si vuole il signor Anton Giulio e potrà far fido al signor Anton Giulio, se a contanti io mi sa mai lasciato persuadere a darla per un soldo meno di cento doble, a lui medesimo a cui vi era tanto servitore? Sarà egli degno di fede questo testimonio, che pure è suo cognato?
Hora io ho fatto havere al signor marchese dieci figure di Guido per otto-cento ducatoni de quali ne van sotratti cento almeno, che ne vaglino le cornici, che pur sono ricchissime
357
Carta 3 verso e nobilissime e si duole che fra questi ve sieno tre di minor finimento per
fortune degli altri. Se non segli vede volentieri in casa, gli doni poscia che questi gli sono mandati propriamente per un sopramercato, ed io che aquistava d’esserne ringraziato, mi ha (…) trafito nell’honore (…) obbligato a schiantarmi dal cuore un’amico si caro, e per tant’anni adorato?
Per l’amor di Dio, e di Maria Vergine Nostra Signora veda ch’io resti sodi-sfatto che al cospetto di Dio santissimo giuro e mi professo sull’orlo di un preci-pizio troppo et troppo pericoloso. Le parlassi poco modesta e discretamente su-plico il mio Gio Antonio a compatirmi, che la passione ch’io ho mi sviscera. Son huomo da bene e voglio l’honor mio per me e so che di qualsivoglia precipizio in ch’io possa incorere tuto il mondo, non che Genova sola mi compatirà. Sono sta-to toccato troppo sul mio e da chi? Forse da un mio nemico? O ira di Dio e sarà mai questo? Da colui ch’o adorato sopra tutto le cose che mi sono entrate giam-mai da che son nato in cuore, e volesse Dio che io havessi fatta così fedele e com-pitamente la mia parte che Dio come lo ho fatta con lui (…). Vostra signoria mi compatisca e con la sua solita distrezza veda d’indurre il signor marchese a rimet-tere i quadri in mano, o del signor cardinal legato, od altri, perché io non so tro-var altro modo, come poter sodisfare e restar sodisfatto. Bacio a vostra signoria illustrissima amorevolmente le mani. Bologna, li 4 maggio 1641. Gio Battista Manzini
359
Figg. 1-4 - Guido Reni e bottega. Le quattro Sibille contestate da Anton Giulio I Brignole-Sale a
Giovanni Battista Manzini. Genova, Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso.
360
Figg. 5-6 - Guido Reni e bottega, Cristo e Madonna orante. Genova, Musei di Strada Nuova –
Palazzo Rosso.
525
Indice LUIGI TODISCO, Rilievi romani con ghirlanda, maschera gorgonica e
strumenti di lavoro a Orsara di Puglia (Foggia) ........................ pag. 5 GIUSEPPE MASTROMARCO, Il Diverso, dalla Grecia antica al
mondo contemporaneo .............................................................. » 21 ANNA TIZIANA DRAGO, Commento all’epistola 1 di Claudio Elia-
no............................................................................................... » 41 PIERLUIGI PERRONE, Men. Georg. 77s. e la tradizione di un
apóphthegma sulla povertà ....................................................... » 49 MARIO ANDREASSI, Barbieri, umorismo e la redazione del Philoge-
los .............................................................................................. » 61 DOMENICA PAOLA ORSI, Le pere di Catone l’Uticense (Plutarco,
Cato Minor 46,4) ...................................................................... » 75 NICOLA BIFFI, La Giudea e i Giudei nella Geografia di Strabone » 77 ANDREA FAVUZZI, L’«Eracleide» nascosta della Suda .................. » 107 ANDREA FAVUZZI, Congetture su due frammenti anonimi della
Suda........................................................................................... » 121 CLOTILDE CRACA, Marziale 12,38 e 39: ritratti di damerini ......... » 131 FEDERICA MONTELEONE, Tempi e strumenti di potere nella Pu-
glia meridionale tra età bizantina e normanna .......................... » 139
526
ALESSANDRA MASTRODONATO, Cittadinanza e mestiere: appar-tenenza corporativa e privilegi nella Napoli moderna (secc. XV-XVIII) ................................................................................. » 159
ANTONIA ACCIANI, Petrarca e i nipotini ....................................... pag. 191 MONIA DE BERNARDIS, Forme e retorica del conflitto nell’Agata
di Luca Riccio ............................................................................ » 203 EMILIO FILIERI, Mater dolorosa e mulier giacobina. Momenti e
scritture in Eleonora de Fonseca Pimentel ................................ » 213 STEFANIA RUTIGLIANO, Al centro della circonferenza: la poesia
di Emily Dickinson .................................................................... » 253 ROSSELLA ABBATICCHIO, Speed reading e educazione letteraria:
un esperimento “di classe” ......................................................... » 275 ALESSANDRO CAZZATO, Variazioni beethoveniane. Luigi Magnani
tra saggio e romanzo .................................................................. » 291 ANTONIO GIAMPIETRO, I sistemi impossibili: filosofia e libertà
in Renato Serra e Charles Péguy................................................ » 307 ROSANNA BIANCO, Ordini monastici, spazio sacro e liturgia. Gli
altari della basilica di S. Caterina d’Alessandria a Galatina ...... » 317 ANDREA LEONARDI, Gio Antonio Sauli e una lettera di Giovanni
Battista Manzini. Su dieci quadri di Guido Reni acquistati da Anton Giulio I Brignole-Sale..................................................... » 337
CHRISTINE FARESE SPERKEN, Il nero nell’arte sacra contemporanea » 361 NICOLA ZITO, Dinamiche di un recupero “reportagista”. La
“Scuola di piazza del Popolo” tra Pop Art e tradizione .............. » 389 ALESSANDRA GIANNELLI, Le Isole Tremiti nella realtà e nella
cinematografia ........................................................................... » 413
527
GIANVITO CAMPANILE, Il culto di un Santo come “risorsa” per rafforzare un’identità territoriale e culturale in era di globa-lizzazione................................................................................... » 431
ANNAMARIA DICHIO, Le possibilità di realizzazione dell’etica del
discorso di K. O. Apel................................................................ pag. 439 SABINO PAPARELLA, Di comune disaccordo. Il “paradosso
democratico” da Chantal Mouffe a Jacques Rancière .............. » 457 DOMENICA DISCIPIO, Viaggiare in terre notturne Loren Eiseley e
l’antropologia onirico-futurista di The Night Country ............. » 481