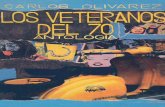La Memoria Divisa nella prospettiva di Giovanni Contini
Transcript of La Memoria Divisa nella prospettiva di Giovanni Contini
Relazione Storia contemporanea III
La Memoria Divisadi Giovanni Contini
A cura di Zaccarias Gigli
“Noi abbiamo portato, purtroppo, la rovina in quel paese. Diciamo la verità:
involontariamente, per fare del bene : ma purtroppo... purtroppo anche la Resistenza, non
è mica fatta di tutte azioni ben congegnate, bene studiate, ben fatte: quella fu un azione
sbagliata. Purtroppo”
(Succhielli comandante della formazione partigiana “Renzino”)
Inquadramento storico: La Toscana del 1943-44
Alla fine di maggio del 1944 la linea difensiva tedesca che si
attestava su Montecassino (Linea Gustav) crolla sotto gli attacchi
degli Alleati. Il 4 giugno le truppe anglo-americane guidate dal
generale Alexander dopo aver superato la Linea Caesar (Ostia -
Pescara) sgomberano Roma.
La Wermacht è costretta alla ritirata, in un solo mese aveva perso
la zona dell’Italia centrale tra Montecassino e Perugia. A questo
punto la costruzione e fortificazione della Linea Gotica, poi
ribattezzata Linea Verde, per i tedeschi era fondamentale.
Kesselring fra il 5 e l’8 giugno si stabilì con le truppe prima
sulla Linea Anton, poi sull’Emil, questo perché la Linea Gotica
necessitava ancora di lavori per essere completata. Lo stesso1
Hitler il 13 giugno ordinò al feldmaresciallo [cfr. Kesselring] di
attestare l’esercito lungo la linea Frida (Piombino-Civitanova)
ma, dopo la presa di Grosseto da parte delle truppe alleate il 17
giugno, l’esercito tedesco si stabilì sulla linea lungo il
Trasimeno, la linea fu ribattezzata Albert in onore di Kesselring1.
Le strutture della Repubblica Sociale in Toscana erano in
disfacimento, come nota lo stesso Pavolini nel suo viaggio:
Da per tutto, si è verificato lo squagliamento -quasi sempre
con le armi- dei carabinieri. Fatto più grave, quasi da
tutto una parte della Guardia si è pure squagliata, al
contagio dei carabinieri e della situazione generale.
Altrettanto -e più- dicasi dei reparti dell’esercito 2.
La preoccupazione per i ritardi nella costruzione della Linea
Gotica fece si che le direttive tedesche nell’estate del 1944 si
sviluppassero in tre rami: Difesa ad oltranza della Linea Gotica;
controllo assoluto sulla popolazione civile; deportazione della
popolazione maschile. Da qui segue necessariamente un rigido
controllo della popolazione, punizioni per ogni difficoltà che
essa provoca e il tentativo di eliminare il fenomeno della
renitenza al lavoro.
L'attività partigiana in una zona come la Toscana militarmente
sensibile attirò l'attenzione delle forze armate tedesche. Nella
lotta alle bande partigiane i tedeschi potevano avere successo1
Lutz Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino
1993, pp. 350-366.2Lutz Klinkhammer , Le stragi naziste in Italia 1943-44, Donzelli Editore, Roma 2006 , pp.106.
2
afferma Klinkhammer «soltanto se spie affidabili si fossero
preventivamente infiltrate tra i partigiani e avessero fornito
informazioni precise, in modo da rendere possibile un
accerchiamento prima che essi potessero dileguarsi in altre zone3».
Per questo motivo furono messi in atto rastrellamenti e
rappresaglie contro i civili, che dovevano portare a due effetti:
provocare l'odio dei civili contro i partigiani; effetto
repressivo sui ribelli.
La fase più dura dei massacri iniziò dopo il 4 giugno con la presa
di Roma. Il 17 giugno il feldmaresciallo Kesselring inviò il suo
ordine più noto, definito da Klinkhammer “clausola dell'impunità”,
riguardo alle misure antipartigiane:
Darò la mia copertura a ogni comandante che nella lotta contro
le bande oltrepassi nella scelta e nel rigore dei mezzi la
moderazione che ci è solita. Vale anche qui il vecchio
principio, che una mossa falsa nella scelta dei mezzi per
imporsi è sempre migliore dell'omissione o della
trascuratezza4.
Inoltre riaffermava le linee già dettate dal generale Von Zangen:
La dove compaiono bande di notevoli proporzioni bisogna ogni
volta arrestare una determinata percentuale della popolazione
maschile della zona e, qualora si verificassero violenze,
fucilarla. Bisogna farlo sapere agli abitanti. Se in qualche
3Lutz Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 354.4 Ivi. pp. 359.
3
località si sparerà sui soldati […] la località stessa dovrà
essere incendiata. Esecutori o caporioni saranno impiccati in
pubblico5.
L'appartenenza al partigiano ora non era più stabilita su
caratteri militari ma, su supposizioni e anche i civili ne vennero
considerati parte. La durezza delle misure dipendeva dai
comandanti locali, che avevano ampia autonomia sulla loro condotta
e a cui era stata data la copertura dall'alto.
L'obiettivo era di vendicare ogni atto di violenza partigiana, ma
le rappresaglie erano dirette in primo luogo verso la popolazione
civile, contro la quale furono ordinate le misure più dure e
cruente qualora nelle vicinanze fossero stati visti agire
partigiani.
La resistenza nella provincia di Arezzo e nelle zone di
Civitella in Val di Chiana
Nel dicembre del 1943 la Resistenza in Casentino era stata
descritta da un informatore “repubblichino” come se si trattasse
di un vero e proprio esercito, numeroso e ben armato. La realtà
invece era molto diversa, la Resistenza aretina, fino ad aprile,
era stata rallentata dalla cronica mancanza di armi e munizioni e
dalla crisi e spopolamento del capoluogo dovuto ai bombardamenti
degli Alleati. Arezzo fu la città toscana che più di tutte subì le
distruzioni causate dalle incursioni aeree, ciò porto la
popolazione cittadina ad andare nelle campagne circostanti e nei
5 Ivi. pp. 357.4
paesi vicini, così che la provincia rimase senza un centro. Questa
situazione peculiare oltre che, creare problemi alla popolazione,
rallentò il processo di coordinamento fra i vari gruppi di
liberazione, che si stavano formando. Contini scrive :
L'immagine di una Resistenza tutta unificata nella Divisone
partigiani di Arezzo è una costruzione largamente successiva
agli eventi, perché in realtà si configurarono due distinte
situazioni da una parte la XXIII Brigata garibaldina “Pio
Borri”, con una organizzazione unitaria, dall'altra
continuarono ad operare le cosiddette “bande esterne” [...]
con relazioni molto scarse con il centro della Resistenza e
occasionali con le bande, simili per natura, che operano in
territori confinanti6.
Erano attive nella provincia due bande, una era la “Renzino”, che
si muoveva nelle zone tra Civitella, Cornia e San Pancrazio,
l'altra era quella guidata da Raoul Bellocci, nonostante entrambe
si definissero comuniste vennero inquadrate nelle formazioni
monarchico-badogliane Monte Amiata.
Renzino è il nome di una frazione di Foiano della Chiana, dove il
17 aprile del 1921 ebbe luogo uno scontro tra comunisti e
fascisti. Il nome intendeva quindi riallacciarsi alla più forte
opposizione al regime fascista della zona, ma, il comandante
Edoardo Succhielli, nel 1944 aveva da poco approcciato il
comunismo. Egli proveniva da una famiglia povera, che comunque era
riuscito a farlo studiare, infatti, era diventato maestro
6 Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 32.5
elementare.
Nel 1943 era nell'esercito italiano con il grado di tenente e
serviva in Sardegna, dopo l'8 settembre si schierò inizialmente
con i tedeschi. In seguito tornato a Civitella per via di un
congedo, cambiò opinione perché vide lo sfascio
dell'organizzazione della Repubblica Sociale e ascoltò i discorsi
dei vecchi antifascisti, amici di suo padre, così decise, per via
delle sue conoscenze militari, di diventare capo di un gruppo di
giovani ribelli.
Ad Aprile del 1944, quando si formò la banda, i componenti erano
appena una dozzina scrive Succhielli nelle sue memorie, ma dopo
l'azione in Val d'Ambra il 10 o il 12 giugno le fila della
“Renzino” aumentarono, anche perché si erano inasprite le pene per
i renitenti alla leva. Inoltre tra l'8 e il 9 il generale
Alexander aveva radiodiffuso il proclama, che invitava i
partigiani ad uccidere i tedeschi. Ciò complicò il già
problematico reperimento delle armi e delle munizioni della
formazione “Renzino” 7.
L’uccisione dei tedeschi al Dopolavoro di Civitella
Il 18 giugno a Civitella arrivò un gruppo di tedeschi armati senza
intenzioni bellicose, Succhielli e i suoi uomini decidono di
intervenire con l'idea di disarmarli. Si decise di attaccare i
tedeschi nel Dopolavoro del paese, confidando nell'effetto
sorpresa. La ricostruzione dei fatti come sono accaduti veramente
non si ha ancora oggi. Contini scrive che “conviene limitarsi all'essenziale”:
7Ivi. pp. 31-38.6
i partigiani irrompono nel Circolo, i tedeschi sembrano reagire
prima un partigiano poi tutti sparano. Due tedeschi cadono morti a
terra uno rimane ferito gravemente e un quarto rimasto in vita
perché si trovava in un’altra stanza scappa portandosi dietro il
compagno morente. I partigiani prendono le armi e ritornano nei
boschi. Durante la notte molti abitanti scappano da Civitella
verso le case coloniche dei contadini, in paese rimangono
pochissimi uomini, alcune donne e bambini. Il 20 giugno vengono
sepolti i soldati tedeschi e fu interrogato Lammioni, impiegato
comunale, sui partigiani; gli fu chiesto espressamente di dire i
nomi. Egli dopo un consulto con il podestà locale Mammoli, dirà ai
tedeschi che non aveva scoperto nessun nome. Intanto che i giorni
trascorrevano gli abitanti fuggiti nelle case coloniche, rientrano
a Civitella pensando che, ormai non vi sarebbe più stata una
rappresaglia. Il 27 giugno su una fiat color crema, dei tedeschi
si presentarono in paese e sequestrarono le radio e dissero al
parroco don Lazzeri che avevano l'ordine di uccidere cinquanta
civili per ogni soldato ucciso dai partigiani8.
Lo scontro di Montaltuzzo
Dopo lo scontro del dopolavoro, i partigiani cambiano il loro
atteggiamento di guerriglia, mentre prima aggredivano tedeschi
isolati nei pressi di Montaltuzzo, ora li catturano e li tengono
come ostaggi per evitare rappresaglie. Ne catturano diciotto e con
l'aiuto della signora Cau, una svedese che conosceva il tedesco,
scrivono una lettera al quartier generale tedesco di monte San
8 Ivi. pp. 38-41.7
Savino, specificando i nomi dei prigionieri e che li avrebbero
liberati solo nel caso in cui il generale tedesco si sarebbe
impegnato a non toccare la popolazione civile. La base partigiana
viene scoperta dai tedeschi per caso il 22 giugno, quando arrivano
nei pressi di Montaltuzzo per sequestrare la macchina del dottor
Magrini, essi non sapevano che il dottore faceva parte della
Resistenza, e si trovano i partigiani contro che gli sparano. Il
giorno seguente i tedeschi tornarono e occuparono la villa di
Montaltuzzo e liberarono gli ostaggi, la banda “Renzino” dopo lo
scontro aveva finito le munizioni e si era divisa. Magini, che
proveniva da una famiglia legata alla Resistenza, ricorda:
«Quando gne successe questa famosa battaglia, e' partigiani allora
si sparpagliòno tutti, allora non se riméssan più insieme. Pèrsino
fucili... insomma: la banda fu sfatta. Da quel momento lì … non se
rimèssan più insieme9».
Le stragi di Civitella, Cornia e San Pancrazio
Il 29 giugno 1944 era un giovedì, festa dei santi Pietro e Paolo,
patroni di Civitella. Per la festa che si sarebbe essere dovuta
tenere in paese, quasi tutti coloro che erano fuggiti nelle case
coloniche erano tornati. Don Lazzeri e il podestà erano
tranquilli, non avevano dato peso alle parole dei tedeschi
riguardo a una possibile rappresaglia, e avevano rassicurato la
popolazione civile che oramai non c'era più nulla da temere. Il 29
giugno, giorno vicino al solstizio d'estate, fa luce presto poco
dopo l'alba, tra le sei e le sette gli abitanti scorsero dalle
9 Ivi. pp. 43.8
mura cittadine l'arrivo dei tedeschi, non pensarono a una
rappresaglia ma bensì ad un rastrellamento di giovani, che infatti
furono gli unici a darsi alla macchia. Subito dopo si sentirono
solo spari e grida strazianti. I tedeschi arrivati in paese fecero
irruzione nelle case e spararono agli uomini che vi trovavano
all'interno senza distinzioni per vecchi, infermi o malati come ci
raccontano le testimonianze delle vedove di Civitella. Gli altri
uomini che non erano stati trovati ma, fuori o all'uscita della
chiesa venivano raggruppati nella piazza del paese dove erano
circondati da mitra. Le persone che erano andate a messa vennero
prelevate dalla chiesa verso le otto e mezzo e portate anche loro
nella piazza, don Lazzeri ebbe il permesso di benedire i presenti.
Nel frattempo gli altri soldati tedeschi con granate incendiari
stavano dando fuoco alle case, le donne e i bambini furono
cacciati da Civitella e vissero così un'altra tragedia interiore :
la fuga dal paese in fiamme, mentre i tedeschi erano intenti ad
uccidere i loro mariti, conoscenti, nonni.
I superstiti Daniele Tiezzi e Gino Bartolucci, con le loro
testimonianze rilasciate agli inglesi nel novembre del 1944,
permettono di capire come i tedeschi hanno ucciso gli uomini
raggruppati nella piazza di Civitella. Tiezzi all'epoca aveva
diciotto anni, era il seminarista e aveva appena servito la messa.
Egli narra:
La gente si mise in fila per uscir di chiesa ed io, ancora
vestito con l'abito con cui avevo servito messa, ero uno degli
ultimi. Quando uscii dal portone vidi, nella piazza, sette o
otto mitragliatrici piazzate con i soldati tedeschi pronti
9
dietro. Sentii una voce che gridava “Su le mani!” e mi mossi
in avanti insieme alle donne, pensando che la mia tonaca
potesse celare la mia identità […] Stavo ancora in mezzo a
molte donne quando lo stesso maresciallo tedesco che mi aveva
strappato fuori da casa mia, mi vide, mi afferrò per un
braccio e mi portò dove stavano in fila gli uomini10.
La narrazione di Tiezzi continua, egli dice poi che vennero
perquisiti e una voce in perfetto italiano gridava cinque. Tiezzi
insieme ad altre quattro persone fu portato dietro la scuola di
Civitella, venne posizionato insieme agli altri lungo una linea,
di fronte c'erano le carcasse degli uomini uccisi. Il giovane
seminarista dopo aver sentito “clic”, che pensava fosse lo scatto
del cane della mitragliatrice, si girò e scappò. Superò il tedesco
armato di pistola e si diresse verso i boschi con dietro gli spari
delle mitragliatrici, fu colpito ma, continuo la corsa, scavalcò
le mura cittadine e riuscì a scampare alla morte. Nel bosco trovò
una ragazza che l'aiuto a medicarsi, nei giorni seguenti
nonostante avesse un braccio malmesso fu preso dai tedeschi a
scavare trincee. Non riconosciuto, i tedeschi lo stavano cercando,
scappò di nuovo e riuscì a salvarsi. Contini spiega come Tiezzi si
sia sbagliato il clic non era delle mitragliatrici ma, il cane
della pistola con cui il soldato tedesco infliggeva il colpo alla
nuca ai suoi compaesani. 11
Dino Bartolucci all'epoca era un fabbro, come Tiezzi descrive il
rituale della chiamata in gruppi di cinque dietro la scuola, così
descrive quegli attimi di terrore: 10Ivi. pp. 6511Ivi. pp. 65-68
10
Toccava a me. Il tedesco si piazzò dietro di me ed io vidi,
con la coda dell'occhio, che alzava il revolver contro la mia
nuca. Mi presi la testa fra le mani e, nel momento che
sparava, anticipando lo sparo, voltai la testa a sinistra.
Sentii la bocca del revolver contro la mano e udii la
detonazione. Immediatamente provai un dolore lancinante ad
entrambe le mani, la faccia, la bocca e la gola, e, resomi
conto di essere ancora vivo, caddi apposta per terra e rimasi
giù, facendo finta di essere morto12.
Così Bartolucci rimase per terra facendo finta di essere morto
fino a che i tedeschi non andarono via e dopo scappò nei boschi,
dove fu curato da un suo amico.
I tedeschi inoltre avevano piazzato una mitragliatrice sotto
Civitella vicino al ponte che conduce alla strada per Arezzo, qui
vennero condotti i contadini con le loro famiglie delle case
coloniche vicine, donne e bambini in seguito furono cacciati e gli
uomini furono invece fucilati, i superstiti salvatisi
miracolosamente dalla strage, ricordando gli eventi affermano che
tra i tedeschi vi erano anche due fascisti Celso Pratesi di
Ciggiano e Alfredo Rapanai di Pescaiola.
Le vedove tornate a Civitella poche ore dopo il massacro si
trovarono davanti ad uno spettacolo orrendo: case carbonizzate,
sangue sparso ovunque e cadaveri, di cui alcuni ancora in fiamme.
Una delle vedove ricorda:
12 Ivi. p. 6911
Volli andare a Civitella. Appena giunsi alla porta, dinnanzi a
tanta distruzione, mi misi a urlare. C'era puzzo di bruciato e
di cadavere […] piangendo disperatamente, giunsi fino alla
chiesa. Che tragico spettacolo! Più di cento cadaveri avvolti
dai lenzuoli, coprivano il pavimento13.
Cornia, il secondo luogo interessato dalle stragi non era neanche
un paese ma, un gruppo di case raccolto attorno alla chiesa
parrocchiale. Qui i tedeschi non fecero distinzione né di genere
né di età ma, uccisero tutti coloro che trovarono per la strada,
questo poiché gli informatori “repubblichini” avevano riferito,
che lì vi era la maggiore presenza dei partigiani.
I tedeschi prima si diressero verso il podere dei Rossi, dove
uccisero i tre fratelli di Danilo Rossi, che la sera prima si era
nascosto sulle colline con i propri buoi, per evitare che i
tedeschi li prendessero, e misero a fuoco la fattoria.
In seguito si diressero verso Mercaggiolo, dove c'era la fattoria
Caratelli, qui risiedeva la vedova Caratelli, con la figlia, il
cameriere e la famiglia contadina. I tedeschi entrarono nella
fattoria e uccisi gli uomini si diressero nella stanza, dove
stavano la signora Caratelli, sua figlia, altre quattro donne e un
bambino di quattordici anni. Qui spararono alle donne e al bambino
uccidendoli tutti tranne la vedova Caratelli, che riportò una
grave ferita, la casa fu messa in fiamme. A salvare la signora
furono Dante Pasquini e Settimia Lazzeroni.
Caterina Rossi il 29 giugno stava tornando a casa a Burrone dopo
che era stata a messa a Cornia, sulla via del ritorno incontrò un
13 Ivi. p. 82.12
uomo, che gli disse di non andare a Burrone perché c'erano i
tedeschi.
Caterina così si nascose nel bosco, senti una sparatoria e dopo
qualche ora tornò a casa per vedere cosa era accaduto. Arrivata,
trovò la sua intera famiglia uccisa, il marito, la figlia e il
figlio. A Burrone inoltre furono massacrati tutti coloro che si
trovavano nella fattoria di Ranieri Petrelli, tra i morti fu
ritrovato anche un componente della banda “Renzino”.
A Cornia i tedeschi assalirono il piccolo abitato accerchiandolo,
tra le vittime c'era anche una donna paralitica Emma Romanelli.
Angiolino Biagiotti ci narra poi che i tedeschi si spostarono a
Gebbia, un piccolo nucleo di case, gli abitanti qui erano per lo
più rimasti nelle loro case, perché la signora Cau aveva loro
detto che i tedeschi non gli avrebbero fatto del male, così non
fu, infatti, l'intera popolazione cittadina rimasta nel borgo, fu
uccisa. Questo perché un soldato tedesco che era stato ostaggio
dei partigiani a Montaltuzzo riconobbe la Cau. I coniugi Cau
furono portati sopra un autocarro e trasportati al quartier
generale di Monte San Savino, dove furono poi uccisi. 14
Ultima tappa della stage del circondario di Cornia fu Solaia, qui
c'era un gruppo di case contadine e vi abitava Dario Polletti,
appartenente alla “Renzino”. Polletti, con la famiglia, alle prime
luci della mattina visti i tedeschi si rifugiò in un podere
distante dalla via principale, in seguito si nascose nella macchia
perché pensava che i tedeschi fossero venuti a cercare uomini per
farli lavorare. Rientrato poi a Solaia nel pomeriggio, trovò gli
edifici in fiamme e la sua famiglia massacrata.
14 Ivi. pp. 87-113.13
Terzo luogo della strage fu San Pancrazio, villaggio di braccianti
agricoli, posto sulla vecchia strada che collega Monte San Savino
con Firenze. Come a Civitella i tedeschi sorpresero la popolazione
locale accerchiandola alle prime luci del sole. Come a Civitella
furono massacrati solo gli uomini, donne e bambini furono lasciati
in vita. Tra le fila dei tedeschi fu riconosciuto un fascista del
posto Lammioni di Bucine. Dato il perfetto accerchiamento da parte
dei tedeschi, furono in pochi coloro che riuscirono a salvarsi.
Come a Civitella e Cornia vennero massacrati uomini invalidi,
malati e anziani, la maggior parte delle donne e dei bambini
vennero allontanati dal paese. L'omicidio più brutale che
ricordano gli abitanti di San Pancrazio è quello della suocera di
Laura Ciofi, una donna di settantacinque anni paralitica.
Gli uomini vennero portati nella piazza principale e li rimasero
ad attendere per alcune ore, in seguito furono portati nella
fattoria Pierangeli, antistante la piazza, e condotti nei locali
della ziraia, la stanza dove si conservano gli orci dell'olio [cfr
ziri]. In questa sala fu raggiunto il massimo dell'orrore, furono
uccisi con il metodo del colpo alla nuca ben sessanta uomini. A
logorare ancora di più gli animi già a pezzi fu l'attesa e vedere
accatastati i corpi degli uccisi, che erano parenti e conoscenti.
I superstiti furono pochissimi: Alfredo Sorboli si salvò perché
era un tecnico delle linee elettriche, Aldo Sebastiani, sfollato
di Siena, venne portato a Monte San Savino al quartier generale
della Goering. Infine Emilio Fabbri, Silvano Bechi, Elia Nannini,
Ugo Casciotti e Arnaldo Savini furono risparmiati perché
rivelarono i luoghi dove si nascondevano i partigiani.
Le donne furono raggruppate nell'altra piazza di San Pancrazio,
14
detta del Pozzaccio. Qui attesero fino a mezzogiorno, quando un
soldato in motocicletta arrivò da Civitella con un pezzo di carta,
che consegnò ai tedeschi che le sorvegliavano. Dopo aver letto il
foglio alle donne, fu intimato di lasciare la piazza, esse si
diressero verso la macchia. Molte di esse tornarono nel pomeriggio
a San Pancrazio, dove trovarono le case in fiamme e dovettero
ritornare nei fondovalle, dove i carbonai avevano costruito delle
baracche per i renitenti alla leva. In questi capanni restarono
fino all'arrivo degli Inglesi subendo le razzie dei tedeschi. 15
Il Perché
In primo luogo sono le fonti tedesche a essere silenziose sulla
strage di Civitella.
Lo storico tedesco Geyer ha spiegato il silenzio con il fatto che
“ i luoghi della strage si trovano nella zona di confine tra
l'area controllata dalla Decima e quella controllata dalla
Quattordicesima armata della Wermacht, sorta di “terra di nessuno”
dove gli sconfinamenti e le sovrapposizioni non erano
infrequenti16. Geyer individua anche una seconda causa, a fare la
strage fu la Fallschirmpanzerdivision Hermann Goering, composta da
giovanissimi, facenti parte delle Waffen-SS, i quali combattevano
con grande fanatismo. Quest’unità che partecipò anche alla strage
di Vallucciole, lascerà l'Italia dopo il massacro di Castelnuovo
dei Sabbioni e Meleto, spostata sul fronte orientale, dove venne
annientata.
15 Ivi. pp. 113-129.1616 Michel Geyer, Civitella della Chiana, dattiloscritto, cit. in Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, p.138.
15
La strage, dice lo storico tedesco fu studiata e premeditata, la
brutalità che accompagnò le uccisioni fu dovuta al fatto che a
compierle, fu un corpo dell'armata tedesca estremamente
nazificato.
Cruciale fu inoltre l'ordine di Kesselring del 17 giugno, che
garantiva la copertura dall'alto sulle uccisioni.
Geyer aggiunge che le stragi furono un mezzo per sollevare il
prestigio dell'esercito e per vendicarsi delle vittorie degli
Alleati17.
Fulvetti pone l'accento sull'importanza di creare una linea sicura
di passaggio tra la Val di Chiana e il Valdarno da parte dei
tedeschi, dunque i territori andavano resi sicuri: «In un contesto
così modulato la soglia di sopportazione della presenza partigiana
è “fisiologicamente” bassa; lo diventa ancor di più, poi, se a
operare è un reparto come la Göring e se, infine, la 14° Armata
entra in fibrillazione18».
L’inchiesta ingleseL'inchiesta inglese, che si concluse nel 1945, ricostruì una
cronologia dei fatti simile a quella della popolazione di
Civitella: i tedeschi prima venivano nel paese e si comportavano
in maniera amichevole, l'uccisione dei due soldati nel Dopolavoro
è l'unico episodio che può aver attirato l'attenzione su
Civitella; già il 20 di giugno i tedeschi avrebbero voluto
effettuare la rappresaglia, ma poiché avevano trovato nelle case17 Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 137-139.18 Gianluca Fulvetti,Uccidere i civili Le stragi naziste in Toscana 1943-1945, Carocci editore Roma ,2009, p.124
16
pochi uomini decisero di rimandarla; la battaglia di Montaltuzzo
pose l'attenzione tedesca anche su Cornia e San Pancrazio.
Sicuramente la presenza partigiana fu essenziale, ma tuttavia
numerose testimonianze raccolte dagli inglesi mostrano una strage
giudicata dagli stessi massacratori come una lotta ai “ribelli”
piuttosto che a una rappresaglia.
L'indagine inglese infine dimostra come le informazioni dei
“repubblichini” furono importanti per i tedeschi per localizzare
Cornia e San Pancrazio19.
Le CauseL'azione al Circolo, sommata alle altre azioni partigiane, prima
fra tutte la battaglia di Montaltuzzo, può sicuramente essere
stato un elemento importante nella decisione tedesca della strage.
L'operazione della “Renzino” andava ad innestarsi in circostanze
che nessun membro della formazione poteva immaginare: nel giugno
del 1944 Kesselring voleva tenere a tutti costi Arezzo, le strade
utilizzate per il trasporto dei rifornimenti passavano da
Civitella e andavano rese sicure, l'ordinanza del Comando Supremo
che dava alle unità licenza di uccidere, la presenza della
Goering, il desiderio di vendetta nei confronti dei partigiani.
Concause che unite assieme portano inevitabilmente a un’unica
soluzione: il massacro. Così anche se i partigiani, dal punto di
vista dell'etica della responsabilità di cui parla Todorov hanno
commesso un errore, non si possono considerare i responsabili di
ciò che accade in seguito20.
19Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 144-149.20Ivi. pp. 152-153.
17
Ricordo, Tragedia, Orrore e la costruzione di una Memoria
Divisa
Nelle interviste raccolte a Civitella, Cornia e San Pancrazio a
cinquant'anni dal 29 giugno 1944 emergono due caratteri: quello
del ricordo del massacro, individuale; e quello della memoria,
collettivo.
Il ricordo personale degli avvenimenti si compone quasi sempre di
percezioni uditive o olfattive, oppure di immagini. In alcuni casi
le bellissimi immagini della natura trionfante del 29 giugno si
contrappongono nei racconti dei superstiti con l'orrore. Ad alcuni
piccoli il ricordo traumatico è stato costruito intenzionalmente
perché, seguendo un’usanza antica, bisogna ricordare gli episodi
importanti della vita anche quelli più traumatici: traumatizzare
la memoria dei bambini per farla funzionare da archivio. Tanto a
Civitella che a San Pancrazio i testimoni raccontano di tedeschi
“buoni”, che cercarono di favorire la fuga degli abitanti. Secondo
Contini quello del tedesco “buono” è un racconto mitico e
condivide la stessa opinione dello storico Portelli: «un mito […]
non è necessariamente un racconto falso, quanto un racconto che,
veridico o meno, amplifica il significato simbolico di un evento
per dare forma narrativa alle autorappresentazioni condivise da
una comunità e da una cultura»21.
Il tedesco “buono” rappresenta l'eccezione, anche se immaginata,
in quella struttura coesa, e dunque il sogno di un passato che
21Sandro Portelli, Lutto, senso comune, mito e politica nella memoria della strage di Civitella, cit in Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, p.169.
18
avrebbe potuto concludersi in altro modo.
Nella cruenta vicenda di Civitella la memoria collettiva degli
eventi che precedono e seguono la strage costituisce l'aspetto più
suggestivo e sconvolgente. Non è insolito che nelle piccole
comunità si costruisca una memoria collettiva sugli eventi
passati. A Civitella il fatto sconvolgente è che si sia formata
dopo un evento così macabro, traumatizzante e perché si forma come
giudizio degli eventi che precedono immediatamente la strage. A
questo racconto si contrappongono quelli dei partigiani, molto
contraddittori fra di loro. Essi sembrano essere reattivi, cercano
cioè di rispondere alla grande e coerente narrazione sviluppata
dai cittadini di Civitella, che ricostruisce la strage del 29
giugno vedendone la causa nell'azione della banda “Renzino” del 18
giugno. In quel resoconto i partigiani diventano i principali
responsabili della strage. La prima differenza che si ha nei due
racconti è sul comportamento dei tedeschi uccisi il 18 giugno,
mentre per i civitellini essi erano amichevoli ed erano stanchi
per la guerra, per i partigiani facevano razzie e infastidivano le
donne.
Altro punto di scontro riguarda il perché questi soldati vennero
assaliti. I partigiani presentano il fatto come il risultato di un
desiderio collettivo di agire contro i tedeschi, che loro si
sarebbero semplicemente incaricati di realizzare. Mentre i
civitellini affermano che non avrebbero mai chiamato i partigiani,
perché sapevano delle rappresaglie e dicono che la scelta fu presa
in autonomia dalla “Renzino”. Le controversie maggiori si hanno su
ciò che è avvenuto al momento della sparatoria nel Circolo del
Dopolavoro. Caroti, un membro della formazione partigiana,
19
ricorda:
I quattro tedeschi se ne stavano a bere, tranquillamente
seduti e rilassati […] In pratica entrammo tutti
simultaneamente. Cinque armati che irrompono in una stanza per
ammazzare quattro individui seduti ed ignari fanno quattro
cadaveri inchiodati alle rispettive sedie. Ma noi non volevamo
ammazzare. Puntando le nostri armi. “Haende hoch” intimò
allora Renzino (Succhielli)22.
Uno de tedeschi non obbedì e scattò verso Succhielli, un secondo
imitò il primo e si ribellò pure lui, i partigiani furono
costretti a difendersi e partirono i colpi di fucile. Cadono a
terra morti due e un terzo gravemente ferito, mentre il quarto
riesce a fuggire, Caroti ricorda che Succhielli gli disse:
“Lascialo stare; potranno essere undici vite risparmiate”.
Proprio sulla mancata uccisione del quarto tedesco insiste la
memoria antipartigiana, che inizia il suo racconto attribuendo ai
partigiani l'intenzione di uccidere i tedeschi. Alda Bonichi
riferisce le parole del padre, che al momento della sparatoria si
trovava nel circolo: «E' entrato uno co' un cappellino e ha
sparato, subito. […] Dice che il Succhielli abbia detto: “Mani in
alto”, ma così, tanto per fare ma, intanto quell'altro ha sparato,
e poi ha sparato anche lui»23.
La popolazione di Civitella ancora più dell'uccisione dei tedeschi
e di aver fatto fuggire il quarto tedesco, rimprovera ai
partigiani il non aver difeso il paese. I civitellini erano22Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 176.23Ivi. pp. 178.
20
convinti che il borgo essendo murato potesse essere difeso dagli
abitanti con un paio di mitragliatrici o, addirittura con i
fucili.
Nelle testimonianze raccolte da Contini e Paggi si nota che
affianco al racconto fattuale viene incorporato il giudizio sugli
avvenimenti e sopratutto verso i partigiani: «Si sa che i tedeschi
l'è una razzaccia […] si sa che erano cattivi! […] Perché siete
andati a dargli noia? Scusi, se c'è un leone lì, e l'è feroce,
però ha mangiato, però andate a dagni noia, icché 'ni fa? La
mangia anche se 'un ha fame!»24.
Un’altra: «I signori partigiani io li chiamo delinquenti! Ché non
c'era motivo, scopo di avere fatto quel che han fatto»25.
Ai partigiani inoltre viene attribuita la colpa della rovina di
Civitella, che avrebbe potuto svilupparsi diversamente se non vi
fosse stata la strage: la fine dei contadini, la crisi
dell'agricoltura e la migrazione verso la città.
Il lutto di Civitella costituisce un caso particolare, perché si
tratta di un lutto collettivo per il quale non funzionano
completamente le interpretazioni psicoanalitiche. Un punto da
tenere presente che il lutto è subito ed è elaborato da donne. Il
lutto personale dopo la strage diventa lutto collettivo: quasi
ogni abitante con la sua presenza, suggerisce la memoria di una
parte della tragedia, perché tutti ricordano chi fossero i suoi
familiari massacrati. Questo lutto “straordinario” richiedeva un
rituale adeguato, la vita quotidiana divenne il luogo dove venne
celebrato. Le donne s’imposero di vestire di nero e allungarono
l'imposizione anche alle giovani figlie. Le donne dice Tiezzi non24 Ivi. pp. 185.25Ibidem.
21
accettavano che si iniziasse a dimenticare la strage, per loro il
lutto doveva continuare nel tempo. L'identificazione dei
partigiani come responsabili dipende dalla necessità di trovare
dei colpevoli, mentre i tedeschi vengono identificati come
l'equivalente delle cause naturali dei disastri, quindi come un
qualcosa di non umano, i partigiani erano e sono umani, che non
sparirono ma, vi rimasero negli anni a Civitella.
A Civitella a differenza di altri luoghi di stragi come Meleto o
Castelnuovo dei Sabbioni, dove vennero uccisi dei “repubblichini”,
non fu mai trovato un capro espiatorio da sacrificare, in assenza
dei veri colpevoli.
I partigiani non compirono mai dei passi verso la riconciliazione,
si limitarono loro a colpire i fascisti, offrendo quella punizione
alla popolazione. Dopo che vennero bastonati Massimo e Giorgio
Marsili, fu chiesto ai ragazzi presenti di indicare chi fossero
gli assassini dei loro padri, uno dei ragazzi indicò il capo
partigiano, forse Raoul Bellocci.
Negli anni seguenti alla guerra furono arrestati prima Succhielli
per diserzione e a tre anni dalla Liberazione Raoul Bellocci viene
incarcerato per sedici mesi per un episodio accaduto nel 1944.
La Democrazia Cristiana al governo con primo ministro Fanfani,
aretino, si muove con molta attenzione a Civitella garantendo alle
vedove le pensioni di guerra, la ricostruzione delle case e la
costruzione di un acquedotto. E' il nuovo parroco del paese don
Randellini a organizzare la vita politica e a mettere tutta la
popolazione cittadina contro il comunismo. L'accusa dei partigiani
già presente nel paese fu strumentalizzata dal sacerdote che se ne
servì per promuovere la Democrazia Cristiana. Randellini rimase
22
parroco a Civitella fino al 1954, sostenne nella lettera d'addio
di essersi “in tante circostanze […] sentito ispirato” dai morti del 1944, che
lui chiamava martiri.
Negli anni successivi a più riprese i partigiani tentarono di
riprendere in mano la memoria di Civitella, per tentare quella
connessione tra la Resistenza e la storia di Civitella senza
riuscirci.
Nel corso dei primi anni del dopoguerra molti giovani devono
lasciare il paese per studiare, un destino che se non ci fosse
stata la strage molto difficilmente gli sarebbe toccato,
l'istruzione infatti fu assicurata da specifiche sovvenzioni.
Civitella divenne dunque il luogo, dove si passavano le vacanze,
dove i giovani si dividono tra la spensieratezza e la nostalgia
per il passato. Alcuni non resistettero al ricordo traumatico e si
tolgono la vita.
Tutti gli avvenimenti pubblici, il processo vinto da Succhielli
nel 1951, fecero uscire la dinamica della memoria divisa fuori dal
suo contesto relegato nelle memorie delle vedove.
Le discussioni sulla strage e le recriminazioni contro i
partigiani investono i figli, nel corso degli anni sessanta sono
loro i giovani che boicottano le celebrazioni delle stragi e a
indignarsi per i libri di Succhielli e Gambassini.
I bambini del 1944 si presentano dice Contini come i “custodi di una
memoria speciale” .
La lettera inviata di risposta a Succhielli nel 1950 invitava a
non parlare più della “dolorosa storia”, ma per evitare l'oblio durante
la celebrazione del cinquantesimo anniversario della strage gli
abitanti hanno interpretato una rappresentazione corale del
23
massacro26.
Inoltre nel 1994 usciva il libro d’interviste di Ida Balò Valli,
mentre Leonardo Paggi con Storia e memoria di un massacro
ordinario ha presentato un tentativo di osservare il massacro da
un angolo prospettico multidisciplinare, anche se è stato
considerato offensivo dai civitellini27.
L’uso delle fonti orali e il “metodo” di Contini
Quando si parla di storia orale, ci si riferisce prevalentemente
alla produzione e all'uso d’interviste con testimoni, parole e
immagini che non esisterebbero se qualcuno non avesse deciso di
fare le interviste. Si tratta di fonti intenzionali. Possono
essere il risultato della ricerca di un sociologo, di un
antropologo o di uno storico. Sono gli storici contemporaneisti e
gli antropologi quelli che utilizzano più di frequente il metodo
dell'intervista libera.
Nell'incontro che produce la fonte orale, un ruolo fondamentale è
giocato dall'intervistatore, egli è spesso quello che sollecita e
conduce l'intervista, la trascrive e infine la interpreta,
utilizzandola per scrivere un testo del quale è autore. Proprio
per l'importanza strategica dell'intervistatore dice Contini è
opportuno che, egli registri in qualche forma le sue impressioni
sull'intervista subito dopo e non si nasconda. L'intervista dunque2626 Nel 1950 ci fu uno scambio di accuse reciproche in alcune lettere inviate ai giornali “Avanti!” da parte di Succhielli e Mattino dell’Italia centrale da parte dei civitellini. Succhielli querelò il direttore del Mattino e nel 1951 vinse la causa, per gli abitanti del borgo fu un’altra sconfitta.27Ivi. pp. 201-256.
24
non è una semplice emissione d’informazione da parte di un
testimone/fonte che l'intervistatore si limiterebbe ad ascoltare,
registrare e archiviare, Contini afferma, infatti, che
l'intervista «somiglia piuttosto a un campo di forza, uno scenario
dove entrambi i protagonisti arrivano con schemi precostituiti e
recitano ciascuno il proprio ruolo, tenendo conto l'uno
dell'altro».
Da tenere presente inoltre è il fatto che l'intervistatore sia uno
storico, o un antropologo con interessi storici, che è tutt'altro
che secondario, ciò orienterà l'intervista in direzione del
passato e non del presente del narratore. Il metodo della storia
orale pone quindi in relazione dialogica non solo due individui,
intervistato e intervistatore, ma i due fondamentali modi di
trasmissione-elaborazione della memoria del passato. Così
l'intervistatore-storico è costretto a entrare all'interno di un
modo discorsivo che non ha interesse per la verità e talvolta
neanche per la verosimiglianza, sfiora non di rado il mito,
restringe e sposta nel tempo e nello spazio eventi e persone in
funzione di scopi formativi. L'intervistato, da parte sua,
vorrebbe raccontare la propria storia, breve e composta di
aneddoti retoricamente efficaci, ma è costretto
dall'intervistatore a tornare continuamente sulla via della
“verità”, l'intervistato è costretto a un’intervista lunga quando
invece solitamente ha trasmesso il suo sapere con piccoli aneddoti
raccontati nel rapporto quotidiano. Contini dunque dice che:
«L’intervista è quindi il risultato degli sforzi di due attori che
cercano di ascoltare e di raccontare cose diverse».
25