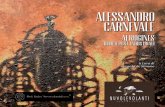Istituzioni e cambiamento politico nelle società pre-industriali
Transcript of Istituzioni e cambiamento politico nelle società pre-industriali
quaderni di scienza politica – anno XX – terza serie, Vii – n. 2, agosto 2013
istituzioni e caMbiaMento politico nelle società pre-industriali
di paolo Franzosi
A proposito di: Francis FukuyAMA, The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011
È presto per capire se il primo volume dell’opera di Francis Fukuya-ma sulle istituzioni politiche storiche darà inizio a una nuova stagione di studi di analogo respiro, ma senza dubbio la sua uscita, con il dibattito che ha generato, testimonia il ritorno dell’interesse sulle ampie visioni confi-gurative volte a interpretare il corso della storia della civilizzazione umana, che ciclicamente si ripropongono. L’ultima grande stagione è stata quella della sociologia politica degli anni Ottanta e primi Novanta del Novecen-to, con le opere di Mann, Hall, Runciman, Gellner e altri, preceduta dal-la proposta neo-evoluzionistica di Parsons di circa un ventennio addietro. L’esistenza di una tradizione di indagine che ha il suo culmine nei lavori di questi autori pone subito in chiaro alcuni termini di confronto con le opere che giungono dopo in ordine di tempo, tra cui quella di Fukuyama, impo-stando la discussione sulla capacità di superarne le debolezze e di farne propri i punti di forza.
Dalla lettura di The origin of political order balza subito all’occhio del politologo la centralità dell’aspetto “politico”, che risente dell’evidente influenza della prospettiva di Samuel Huntington. L’impianto di base pro-mana dal riconoscimento della pluridimensionalità dei fattori determinanti l’agire umano, che rimanda a una concezione che potremmo ritenere asso-data in letteratura, a partire da Weber. All’interno di questa impostazione, risalta appunto per importanza il fattore politico in senso stretto, che appare qui “sganciato” dal fattore coercitivo-militare. In precedenza, già Michael Mann aveva imboccato questa strada, distinguendo quattro tipi di potere “sociale” (a fronte di una posizione diffusa che ne contemplava tre: econo-mico, coercitivo-politico, ideologico), includendovi il potere di governo e
288 paolo franzosi
di amministrazione di uno stato territoriale, differenziato rispetto al puro potere coercitivo(1). In Fukuyama il fattore politico si fa ancor più artico-lato, da un lato collegandosi con l’idea (classica) di “ordine”, dall’altro individuando le tre istituzioni politiche cardine che segnano l’emergere di un sistema politico istituzionalizzato: il governo centralizzato fondato sul controllo di un apparato burocratico; il rule of law, inteso come un corpo di leggi considerate “superiori” al potere del sovrano, che ne limitano l’a-zione, e che si collegano sempre all’azione di un potere sociale che, o com-pete con il potere politico, o con questo instaura forme istituzionalizzate di cooperazione che ne vincolano le possibilità di intervento sulla società; le istituzioni della political accountability.
La scelta à la Huntington di privilegiare i fattori istituzionali dell’or-dine politico, pur senza relegare in secondo piano l’analisi dei poteri in-fluenti diffusi nella società, apre direttamente alla dialettica tra due modelli istituzionali antitetici di organizzazione politica, che può essere considera-ta nell’ottica del processo di cambiamento politico. Al centro dello schema esplicativo si colloca così la dinamica relativa alla lotta per la fondazione e la difesa dello stato burocratico contro le istanze particolaristiche delle organizzazioni tribali e dello stato patrimoniale.
Abbiamo così due modelli politico-istituzionali che vanno a costi-tuire i pilastri di uno schema di riferimento per l’interpretazione della dinamica politica. (1) L’organizzazione politica fondata sulla parentela e i legami diretti, personali, tra capo e seguaci, che si articola in diverse strutture e dà vita a orientamenti particolaristici; le cui ridotte dimensioni rispecchiano il fatto che il potere politico può organizzarsi solo su scala relativamente modesta, privo di un sistema burocratico e della capacità di concentrare in un apparato ad hoc le risorse di violenza. (2) Lo stato qua-le organizzazione di autorità centralizzata e strutturata in una gerarchia di ruoli, che controlla un apparato amministrativo i cui criteri di accesso rompono con il particolarismo, che mantiene saldo il controllo di un am-pio territorio anche grazie al monopolio della violenza, e il cui sistema di legittimazione fa riferimento a uno schema elaborato di credenze facente a sua volta capo a un’organizzazione delle risorse simboliche in forma istituzionalizzata. Questi due modelli antitetici hanno i propri referenti empirici in sistemi che vanno dalla tribù, agli stati medievali, alla Cina, allo stato moderno di matrice europea.
(1) Michael MAnn, The Sources of Social Power, Cambridge, Cambridge University Press, 1986-1993, 2 voll.
289IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
Il cambiamento politico è pertanto risolto nel processo di istituzio-nalizzazione del sistema politico, messo in moto dalla lotta finalizzata a imporre il secondo modello, il quale deve poi vedersela con la necessità di contrastare secessioni e sfaldamenti.
Con il consolidamento dello stato, vengono ad articolarsi le forme di ostacolo e di vincolo al potere di governo. La seconda e la terza delle proprietà istituzionali che caratterizzano l’ordine politico completamente realizzato consentono di riconoscere il modello compiuto nella forma orga-nizzativa nelle liberal-democrazie. Tuttavia, se la compresenza simultanea dei tre fattori dell’istituzionalizzazione politica si ravvisa nei pilastri istitu-zionali delle poliarchie contemporanee e nei requisiti indispensabili della libertà politica, ognuno preso di per sé può essere un elemento qualificante di taluni regimi storici emersi in epoche e contesti assai diversi e con ca-ratteri loro propri.
Tale impostazione segna un netto distacco dalle teorie evoluzionisti-che di impianto teleologico e deterministico, dal momento che la combina-zione dei tre elementi strutturali dell’ordine politico è concepita in ultima istanza come il parto della contingenza storica. E questa considerazione fa tutt’uno con un accostamento che nega dichiaratamente la possibilità di co-struire ampi schemi teorico-esplicativi, privilegiando al loro posto modelli intesi sgorgare quasi senza mediazione dalla generalizzazione empirica dei risultati dell’osservazione dei casi storici(2).
Lo sviluppo politico nella prospettiva storica
Governo. Ampio spazio l’autore riserva all’origine della politica, rav-visandola nell’organizzazione dei primati. Piegando i risultati della lettera-tura biologica e antropologica a dati utili a formulare una critica efficace – sebbene forse un po’ miope(3) – alle teorie del contratto sociale quali descrizioni inattendibili dell’origine della società, Fukuyama ricava che l’agire sociale è vincolato da fattori innati comuni a tutti gli esseri umani,
(2) Non deve quindi stupire l’assenza di un vero e proprio capitolo “teorico” introduttivo. (3) Sebbene, come l’autore stesso in un frangente riconosce, queste teorie, sotto il me-
desimo aspetto già criticate da diversi altri autori, abbiano natura normativa, ponendosi dunque scopi altri da quelli che in questa sede Fukuyama persegue. Senza contare che su di alcune semplificazioni “irrealistiche” sono state costruite teorie empiriche efficaci, come dimostra il contributo di Hobbes alla teoria delle relazioni internazionali. Francis Fukuyama, op. cit., p. 82.
290 paolo franzosi
da cui scaturiscono anche dei modelli di atteggiamento e di comportamen-to significativi per la politica, come l’inclinazione a conformarsi alle norme sociali e la propensione all’azione cooperativa.
L’agire in gruppo e sotto la guida di un capo ha radici in forme di collaborazione preumane, ma è solo con lo sviluppo degli attributi che definiscono la natura antropologica che emergono i tratti distintivi della vita politica. Tra i fattori propriamente “umani” della cooperazione so-ciale, cruciali sono le facoltà di linguaggio e di pensiero, in primo luogo quali precondizioni del pensiero religioso, la fonte principe di coesione interna alle piccole comunità primitive. Dal pensiero sgorgano creden-ze sulla relazione tra forze sovrannaturali ed eventi della natura, di cui le prime sono credute le cause, sulla cui base è possibile intervenire attraverso la manipolazione dei secondi. Di qui anche la possibilità di rafforzare le norme agganciandole a un sistema di sanzioni simboliche positive e negative in riferimento al soprannaturale, e collegandole all’a-zione collettiva per eccellenza, il rituale, a mo’ di rinforzo della solida-rietà comunitaria.
La prima forma di società è la banda. Essa non conosce né la proprie-tà né la gerarchia, pratica il nomadismo e ha struttura acefala. La religione si lega con il criterio fondamentale dell’organizzazione di questa società che è la parentela. I confini della lealtà e della solidarietà a fondamento dell’agire collettivo, quale si esprime nelle attività di guerra o di caccia, non vanno oltre quelli della struttura familiare.
Solo con lo sviluppo delle prime forme di agricoltura presso le aree alluvionali di parte del globo abbiamo la forma tribale di organizzazione sociale, la quale è per certi versi una risposta all’incremento demografi-co e alla necessità di organizzare i nuovi bisogni legati alla produzione agricola. I criteri fondamentali dell’organizzazione per famiglie o ban-de non sono pertanto scardinati, tuttavia la religione acquisisce ulteriore importanza come fonte di saldatura di rapporti più larghi oltre i confini familiari: prende forma una società “segmentata” con i gruppi di lignag-gio in veste di unità componenti. La religione interagisce con la struttura della parentela dando vita al culto degli antenati, che si istituzionalizza e sviluppa legami in estensione. La credenza religiosa che innerva il cul-to stabilizza i rapporti reciproci dei componenti della tribù e rafforza le norme su scala così ampia. La funzione della religione è dunque quella di facilitare l’azione collettiva: di produrre coesione sociale e disciplina, stabilendo anche un sistema normativo comune di “diritti” e “doveri” per i discendenti di uno stesso antenato, che si estendono in principio a chi deve ancora venire alla luce, tenuto conto che l’organizzazione della
291IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
società sulla base della parentela e degli altri legami di natura particola-ristica deve fare i conti anche con bisogni sociali emergenti dall’impiego di forme embrionali di agricoltura.
Andando oltre, lungo il cammino della storia si assiste sporadica-mente alla formazione di strutture politiche relativamente più articolate, qualificabili, semplificando, con l’espressione “stato patrimoniale”. Il cri-terio particolaristico e quello ascrittivo rimangono alla base anche dell’or-ganizzazione sociale e politica di questo sistema politico, costellato da legami personali tra patroni e clienti; è lo standard “negativo” al quale il modello dello stato burocratico, universalistico e impersonale si oppone antiteticamente.
Il primo esempio storico di “stato moderno” è rappresentato, secondo Fukuyama, dalla Cina(4). Con l’unificazione imperiale sotto la dinastia Qin – al pari dello stato moderno europeo per Tilly, l’impero cinese figura alla stregua di un epifenomeno dello stato di guerra e fuoriesce da una progres-siva operazione di conquista –, abbiamo la costituzione del prototipo dello stato burocratico e dispotico (ossia non limitato da alcuna istituzione di rule of law o assemblea rappresentativa), il cui processo di consolidamento sotto le dinastie successive si arresta solo di fronte ai limiti “tecnologi-ci” che intaccano le risorse di potere a disposizione dei suoi agenti, e di fronte alle ribellioni che scoppiano qua e là nelle periferie del suo vasto territorio. Contrariamente ad Atene e a Roma, in Cina è eretto un apparato amministrativo a più livelli sotto il controllo dell’imperatore, e l’opera di consolidamento dello stato va di pari passo con la creazione di una cultu-ra condivisa da una classe di letterati di respiro universalistico. Le redini dell’esercito rimangono abbastanza salde nelle mani del governo e nessun altro potere fa da contraltare a quello dello stato.
Nato più o meno direttamente dalle esigenze imposte dalla guerra (organizzazione militare e prelievo fiscale), l’impero cinese si consolida anche attraverso la capacità di controllo delle risorse di potere di natura simbolica. La riflessione sulla politica e sulla morale si fa profonda nei periodi di turbolenza e di guerra, traducendosi nell’opportunità per diver-
(4) Questa posizione di Fukuyama contrasta sia con la tradizione sociologica e politolo-gica occidentale che sancisce l’identità europea dello stato moderno, riconoscendo ponti con la cultura classica e le antiche istituzioni di Roma, sia con l’impostazione marxista che raggruppa l’esperienza cinese e quella indiana nella categoria del paradigma asiatico e del dispotismo orientale. Niente di tutto questo, il primo esempio di modernizzazione (politica) lo si ha in Cina, e solo in Cina; (anche) nel senso che l’India sotto questo aspetto dà origine a un modello istituzionalmente antitetico, come ci apprestiamo a vedere.
292 paolo franzosi
se figure intellettuali (insegnanti, filosofi, scrittori) di fondare scuole e di viaggiare lungo le vie dell’impero diffondendo messaggi e idee. Il lascito di questo fermento culturale e dell’opera di questi intellettuali erranti, i quali col tempo si stabiliscono a servizio degli uomini di potere, è la costi-tuzione di un bagaglio di simboli e di idee che coincide con la produzione di una salda identità trans-locale: un’identità che assume i caratteri quasi di un’“ideologia”, dal momento che affronta direttamente i problemi del giusto ordine politico, del limite dell’azione del governo e delle basi della legittimità dei ruoli politici e, di riflesso, le fonti della lealtà della popola-zione cinese. È l’identità di un’élite sociale diffusa e anche di una classe di governo “nazionale”, il cui prestigio supera quello della classe militare o dei religiosi, andando a braccetto con il senso di superiorità intellettuale basato sulla conoscenza dei classici. “Grecia capta ferum victorem cepit”: tale cultura “catturerà” nel corso della storia gli invasori barbari, preservan-do l’identità cinese e di fatto non fornendo alternative alla gestione delle medesime istituzioni di governo. E ai periodi di disgregazione dell’impero, che coincidono con il ritorno al sistema patrimoniale, segue la riunificazio-ne portata avanti sotto l’egida di questa unità culturale e identitaria.
L’immagine antitetica è il puzzle di regni e principati dell’India. An-che queste forme del potere politico sostituiscono il sistema delle società tribali, senza però dare sfogo a guerre cruente come in Cina. Il declino dello stadio tribale ha così sbocco in una pluralità di organismi politici che non si organizzano su base burocratica, bensì forgianti un particolare mo-dello di organizzazione sociale incentrato sulla divisione netta, che sfocerà più tardi nel sistema castale “Jati”, tra “classi” di preti (Bramini), guerrieri, mercanti e contadini. Su questa base si istituzionalizza la separazione tra autorità politica secolare e autorità religiosa, segnando una divergenza fon-damentale rispetto al caso cinese, dove i religiosi e i filosofi erano inseriti nel regime politico alla stregua di ufficiali di corte; piuttosto avvicinando il caso indiano a quello dell’Europa cattolica, fatta salva l’assenza di una chiesa organizzata su base burocratica. Il consolidamento del sistema Jati impone la separazione “sacra” di gruppi occupazionali, che, se da un lato irrigidisce le divisioni all’interno di una gerarchia stabile, dall’altro sanci-sce le regole di interconnessione delle diverse collettività chiuse, stabilen-do un ampio sistema di divisione del lavoro.
La posizione di preminenza dei Bramini è il principale ostacolo all’af-fermazione di un sistema di governo burocratico e accentrato. Costoro, organizzati in lungo e in largo grazie allo sfruttamento di reti di comunica-zione su ampia scala, fondano il proprio potere religioso sulla produzione di un corpo articolato di credenze, caratterizzato da una profonda specula-
293IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
zione metafisica e incentrato sulla trascendenza(5); che si collega a una forte capacità di penetrazione nella vita personale e sociale della popolazione, attraverso il controllo di quella che Mann aveva a suo tempo indicato come la terza componente strutturale del potere “ideologico”: i rituali quotidiani e del ciclo di vita. Il sistema si fonda sul controllo di una tradizione orale e chiusa, che non si avvale della scrittura: e ciò contrasta con le esigenze di un apparato burocratico sviluppato, in quanto poco può servire alla forma-zione di amministratori qualificati.
Nel quadro così delineato si inserisce un elemento di rilievo: la pro-duzione di alcuni codici di regole e “leggi”, prima di costume e in forma orale, di seguito trascritte in alcuni testi (Manava-Dharmasastra), legit-timate e quindi rafforzate sacralmente. La stabilizzazione su base sacra e rituale di questo corpo autonomo di leggi, che Fukuyama riconosce come un esempio di “rule of law”, va a costituire un limite al potere dei sovrani, la cui legittimità rimanda al riconoscimento della supremazia della legge. Il re è il protettore della legge ed è, in caso di violazione, sanzionabile. Il risultato è la sua debolezza politica.
Spinte all’uscita dalla condizione tribale in vista della costituzione di uno stato burocratico attraversano anche il mondo islamico, dove lo svi-luppo politico, in seguito alle conquiste compiute in nome della religio-ne universalistica di Maometto, è minato da pressioni destabilizzanti che impediscono il consolidamento di un sistema di governo centralizzato e impersonale. Ciononostante, si hanno anche esempi di tentativi riusciti, in massimo grado con l’impero ottomano, una volta che il governo ha sa-puto perfezionare il sistema della schiavitù militare, la base istituzionale cardine per la realizzazione di tale modello in tutto il mondo islamico. In questo mondo, le reti tribali sono disarticolate con la formazione dei corpi di Mamelucchi al servizio dei califfi abbasidi e dei Giannizzeri del sultano ottomano: sradicati dai contesti locali, questi schiavi vanno a comporre le fila degli ufficiali e dell’esercito, senza che la loro discendenza possa ere-ditarne le cariche e gli uffici.
L’esperienza europea non si sviluppa nel solco dello stesso cammino di istituzionalizzazione, tentato ma non ovunque riuscito, illustrato dai ca-si storici fin qui affrontati. L’eccezione concerne il fatto che lo stato non emerge direttamente dal sistema di società tribali, bensì da una società, quella feudale, di per sé generata da una precedente rottura con quel siste-
(5) Cfr. John HAll, Powers and Liberties: the causes and the consequences of the rise of the West, Oxford, Basil Blackwell, 1985; Michael MAnn, op. cit., vol. I.
294 paolo franzosi
ma, pertanto sotto alcuni aspetti già “moderna” prima della costituzione degli stati. Le fondamenta della modernizzazione europea sono “sociali” e “culturali”, ossia collegate al consolidamento e all’azione di un potere sociale: il cattolicesimo medievale. Fukuyama insiste sulla forza di questo condizionamento, nel prevenire efficacemente la decadenza che invece ha caratterizzato Cina, India e mondo arabo, dando luogo alla ri-patrimonia-lizzazione della società.
Per il nostro autore la modernizzazione “sociale”, che accoglie al ri-guardo le tesi di Jack Goody, ha radici antiche, ben più antiche di quelle messe in luce da Weber nella sua famosa teoria sull’impatto dell’etica pro-testante, risalenti precisamente al Sesto secolo; sicché la società medievale è una società fondamentalmente individualistica, o proto-individualistica, dal momento in cui, a partire da quei lontani secoli, l’individuo, e non la famiglia o il gruppo di parentela, acquista potere decisionale negli ambiti del matrimonio e della proprietà.
«Individualism in the family is the foundation of all other individualisms. Individualism did not wait for the emergence of a state declaring the legal rights of individuals and using the weight of its coercive power to enforce those rights. Rather, states were formed on top societies in which individuals already enjoyed substantial freedom from social obligations to kindreds. In Europe, social development preceded political development»(6).
E rimanda al rapporto di vassallaggio che innerva la struttura delle gerarchie feudali.
«The fact that these social institutions were feudal rather than kinship based made a huge difference to the subsequent political development of Europe. The feudal relationship of vassalage was a contract entered into voluntarily between a stronger and a weaker individual, and it entailed legal obligations on both sides. Although it formalized a highly unequal and hierarchical so-ciety, it nonetheless set precedents for both individualism (since the contracts were entered into by individuals and not by kin groups) and for the broade-ning of the understanding of legal personhood»(7).
Se le cause sono più remote dell’impatto della Riforma e della rivoluzione industriale, è l’esito della politica dei matrimoni portata
(6) Francis FukuyAMA, op. cit., p. 231 (corsivo nel testo). (7) Ivi, p. 240.
295IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
avanti dalla chiesa cattolica a metterle in luce, in contrasto con i fon-damenti della società segmentata e delle istituzioni della parentela del mondo classico che mirano alla chiusura e al controllo familiare del-la proprietà attraverso le generazioni. La chiesa medievale, impegnata nella conversione delle tribù germaniche, promuove all’opposto una spinta a una più spiccata esogamia, opponendosi ai matrimoni tra cu-gini e parenti stretti e al levirato, disincentivando le adozioni e vietan-do il divorzio. Questo disegno non pare guidato da ragioni di natura genuinamente dottrinaria, bensì dalla ricerca del vantaggio materiale che fa seguito all’indebolimento del legame tra proprietà e parentela, che si traduce in maggiori donazioni di terre alla chiesa; e col tempo neutralizzerà le resistenze all’emersione del capitalismo. L’incentivo delle donazioni esorta a far fronte all’organizzazione di ingenti stock di risorse, che solo una volta istituito il controllo di un apparato am-ministrativo può concretizzarsi in una fonte di potere efficace, persino strumentale all’intrapresa religiosa.
A tutto questo si affianca l’istituzione del celibato sacerdotale per ma-no di Gregorio VII, valida arma di contrasto alle derive particolaristiche degli organi dell’organizzazione ecclesiastica. Il disegno va a buon fine e il risultato è il consolidamento di un potere istituzionalizzato autonomo: un caso unico al mondo.
Rule of law. L’esperienza europea è paradigmatica per il particolare corso dell’istituzionalizzazione del secondo elemento dello sviluppo poli-tico, il cui esito è la costituzione del moderno rule of law, che si rafforza assieme allo stato e non contro lo stato.
«The Law is a body of abstract rules of justice that bind a community toge-ther. In premodern societies, the law was believed to be fixed by an authority higher than human legislator, either by divine authority, by immemorial cu-stom, or by nature»(8).
Si apre così lo spazio per la dialettica tra diritto e legislazione, sicché, se il rule of law è in vigore, la seconda deve attenersi al primo. L’istitu-zionalizzazione del rule of law implica in altre parole che le leggi dello stato debbano risultare conformi al corpo di leggi fondamentali, da cui ha origine il costituzionalismo moderno svincolato dalla legittimazione divina
(8) Ivi, pp. 245-46 (corsivo nel testo).
296 paolo franzosi
di tale impianto normativo fondamentale(9). Esso dà vita a forme di prote-zione, e dunque di potere in mano a persone che ne hanno titolo – una mi-noranza qualificata nei tempi antichi, la cittadinanza intera nelle poliarchie contemporanee – nei confronti del potere discrezionale del sovrano.
Il caso inglese ci mostra per primo e in modo molto chiaro il legame tra rule of law e stato, con l’istituzione del common law. In contrasto con la nota teoria di Hayek, per Fukuyama il rafforzamento delle istituzioni politiche è indispensabile per la genesi del common law, attraverso un in-tervento politico mirato alla costituzione di un sistema di leggi uniforme portato avanti con successo dal governo inglese: le corti di giustizia sparse sul territorio passano sotto il controllo regio, segnando il vero salto di qua-lità rispetto alla struttura a base tribale della società politica.
L’esito positivo di questa operazione, come di talune analoghe nel continente, poggia su dei prerequisiti facenti capo all’intrapresa della chie-sa, ossia al suo potere di condizionamento e di stimolo di attitudini all’ob-bedienza delle leggi su base “morale” (normativa) in capo a governanti e governati. Ancora una volta, il ruolo della religione, sebbene indiretto, è essenziale; e si accompagna alla garanzia di effettività derivante dai mezzi coercitivi che il sovrano offre in suo sostegno. La legittimità dello stesso monarca viene a dipendere dalla capacità di garantire l’applicazione cor-retta della legge contro i soprusi dei potentati locali dispersi. Il che indica l’intimo connubio tra un rule of law istituzionalizzato e delle robuste istitu-zioni politiche facenti capo a un governo centralizzato.
Se il caso dell’Inghilterra ha la sua peculiarità in uno stato forte, capa-ce di garantire la giustizia sul territorio, per comprendere la dinamica degli altri stati dell’Europa occidentale bisogna inquadrare ancor più da vicino il rapporto tra il cristianesimo e il potere secolare. Nel continente, come corrispettivo del common law britannico nel senso del rule of law abbiamo il diritto civile derivato dal codice giustinianeo, il cui garante è la chiesa.
Il significato religioso del rule of law lo incardina alla base del con-senso diffuso nella società. La concezione della sovranità della legge non deriva dalla dottrina teologica, ma è l’esito dell’azione della chiesa cat-tolica in veste di attore istituzionalizzato di potere religioso (e politico) autonomo dal potere secolare; e si articola, soprattutto a partire dal XII
(9) L’autore si sofferma a puntualizzare che il rule of law non è necessariamente e indissolu-bilmente legato allo sviluppo economico, che altre forme istituzionali possono garantire come ci illustra l’esempio della Cina moderna, o all’imporsi di particolari istituzioni economiche. (Semmai, nessi con un qualche fattore “esterno” sono da cogliere nel rapporto con la religione).
297IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
secolo, di seguito alla riscoperta dei codici classici del diritto romano e all’istituzione del diritto civile sostenuta dalla formazione di una categoria di professionisti della funzione legale, collegandosi alla diffusione delle università in tutta l’Europa. Il potere autonomo della chiesa abitua i go-vernanti all’idea di rinunciare a proporre se stessi come fonte ultima della legge, stante la dipendenza, in termini di legittimazione, dalle credenze religiose e dall’agenzia che le controlla(10).
Affinché il rule of law sia pienamente efficace nei confronti del gover-no, occorre che vada in porto la razionalizzazione del diritto, sì da istitu-zionalizzare un potere relativamente autonomo capace di camminare sulle proprie gambe. Da questo processo di istituzionalizzazione hanno origine il costituzionalismo e il sistema di separazione dei poteri, le cui fondamen-ta non sono altro che un sistema legale solido, facente capo a una rete di professionisti specializzati e a un codice di leggi articolato e coerente.
Prima della forma di legittimazione, secolare o religiosa, del codice che si impone, conta quindi l’istituzionalizzazione in sé; e parimenti il suo costi-tuirsi a veicolo (e base) di un consenso diffuso. Il tutto ha origini storiche lon-tane, nell’azione della chiesa cattolica. In questo modo, Fukuyama sottolinea la continuità piuttosto che la discontinuità del processo di sviluppo che vede l’istituzionalizzazione del secondo elemento costitutivo dell’ordine politico moderno, osservando che il consenso è espresso religiosamente dove la re-ligione è forte, ossia penetra la quotidianità degli individui; è secolare dove questa ha lasciato il campo a identità (e a dottrine di legittimazione) secolari. Indipendentemente della natura religiosa o secolare della legittimazione, ri-mane la convinzione della legge-diritto quale espressione della giustizia, che è il nucleo del rule of law e la fonte della sua efficacia.
Da tutto ciò consegue che queste antiche istituzioni, e la stessa chiesa cattolica come istituzione, precedono lo sviluppo delle istituzioni economiche e culturali caratteristiche dell’Europa moderna, costituendone i prerequisiti.
Political accountability. Il terzo fondamento della politica moderna è la “accountability” dei governi.
«Accountable government means that the rulers believe that they are responsi-ble to the people they govern and put the people’s interests above their own»(11).
(10) Sarà poi con le monarchie assolute di epoca moderna che il potere politico tenterà di invertire questa gerarchia di valori, con esiti ambivalenti.
(11) Ivi, pp. 321.
298 paolo franzosi
Va da sé il ravvisare punti di congiunzione con il rule of law, dal momento che quest’ultimo è una tra le fonti di accountability, o per lo meno sulla sua base è possibile avanzarne le pretese(12). Ciò indica che il principio può coesistere con forme istituzionali differenti, e da queste essere più o meno incisivamente veicolato: dall’educazione “morale” dei principi da parte di una classe di colti, al sistema parlamentare e al mec-canismo democratico, passando per l’appunto per le diverse esperienze di rule of law.
Il fenomeno di istituzionalizzazione dell’accountability in chiave moderna riguarda il periodo della genesi degli assolutismi europei e delle diverse risposte ad essi nei vari paesi che trovano la loro formula compiuta nelle assemblee rappresentative.
Il progressivo successo dell’idea di “uguaglianza” in Europa e nel mondo, di seguito all’impatto della Riforma e della rivoluzione scientifica sulle concezioni del mondo e sulla spinta della rivoluzione industriale, ha un riflesso sulla crescita di pretese da avanzare nei confronti dei governi e sulla promozione di istanze rappresentative o comunque di cambiamento politico. Tuttavia, precisa Fukuyama, siffatte idee, pur forti di un progressi-vo radicamento di seguito alle citate trasformazioni delle strutture più pro-fonde della società europea, hanno modo di divenire operative a patto di in-serirsi in un impianto istituzionale capace di farle funzionare nei termini di freno al potere effettivo dei governanti, producendo l’esito dell’equilibrio di potere tra le nuove forze sociali e i governi in forma istituzionalizzata. Viceversa, ove non si realizza questo equilibrio, abbiamo o l’assolutismo o il governo impotente.
Il fatto che le idee, per funzionare “politicamente” e incidere sui com-portamenti politici, debbano “tradursi” in istituzioni e, prima ancora, col-legarsi al potere, spiega come a fronte della diffusione delle stesse idee in tutta l’Europa moderna l’assolutismo si sia realizzato in forme diverse e non dappertutto(13).
Lo schema dell’emersione degli stati europei segue la logica tracciata da Tilly: dalla guerra viene la spinta principale alla formazione dello stato
(12) I nessi si colgono anche col primo fattore, dal momento che occorre la presenza ef-fettiva di un governo affinché si possa pensare di limitarne l’azione. Cfr. Carl J. FriedriCH, Governo costituzionale e democrazia, Vicenza, Neri Pozza, 1963.
(13) Conta l’influsso delle istituzioni precedentemente radicate nei vari paesi coinvolti dal processo, ereditate dal passato medievale che incide sulla situazione di potere entro la quale si trovano a concorrere i monarchi e gli altri attori impegnati nella lotta per il potere.
299IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
moderno. Oltre alla necessità di estrarre risorse con la tassazione e di mo-bilitare risorse umane, pertanto di organizzare un apparato burocratico-am-ministrativo funzionante, occorre piegare la resistenza dei gruppi di potere che hanno tutto da perdere dai risultati del cambiamento politico in atto. La forza relativa degli attori in campo sancisce lo sbocco istituzionale della “battaglia”, nei termini della costituzione o meno del regime assolutistico. Poi, l’interdipendenza e la necessità di confronto tra gli attori in campo (monarchie, alta nobiltà, gentry, terzo stato), quando non porta a una vit-toria schiacciante dell’uno sull’altro, dà luogo a nuove forme di “scambio politico” tra sostegno alle attività e all’autorità del sovrano e condiziona-mento della sua azione, che nel tempo si istituzionalizzano.
Quattro sono i casi europei approfonditi: l’assolutismo debole e patri-monialistico di Francia e Spagna, l’assolutismo pieno ma patrimonialistico russo, le oligarchie fallimentari di Polonia e Ungheria, i governi rappresen-tativi di Inghilterra e Danimarca(14). Per tutti il quadro di partenza è una so-cietà medievale sottoposta al tentativo accentratore delle risorse di potere da parte dei governanti; di fronte a essi si staglia una pluralità di poteri che hanno il fulcro istituzionale in diete, parlamenti e corti diffuse lungo tutto il regno. Ma solo i processi di istituzionalizzazione centralizzata di un potere in grado di contrastare il governo sfociano nel modello che sarà alla base dei sistemi politici contemporanei: il caso inglese sperimenta precisamente questa evoluzione, ove un parlamento forte e accentrato fa da contraltare al potere altrettanto solido del sovrano, portando al costituzionalismo(15).
La natura dell’accostamento e la centralità della politica
Paragonata alle opere di analogo respiro cui si è fatto cenno nelle righe introduttive, l’analisi di Fukuyama riserva ai fattori strettamente po-litici una preminenza decisamente accentuata, forte di un accostamento che accoglie la lezione di coloro che hanno adottato l’approccio del potere per
(14) Casi che aiutano a comprendere anche il patrimonialismo delle colonie dell’America latina e il governo rappresentativo degli Stati Uniti.
(15) Le cause del successo inglese risiedono in parte nella possibilità da parte dei parla-mentari di far leva sul common law, e anche nello sprone religioso all’organizzazione della resistenza parlamentare al “despota” cattolico. Mentre i casi scandinavo e olandese inducono l’autore a riconoscere che le tre componenti dell’ordine e dello sviluppo politico “funzio-nano”, se interconnessi istituzionalmente, indipendentemente dai singoli e diversi percorsi nazionali.
300 paolo franzosi
dare vita a una descrizione realistica della società e della storia politica, stimando la rilevanza e l’intreccio di poteri differenti. L’autonomia del po-tere spicca in un quadro di fondo multidimensionale, che ha l’ambizione di dare soluzione all’annosa questione che vede contrapposti materialismo e idealismo: un angolo visuale che opta per la pluralità delle risorse di potere, la quale rimanda alla pluralità dei fattori che incidono sulla configurazione delle azioni e delle istituzioni sociali, segna l’abbandono dei determinismi a senso unico. Così, riconosciuta la compresenza e l’interconnessione tra fattori diversi, l’autore sottolinea il ruolo della contingenza e puntualizza l’aspetto non intenzionale delle diverse intraprese storiche implicate nella genesi delle istituzioni e nel cambiamento storico-politico. Il che indirizza l’attenzione sugli esiti delle lotte per il potere, e quindi sulle risorse degli attori in campo.
Questa impostazione funziona anche evitando di considerare i diver-si fattori – i diversi poteri – sullo stesso piano, conferendo per l’appunto centralità al fattore politico. In quest’ottica, l’impianto e l’analisi stessa vanno oltre i modelli quadridimensionali, à la Mann, ove il potere po-litico è inteso come un particolare tipo di potere sociale. In The origins of political order il potere politico si pone in relazione con altri poteri sociali, ma non è in se stesso un potere sociale, stante alcune proprietà sui generis, che per Fukuyama risalgono (anche) alle caratteristiche della sua istituzionalizzazione.
In ciò si ravvisa uno spunto importante, che va nel senso del conferire autonomia alle variabili strettamente politiche nel delineare un vasto affre-sco di forme di organizzazione che sono, appunto, politiche. E l’apprezza-mento resta, anche se si sconta la mancanza di una definizione del “potere politico” capace di coglierne la struttura concettuale fondamentale, che so-la potrebbe fornire le categorie per guidare consapevolmente l’analisi dei nessi con gli altri poteri. Pesa probabilmente qui lo scetticismo dichiarato dell’autore verso le teorie generali e il metodo nomotetico-deduttivo appli-cato alle scienze sociali; anche se queste riserve di principio non impedi-scono di fatto l’utilizzo di strumenti del genere per dar corpo all’opera – come del resto dimostrano lo stesso impianto categoriale e l’impostazione latamente evoluzionistica, sebbene non lineare, che emerge dalla delinea-zione dei processi di sviluppo e di decadenza dei sistemi politici. Ciò detto, possiamo passare alla valutazione degli elementi di interpretazione che si attingono qua e là nella ricostruzione dei casi storici e nei paragrafi in cui si tirano le somme dei risultati raggiunti.
Sia la mancanza di una determinazione chiara del concetto di “potere” sia l’enfasi sull’istituzionalizzazione portano l’autore a concentrare l’ana-
301IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
lisi dello sviluppo politico sui processi di consolidamento di assetti orga-nizzativi e procedurali, con un debito evidente con la prospettiva avanzata a suo tempo da Huntington. In quest’ottica, la classificazione dei poteri sociali serve a delineare il quadro delle condizioni che ostacolano oppure favoriscono quei processi, e ne determinano l’esito; come abbiamo ampia-mente avuto modo di constatare nel nostro sunto, la situazione di potere nel suo complesso è lo sfondo che segna il corso dell’istituzionalizzazione. Ma l’individuazione delle fonti del potere sociale che incidono sulla politica non dà luogo a una tematizzazione rigorosa dei nessi causali; piuttosto, viene sviluppata ecletticamente, nella discussione dei vari casi storici, sulla base dell’argomento testé accennato contrario ad analisi troppo ambiziose. Ma non è sempre così. Di fatto, alcuni di questi rapporti sono chiaramente determinati, soprattutto per quel che concerne due questioni: (1) le con-dizioni di fondo che incidono sullo sviluppo politico; (2) il rapporto tra potere politico e potere religioso(16).
(16) Fukuyama sottolinea l’autonomia del potere “simbolico”: il potere simbolico non de-riva la sua efficacia dal controllo di risorse economiche o di violenza, ma dalla diffusione di determinate dottrine, per l’epoca in esame soprattutto di natura religiosa, la fonte della cui efficacia risale a bisogni specifici di identità e di riconoscimento sociale da parte degli individui, sulla cui base organizzare l’azione collettiva. Ciò spiega fenomeni storici diversi come la spinta alla conquista araba, lo spirito egualitario alla base delle rivendicazioni de-mocratiche, la mobilitazione di forze sociali emergenti da parte del cristianesimo romano, e altri fenomeni non riconducibili all’interesse economico o al bisogno di sicurezza. L’origine della religione si perde nel buio dei tempi. A un’innata propensione a costruire dei modelli mentali capaci di fornire le coordinate per orientarsi nel mondo, rendendolo conoscibile e manipolabile, si collega la concezione del sovrannaturale. Questi modelli vengono interio-rizzati in credenze che si stabilizzano su base emozionale, integrandosi con norme e regole di condotta che nelle dottrine più articolate costituiscono dei veri e propri codici prescrittivi. Ciò fa capire l’importanza della religione come molla della cooperazione sociale e dell’azio-ne collettiva. In più passaggi della nostra ricostruzione è emersa l’importanza della religione, in riferimento esplicito all’opera di attori che controllano le risorse religiose; così come è stato dato rilievo al tipo di organizzazione istituzionale delle stesse risorse simboliche (chie-sa cattolica e Bramini). La trattazione che il nostro autore riserva al tema non è imputabile di “emanazionismo”, nel senso che non fa derivare la forza di queste risorse dal mero impatto di una determinata costellazione di credenze come “idee”, ma la connette al problema del loro funzionamento come risorse di potere e della relativa gestione (anche se ci si imbatte talvolta in espressioni fuorvianti del tipo “idee come cause”). In riferimento a questi temi, probabilmente sarebbe stata d’ausilio la delineazione di un concetto specifico di “potere simbolico”, tale da poter con precisione fissare i termini dei rapporti di potere tra i portatori di questo tipo di risorsa e il potere politico. Ma certamente l’attenzione per questa base del potere sociale è cospicua nel libro di Fukuyama, soprattutto se la si confronta con lo scarso interesse dimostrato dall’autore per un’altra importante risorsa di potere sociale, quella eco-nomica, nei suoi rapporti con la politica.
302 paolo franzosi
Nell’ultima sezione, approfondirò, seppur nei limiti ragionevoli di questa breve discussione, il primo importante punto, dopo aver avanzato alcune considerazioni più direttamente rivolte alla teoria dello sviluppo po-litico del nostro autore.
La teoria dello sviluppo politico
La logica dello sviluppo politico di Fukuyama presenta profili analo-ghi alla teoria darwiniana(17), fatta salva l’attribuzione alla capacità dell’uo-mo di pianificare deliberatamente la variazione tra le istituzioni e di adot-tarle per imitazione e trasmetterle culturalmente(18); punto, quest’ultimo, che comporta la ricerca di strumenti efficaci per la stabilizzazione dei mo-delli di comportamento al fine di scongiurarne il dissolvimento nell’arco di poche generazioni, e dunque di escogitare taluni meccanismi di rinforzo (investimento di valore, norme, rituali) delle istituzioni. In virtù di tale lo-gica, tra tutti i diversi modelli di organizzazione politica vengono “selezio-nati” quelli che riescono a generare fonti più copiose in termini di potere: le formule più istituzionalizzate e funzionali, quale che ne sia l’origine storica. Se ciò è vero, si deve guardare alla lotta per il potere e ai relativi esiti per la comprensione dei fattori di pressione selettiva che determinano l’imporsi di alcune forme di organizzazione a discapito di altre.
Dalla delucidazione di questi processi, assai lenti, prende forma un quadro intelligibile di riferimento per i casi storici, che addita i luoghi ove il potere istituzionale-politico ha avuto modo di realizzarsi compiutamen-te: un percorso di sviluppo contraddistinto dal passaggio dalla tribù allo stato patrimoniale e allo stato burocratico (processo di istituzionalizzazio-ne), al quale però fa da contrasto la spinta al ritorno a forme patrimoniali e primordiali (processo di de-istituzionalizzazione). L’immagine conclu-siva è pertanto quella della parabola rovesciata, che evoca Eisenstadt(19). Di conseguenza in tale disegno, una volta affermatasi compiutamente la forma organizzativa dello stato, il cambiamento politico successivo as-
(17) Cfr. Walter G. runCiMAn, A treatise on social theory, Cambridge, Cambridge Univer-sity Press, 1983-1989, 2 voll.
(18) Cfr. Talcott PArsons, Sistemi di società, Bologna, Il Mulino, 1971-1973, 2 voll.(19) Shmuel N. eisensTAdT, The political system of empires, New Brunswick, Transaction
Publishers, 2010. Eisenstadt aveva colto lucidamente il processo di “liberazione” delle ri-sorse sociali dalle maglie dei gruppi parentali, in relazione alla formazione del sostegno alla costituzione degli imperi burocratici.
303IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
sume le sembianze del declino e del decadimento dell’“ordine”, sotto le pressioni per la riaffermazione dei criteri particolaristici. Solo in alcuni casi più vicini a noi (Europa moderna) il destino dei sistemi politici va in una direzione diversa.
Nel complesso, questo modello che si impernia sulla teoria dell’isti-tuzionalizzazione politica permette a Fukuyama un’analisi efficace: sotto-linea la centralità di fattori strettamente politici, catturandone dei tratti di prima importanza per la determinazione dei comportamenti umani, così da confermare la peculiarità della logica propria del cambiamento politi-co, non sempre correlabile – e conciliabile – con quella del cambiamento economico e sociale. Ciononostante, è difficile accettare l’appiattimento della politica sul fenomeno dell’istituzionalizzazione; e tanto meno pensa-re che quest’ultima esaurisca il potere nelle sue più diverse forme, specie in riferimento a realtà molto fluide, come quelle di epoca premoderna. Si comprende così la necessità di Fukuyama di far riferimento anche a rapporti di potere che non sono riconducibili all’istituzionalizzazione, se non in chiave indiretta e mediata, che però non sempre sono fissati in termini precisi, proprio a causa della mancanza di uno schema teorico di riferimento (la teoria delle istituzioni politiche). Si sconta, lo ripetia-mo, l’assenza di una teoria del potere più inclusiva, capace di far leva su un concetto di “potere” sulla cui base inquadrare i nessi cruciali per la comprensione dei casi storici, distinguendo le forme istituzionalizzate da quelle non o in minor grado istituzionalizzate, e il funzionamento stesso delle diverse istituzioni. Per esempio, un conto è individuare le forme di equilibrio di potere e le relazioni di “scambio” stabilizzate tra potere politico e potere simbolico che non trovano sbocco in veri e propri ambiti adibiti al “confronto” (India, Europa medievale); altro conto è delucidare i rapporti di potere che trovano sede in vere e proprie istituzioni politiche (parlamentarismo inglese). In altre parole, manca un approfondimento dei meccanismi stessi dell’istituzionalizzazione politica. Beninteso, vari spunti emergono dall’accurata analisi dei casi, ma in assenza di un raccor-do a uno schema di riferimento unitario.
Uno schema del genere consentirebbe di illuminare ancora meglio alcuni altri aspetti interessanti toccati dall’autore, come quello dell’incre-mento, parallelamente al rafforzamento del potere dello stato, dei poteri sociali che in epoca moderna vanno a controbilanciarne la forza, o per lo meno a condizionarne in chiave sia positiva sia negativa l’azione. Il che consentirebbe anche di valorizzare, attraverso l’approfondimento analitico del funzionamento delle sedi istituzionali in cui si dispiegano tali rapporti, il pregio principale dell’opera: quello di aver sottolineato la necessità, a
304 paolo franzosi
dispetto di orientamenti condivisi dai più, di un forte potere di governo af-finché si consolidino al suo cospetto altrettanto forti istituzioni di controllo e di rappresentanza(20).
I limiti strutturali allo sviluppo politico
Nell’ultimo capitolo del libro troviamo un ampliamento d’orizzonte che sembrerebbe stridere con la posizione teorica fin qui illustrata. Qui la riflessione fa affiorare il quadro generale delle condizioni entro cui si dà lo sviluppo politico: uno sfondo che conferisce fisionomia unitaria all’età pre-moderna. In conseguenza di ciò, la tesi della pluralità delle fonti di determinazione dei comportamenti – quelle che empiricamente emergono come maggiormente incisive in un’epoca e una regione del mondo – si trova a dover fare i conti con un condizionamento che giunge da qualcosa di più profondo. Il che riporta la discussione sul tentativo di sganciamento dall’annosa controversia tra materialismo e idealismo(21).
Senza dilungarci più del dovuto, il punto è che nel trarre le fila del suo discorso Fukuyama è spinto a far riferimento alla logica della struttura di base delle società precedenti la seconda rivoluzione industriale e la politica di massa; epoca che egli chiama “maltusiana”: abbiamo pertanto dei fattori
(20) Il caso inglese è illustrativo dell’opera di rinforzo dello stesso potere di governo eser-citata da solide istituzioni di controllo e di rappresentanza. Il caso indiano evidenzia invece l’indebolimento dello stato. A suo tempo, Friedrich ha individuato nell’istituzione di limiti effettivi all’azione dei governi e nella relativa regolarizzazione i requisiti del “governo co-stituzionale”. Se confrontato con l’impostazione di Fukuyama, il contributo di questo autore può servire da stimolo per l’inquadramento del problema dell’istituzionalizzazione politica. Abbiamo in mente soprattutto la posizione originale di Fukuyama sul caso cinese. Cfr. Carl J. FriedriCH, op. cit.
(21) A margine, è ravvisabile anche una fonte di problematicità tipica della spiegazione funzionalistica – l’accento esclusivo sulle necessità funzionali quali matrici di cambiamen-to – che collega il venir meno del principio ascrittivo alla modernizzazione dell’Europa occidentale. Una ipotetica condizione favorevole o una necessità funzionale, tende a esse-re scambiata per un fattore di causazione e per una matrice di mutamento, senza ulteriori esplicazioni, quasi che il cambiamento sia un’emanazione del principio. E ci si potrebbe anche spingere oltre. Nulla vieterebbe infatti di sostenere una posizione diversa, asserendo per esempio che il feudalesimo occidentale dimostra che un legame stretto tra parentela e diritti di proprietà è una condizione per la nascita dell’impresa capitalistica su base familiare, dunque un fattore di modernizzazione. Talcott PArsons, Some Reflections on the Institutional Framework of Economic Development, in AA.VV., The Challenge of Development, Jerusa-lem, Hebrew University, 1958. Per una critica a questo approccio: Philip AbrAMs, Sociologia storica, Bologna, Il Mulino, 1985.
305IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
di fondo, radicati nelle condizioni materiali dello sviluppo economico e dell’innovazione, che condizionano il processo politico, incidendo diret-tamente sulle risorse e sui valori implicati nei rapporti di potere, e sulle motivazioni che guidano l’azione degli attori di potere. Per esempio, l’au-tore osserva che, a fronte dell’arretratezza dei mezzi e dell’assenza di in-novazione, l’economia di quest’epoca può svilupparsi solo “in estensione” (economia estensiva), così che la predazione e la conquista determinano fonti stabili di approvvigionamento e crescita economica. Di qui l’impor-tanza dell’organizzazione del potere coercitivo e politico per lo sfruttamen-to delle risorse economiche(22). Di più, in un’epoca di penuria, la risorsa economica ha incidenza non solo sul benessere delle persone ma il suo possesso diviene questione di vita e di morte. Il controllo di risorse così scarse e cruciali non può che riguardare un’élite ristretta, quella capace di organizzare risorse di violenza in modo efficace, impegnata nella conqui-sta; un’élite a sua volta rafforzata dalle risorse economiche che riesce ad estrarre con la sua azione. In tal modo si instaura un “circolo virtuoso”, dal punto di vista dell’attore di potere, di consolidamento del proprio dominio sulle masse impotenti.
Anche quando un potere si istituzionalizza nella forma statale, non cambia la natura elitistica della società, che deriva fondamentalmente dalla penuria e dalla qualità delle risorse sociali che le condizioni di fondo con-sentono di produrre; e la possibilità di mobilitazione politica è ridotta ai minimi termini, dato che le facoltà di organizzare risorse di potere rimane ristretta entro questi margini necessariamente angusti. Non stupisce perciò che le principali spinte al cambiamento politico risultino essere quelle di natura esterna come la guerra, come abbiamo rilevato, e quelle interne dei gruppi che si oppongono ai progetti di accentramento di potere statale(23); a parziale eccezione degli attori che controllano il potere religioso, impe-gnati nel conferimento o nel ritiro del sostegno al governo e al regime, con i riflessi che abbiamo incontrato sull’istituzionalizzazione del rule of law e di forme di controllo dei governanti, sviluppantisi dove il potere simbolico si stabilizza su base autonoma.
Vien da osservare che questa impostazione sembra dover molto alla teoria marxiana del materialismo storico, che fa perno sul concetto di “mo-
(22) Il riferimento qui naturalmente è l’opera di Spencer.(23) Mentre un’analisi della natura e dell’azione dei gruppi di potere che sostengono l’im-
presa dei conquistatori e dei sovrani in epoca antica la si trova, lo ricordiamo, in: Shmuel N. eisensTAdT, op. cit.
306 paolo franzosi
do di produzione”, perlomeno nella sua accezione più ampia(24). È noto che negli scritti di Marx questo concetto non si trova formulato in chiave uni-voca, e in qualche passaggio l’autore stesso è portato a contraddirsi, mani-festando da un lato la tendenza a definire il concetto (in senso ampio) quale base organizzativa delle società nel loro complesso o modo di riproduzione della vita sociale – dettante in linea di massima l’ampiezza dei raggruppa-menti umani e stabilente i ruoli sociali –, dall’altro (concezione ristretta) a ridurlo alla dimensione economica – struttura e rapporti economici. Il con-cetto di modo di produzione, nella misura in cui guarda in senso ampio al fondamento generale della società (prima accezione), per un verso denota e prescrive un punto di vista “realistico” (“sociologico”) per lo studio dei fenomeni storico-sociali e della condizione umana nella storia – focalizza l’attenzione sugli attori sociali così come essi effettivamente organizzano i loro rapporti e impiegano risorse, e soprattutto sulle condizioni che spin-gono loro ad adottare determinate soluzioni organizzative; per l’altro nella sostanza imputa un valore cruciale al condizionamento degli strumenti che gli uomini creano e impiegano per, diciamo così, agire e organizzarsi so-cialmente – produzione di beni, di armi, ma anche di idee e simboli intesi qua strumenti per l’azione –, dando vita a un dinamismo storico che ha per motore il sorgere di sempre nuovi bisogni “sociali” – di benessere, di sicurezza, di conoscenza, di identità – da soddisfare. In Fukuyama l’ado-zione di questa impostazione, a dispetto dell’evidenziata contraddizione, va a rinforzare la posizione “realista” già sancita dall’aderenza a Hobbes.
Ma, se così stanno le cose, l’autore si espone alla critica che a suo tempo Perry Anderson sferrò contro l’impostazione di Michael Mann, in riferimento a un’analoga presa di posizione sulla risoluzione del dilemma materialismo/idealismo attraverso una soluzione in grado di trascenderlo al livello più profondo, e non sul mero piano del riconoscimento e della valorizzazione della pluralità dei poteri(25). Il che ribadisce quanto il pro-blema delle impostazioni “tradizionali” del tipo di quelle che rimandano a tale storica controversia sia lungi dall’essere superato in senso definitivo.
In chiusura, una considerazione sul concetto di “ordine politico” che il nostro autore riprende da Huntington. Come è noto, il concetto di “ordi-ne” è stato ampiamente criticato in letteratura. Ciononostante, dall’opera di
(24) Cfr. Ernest gellner, L’aratro, la spada, il libro, Milano, Feltrinelli, 1994; Mario Al-berTini, Il corso della storia, in Tutti gli scritti, Bologna, Il Mulino, 2007.
(25) Perry Anderson, Al fuoco dell’impegno, Milano, Il Saggiatore, 1995, p. 105.
307IstItuzIonI e cambIamento polItIco nelle socIetà pre-IndustrIalI
Fukuyama sembra che questo concetto tenga, nell’illustrare il quadro poli-tico delle società antiche, dal momento che il valore della stabilità sembra innervarne la struttura ed è il fine immanente cui lo sviluppo delle istitu-zioni politiche tende – con importanti riflessi sulle dottrine di giustifica-zione del potere. Inoltre, abbiamo visto che la dinamica del cambiamento politico assomiglia a una parabola, la quale ha un apice nel punto massimo di realizzazione del processo di istituzionalizzazione di un sistema politico stabile, oltre il quale vi è solo la possibilità di declino.
Il dubbio sull’adeguatezza di tale impostazione affiora se, per conver-so, ci riferiamo a società in continuo mutamento come quelle moderne e contemporanee: società che si reggono sull’innovazione e che perseguono lo sviluppo economico evitando la trappola malthusiana, a cui si collega l’insorgenza di forze sociali emergenti suscettibili di mobilitazione politi-ca, e quindi sempre alla ricerca di nuovi equilibri di potere. La risposta a questi dubbi forse la si potrà trovare nel secondo volume del nostro autore, dedicato alla politica degli ultimi due secoli.































![Il libro a stampa, le istituzioni e la cultura editoriale in epoca Edo (1600-1868) [Printed books, institutions and publishing in the Edo period (1600-1868)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321e51464690856e108e8fd/il-libro-a-stampa-le-istituzioni-e-la-cultura-editoriale-in-epoca-edo-1600-1868.jpg)