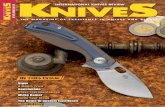Il dialogo tra le istituzioni della memoria e la città in: "Nuovi alfabeti della biblioteca....
Transcript of Il dialogo tra le istituzioni della memoria e la città in: "Nuovi alfabeti della biblioteca....
Il dialogo tra le istituzioni della memoria e lacittàMaurizio Vivarelli
Questo contributo ha per oggetto d’assieme ilposizionamento documentario di archivi,biblioteche, musei in relazione al contestosociale, culturale, documentario,contemporaneo.La rappresentazione documentaria della memoriaculturale è, naturalmente, un tema di grandecomplessità. Di questo era ben consapevoleItalo Calvino, quando, nelle Città invisibili(Torino, Einaudi,1972: immagine 1), scrive che:
«Il Gran Kan possiede un atlante in cui sonoraccolte le mappe di tutte le città: quelle cheelevano le loro mura su salde fondamenta, quelleche caddero in rovina e furono inghiottite dallasabbia, quelle che esisteranno un giorno e alcui ancora non s’aprono che le tane delle lepri[…]. Il catalogo delle forme è sterminato:finché ogni forma non avrà trovato la sua città,nuove città continueranno a nascere».
Maurizio Vivarelli. Università di Torino. Dipartimentodi Studi storici, Via S. Ottavio 20, 10124 Torino. Postaelettronica: maurizio [email protected].
Le rappresentazioni documentarie, e glistrumenti utilizzati per produrle e renderledisponibili per l’uso, sono evidentementesoggette alla stesse problematiche generali, inrelazione sia alla propria natura intrinseca,sia, soprattutto, in ordine alle relazioni checonnettono, o dovrebbero connettere, quellestesse rappresentazioni agli ambienti culturalida cui traggono origine.Nel quadro di queste generali ed amplissimetematiche, non vi è dubbio tuttavia chebiblioteche, archivi, musei, stianoattraversando un periodo di profonda crisi, pernumerosi motivi di diversa natura:
- economica e finanziaria;- politica, normativa, istituzionale;- organizzativa;- disciplinare, che investe cioè il livello
dei princìpi, delle metodologie, delleprocedure;
- comunicativa, connessa alle relazioni tramodelli documentari classici econfigurazione del web;
- sociale, che riguardano le modalità diutilizzo da parte delle persone delleinformazioni documentarie;
- formativa, che investe i percorsi dicostruzione delle ‘professionalità’ inambito bibliotecario, archivistico, museale.
Anche per questo, il 12 giugno 2011, è statoformalmente costituito il MAB. Musei ArchiviBiblioteche Italia (http://www.mab-italia.org/)che, all’art. 2 del proprio atto costitutivo,caratterizza anche come segue il proprio ambitodi attività:
“1. [MAB] si propone come strumento dirappresentanza delle istanze deiprofessionisti degli istituti culturali;2. promuove il coordinamento culturale,tecnico-scientifico e organizzativo delleattività degli operatori di archivi,biblioteche, musei
5. propone programmi e appronta strumenti perla crescita e il rafforzamento degli istituticulturali esistenti e la promozione di nuoveiniziative;8. effettua studi e ricerche;11. svolge ogni altra attività che si rendanecessaria per la realizzazione dei finiindividuati nel presente atto costitutivo”.1
Le linee e le ipotesi di collaborazione edintegrazione proposte dal MAB, anche in motivodella recente costituzione, non sono ancorachiaramente delineate e definite. Appare certo,fino a questo momento, un forte, deciso enecessario impegno a tutela e promozione dellecompetenze delle diverse tipologie diprofessionisti impegnati nelle varie struttureorganizzative, e dunque definibili, con tuttele oscillazioni del significato di questeparole, archivisti, bibliotecari, operatori dimuseo. A questi temi, in particolare, sonostati dedicati i recenti Stati generali deiprofessionisti del patrimonio culturale, organizzati il 22e 23 novembre del 2012 a Milano(http://www.mab-italia.org/index.php/stati-generali-cultura-2012/presentazione). Le dimensione storica e documentaria dellerelazioni tra archivi, biblioteche e musei, asua volta, si radica in momenti fondativi molto1 http://www.mab-italia.org/images/pdf/MAB-Naz_Atto-costitutivo_2012-06-12.pdf.
complessi della storia culturale europeadell’età moderna. A partire dal primoCinquecento, come è noto, nel contesto dellaripresa delle arti della memoria classiche,innestate negli elementi magico-simbolici checaratterizzano la ripresa del pensiero diRaimondo Lullo, cominciano a delinearsi leprime tracce di quelle che, molti secolo dopo,si sarebbero caratterizzate come le“discipline” connesse all’organizzazione egestione del patrimonio culturale. Nell’ampio,sfumato ed opaco contesto dell’historia literaria, econ le tensioni derivanti dalla ricerca dimodelli universali per l’organizzazione delsapere (dalla Bibliotheca Universalis di ConradGesner alla pansofia di Giovanni Amos Comenio,dalla ricerca delle lingue universali di JohnWilkins e George Dalgarno alla clavis universalis diGottfried Wilhelm Leibniz, il secondoCinquecento ed il Seicento sono percorsi da unpullulare di pratiche, tentativi, ricerche,della più diversa natura, che nella lorosostanza ultima vanno in cerca dell’atlantemitico di cui solo il Gran Kan segretamentedispone.In questo contesto, dunque, si situano tral’altro gli studi mnemotecnici di GiordanoBruno, che nel De umbris idearum (1582) modificaed innova i concetti di ‘luogo’ e di‘immagine’, che, non più statici, devono invece
esprimere le ‘relazioni’ che correlano letipologie di informazioni. Obiettivi analoghi,ad esempio, caratterizzano l’attivitàdell’umanista francese Christophe de Savigny,nel XVI secolo, che nella sua opera Tableauxaccomplis de tous les arts libéraux […], (1587: immagine2) elabora uno dei primi modelli enciclopediciin cui le relazioni tra le diverse partizionidel sapere sono rappresentate in modoreticolare, superando dunque sia il simbolismodell’albero sia i consueti modelli gerarchicisu base dicotomica e dendritica.2
2 Per una trattazione sistematica di questi temi cfr. Alfredo Serrai, Le classificazioni: idee e materiali per una teoria e per una storia, Firenze, Olschki, 1977.
Solo in una fase molto più tarda, come siaccennava, si delinea del tutto il profilodella attuali tradizioni disciplinari. Perquanto riguarda l’archivistica, in modoestremamente schematico e sintetico, gliestremi cronologici di questo percorso possonoessere tracciati tra 1794, quando la Convenzionefrancese, con la Legge del 25 giugno (7Messidoro II) afferma il principio della«pubblicità» degli archivi, riorganizzati ai
sensi della stessa legge3, e 1928, anno in cuiEugenio Casanova sistematizza il campodisciplinare di sua pertinenza nel trattatoArchivistica.4 La biblioteconomia, in sensocontemporaneo, inizia a precisare il suo ambitoin primo luogo tra 1808 e 1829, periodo in cuiil monaco benedettino Martin Schrettingerinizia ad usare il termine‘Bibliothekswissenschaft’ (Versuch einesvollständigen Lehrbuches der Bibliothekswissenschaft,1829), fino all’ Handbuch der Bibliothekswissenschaftdel 1834. Nasce in questo modo la «scienzadella biblioteca», locuzione tradotta con‘bibliothéconomie’ da Léopold Auguste ConstantinHesse nel 1839.5
La museologia, infine, si formalizzadisciplinarmente nella sua dimensione piùprecipuamente applicativa a partire dal 1948,in modo connesso alla costituzione dell’ ICOM.3 Cfr. Adolf Brenneke, Archivistica: contributo alla teoria ed allastoria archivistica europea testo redatto ed integrato da WolfgangLeesch sulla base degli appunti presi alle lezionitenute dall'autore ed agli scritti lasciati dalmedesimo; traduzione italiana di Renato Perrella,Milano, Giuffrè, 1968,http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Brenneke/12_Cap9_211_482.pdf .4 Pubblicato a Siena, Arti Graf. Lezzeri.5 Per una sintetica introduzione storica cfr. la voce‘Biblioteconomia’, redatta da Alberto Salarelli, in Guidaalla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini [et al.],Milano, Editrice Bibliografica, 2008, p. 22 e ss.
International Council of Museums(http://icom.museum/the-organisation/history/),fino alla più precisa delimitazione del campodi attività effettuata nel 1977dall’International Commitee for Museology(IFOCOM).6 Oltre la tradizione museograficasettecentesca (tratta nella Museographia diCaspar Friedrich Neickel, 1727), la museologiaacquisisce infine la fisionomia di una scienzaapplicata che si occupa del museo comeistituzione permanente che acquisisce, conservae comunica le testimonianze materiali edimmateriali dell’umanità per studio, educazionee diletto.7
In seguito al graduale definirsi dei «campi»disciplinari, per motivi connessi anche allepolitiche accademiche, i ricercatori/contadini(ampiamente trattati nel volume di Peter BurkeStoria sociale della conoscenza. Da Gutenberg a Diderot,Bologna, Il Mulino, 2002) si sono preoccupatidi difenderne con convinzione i «confini».L’interesse delle comunità disciplinariprogressivamente costituitesi, nelle complesse
6 Cfr. Key Concepts in Museology, Edited by André Desvalléesand François Mairesse, Paris, Armand Colin, 2010, p. 11e ss., http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf. 7 Per un’introduzione a questi temi si veda AdalgisaLugli, Museologia, Milano, Jaca Book, 1992, p. 11 e ss.
dinamiche successive, si è orientatoprevalentemente a discutere e motivare ledifferenze che a prendere in esame gli elementicomuni. Ciò in particolare si è verificato perle relazioni tra archivi e biblioteche,particolarmente contrastate entro un dibattitoche ha coinvolto, a partire dalla prima metàdel secolo scorso numerosi studiosi tra cuiGiorgio Cencetti, Guido Battelli, ArmandoPetrucci, Piero Innocenti.8
Per questa serie di motivi è importanteprendere in esame, in modo differenziato econsapevole, la natura delle convergenze edelle divergenze che investono le relazioni,oggi, tra le diverse tradizioni disciplinari eprofessionali; e dunque tra archivi ebiblioteche, tra biblioteche e musei, traarchivi e musei, e, ancora tra archivi ebiblioteche e musei.Si ritiene inoltre utile dare notizia dellalinea di progetto, in via di definizione,promossa dal comune di Montelupo Fiorentino, in8 Giorgio Cencetti, Sull'archivio come "universitas rerum",«Archivi», s. 2, 4, 1973, p. 7-13; Id., Inventariobibliografico e inventario archivistico, «L'Archiginnasio», 24,1939, p. 62; Giulio Battelli, Archivi, biblioteche e musei: compiticomuni e zone d'interferenza, «Archiva Ecclesiae», 5-6, 1962-1963, p. 62-78; Armando Petrucci, Sui rapporti tra archivi ebiblioteche, in «Bollettino d'informazione AIB», n.s. 4,1964, p. 213-219; Piero Innocenti, Biblioteche e archivi,«Biblioteche oggi», 12, 1994, 5, p. 52-57.
provincia di Firenze, il cui obiettivo è quellodi co-localizzare negli spazi attualmenteoccupati dal Museo della ceramica anche labiblioteca civica (denominata Centro culturaleNautilus) e parte della documentazione dipertinenza dell’archivio storico.9 Una occasione, questa, che è da ritenereimportante e significativa per riflettereoperativamente sulla qualità delle relazioniistituibili tra le diverse istituzioni dellamemoria che è utile ed opportuno valorizzare,sempre con l’obiettivo di promuovere ladimensione comunicativa delle diverse tipologiecontenuti informativi dei materialidocumentari.Secondo questa prospettiva, se non la mappamitica del Gran Kan, diviene forse piùprobabile riuscire a definire mappe reali,utili e produttive per mantenere viva edoperativa la ricerca di un senso d’assiemedelle diverse tipologie di contenuti deidiversi ambiti disciplinari.Archivi, biblioteche, musei, facendo sintesidelle linee di riflessione proposte con questointervento, possono essere dunque qualificati
9 Per ulteriori informazioni sulla attuale organizzazionedegli istituti documentari cfr.http://www.museomontelupo.it/mu/1/museoceramica/museoceramica.asp e http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda.asp?ID_SCHEDA=15.
come, richiamando esplicitamente i loci communesdi Gesner, luoghi comuni della memoria, in cuisi situino gli oggetti cui è affidata laconservazione e la comunicazione della memoriaculturale.10 Il catalogo delle forme della città, e dellesue infinite tracce documentarie, èindubbiamente sterminato, come abbiamomostrato, appoggiandosi al bellissimo libro diItalo Calvino richiamato in apertura. Archivi,biblioteche, musei tuttavia possono, ecertamente debbono, insegnare a costruirlo ed aleggerlo, ed in questo modo suggeriretraiettorie interpretative che possanomigliorare e rendere infine più felice la vitadei suoi interpreti e dei suoi lettori.
10 Sull’opera di Gesner si rimanda al recente volume diFiammetta Sabba La Bibliotheca universalis di Conrad Gesner:monumento della cultura europea, premessa di Alfredo Serrai,Roma, Bulzoni, 2012, oltre naturalmente ai numerosistudi intrapresi e guidati da Alfredo Serrai.