NUOVO ORDINE CARNEVALE. Conferenze, saggi, recensioni, esercizi di memoria
Alessandro Carnevale. AERUGINES. Relitti post-industriali, 2014
-
Upload
accademia-carrara -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Alessandro Carnevale. AERUGINES. Relitti post-industriali, 2014
All’alba della civilltà industriale, in controcanto ai progressi della tecnica e della vita ma-teriale, la rivoluzione psicologica alimentò il genio creativo dei “pittori dell’immagina-rio” – secondo la felice formula di Giuliano Briganti – che attraverso visioni, incubi, so-gni, fantasie, rievocazioni mitiche e letterarie diedero forma ai fermenti protoromantici e agli spettri dell’irrazionale (quello che un secolo più tardi verrà chiamato l’inconscio). Altrettanta forza visionaria può servire per raccontare, in parole o immagini, l’estremo opposto della parabola, il tramonto odierno dell’età industriale, la fine di un’epoca se-gnata in profondità, nell’economia e nella società, nella cultura e nell’ideologia, dalla produzione meccanizzata, dalle fabbriche, dagli operai, dalla lotta di classe, dalla ‘re-ligione’ del lavoro – un repertorio che ha potentemente alimentato l’immaginazione artistica, dai ‘moderni Ciclopi’ di Menzel al Quarto Stato di Pellizza, dalle mitologie tubo-cubiste di Léger agli operai ‘costruttori’ delle acciaierie di Piombino di Fernando Farulli. La storia degli ultimi vent’anni, in Italia e in altri paesi, è costellata di dismissio-ni (come quella dell’ILVA di Bagnoli narrata da Ermanno Rea), delocalizzazioni, chiu-sure di stabilimenti, smantellamenti. La dimensione umana, antropologica di questo cambiamento, dai risvolti spesso drammatici ed emergenziali – e in assenza ad oggi di alternative concrete o di prospettive di ripresa – è lo specchio più evidente della crisi, testimoniata quotidianamente dalle cronache. Ma non meno importante, anche se assai meno presente negli organi di informazione e nell’opinione pubblica, è l’aspetto che investe gli spazi, i luoghi della produzione in-dustriale. Tra Otto e Novecento le architetture della modernità plasmarono nuovi sce-nari (urbani e suburbani), nuovi paesaggi, nuovi simboli. Cantieri, fonderie, capannoni, ciminiere, raffinerie, gasometri, padiglioni, cisterne, gru, centrali, tralicci… strutture di possente impatto visivo ed ambientale.
Sono questi luoghi abbandonati, moderne rovine in ferro, acciaio, cemento, amianto ad aver calamitato l’attenzione e l’ispirazione del giovane artista ligure Alessandro Carne-vale, in particolare le vestigia a lui familiari nella sua terra d’origine, il Savonese.Carnevale, il cui talento versatile si cimenta anche in musica, letteratura, video, ha re-cepito in profondità il potenziale evocativo di questi scheletri giganteschi di un mondo dismesso, realizzando un ciclo potente e memorabile, da lui intitolato “Sullo scandalo metallico”. L’efficacia di queste vedute di archeologia postindustriale – definite “un atto di giustizia”, di risarcimento testimoniale nei confronti della defunta civiltà dell’acciaio, dallo scrittore Maurizio Maggiani – è data anzitutto dalla scelta del medium. Mai come in questo caso «il medium è il messaggio»: l’artista infatti non ha dipinto su supporti tra-dizionali, come la tela o la tavola, ma è andato alla ricerca di materiali consustanziali agli oggetti rappresentati: lastre di ferro reperite nelle discariche, residui di rottamazione (di altiforni, caldaie, etc.), corrose e ricoperte di ruggine, irregolari, scabre, frammentarie. Brandelli riesumati dagli scarti della metallurgia, fossili di un’era non geologica ma sto-rica e tecnologica, che recano su di sé, nella “carne viva” della propria matericità corrosa, l’essenza sedimentata e “sanguinolenta” della propria vicenda di uso e abbandono (lo “scandalo” dell’abbandono). Reperti combusti, ma ancora ardenti, affocati di rugginosi-tà incendiaria, sui quali Carnevale traccia – con acrilici, smalti, graffiture, mordenti acidi – ragnatele segniche, suture spinate, cicatrici di ferite non rimarginate, coaguli, chiazze, stesure liquide: scure, indelebili impronte, “marchiate” in negativo, di scenari grandio-si della decadenza postmoderna; vedute ora liricamente lontananti, ora frastagliate in primo piano; a volte indizi di cartografie, o “griglie” invalicabili (nel senso di Rosalind Krauss). Da un lato l’artista è ben cosciente della forza espressiva della materia e delle sue trasformazioni, anche violente (si pensi ai sacchi e alle plastiche bruciate di Burri; o all’uso dei metalli e alla sensibilità alle polarità energetiche dell’Arte Povera – Merz, Kounellis…), e delle pulsioni visive e sentimentali dell’Informale (i segni di Hartung, le astrazioni poli-materiche di Tàpies); dall’altro rivela una sintetica, visionaria forza figurativa, che rimonta fino alla Toledo allucinata del Greco, a Turner – come ha ben visto un commentatore dell’o-pera di Carnevale, Francesco Maria Fabrocile –, campione dei “pittori dell’immaginario” prima evocati, nelle accensioni cromatiche, nei tagli delle inquadrature (debitrici anche di Monet), nella percezione acuta della bellezza “sublime”della distruzione; e in generale
a quel filone che dal Romanticismo propriamente detto giunge al “romanticismo in-formale” novecentesco criticamente messo a fuoco da Francesco Arcangeli. Nello stile compendiario e stenografico, e nella dimensione rievocativa, la pittura di Carnevale può richiamare Klee o de Pisis (il ferrarese anche in certe corde tematiche ed emotive); nello spirito tragico Giacometti, Sironi (per la cupezza delle visioni architettoniche), Kiefer (per l’urgenza pittorica), Vespignani (pure richiamato da Fabrocile: si osservino le vedu-te spettrali dei gasometri di Roma); nei soggetti, i cicli di ‹ritratti di fabbriche› dei co-niugi Becher e di Gabriele Basilico, sguardi tuttavia fotograficamente freddi e impietosi, diversi dalla incandescente temperatura delle ruggini di Carnevale.La pluralità e la diversità dei referenti (che non vuol dire necessariamente fonti), sor-prendente in un artista così giovane, non mina tuttavia in senso citazionistico o deri-vativo questo ciclo così compiuto e coerente, che fonde mirabilmente energia materica, grandiosità visionaria, memorialismo dolente, e che si completa di titoli (Rifrazioni, Limpido addio, Smisurata preghiera, Eresia della sera, Verso Est, Questo bacio vada al mondo intero – omaggio al romanzo di Colum McCann, Il seme del pianto, Il respiro del mondo, Musei interiori, Escatologia industriale…) e aforismi suggestivi: “Cattedrali di ferro, tempeste di luce, incendi – di ghiaccio… Circolari scheletri dormienti: meravi-gliose geometrie d’un relitto incandescente”. “Che bell’inganno sei, mia disperata for-tezza. E che grande il tuo tempo, che solitudine. Dipingo un incendio d’intenzioni, un sottosquadra di malinconia. Guardo attraverso protezioni che tutto infrangono tranne la bellezza, incompiuta, d’uno sbaglio. Resiste un assedio di ruggine, polvere e rimpianti”. “La notte si rincorre fra le fessure, i cavi, i nodi di ferro. E piano accende una speranza stellata, intima, sommessa, che libra leggera fra questi mostri immobili, freddi, dolcissimi, sublimi”.
Gerardo de Simone
Rifrazioni / Le Stelle Freddeesposte a Venezia presso l’antibiennale “Canal Grande”,
collaterale alla Biennale dell’anno 2013
Eresia Della Serafinalista al premio Cascella 2013
Teoria, Memorieesposta a Roma alla Galleria Rosso Cinabro
e al museo dell’arte vetraria di Altare





















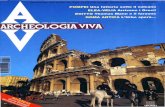










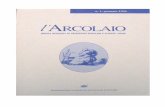
![Stefano Medas, Due relitti con carichi lapidei rinvenuti al Bacàn (Bocca di porto di Lido, Laguna di Venezia) [Two shipwrecks with a stone slabs freight from Lido inlet, Venice lagoon]_2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633282958d2c463a5800e861/stefano-medas-due-relitti-con-carichi-lapidei-rinvenuti-al-bacan-bocca-di-porto.jpg)





