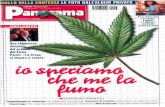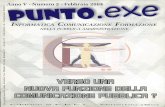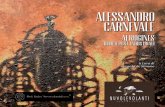Il carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno. Relazione di presentazione del volume di Mauro Gioielli...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno. Relazione di presentazione del volume di Mauro Gioielli...
Giovanni Mascia
IL CARNEVALE DEI MESI
A BAGNOLI DEL TRIGNO Relazione di presentazione del volume di Mauro Gioielli
(Bagnoli del Trigno, 23 febbraio 1995)
Ho accettato di buon grado l’invito di Franco Mastrodonato a presentare Il
Carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno. Per due buoni motivi:
Primo, il sicuro valore della pubblicazione edita dalla Compagnia di Cultura
Popolare La perla del Molise, a firma di Mauro Gioielli. Anche senza confrontarmi
con le bozze del libro, ero certo della bontà dello stesso. Mauro Gioielli, sotto questo
aspetto, rappresenta un’assicurazione di garanzia. Come ribadirò più
circostanziatamente.
Secondo, l’interesse che da qualche tempo suscita nel sottoscritto il patrimonio
popolare di Bagnoli del Trigno.
Nelle parole di Franco Mastrodonato, Presidente della Compagnia di Cultura
Popolare, di Angelo Camele, Sindaco di Bagnoli e di Andrea Vespa, Presidente della
Pro-Loco, ho sentito aleggiare il giusto sentimento di attaccamento e amore per il
paese natio. Facendo leva su questo sentimento, credo di fare cosa gradita ai
presenti, se lascio precedere l’analisi del libro di Mauro Gioielli, da alcune
considerazioni sul rapporto dei bagnolesi con la propria cultura popolare, secondo
quanto mi è stato dato di rilevare.
* * *
Cultura popolare a Bagnoli
Rupe pittoresca
La perla del Molise.
Mi si perdoni l’insistito riferimento personale. Esso non è motivato dal desiderio
insano di porre me stesso al centro del discorso, ma per comunicare a voi bagnolesi,
l’esito di un approccio che si può ritenere tipico, di un forestiero con la vostra terra, il
vostro paese.
Vigilia di Pasqua del 1989. Percorrevo con un amico di Monteroduni la Trignina per
la prima volta, provenienti da Monteroduni, per l’appunto, alla volta di Castiglione
Messer Marino. Il profilo inconfondibile e pittoresco di un paese abbarbicato ai
peschi1 mi colpì. A tal punto che fermai la macchina per ammirarlo con maggior
comodo. L’amico mi disse il nome del paese, Bagnoli del Trigno, e aggiunse l’epiteto
gratificante di Perla del Molise, che davvero non abbisognava di spiegazioni. Come
1 Lat. pesclum, macigno. Il toponimo pesco è largamente diffuso in Molise e nel meridione in genere. A Toro è registrata la voce dialettale peschionata, che vale colpo dato con una grossa pietra.
accade in questi casi. Registrai il nome del paese nell’agenda dei miei pensieri: da
visitare assolutamente.
Diaspora Proseguimmo per la nostra strada. Incrociando, sorpassando e venendo sorpassati da
una lunga teoria di taxi gialli, targati ROMA: il mio Cicerone mi disse del tutto
normale la cosa, accennando all’esodo bagnolese e salcitano verso Roma, le cui
colonie nella capitale si erano andate tradizionalmente aggregando attorno alle
carrozzelle, alle botticelle prima e ai taxi poi. A frotte i bagnolesi di Roma tornavano
alla loro terra, per la festività pasquale, per la scampagnata di pasquetta.
La nostra passeggiata era mirata a una visita a Felice del Vecchio. Non so se questo
nome dica qualcosa ai presenti. Spero di sì. Del Vecchio scrisse e pubblicò nel 1957
presso Einaudi quello che considero il più bel libro sul Molise: La chiesa di Canneto.
Per inciso, libro che meritò all’autore, allora poco più che ventenne il Premio
letterario più prestigioso, il Viareggio Opera Prima. L’ho voluto ricordare, perché‚ La
chiesa di Canneto è libro emblematico. Nella realtà di Roccavivara, può specchiarsi
la realtà di ogni comune molisano, a ridosso della seconda guerra mondiale. Specie i
comuni della valle del Trigno. Penso a Bagnoli, ovviamente. La chiesa di Canneto è
un po’ l’inno, il tributo di affetto a tutta la vallata del Trigno. Ogni molisano
dovrebbe leggerlo. Il trignino più di tutti. E, per questa primavera, opportuna arriverà
la riedizione del testo, divenuto leggendario2.
Bagnolesi e cultura
Bagnolesi e Masciotta
Come si può immaginare, purtroppo l’impegno a visitare Bagnoli è rimasto lettera
morta, nonostante la passeggiata di Pasqua a Castiglione sia da allora divenuta una
tradizione.
Nell’attesa ho pensato almeno a documentarmi su quel paese così pittoresco, e l’ho
fatto su due testi in particolare. Il Molise di Masciotta e I Canti popolari di Cirese.
Rilevando una discrepanza a carico dei bagnolesi. Che nei primi anni del secolo
assicurarono a Masciotta scarsa collaborazione, provocandone il rammarico formale,
dal momento che lo studioso dovette limitarsi a registrare solo il nome delle quattro
chiese di Bagnoli. Nessuna parola spesa dai bagnolesi del tempo, corrispondenti di
Masciotta per illustrare le particolarità dei loro monumenti sacri. E sì che c’erano
aspetti artistici d’indubbio valore. Basta accennare alla chiesa romanica di San
Silvestro con il prezioso portale romanico.
Bagnolesi e Cirese
Discorso completamente diverso per i bagnolesi in rapporto a Cirese. L’invito rivolto
dal poeta di Fossalto ai molisani a ridosso del secondo dopoguerra trovò a Bagnoli
feconda accoglienza. Certamente non a caso l’antologia dei canti raccolti a Bagnoli
costituisce la sezione più consistente del libro, quasi un libro nel libro. E allora c’è da
2 Riedizione in corso di stampa presso Edizioni Enne di Campobasso, anche a cura del sottoscritto.
chiedersi: ma cos’è questo paese, che quarant’anni prima, certamente in un caso
particolare, ha mostrato scarso attaccamento campanilistico e culturale e quarant’anni
dopo ha dato prova del tutto opposta? Va da sé‚ che la voglia di visitarlo ne sia stata
acuita. E finalmente ho avuto l’occasione. E ringrazio ancora una volta gli
organizzatori di questa serata che me ne hanno dato l’opportunità.
I nomi.
Anche per bilanciare Masciotta, che ha stigmatizzato un comportamento negativo, è
doveroso ringraziare qui coloro i quali a suo tempo, collaborando con Cirese, hanno
assicurato la documentazione a Bagnoli di un patrimonio folclorico di prim’ordine.
Certo, tempo ne è passato, alcuni di loro magari non ci saranno più Comunque ci
saranno figli, nipoti, parenti, conoscenti, ai quali sicuramente farà piacere sentirli
ricordare... E leggiamoli allora i loro nomi, nell’ordine in cui li ricordano Cirese
padre e Cirese figlio: Carolina Baiocco, Carolina Battaglia, Assunta Celano,
Giuseppina Ciarniello, ins. Silvio Ciarniello, Luigi De Vita, Francesco D’Onofrio,
Flora Minni, Pasquale Minni, ins. Matilde Pizzirani Pascasio, Carolina Sinistro, ins.
Chiarina Pascasio3. Nonché‚ Anselmo De Blasio e Modestina Lazazzera
4.
I canti: un libro nel libro
Canti bagnolesi dunque, presenti in tutte le sezioni dei due volumi di Cirese. Ripartiti
a piene mani: Ninne nanne, Canzoncine per l’infanzia e per i giochi, Preghiere5,
Scongiuri contro streghe e malocchio, Canzoni di amore e d’altro, Canti augurali per
Capodanno e Sant’Antonio Abate, Zembarelle e canzoni da ballo, Strofette e canti
carnevaleschi6, Satire politiche e amorose, Lamenti funebri (Repuote). Una vera
messe, come si vede.
Per ringraziare ancora una volta, e meglio, chi ce li ha tramandati voglio provare a
recitare, scusandomi della pronuncia, un canto il cui testo è da considerare tra i più
delicati e belli dell’intero patrimonio popolare molisano. E non è da credere questo
giudizio, dettato dalla circostanza, per ingraziarmi l’uditorio. Ho fatto riferimento a
questo canto già in qualche lavoretto edito7:
Bella figliola se te vuò fa’ bella
alzati a la prim’alba la matina,
pigliate la tinella e va’ pe d’acca
3 E. Cirese, I Canti popolari del Molise, vol. I, Rieti, 1953. 4 A.M. Cirese, I Canti popolari del Molise, vol. II, Rieti, 1957. 5 Eugenio Cirese, op. cit., tra l’altro ricorda la figura del “cieco di Bagnoli” seduto su un mucchio di pietre, con il boccale di vino a fianco, che dinnanzi a casa sua, a Fossalto, cantava i verbumcaro per
“rifriscare le anime del purgatorio”. E parla di uso in auge un tempo, quello di far recitare a
pezzenti tali preghiere nenie, mezze italiane, mezze latine, spesso indecifrabili. Del cieco di
Bagnoli, in particolare, è ricordata la voce lamentose e cantilenante, interrotta ogni due strofe dalla
pausa per attingere un sorso di vino dal boccale. 6 Tra cui “La canzone dei Mesi” e “La dichiarazione di Carnevale” (Sanghe de Serinella). 7 Per esempio, Giovanni MASCIA, Fontane del Molise. Calendario ERIM (Ente risorse idriche del Molise), Campobasso 1995.
ch’a la fonte ce sta lu nnammurate;
la fonte sta chiperte a matinelle,
la tina è d’ore e la patrona è bella.
L’acca de chésta fonte è luce luce,
chiù luce la tinella e chi•ia l’adduce;
chiscì te luce ru pette e la canna,
come luce ru sole pe la campagne;
chiscì te luce ru pette e ru vise,
come luce la stelle in paradise.
Per ricollegarmi all’accenno a Felice del Vecchio e alla sua Chiesa di Canneto, come
inno della valle del Trigno, voglio ricordare anche una modesta strofetta, raccolta a
Bagnoli, la quale con leggera variante può leggersi anche nella Chiesa di Canneto,
Sciocca sciocca
a la via de la Rocca
a la via de Castellucce
e ce mettéme re cappucce.
La variante di Roccavivara riportata da Del Vecchio ha invece di via, muntagne e
l’ultimo verso e ce magname pane e cappucce.
Bagnolesi nel mondo
Per chiudere il discorso sulla ricchezza del patrimonio folclorico di Bagnoli, è
doveroso accennare ai bagnolesi nel mondo, alla diaspora bagnolese, che non è
limitata ai botticellari, ai tassisti di Roma, ricordati prima. Si allude alla lodevole
iniziativa dei bagnolesi nel mondo di mettere su negli anni ‘70 un notiziario annuale
di notizie, folklore e cultura bagnolese.
I quali emigrati avevano già data materia per un paio di canti, che ovviamente non
potevano sfuggire alla sagacia dei ricercatori facenti capo a Cirese: canti per la verità
molto famosi, specie quello intitolato a Le muglie de ri merichiane, e perciò presenti
anche altrove8.
8 Ecco i due testi, Cirese vol. I,:
*
Mariteme dalla Merica nem me scrive,
nen r’haie fatte nemméne na mancanze;
na mancanza sola r’haie fatte,
n’avéva une e mo ne trova quattre.
E zitte marite mie ca nun è niente,
re manname a Napule pe farne re studiente.
*
Le muglie de re merichiani
viane a la chiesa che sette suttane,
ze nginocchiane devante Die:
- Manna quatrine chiurnute mie.
Re quattrine che mi è mannate
Il Carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno
L’autore
Ma per arrivare finalmente al libro in presentazione questo pomeriggio, è doveroso
spendere alcune parole sull’autore, su Mauro Gioielli, che senza dubbio è oggi il
maggior folclorista molisano.
Ricercatore attivo, Gioielli è costantemente impegnato, direi a tempo pieno, in studi
che riguardano feste e rituali, fiabe e leggende, canti e strumenti musicali del
patrimonio molisano e non.
Ha partecipato a convegni nazionali e all’estero; cura una rivista internazionale
monografica sulle cornamuse, che si va sempre più caratterizzando come palestra
editoriale per la conoscenza etnografica in genere.
Apprezzato folk-singer, ha tenuto concerti in Europa e oltreoceano; ha composto
canzoni e inciso dischi.
Esperto di narrativa popolare, ha rintracciato e catalogato pressoch‚ tutto il repertorio
dei racconti tradizionali molisani. Ha collaborato con Mondadori per la Collana di
fiabe regionali.
Direttore artistico di manifestazioni folcloriche, ha riscoperto e dato giusta valenza
antropologica a importanti rituali.
Tra le sue pubblicazioni:
La zampogna molisana (1981), Fiabe isernine (1984), La processione del Cristo
morto (1987), Fiabe molisane (1988), Bagpipes in Greece (1989), Popolare e
popolaresco: la canzone anonima e quella d’autore nel dialetto molisano (1992);
Contributo allo studio del carnevale molisano (1993), Fiabe, leggende e racconti
popolari del Sannio (1993).
Polemica simpatica
Ma perché questa presentazione di Gioielli non assuma i connotati di un panegirico,
eccessivamente laudativo, accennerò a una garbata polemica. Ben sapendo, così
facendo, di riconoscergli meriti anche nel campo creativo, non solo in quello della
ricerca etnografica.
Mi permisi di sollevare la polemica anni addietro a proposito delle citate Fiabe
molisane (1988)9. Gioielli aveva arricchito il volume con una sua personale teoria
circa la nascita della fiaba popolare. Teoria, a dire il vero molto suggestiva, che
intitolò alla scacchiera, articolando dei paralleli tra gli elementi e lo sviluppo creativo
della fiaba e gli elementi e lo sviluppo della partita a scacchi.
Pur dicendomi non eccessivamente convinto della sua creazione teorica, soprattutto
da scacchista praticante, riconobbi e riconosco oggi a Gioielli ogni merito. Basta
pensare alla compagnia di scrittori, scomodati per l’occasione per tenergli testa. Mi
limito a ricordare lo statunitense William Faulkner e il cinese Acheng, quest’ultimo
me r’haie frusciate che re nammurate,
tiretùppete e pane grattate,
cheste so’ le corne ch’aie truvate. 9 Giovanni MASCIA, Il principio magico in «Mondo-Molise», Set.-Ott. 1989.
tra i più letti e tradotti scrittori al mondo in questi ultimissimi anni. Se non il più letto
e tradotto in assoluto.
Il senso delle ricerche Per scendere finalmente al libro di Gioielli, a Il carnevale dei mesi a Bagnoli del
Trigno, bisogna dirsi d’accordo con il principio di fondo che ha animato anche questo
libro. Tra le righe della ricerca di Gioielli, così come dallo stesso annotato, “riappare
un tempo trascorso. Ma senza nostalgie: si vuol documentare la storia-dei-poveri, non
enfatizzarla o, peggio, rimpiangerla”.
Anche per Gioielli è valso il principio che dovrebbe valere per chiunque opera nel
campo: nessuna spinta nostalgica, ma solo l’impulso alla conoscenza del mondo del
nostro passato, un mondo che è stato detto della civiltà contadina, per non dirlo della
fame e della miseria. L’impulso alla conoscenza e il consapevole slancio a vivificare
l’anelito alla solidarietà (oggi tutti ne parlano), alla condivisione, tipico dei contadini,
che oggi rischia di scomparire per sempre con lo sparire del loro mondo.
Il carnevale in genere
Le ambasce legate alla civiltà della fame e della miseria, una volta all’anno, erano
messe da parte. Il grigio di un’esistenza monotona e stentata è mandato all’aria
almeno per un giorno nell’arco dell’anno. Come scriveva Jovine in un articolo
rimasto famoso, citato più volte anche da Gioielli, Rappresentazioni all’aperto: “Le
mascherate [e quindi il carnevale] ritorna come ritornano le stagioni, come ritornano i
lavori dei campi, le feste, i riti per i morti e per i vivi”.
Non è il caso di dilungarsi qui sulla valenza del Carnevale in genere, di questo
periodo dell’anno, in cui come dicevano i latini, licet insanire, è lecito impazzire.
Semel in anno, però, una volta all’anno. Periodo della trasgressione, in cui il mondo
viene messo sottosopra, a capecule, come dico io, o alla rovescia, come dice
Cocchiara già nel titolo di un libro famoso. Trasgressione su cui non è riuscito ad
avere la meglio neppure il formalismo perbenista di una chiesa bimillenaria.
Trasgressione che si formalizza coralmente nella rappresentazione mascherata.
Riguardo al cui tessuto poetico e drammatico, sempre Jovine ebbe a parlare di
“iterazioni ingenue, assonanze, elementare espressione di rozzi sentimenti. Siamo
all’alba del teatro; qui si ripete il miracolo della nascita della rappresentazione per
generazione quasi spontanea. È fatto antichissimo, primordiale [...] che si rifà nuovo
per la freschezza con cui il miracolo si ripete”.
Varrebbe la pena di rileggerla tutta, quella bella pagina di Francesco Jovine. Facendo
i conti con il tempo a disposizione, dobbiamo almeno ricordare la chiusa. “Non so -
scrive lo scrittore molisano - se il lontano ricordo e le posteriori esperienze di cultura
mi portino a caricare di troppi significati queste prime feste della mia infanzia”. Di
certo sarebbe imperdonabile, lasciar perire “l’immagine viva che [gli] è rimasta nella
mente dei canti, dei balli, del tenero sole di febbraio, del sentore delle prime viole e il
gran ridere degli spettatori, i loro frizzi salaci, e il pungente senso dell’umano che era
in tutto lo spettacolo”.
Il libro di Gioielli, in particolare
Introduzione
Consci di ciò, La compagnia di Cultura Popolare “La perla del Molise” di Bagnoli, il
suo presidente, quanti a Bagnoli sentono urgere il bisogno di non lasciare disseccare
le radici, hanno rinverdito da qualche anno l’antico rituale dei Mesi. E hanno affidato
a uno specialista il compito di documentarne la valenza antropologica e culturale.
Proponendo il tutto, rappresentazione del rito carnevalesco e libro, in prima battuta a
un attore, uno spettatore, un lettore ideale che è il bagnolese tipo: sia esso contadino o
studente, casalinga o professionista o pensionato... Ma proponendo altresì
rappresentazione e libro anche all’attenzione della popolazione molisana tutta, e di
quanti avranno la fortuna di imbattersi in essi.
E il libro puntualmente si offre al lettore in uno stile immediato, essenziale e
divulgativo (anche se documentato e “scientifico”).
L’Introduzione di Mauro Gioielli si sofferma sull’afflato poetico, insito nello scorrere
dei mesi, nel giro delle stagioni, che imbeve le culture delle varie epoche, dalle
primitive, alle greco-romane, alle medievali, etc. e, soprattutto, imbeve la cultura
contadina chiamata a confrontarsi momento per momento con lo scorrere del tempo e
con gli sconvolgimenti che il tempo cronologico e il tempo meteorologico portano
con sé.
Il tempo, scandito dal tornare perenne delle stagioni, il tempo che modella l’antica
sapienza della cultura contadina, il tempo non rettilineo, il tempo circolare, che si
ripiega su se stesso e sembra non portare da nessuna parte, per ribadire in eterno un
mondo sempre uguale. Oggi come ieri. Domani come oggi. Un mondo immutabile,
senza futuro, quindi, che aveva bandito il futuro dai propri orizzonti.
Significherà pure qualcosa la circostanza che rileva nei dialetti del nostro mondo
contadino l’assenza del tempo futuro. Io dirò, io farò, io partirò: non esiste un modo
siffatto di proporsi. C’è solo il presente per affrontare l’oggi, ma anche il domani. Il
presente, ed eventualmente, un avverbio di tempo: - Domani dico, il mese che entra
faccio, l’anno che viene parto.
Gioielli crede di fondare il rituale dei Mesi, così come riproposto da qualche anno a
Bagnoli e in altre comunità molisane, su antiche ballate medievali. Tanto per non
rimanere sul generico, ricorda i nomi di Bonvesin de la Riva, che ci ha lasciato un
Tractato dei Mesi, e di Folgore da San Gimignano, con la sua famosa Corona di
sonetti dedicati ai Mesi. Opere entrambe riconducibili al finire del ‘200 e al
principiare del 1300. E in effetti la larga popolarità dei sonetti di Folgore, in
particolare, autorizza l’ipotesi di una loro volgarizzazione. I consigli, che il poeta si
permette di dare a un’allegra, ricca, signorile e giovane brigata per godere nel
migliore dei modi delle opportunità offerte dai diversi mesi dell’anno, assursero a
grande risonanza. Prova indiretta ne è la non meno celebre parodia che di essi fece
Cene de la Chitarra di Arezzo. Come Folgore si industriava a sottolineare e
raccomandare i piaceri e i frutti legati ai diversi mesi, così Cene rimarca i crucci, le
pene, i fastidi, che gli stessi mesi apportano a una malconcia e scalcagnata brigata di
poveracci. C’è da sorprendersi anzi, per completezza di discorso, che, stante la
predisposizione del Carnevale a mettere a testa in giù il mondo di tutti i giorni, i
sonetti parodistici di Cene de la Chitarra non abbiano inciso con maggior forza sul
tessuto poetico delle strofe popolari dei Mesi, a Bagnoli, come in Molise, come
altrove.
I Mesi di Bagnoli
Liquidata la doverosa introduzione, Mauro Gioielli passa a illustrare il rituale dei
Mesi a Bagnoli, precisando come esso si sia ricompattato nel 1992 non più attorno
alla sfilata dei Mesi impersonificati dagli abitanti del luogo, ma attorno alla sfilata dei
carri allegorici, in linea con quelli che oggi sono i Carnevali che vanno per la
maggiore in Italia. Ma in linea anche con qualche antica tradizione carnascialesca
locale (Isernia, per esempio).
I carri assumono così il ruolo di palcoscenici mobili che, al comando ognuno del
rispettivo capo-carro, esibiscono i segni, i simboli, le cerimonie atte a rappresentare i
dodici Mesi. Su di essi, anno per anno, viene allestito un vero e proprio museo della
civiltà contadina, un museo che non dormicchia in penombra in attesa dello sparuto
visitatore, ma che nel chiasso e nell’allegria si fa simpaticamente incontro ai
visitatori. Proponendo loro, in primis, sul tettuccio del trattore, il tabellone con la
quartina relativa al mese illustrato.
Gioielli opportunamente riporta il testo della Canzone dei Mesi, secondo tre versioni,
rimandando il lettore anche a una quarta, raccolta e pubblicata da Cirese a suo tempo,
nell’opera più volte citata.
La prima versione proposta da Gioielli, sulla falsariga del testo ciresiano, si deve
all’ins. Silvio Ciarniello. La seconda è quella trascritta sui tabelloni dei carri. La
terza, infine, è quella raccolta dalla Compagnia di Cultura Popolare “La perla del
Molise”, della quale è presentata anche la musica raccolta a Bagnoli da Gioielli stesso
e trascritta da Pietro Ricci.
Un’analisi sommaria delle varianti proposte porta Gioielli a parlare di evoluzione.
Significativamente l’attacco delle varie strofe, che in Cirese e in Ciarniello (le
versioni più antiche) è Ie singhe (Io sono), si trasforma nelle altre due varianti in
Ecch (Ecco), che sembra meglio indicato a presentare non più il mese-persona, ma il
mese-carro. Con l’eccezione, però, costituita dalla strofa di Maggio, che continua
anche nelle versioni più recenti a valersi della formula introduttiva Ie singhe. E
stando così le cose, davvero non si vede perché non si è lasciato in essere la vecchia
formulazione, con la quale, tra l’altro, si sarebbe evitata la curiosa e brutta
circonlocuzione per introdurre il discorso diretto di Febbraio, “che mi disse” etc.
Ma quello che è più, le versioni semiculte di Cirese e Ciarniello, giocate su una
falsariga costituita da una quartina di endecasillabi, a rima o consonanza o assonanza
alternate, risultano essere, nelle altre due versioni, alquanto annacquate, per dire così.
È evidente lo scadimento formale della Canzone.
Un solo esempio. Agosto, che richiama alla mente le perniciosissime febbri
malariche. Agosto in Cirese e Ciarniello, valorizzando le consonanze alternate e
semiconsonanti tra loro di accuste/cumpuoste - pulluastre/vostre, si presenta così:
Ie singhe auste che lu male accuste
e lu mideche mi ordina lu pulluastre
me lu ordina richina e ben cumpuoste
bon giorno a signuria a le facce vostre.
Nelle versioni ultime (La perla del Molise) la strofa diventa:
Ecch Agusct e ch la malatia
l midc ordena la gallina
la ordena ben fatta e ben chemposta
bongiorn a signeria, a la faccia vostra.
Anch’essa a dire il vero introduce un’assonanza, gallina/malatia, che però non lega
con gli altri due versi. E, poi, adagiandosi su un doppio distico baciato, riesce
sicuramente meno elegante.
In conclusione, e facendola breve, più che di evoluzione sarebbe meglio parlare di
involuzione. C’è, quindi, da essere ancora più grati a Ciarniello e a Cirese.
Francische, il Pulcinella bagnolese
Molto interessante è il capitolo intitolato e dedicato a Francische ru giulliere.
Di questa emblematica figura carnevalesca sembravano sussistere a Bagnoli, con
qualche sentito dire, solo vaghi ricordi. Per fortuna, il ricercatore Gioielli ha potuto
contare su una precisa base di partenza, che si è rivelata gravida di sviluppi. Manco a
dirlo, la base di partenza era ed è data da Cirese, con il canto di Francische,
conosciuto con il titolo ripreso dal verso iniziale Sanghe de serinella e corredato da
annotazioni riferite al canto e ai personaggi dal canto evocati. E quant’anche fosse
per questo unico caso particolare, sarebbe ancora una volta da benedire l’opera di
Cirese e dei suoi attivi collaboratori bagnolesi. E da benedire con essa ogni altra
opera di seria raccolta di documenti della cultura popolare.
L’analisi delle indicazioni sparse nel canto, il far leva su di esse per stimolare e
risvegliare ricordi negli anziani del paese, hanno compiuto il miracolo. Una figura
evanescente si è andata a poco a poco concretizzando in movenze, abbigliamento,
accessori. Quello che era diventato un puro nome, Francische ru giulliere, è finito
per incarnarsi nel “Re del Carnevale”, in colui che in groppa a un somaro apre la
sfilata dei carri del Mesi a Bagnoli del Trigno. Re del Carnevale, ma anche
incarnazione del Carnevale stesso, secondo il costume popolare d’incarnare in uomini
(e donne) concetti e miti (i Mesi a loro volta hanno offerto e offrono lo spunto per
l’incarnazione in mesi-persona).
Di Francische ru giulliere è stato riscoperto il vestito bianco, il cappello anch’esso
bianco, un cono alto circa mezzo metro, il bastone con la patata alla sommità, a mo’
di pomello, e tanti altri accessori particolari. Sul conto dei quali s’intrattiene Gioielli
per offrire al lettore i riferimenti più dettagliati, sia sotto il profilo storico, sia sotto il
profilo etnografico, sia, infine, sotto il profilo dell’esatta interpretazione della
simbologia popolare.
Francische ru giulliere è stato ricondotto da Gioielli, sulla scorta di una valutazione
accurata delle componenti iconografiche e comportamentali, nella tipologia del
Pulcinella: buffone, annunciatore, uomo d’ordine ed emblema per eccellenza del
Carnevale in Molise. Il capitolo è arricchito dalla comparazione di alcuni tipici
Pulcinella molisani: tra i quali, degni di ben figurare accanto al bagnolese
Francische, il Pulcinella di Scapoli (che fissa il Carnevale quale momento di
esaltazione del mondo a capecule, arraffando spaghetti dal pitale: dal vaso, cioè, cui
di norma altro orifizio, non la bocca, affida, non prende, cibo), e Martino (anch’egli
uomo di bianco vestito, con il tradizionale, bianco cappello conico, che nella
rappresentazione carnevalesca del Cervo a Castelnuovo al Volturno allarga la
tipologia dei Pulcinella: non già buffone, con le implicazioni più o meno facete e
scurrili di uomo d’ordine e annunciatore, Martino, il Pulcinella di Castelnuovo, è
l’eroe, il mediatore tra gli uomini e il cervo, tra l’umanità e la natura). Gioielli
profitta dell’occasione e seppure in punta di penna polemizza con chi, senza fortuna
in verità, ha cercato di recente di contaminare l’abbigliamento candido di Martino
con l’ombra di un mantello. Motivata non da sterile formalismo, la presa di posizione
di Gioielli è giustificata dalla necessità di preservare a Martino i tratti tipici del
Pulcinella.
Per tornare a Bagnoli e chiudere il discorso su Francische ru giulliere, merita di
essere ricordata una scenetta che lo vede protagonista. Nei panni del seduttore,
Francische è ingravidato dalla villanella da lui concupita, che in realtà è un
giovanotto in gonnella. “So’ iute pe fotte e so’ remaste futtute!” commenta lo
sconsolato Francische, che muore nel dare alla luce una figlia: un fantoccio rivestito
di nero, che ha nome Quaresima.
Tradizioni gastronomiche e musicali a Bagnoli
Gastronomia indissolubilmente legata al carnevale, al punto di battezzare alcuni
giorni importanti di esso, il mercoledì e il giovedì grasso con i nomi di alcune
pietanze tipiche di quel giorno.
Abbiamo così il Mercoledì casciaruole, perché in questo giorno le foglie (verze
bollite con le parti povere del maiale del maiale - ossa, cotiche e zampe) sono
abbondantemente condite con cacio.
E abbiamo così, proprio oggi, il Giovedì scherpellure, da scherpelle, le chiacchiere,
giovedì• grasso che altrove in Molise è anche detto gevedì lardielle.
Gioielli ha raccolto e annotato le ricette di alcune tradizionali pietanze bagnolesi.
Ovviamente esse non sempre possono vantare pretese di tipicità. Variano i nomi da
paese a paese, ma la coltura contadina aveva messo su cibi e pietanze di uso almeno
regionale.
Regionali sono infatti, per esempio, i calzencille, pasta sfoglia ripiegata a mezzaluna
con impasto dolce a base di ceci, calzoni, che in molte località molisane, a Toro per
esempio, costituiscono il dolce tipico del convito di San Giuseppe.
E ovunque in Molise, ma sicuramente anche oltre i confini delle stoppie molisane, era
conosciuto il panunto o la panonta, com’è registrata da Gioielli: spicchi di pizza di
granone condita con sfritto di maiale.
Vale la pena di ricordare il panunto, perché‚ ad esso è legata una filastrocca
carnascialesca ricordata dalla signora Lazazzera
Carnevale musse unte
z’è magnate la panonta
la panonta n’è bastate
Carnevale ze n’è scappate
Una variante della quale era già stata registrata da Cirese
Carnevale musse unte
z’è magnate ru panunte
e la moglie pe despiette
z’ha vennute le sese ‘n piette.
La versione di Cirese è di certo più pregnante, perché tra le righe dipinge Carnevale
per il mangione impenitente che è, il quale tiene a stecchetto la povera moglie
Quaresima, lunga e secca, tanto secca da autorizzare i sospetto di aver venduto il
seno: z’ha vennute le sèse ‘n piette.
Tradizione musicali a Bagnoli
Gioielli presenta uno strumento tipico di Bagnoli: la coppa de ru fuoche, che sarebbe
quell’ attrezzo chiamato altrove anche fressora, testo, coperchio.
Strumento paramusicale originalissimo, il cui uso non risulta essere attestato da
nessuna parte: la coppa va percossa con ditali metallici e con la parte inferiore del
palmo della mano.
“Coppa e bufù” - racconta di Felice Tosto informatore di Gioielli - “erano suonati
sempre”.
Occasionalmente a essi si univano chitarre, fisarmoniche e l’organetto, detto ru
secutasurge, lo scacciatopi, a Bagnoli, forse alludendo alla imperizia dei suonatori.
Gioielli approfitta della circostanza per una dissertazione, interessante come le altre,
sugli strumenti paramusicali e sul loro uso. Per esempio nello charivari.
Altri canti dei Mesi nel Molise
A titolo di esempio sono riportate due varianti molisane, con le relative musiche,
come le altre raccolte da Mauro Gioielli e trascritte da Pietro Ricci.
La variante di Isernia, dove oltre alle persone si addobbavano anche i carri, e uno in
particolare era riservato a Bacco, Re del Carnevale.
La variante della canzone dei mesi a Frosolone si caratterizza invece per il testo che è
del tutto in italiano. Circostanza questa che è abbastanza comune in Molise.
Documenti fotografici
Riguardano le edizioni moderne del Carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno.
Specificatamente le edizioni 1994, 1993, 1992. Le referenze fotografiche sono di
Nino Di Paolo, Franco Mastrodonato, Nunzio Pallotta, Luigi Proietti.
Uno speciale ringraziamento a loro. Senza le loro foto il libro non sarebbe quello che
è: uno strumento serio, scientifico, ma anche divulgativo e, se è possibile, turistico.
APPENDICE:
I proverbi del Calendario
Siamo in presenza di un piccolo saggio dei numerosissimi proverbi molisani che
fanno riferimento al calendario, parlando del tempo, delle stagione e soprattutto dei
mesi. Il capitolo è introdotto da una formula comportamentale che può benissimo
essere riferita alle feste in genere e al carnevale in particolare.
Na vote all’anne
Die u cummanne;
na vote u mese
porta sp‚se;
Tutte i iurne
è nu taluorne
che si trova spesso registrato capovolto, a cominciare dai giorni e finire all’anno.
Siamo in presenza, come si vede, di una perifrasi del già citato Semel in anno licet
insanire degli antichi latini. Una volta all’anno ci si può persino permettere il lusso
d’impazzire (di gioia, ovviamente).
E giacché ci siamo voglio ricordare un altro proverbio latino, che fa riferimento
anche alla cadenza mensile da assegnare a una pratica, diciamo così igienica, per non
meglio specificarla, essendo del tutto inutile farlo, dal momento che si capisce
benissimo a cosa si alluda:
In die perniciosum;
in hebdomada utile;
in mense necessarium.
(Dannoso tutto i giorni, utile settimanalmente, necessaria almeno una volta al mese).
Per chiudere il discorso sul capitolo, voglio ricordare due proverbi molisani, non
citati. Il primo di impronta carnevalesca è riferito proprio alla giornata di oggi, il
giovedì grasso, il gevedì lardielle che secondo l’adagio va onorato senz’altro:
Gevedì lardielle
chi n’tè carne z’ampégne u cappielle
Che non credo abbia bisogno di traduzione.
Il secondo proverbio è invece riferito a Maggio e suona molto simpatico, sfatando un
po’ l’immagine del mese tutto rose e fiori che ci è data dal Canto dei Mesi:
È maie
e ancore fridde haie
se nen vè luglie meture
nen m’arescalle u cule
È maggio, ed ho ancora freddo; se non viene Luglio maturo (pieno) non mi riscaldo.
La fiaba dei Mesi
Bella l’idea di corredare il libro sul Carnevale dei Mesi a Bagnoli con la “Fiaba dei
Mesi” tratta dal Pentamerone, ovvero Lo cunto de li cunti, di Giambattista Basile.
Bella l’idea perché la fiaba risulta del tutto in linea con il tema: i dodici Mesi visti
come dodici giovani fratelli ripagano di moneta buona o cattiva rispettivamente i due
protagonisti, tanto gentile l’uno quanto scostumato il secondo.
Ma bella soprattutto l’idea perché Lo cunto de li cunti di Basile è libro che ha con
forza inciso sul nostro patrimonio favolistico e folclorico in genere. Di molte delle
cinquanta fiabe in esso raccolte, sono conosciute varianti molisane.
Bella l’idea di Gioielli perché Basile è autore interessantissimo che andrebbe
conosciuto e studiato con ogni accortezza da parte di ricercatori e appassionati del
patrimonio culturale popolare.
Basile è una miniera per lo studio della lingua, del dialetto, degli usi, dei costumi, dei
giochi, delle canzoni, dei balli, delle musiche nell’Italia meridionale in genere e nel
napoletano in particolare. Uno scrigno dove cercare mille e mille informazioni sul
Seicento dalle nostre parti.
Un solo esempio: la “Fiaba dei due fratelli” è un formidabile repertorio di proverbi
del tempo, che il padre morente lascia come bussola per il comportamento dei figli.
Si tratta di proverbi, non occorre dirlo, anch’essi largamente diffusi nel nostro
territorio.
Tutto ciò per non parlare della sapienza stilistica di Basile. Basta citare i nomi di due
dei suoi innamorati: Benedetto Croce, cui si deve una traduzione bellissima ma ormai
datata (1924) e Italo Calvino.
Giova aggiungere che proprio in questi giorni è comparsa una nuova aggiornata
traduzione della raccolta di Basile con il titolo Racconto dei racconti, è curata da
Ruggero Guarino ed edita da Adelphi. Sta avendo un’accoglienza davvero entusiasta.
Valga per tutte la recensione fiume di Pietro Citati, grande critico, sul paginone
centrale della “Repubblica” di pochi giorni fa.
Bibliografia del Carnevale dei Mesi nel Molise e Bibliografia generale.
Un vero punto di forza nel libro di Gioielli, a parere di chi vi parla, è costituito
dall’apparato bibliografico, ponderoso e accurato. La bibliografia specifica del
Carnevale dei Mesi nel Molise conta ben 80 titoli, nonostante la prudente avvertenza
dell’autore, che senza alcuna pretesa di esaustività si è rifatto solo alla propria
biblioteca personale: biblioteca ben fornita, bisogna dire.
La bibliografia generale allinea, invece - se abbiamo contato bene, 136 titoli. Una
manna anch’essa per chi voglia approfondire lo studio di tematiche carnevalesche in
genere.
E qui vale la pena di sgombrare il campo da ogni equivoco. Spesso i repertori
bibliografici sono un’arida elencazione di luoghi comuni: si riprendono e si
rimandano da libro a libro, acriticamente. Del tutto meritato, in questi casi, lo
sberleffo che Miguel de Cervantes, nella Prefazione del Don Chisciotte, indirizza agli
scrittori che ostentano titoli e nomi di autori, in realtà mai letti. Miguel de Cervantes
si finge scoraggiato per la povertà del paratesto (sonetti introduttivi, dediche
magniloquenti, risposte altrettante magniloquenti di mecenati illustri, bibliografia,
etc.) del suo capolavoro. Scoraggiato a tal punto, che non vorrebbe più pubblicare.
Per fortuna della letteratura mondiale, ci pensa un amico a tirarlo fuori d’impaccio
con consigli che smascherano il comportamento scorretto di certi autori. In
particolare, facendo riferimento alla lista degli autori da citare, l’amico suggerisce:
Veniamo ora alla citazione degli autori che si trovano negli altri libri, mentre
mancano nel vostro. A questo si può trovar rimedio assai facilmente, perché non
avete altro da fare se non cercare un libro che li citi tutti, dall’A alla Z, come voi
dite. Ebbene, riportate questo stesso indice alfabetico nel vostro libro: anche se la
bugia è evidente, data la scarsa necessità che avevate di servirvi di essi, non
importa nulla, e forse ci sarà qualcuno così ingenuo da credere che li avete
consultati tutti nella vostra storia semplice e schietta. E qualora quel lungo elenco
di autori non servisse ad altro, per lo meno servirà a dar subito autorità al libro.
Inoltre, non ci sarà nessuno che si metta a controllare se ve ne siete servito o no,
non venendogliene alcun guadagno.
La Prefazione al Chisciotte, una pagina magistrale di satira pungente e scoppiettante.
Mi sono divertito a rileggerla e a proporla, con l’avviso che non si attaglia affatto al
caso di Gioielli. La sua Bibliografia del Carnevale dei Mesi nel Molise è bibliografia
ragionata. I testi indicati sono vagliati uno per uno con chiose utili al lettore. Spesso
le indicazioni di Gioielli si condensano in analisi critiche vere e proprie. Si vedano,
per tutte, le annotazioni a margine del II e del III volume di dattiloscritti di Silvio
Ciarniello, I canti del mio paese.
Insomma, e non c’era da dubitarne, Gioielli le sue fonti, i suoi autori, se li è studiati
accuratamente, uno per uno. E ne ha reso conto al lettore, che in tal modo prende atto
del percorso cognitivo ed elaborativo che sottende alla stesura del libro.
Conclusione
Al quale libro auguriamo la migliore fortuna. La merita. È superfluo aggiungere
parola a quanto fin qui siamo venuti esponendo. E pure è doveroso riepilogare il
giudizio largamente positivo. Il Carnevale dei Mesi a Bagnoli del Trigno di Mauro
Gioielli è un bel libro. Auguri e complimenti all’autore.
Auguri e complimenti alla Compagnia di Cultura Popolare “La perla del Molise” e al
suo presidente, Franco Mastrodonato, che con questa edizione hanno voluto dare
ancora più spessore culturale all’azione meritoria di riscoperta e valorizzazione del
patrimonio culturale popolare di Bagnoli.
I migliori auguri e ogni fortuna per il Carnevale dei Mesi a Bagnoli, e per la
popolazione bagnolese tutta, il cui entusiastico coinvolgimento ha reso e rende
possibile una manifestazione che si va accreditando tra le più serie e meglio innestate
alle radici della tradizione. E, sciogliendo il dubbio dal quale sono partito, riesce
chiaro come i bagnolesi siano fortemente attaccati al loro paese e alla loro cultura.
Masciotta, poveretto, dové incappare a suo tempo nella tipica eccezione. Magari suo
corrispondente da Bagnoli fu un parroco non nato in paese.
Ai presenti, con gli auguri, vanno i ringraziamenti più sentiti per l’attenzione e la
disponibilità nei confronti di chi modestamente ha voluto testimoniare della bontà del
libro e della manifestazione carnevalesca.