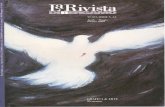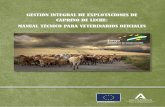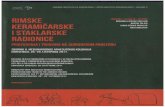Quaderni della ricerca n. 129 -febbraio 2011 ALLEVAMENTO CAPRINO IN LOMBARDIA: STATO...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Quaderni della ricerca n. 129 -febbraio 2011 ALLEVAMENTO CAPRINO IN LOMBARDIA: STATO...
Quaderni della ricercan. 129 - febbraio 2011
LOMBARDIA. COSTRUIAMOLA INSIEME.
www.regione.lombardia.it
ALLEVAMENTO CAPRINOIN LOMBARDIA:
STATO IGIENICO-SANITARIO E PRODUZIONI
Quaderni della ricercan. 129 - febbraio 2011
ALLEVAMENTO CAPRINOIN LOMBARDIA:
STATO IGIENICO-SANITARIO E PRODUZIONI
Sperimentazione condotta nell’ambito del progetto di ricerca n. 845“Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni”(d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20734 - Piano per la ricerca e lo sviluppo 2005).
Testi a cura di:Maria Teresa Manfredi, Valerio Bronzo, Annarita di Cerbo
Ha realizzato le attività sperimentali:Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Salute Pubblica Veterinaria
Università degli Studi di MilanoFacoltà di Medicina VeterinariaVia Celoria, 10 - 20133 Milano
Tel. 02.50318098 - Fax 02.50318095
Referente: Prof.ssa Maria Teresa Manfredie-mail: [email protected]
Per Informazioni:Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura
U.O. Innovazione, cooperazione e valorizzazione delle produzioniStruttura Ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle impresePalazzo Lombardia - P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
Tel: 02.6765.3790 - Fax 02.6765.8056e-mail: [email protected]
Referenti: Maria Lina Sandionigi - Tel. 02.6765.2579e-mail: [email protected]
Gianpaolo Bertoncini - Tel. 02.67652524e-mail: [email protected]
© Copyright Regione Lombardia
3
Presentazione
L’allevamento della capra da latte in Lombardiarappresenta una realtà zootecnica che, nell’ulti-mo decennio, ha sviluppato efficienti modelli di
gestione aziendale e di filiera corta, anche grazie al sup-porto del servizio regionale di assistenza tecnica agli alle-vamenti (SATA).
Si tratta di un settore che ha potenzialità rilevanti sia dalpunto di vista produttivo, per l’ampia gamma di prodotti ca-seari tipici o locali, che dal punto di vista sociale, culturalee ambientale, grazie al ruolo di presidio e di valorizzazioneche gli allevatori svolgono su territori marginali svantag-giati, altrimenti destinati al parziale abbandono per man-canza di valide alternative. L’allevamento caprino è quindi
una concreta fonte di reddito, di particolare valore nelle zone alpine e prealpine,caratterizzate dalla presenza di razze cosmopolite e autoctone, oggetto, questeultime, di specifiche misure volte alla salvaguardia e conservazione del patrimo-nio genetico che rappresentano.
La ricerca condotta nell’ambito del progetto “Allevamento caprino in Lom-bardia: stato igienico-sanitario e produzioni” ha indagato vari aspetti tra i qua-li la distribuzione delle parassitosi in generale e, in particolare, delle parassito-si gastrointestinali, l’interazione tra infestazioni, produzioni e caratteristicheigieniche del latte, l’uso dei farmaci, l’individuazione di fenomeni di farmacore-sistenza, la diffusione delle infezioni dell’apparato mammario. Tutti elementi in-dispensabili per il miglioramento della gestione dell’allevamento, della qualitàdel latte e dei prodotti derivati, a garanzia della salute del consumatore.
Il presente Quaderno fornisce linee guida per una corretta gestione delle pa-rassitosi e della sanità della mammella. Sono stati inoltre realizzati un DVD in-formativo sui cicli di sviluppo dei parassiti e sulla loro diagnosi e una scheda di-vulgativa relativa alla diffusione dei nematodi gastrointestinali sul territorio re-gionale e alle corrette pratiche di controllo. Entrambi strumenti utili per alleva-tori e tecnici che vogliano affrontare in modo integrato aspetti economici, igieni-co-sanitari e ambientali.
Giulio De CapitaniAssessore all’Agricoltura
Regione Lombardia
5
Indice
PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
STATO DELL’ARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
Analisi della realtà produttiva dell’allevamento caprino in Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
Le parassitosi nell’allevamento caprino: stato delle conoscenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8
Le mastiti nell’allevamento caprino: stato delle conoscenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11
FINALITÀ DELLA RICERCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12
Enti coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13
Articolazione della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13
LINEA DI RICERCA 1: DISTRIBUZIONE DELLE INFESTAZIONI PARASSITARIE NEGLI ALLEVAMENTI CAPRINI LOMBARDIIN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA D’ALLEVAMENTO, AL MANAGEMENT, ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI . . . . . . . pag. 15
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15
RISULTATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16
Caratterizzazione aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16
Fattori di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19
Esami necroscopici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21
LINEA DI RICERCA 2: INTERAZIONE TRA INFESTAZIONI DA NEMATODI GASTROINTESTINALI (STRONGYLIDA),PRODUZIONI E CARATTERISTICHE IGIENICHE DEL LATTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27
PARTE A: RELAZIONE TRA INFESTAZIONI PARASSITARIE E PRODUZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28
RISULTATI E DISCUSSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28
PARTE B: RELAZIONE TRA INFESTAZIONI PARASSITARIE E CARATTERISTICHE IGIENICHE DEL LATTE . . . . . . . . . . . . . . pag. 31
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31
RISULTATI E DISCUSSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31
LINEA DI RICERCA 2: STRATEGIE DI CONTROLLO DEI NEMATODI GASTROINTESTINALI (STRONGYLIDA)NELL’ALLEVAMENTO CAPRINO LOMBARDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
ALBENDAZOLO: PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO UTILIZZATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
Protocollo I: trattamento di tutte le capre del gregge con dosaggi del farmaco differenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
Protocollo II: trattamento di tutti i soggetti del gregge con un unico dosaggio del farmaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
Protocollo III: trattamento delle capre che eliminano maggiori quantità di uova (trattamento selettivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33
EPRINOMECTINA: PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO UTILIZZATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34
RISULTATI E DISCUSSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34
CONCLUSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 36
6
LINEA DI RICERCA 3: PRESENZA DI FENOMENI DI FARMACORESISTENZA DEI NEMATODI GASTROINTESTINALI (STRONGYLIDA) NELL’ALLEVAMENTO CAPRINO LOMBARDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39
ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI FARMACORESISTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39
RISULTATI E DISCUSSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41
ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI CONTROLLO DEI NEMATODIGASTROINTESTINALI ADOTTATE DAGLI ALLEVATORI LOMBARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41
CONCLUSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42
INDAGINI SULLE INFEZIONI MAMMARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43
MATERIALI E METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43
RISULTATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 44
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 48
CONCLUSIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 51
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 53
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE INFESTAZIONI DA NEMATODI GASTROINTESTINALINELL’ALLEVAMENTO CAPRINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57
PUNTI CRITICI DA CONSIDERARE PER UNA CORRETTA DIAGNOSI DI LABORATORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57
1) Campionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57
2) Conservazione dei campioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57
3) Tecnica utilizzata per l’esame copromicroscopico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
4) Analisi dei risultati dell’esame copromicroscopico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
5) Identificazione del livello di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
TRATTAMENTI ANTIELMINTICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
I trattamenti parassitari nell’allevamento caprino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
PUNTI CRITICI DA CONSIDERARE PER APPLICARE UN CORRETTO TRATTAMENTO ANTIELMINTICO . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
ALTERNATIVE PER IL FUTURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 60
LINEE GUIDA PER LA SANITÀ DELLA MAMMELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
1) Blocco della diffusione dell’infezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
2) Riduzione dei fattori che favoriscono l’infezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
3) Cura delle infezioni durante l’asciutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
4) Controllo della sintomatologia e contenuto in cellule somatiche del latte durante la lattazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
Indice
7
Introduzione
STATO DELL’ARTE
Analisi della realtà produttiva dell’allevamento caprino in Lombardia
Sebbene a livello mondiale rivesta un ruolo ancora piut-tosto marginale rispetto agli altri settori zootecnici (bovinoe ovino in particolare), l’allevamento caprino ha avuto nel-l’ultimo ventennio un incremento nel numero di capi pari al58%. Tale incremento appare piuttosto significativo, soprat-tutto se rapportato alle altre realtà zootecniche dove, nellostesso periodo, l’aumento di animali da reddito è stato sol-tanto del 10% per i bovini e del 22% per gli ovini (Morand-Fehr et al., 2004).
A livello di Unione Europea, tra i vari stati membri emer-ge una spiccata eterogeneità del comparto e delle relative ti-pologie produttive. Relativamente alla distribuzione territo-riale, il patrimonio zootecnico caprino risulta maggiormenteconcentrato nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo,con il maggior numero di capi presenti in Grecia, Spagna,Italia e Francia (Tab. 1).
Differenze significative, derivanti da diverse tipologied’impostazione produttiva e manageriale degli allevamenti,emergono dal confronto tra il numero di capi e la produzio-ne di latte (e formaggio) a livello nazionale: nei paesi piùpropriamente mediterranei, quali Grecia e Spagna, le forticonsistenze numeriche non si rispecchiano nella produzio-ne lattiera e casearia, che presenta valori decisamente infe-riori rispetto ad una realtà come quella francese. Ciò derivada differenti tradizioni gastronomico-culturali, nonché tec-nico-organizzative, che vedono da una parte la prevalenzadi un allevamento volto alla produzione di carne ed effet-tuato secondo criteri tradizionali ed estensivi, e dall’altrauna realtà incentrata sulla produzione lattiera conseguita inallevamenti intensivi o semi-intensivi caratterizzati da unaconsistenza numerica totale non eccessiva ed alti indici ge-netici e produttivi (Boyazoglu e Morand-Fehr, 2001; Boya-zoglu et al., 2005).
Per quanto riguarda l’Italia la produzione di latte di capraappare decisamente inferiore rispetto agli altri Paesi produt-tori. In effetti, l’allevamento caprino risulta un’attività anco-
ra in via di sviluppo in molte regioni italiane. Considerato ti-pico soprattutto di realtà zootecniche situate in zone del Pae-se degradate o marginali, in questi anni l’allevamento capri-no italiano sta tuttavia attraversando un processo di profon-do rinnovamento e di evoluzione organizzativa e produttiva,che vede il passaggio da comparto marginale ad elementofortemente innovativo, arrivando a rappresentare un settoredalle potenzialità rilevanti da un punto di vista sia produtti-vo e, quindi, anche economico, sia sociale e ambientale, so-prattutto in quei territori caratterizzati dalla mancanza di va-lide alternative.
La capra, infatti, è passata ad essere considerata, soprat-tutto nel contesto italiano, non più una specie minore, carat-teristica delle piccole economie familiari di sussistenza e deicontesti agrozootecnici meno sviluppati e più poveri di ri-sorse, ma animale di punta per il rilancio dei territori margi-nalizzati dalle classiche forme di allevamento e per la tuteladi prodotti e sapori tipici, sempre più apprezzati da un con-sumatore europeo.
Per altro, l’allevamento della capra da latte, in particolare,sta assumendo crescente importanza sul territorio nazionale,non solo per quanto riguarda le aree marginali montane maanche in realtà zootecniche di tipo intensivo. I fattori chehanno contribuito a questo sviluppo sono riconducibili allamaggiore richiesta di prodotti lattiero-caseari di origine ca-prina da parte del consumatore, alla mancanza di quote pro-duttive, al consumo sempre più frequente di latte di capranell’alimentazione umana anche a causa dell’aumento, sianei bambini che negli adulti, di allergie ed intolleranze alleproteine del latte vaccino (Noè et al., 2005). È stato, infatti,statisticamente rilevato che circa il 2,5% dei bambini pre-senta intolleranza alle proteine del latte vaccino nei primi treanni di età (Bellioni-Businco et al., 1999). Ulteriore elemen-to di forza del comparto è rappresentato dalla diffusa perce-zione di salubrità e genuinità dei prodotti di latte caprino daparte del consumatore finale, percezione determinata sia dal-le effettive caratteristiche intrinseche dei metodi ed ambien-ti di allevamento, sia dal modello di commercializzazione,spesso associato nei comprensori montani all’attività agritu-ristica (Dubeuf et al., 2004).
Allo stato attuale la maggior parte del patrimonio caprinoallevato in Italia risiede nelle regioni meridionali, che dasempre mantengono questo primato a seguito di una lungatradizione storica e culturale. A queste grosse consistenzenumeriche totali corrisponde, per contro, una notevole fram-mentazione, con la prevalenza di greggi di piccole dimen-sioni allevate secondo metodiche tradizionali ed estensive, adiscapito della produttività individuale, dell’innovazione emanagerialità del comparto e delle prospettive future (Mo-rand-Fehr et al., 2004).
Negli ultimi decenni, ed in modo più evidente negli ulti-missimi anni, si sta tuttavia assistendo ad un processo di di-
Capi ProduzioneProduzione di
allevati di latte (tonn)formaggio (tonn)
(dato aggiornato al 2004)
TABELLA 1 - Consistenza dell’allevamento caprino e produzio-ni in alcuni Paesi europei (FAOSTAT data 2007).
Italia 955.000 105.000 8.600
Grecia 5.401.545 505.523 48.000
Spagna 2.891.574 488.500 37.000
Francia 1.254.000 579.000 68.000
8
versificazione e ricollocazione sul territorio nazionale degliallevamenti e delle produzioni caprine, con un progressivoaumento dei capi allevati nelle regioni centrali e settentrio-nali ed in particolar modo nella regione Lombardia (secon-do il censimento ISTAT del 2000 nel solo decennio 1990 -2000 si è registrato un aumento del patrimonio caprino al-levato in questa regione del 4%), a cui si accompagna ladiffusione di nuove tecniche di conduzione. Assodata lacentralità della produzione lattiera all’interno del compar-to caprino, le metodiche d’allevamento si sono, di fatto,evolute in questa direzione: si è così assistito al progressi-vo abbandono del sistema prettamente estensivo dei greggitransumanti, che comportava basse produzioni e notevolidifficoltà logistiche per la gestione dell’attività di mungitu-ra, a favore di un sistema di allevamento di tipo semi-in-tensivo o addirittura intensivo, che meglio risponde alle at-tuali richieste del mercato dei prodotti derivanti dall’alle-vamento caprino. L’adozione di tecniche di allevamentosempre più simili a quelle impiegate nell’allevamento del-le bovine da latte a regime intensivo (fecondazione artifi-ciale, alimentazione con unifeed, mungitura meccanica),accomunate con le tecniche di destagionalizzazione dei ci-cli estrali e la spinta selettiva che hanno subito alcune spe-cie caprine a prevalente attitudine alla produzione di latte(Saanen, Camosciata delle Alpi), hanno sicuramente garan-tito produzioni (di latte) sempre crescenti e distribuite sututto l’arco dell’anno. La realtà dell’allevamento caprinopresenta comunque notevoli differenze con l’allevamentobovino, sia dal punto di vista gestionale che zootecnico,contando su minori investimenti strutturali e sulla maggio-re resistenza fisiologica di questi animali. Accanto alle re-altà produttive di tipo intensivo, non bisogna poi trascura-re la recente spinta alla crescita di altri nuclei produttiviche sfruttano le aree più marginali e utilizzano razze au-toctone, soprattutto nell’ottica della valorizzazione dei co-siddetti “prodotti tipici”. Occorre, peraltro, ricordare lacrescente richiesta del mercato di prodotti di “qualità certi-ficata”, che non può prescindere da un buono stato sanita-rio dell’animale.
Nello specifico, per quanto riguarda la Lombardia, l’alle-vamento caprino è una realtà zootecnica interessante, so-prattutto in relazione alla ricchezza di produzioni casearieche impiegano il latte caprino, totalmente o solo parzial-mente. La Lombardia vanta, infatti, la produzione di diversiprodotti tipici (basti ricordare la presenza sul territorio re-gionale delle due importanti Dop del Bitto e della Formag-gella del Luinese) o comunque locali (Tab. 4).
Relativamente alle consistenze del patrimonio caprinolombardo, le stime attuali attestano la presenza di 71.718 ca-prini allevati in 7.469 aziende diversamente distribuite sulterritorio (fonte: Anagrafe Ovicaprina - DG Sanità RegioneLombardia - Anno 2008) (Tab. 2).
La distribuzione dell’allevamento caprino non è uniformeall’interno del territorio regionale, ma rispecchia il tradizio-nale legame tra questo animale e l’economia e le popolazio-ni delle zone di montagna ed alta collina (Noè et al., 2005).
Le province montane e della fascia pedemontana, caratte-rizzate da un’ampia disponibilità di superfici pascolative e dialpeggi, detengono sia il maggior numero di capi che di alle-vamenti (Tab. 2); di contro, nelle zone di pianura si hanno po-
chi allevamenti (nelle province di Pavia, Milano, Cremona eMantova il numero di aziende raggiunge complessivamente il10% del totale) con un numero di capi generalmente mag-giore per unità produttiva. Questa suddivisione rispecchiad’altronde il ben diverso ambito agro-economico caratteriz-zante la montagna e la pianura lombarda, come peraltro evi-denziato all’interno del Programma di Sviluppo Rurale(P.S.R.) 2000 - 2006 della Regione Lombardia, che individual’areale alpino e parte di quello prealpino come zona econo-mica svantaggiata dal punto di vista agricolo (Grafico 1).
Le razze caprine allevate in Lombardia sono undici: la Ca-mosciata delle Alpi, la Saanen, la Orobica, la Bionda dell’Ada-mello, la Verzaschese, la Ciavenasca, la Frisa Valtellinese, laLariana, la Nicastrese, la Meticcia e la Toggenburg; la maggiorparte delle quali sono razze autoctone lombarde (Tab. 3).
Esse risultano strettamente legate al sistema di allevamen-to adottato: le cosmopolite Saanen e Camosciata delle Alpi,risultano diffuse in tutto il territorio regionale in allevamen-ti riconducibili al sistema intensivo; negli allevamenti di tiposemi-intensivo o estensivo, presenti soprattutto nelle zonemontane e di alta collina, oltre alla Camosciata delle Alpi,vengono allevati anche capi di razza autoctona quali Biondadell’Adamello, Frisa Valtellinese, Nera di Verzasca ed Oro-bica (Schembri et al., 2003).
Per quanto riguarda le razze locali, negli ultimi anni sonooggetto di rinnovato interesse anche a seguito di appositemisure legislative volte alla conservazione e valorizzazionedi questo importante patrimonio genetico, culturale e socia-le. Infatti, oltre a rappresentare degli ottimi esempi di adat-tamento al territorio ed allo sfruttamento delle sue risorse ead essere in alcune zone parte integrante dell’ambiente agri-colo tipico, costituiscono una base imprescindibile per laspecializzazione e la caratterizzazione produttiva delle areemarginali e svantaggiate, con benefiche ripercussioni di ca-rattere economico e sociale.
Le parassitosi nell’allevamento caprino: stato delle conoscenze
Nonostante l’ampia affermazione di questo comparto zoo-tecnico, le parassitosi in generale, e più in particolare quelle
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Capi Allevamenti Allevamenti Capi perProvince allevati
n° % allevamento(fattrici)
TABELLA 2 - Consistenze dell’allevamento caprino in alcuneprovince lombarde (fonte: Anagrafe Ovicaprina - DG Sanità Re-gione Lombardia - Anno 2008).
Bergamo 11.819 1.423 19 8,31
Brescia 15.525 1.558 21 9,96
Como 11.555 1.028 14 11,24
Cremona 902 86 1,15 10,49
Lecco 4.016 580 8 6,92
Mantova 1.805 195 2,6 9,26
Milano-Lodi 3.142 317 4,2 9,91
Pavia 992 165 2,2 6,01
Sondrio 17.744 1.456 19 12,19
Varese 4.218 661 9 6,38
Totale 71.718 7.469 100 9,60
9
gastrointestinali, sono ampiamente diffuse e rappresentanotuttora una problematica peculiare all’interno del settore del-l’allevamento dei piccoli ruminanti e, più in specifico, dellacapra, indipendentemente dall’indirizzo produttivo. Infatti,l’organizzazione del ciclo produttivo, le specifiche tecnichedi conduzione, la tipologia alimentare, le caratteristichestrutturali ed economiche del comparto rendono ineluttabile,seppur con incidenze diverse a seconda dei contesti presi inesame, la presenza degli elminti parassiti all’interno dellegreggi di capre.
L’infestazione da parte di nematodi gastrointestinali ri-conducibili a generi quali Teladorsagia, Haemonchus, Tri-chostrongylus ed Oesophagostomum che elettivamente, a se-conda della specie si localizzano nell’abomaso e/o nei varitratti dell’intestino, costituisce, di fatto, uno dei fattori sani-
tari limitanti più rilevanti nel sistema di produzione dei pic-coli ruminanti con conseguenze che vanno dalla riduzionedelle performances produttive alla mortalità (Sykes 1994;Waller 1999). In ambito europeo, le perdite relative alla pro-duzione di latte riconducibile agli effetti del parassitismo va-riano tra il 2,5% ed il 18,5% a seconda del contesto di alle-vamento. Parallelamente ad un calo produttivo inteso comeminore quantità di latte prodotto nel corso della lattazione e,più a lungo termine, in tutta la carriera produttiva (Hoste etal., 2005), è stato notato anche un peggioramento sostanzia-le nelle caratteristiche compositive del latte, rilevando un ca-lo del tenore di grasso (29,9%), di quello di proteina (23,3%)e di lattosio (19,6%) (Rinaldi et al., 2007). Tali perdite si os-servano di norma in situazioni di parassitismo subclinico. Ilmeccanismo patogenetico generale in situazioni di parassiti-smo subclinico può facilmente essere assimilato a quello diun disordine nutrizionale, nel senso che l’azione degli el-minti parassiti si manifesta attraverso un calo dell’ingestio-ne di sostanza secca, una diminuzione dell’efficienza dige-stiva ed una deviazione dei nutrienti alimentari dalle funzio-ni di produzione ed omeostasi alla riparazione dei danni tis-sutali ed all’elaborazione delle risposte difensive (Rinaldi L.et al., 2007).
La conoscenza dell’epieziologia delle infestazioni paras-sitarie è un elemento indispensabile per il controllo sosteni-bile dei nematodi, in quanto questi parassiti interagisconocon l’ospite in uno specifico clima, ambiente di produzionee management.
Gli elementi determinanti nel fenomeno del parassitismogastrointestinale nella capra all’interno del sistema zootecni-co dei paesi occidentali sono essenzialmente riconducibili adue fattori, ovvero la diffusa pratica del pascolamento dellegreggi e le peculiari caratteristiche di resistenza/resilienzadella specie caprina all’infestione parassitaria.
Introduzione
GRAFICO 1 - Suddivisione del territorio lombardo in base alla tipologia dei sistemi agricoli (P.S.R. Reg. Lombardia 2000-2006).
Razza Capi allevati (fattrici)
TABELLA 3 - Razze caprine allevate in Lombardia (Fonte: ban-ca dati Asso. Na. Pa. - anno 2007).
Camosciata delle Alpi 3.265
Saanen 3.208
Orobica o di Val Gerola 981
Bionda dell’Adamello 3.609
Verzaschese (Nera di Verzasca) 1.907
Ciavenasca –
Frisa Valtellinese 859
Lariana o di Livo 2.774
Nicastrese –
Meticcia 273
Toggenburg 5
Totale 16.881
10
Agli indubbi vantaggi derivanti dalla pratica del pascolo,che permette da un lato il contenimento dei costi e dall’altrola valorizzazione di zone altrimenti non raggiungibili dallealtre pratiche colturali, si contrappone tuttavia il fondamen-tale ruolo che questo metodo di conduzione esercita nel-l’ambito della propagazione delle infestazioni all’interno etra le generazioni di animali ospiti (Gasnier et al., 1997; Val-lade et al., 2000).
Il grado di parassitismo è, peraltro, relazionato anche allaquantità di larve infestanti ingerite insieme al foraggio e di-pende dalle abitudini alimentari; quando le capre hanno lapossibilità di alimentarsi di piante e arbusti, meno favorevo-li per l’assunzione di larve rispetto ai pascoli, esse risultanomeno parassitate delle pecore (Vercruysse 1983). Le capreAngora appaiono più esposte alle infestazioni da strongiligastrointestinali rispetto ad altre razze proprio per la scarsaattitudine all’utilizzo di arbusti (Hoste et al., 2001). Il gradodi parassitismo sembrerebbe correlato anche alla capacitàproduttiva: le capre migliori produttrici di latte, sia in condi-zioni naturali che sperimentali, presentano il più alto livellodi parassitismo (Chartier e Hoste 1997; Chartier 1993; Char-tier et al., 2000; Hoste et al., 2002).
È stato, inoltre, evidenziato che le capre alla prima latta-zione possono eliminare più uova rispetto alle altre femmi-ne; questo dato varia, tuttavia, da una situazione all’altra, inrelazione innanzitutto al tipo di management aziendale, chepuò differire tra le capre in prima lattazione e le adulte. In al-
cuni allevamenti le capre giovani sono tenute al chiuso, nonhanno contatto con i parassiti e quindi tendono ad essere piùsuscettibili all’infestazione quando vi sono esposte. Da nontrascurare è, ancora, il fatto che la somministrazione dei trat-tamenti antielmintici è basata generalmente sul peso mediostimato; può quindi verificarsi una sottostima delle dosi pre-scritte per le capre adulte. Le discrepanze osservate nell’ef-ficienza degli antielmintici sono in grado di spiegare le dif-ferenze nell’epidemiologia (Hoste et al., 2000, 2002). Anco-ra, nelle capre ad alta produzione la quantità di proteine pre-senti nella dieta sembrerebbe contribuire a contrastare l’in-festazione parassitaria (Chartier et al., 2000). Infine è statodimostrato nella capra da latte, in Francia, che l’intensitàdell’escrezione di uova di nematodi gastrointestinali è corre-lata negativamente alla produzione di latte e alla produttivi-tà generale della mandria (Cabaret et al., 1984).
Per quanto riguarda le caratteristiche della risposta allapressione parassitaria, le capre e soprattutto gli individui adalto potenziale genetico e produttivo, hanno una capacità in-feriore rispetto alla pecora ed alla bovina di sviluppare nelcorso degli anni un’adeguata risposta immunitaria alle rein-festazioni da elminti; ne consegue che le capre adulte rispet-to agli ovini possono eliminare uova in quantità superiore.Tale fenomeno si rende evidente quando le due specie sonoallevate nelle medesime condizioni (Chartier e Hoste 1997;Attili et al., 2004). Questo elemento riveste particolare im-portanza, dal momento che troppo spesso vi è la tendenza a
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Nome Provenienza Composizione
TABELLA 4 - Formaggi tradizionali a base di latte caprino (da “L’Italia dei formaggi” Guida Touring, TCI 2002).
Agrì di Valtorta Alta Val Brembana (BG) Formaggino a pasta cruda da latte intero vaccino oppure di capra appena munto
Bitto (Dop) Valtellina (SO) Latte vaccino addizionato con latte caprino (fino al 10%)
Branzi Prov. BG Latte vaccino addizionato con latte ovino o caprino
Bernardo Clusone (Valle Seriana, BG) Latte crudo intero vaccino o misto di capra (10%)
Cadolet di capra Valle Camonica (BS) Latte intero caprino
Caprino a coagulazione Lombardia Latte intero di capra, pasta molle (fresco o stagionato), a coagulazione velocepresamica
Caprino a coagulazione Area Lariana (CO, LC) Latte intero di capra, a coagulazione lentalattica
Caprino “di vacca” Lombardia Latte intero o parzialmente scremato, vaccino o misto ovi-caprino, talora con aromi
Casoretta Val d’Intelvi o Porlezza (CO) Latte intero vaccino con eventuale 10% di caprino
Fatulì Alpeggi dell’Adamello (BG e BS) Latte intero appena munto di Capra Bionda dell’Adamello
Formagella del Luinese Montagna di Luino Latte caprino intero con lavorazione presamicae Varesotto (VA)
Formagella di Caglio Triangolo lariano (CO) Latte vaccino crudo parzialmente scremato, eventualmente misto a latte ovi-caprino
Formaggio d’Alpe misto Lombardia (fascia montana) Latte vaccino e caprino (30-40%) crudo
Magnoca Valchiavenna Latte vaccino parzialmente scremato con eventuale aggiunta caprinae Valle San Giacomo (SO)
Matusc Tutte le Valli lombarde, Latte vaccino scremato con particolare addizione caprinain particolare la Valtellina (SO)
Motelì Valcamonica Latte caprino
Ricotta artigianale Alpi e Prealpi lombarde Latte vaccino ottenuto per riscaldamento del siero di latte vaccino, e/o ovi-caprino, (Puina, Mascherpa) eventualmente con aggiunta di latte e/o panna
Scimudin Semogo, Valtellina (SO) Latte vaccino, caprino o misto, intero(Formagella Valtellina)
Sta’el Valcamonica Latte caprino intero
Zincarlin Alto Lario, Val d’Intelvi, Ricotta da siero di latte bovino e talvolta di latte intero di capraAlpi Lepontine (CO)
11
mutuare per la capra le conoscenze acquisite sulla pecoranella gestione sanitaria delle parassitosi, sia per quanto ri-guarda la pianificazione dei trattamenti da effettuare che perla scelta dei dosaggi terapeutici, con il risultato di un sempremaggior tasso d’insuccessi nel controllo e di una diffusionecrescente delle farmacoresistenze nelle popolazioni elminti-che (Jackson e Coop 2000; Cabaret 2000; Bath et al., 2005).A ciò si aggiunga che, ancora oggi, le conoscenze sul con-trollo di queste parassitosi, nei piccoli ruminanti in genere enello specifico per i caprini, sono limitate e l’approccio ge-nerale è quello di eseguire dei trattamenti antielmintici allacieca, in maniera indiscriminata, senza avere informazionisulla specie di parassita presente e sul grado d’infestazionedegli animali. Questa pratica tuttavia è molto discussa a cau-sa dell’insorgenza di resistenze ai più comuni antielminticiusati (Waller 1997; Jackson e Coop 2000) che hanno un’in-cidenza particolarmente elevata nella capra (Cabaret 2000).
Con lo sviluppo di settori zootecnici legati alle cosiddetteSpecie Minori, e ai caprini in modo particolare, grazie anchead una maggiore disponibilità di strumenti diagnostici tec-nologicamente innovativi, sta diventando sempre più radica-ta, soprattutto negli ultimi anni, l’esigenza di affrontare conun approccio più analitico le problematiche relative allo sta-to igienico-sanitario degli allevamenti e conseguentementealle produzioni caprine (carne, latte e derivati).
Il bagaglio di conoscenze acquisite finora in questo cam-po appare, tuttavia, piuttosto disomogeneo, se rapportato al-le singole realtà regionali.
I dati disponibili, seppure localmente consistenti, risulta-no nel complesso ancora frammentari, dal momento che co-prono soltanto alcune delle aree geografiche interessate daquesta realtà e, in modo particolare, le regioni del Mezzo-giorno. Decisamente più lacunose appaiono, infatti, le cono-scenze sullo stato sanitario dei caprini allevati sull’arco alpi-no e prealpino, tenuto conto che negli ultimi anni l’alleva-mento caprino, proprio in queste aree, sta assumendo un ruo-lo meno secondario, perlomeno in ambito locale, in associa-zione anche ad un crescente sviluppo di attività agrituristi-che che puntano proprio su prodotti artigianali di origine ca-prina (Dubeuf et al., 2004).
Più nello specifico, dai dati bibliografici a nostra disposi-zione, si evince che lo studio dei nematodi dell’apparato ga-stroenterico nei caprini è un ambito di ricerca ancora pocosviluppato nel Nord Italia e le informazioni raccolte non so-no rappresentative di tutto il territorio (Genchi et al., 1984ae 1984b; Traldi e Franchi 1987; Di Cerbo et al., 2006).
Diversa è invece la situazione per il Mezzogiorno e la Sar-degna dove, sul modello di altri Paesi europei (Spagna eFrancia in primis), anche di recente, sono stati attivati studiapprofonditi sui parassiti dei caprini che offrono un quadroabbastanza esaustivo del fenomeno per quelle aree (Cara-cappa et al., 1994; Giannetto et al., 1994; Prestera et al.,1994; Veneziano, 2004).
Purtroppo però i risultati ottenuti attraverso questi studinon possono essere esportati al contesto territoriale lombar-do, se non per un eventuale confronto. Questo evidentemen-te se si tiene conto del fatto che sia le tipologie ambientali eclimatiche sia le caratteristiche genetiche delle razze caprineallevate sono diverse da regione a regione e talvolta anche alivello locale.
Da ciò scaturisce l’ipotesi, per altro confermata dai po-chi lavori disponibili per la Lombardia, che vi possano es-sere delle differenze nella composizione della parassitofau-na gastrointestinale nonché nella risposta immunitaria alleinfestazioni da parte delle diverse razze caprine o addirit-tura dei diversi nuclei allevati, differenze che, pertanto,vanno necessariamente indagate su scala locale, anche alfine di meglio calibrare le strategie di lotta. Va sottolineatoche, stanti i caratteri strutturali del comparto, che determi-nano inevitabilmente il persistere delle parassitosi all’in-terno del sistema produttivo caprino, l’obiettivo che ci sideve prefiggere è quello non tanto dell’eradicazione dellafauna elmintica dalle greggi (di per sé impossibile finchépermane la possibilità continua di reinfestazione) quantoquello del suo controllo, attraverso l’adozione di un’oppor-tuna combinazione di trattamenti farmacologici e misuremanageriali, in modo da mantenere le cariche infestanti alivelli compatibili con le produzioni attese e con lo statogenerale di salute del bestiame.
In tale ottica assumono quindi un ruolo rilevante le anali-si di laboratorio di routine per tenere sotto controllo l’effet-tiva carica parassitaria presente e gli eventuali gruppi pro-duttivi maggiormente interessati, la corretta alternanza e do-saggio dei principi attivi, la cadenza stagionale dei tratta-menti in base sia ai momenti del ciclo produttivo che a quel-li del ciclo biologico dei parassiti presenti, l’impiego di far-maci senza residui nel latte allo scopo di poter effettuare lasomministrazione anche durante il periodo di lattazione, checoincide con una fase di grande sviluppo elmintico (VanWyk et al., 2006; Rinaldi et al., 2007).
Il punto di partenza fondamentale è quindi la conoscenzaapprofondita e dettagliata delle specie parassite presenti edelle loro dinamiche stagionali in un dato comprensorio diallevamento, essendo note le strette correlazioni tra ambien-te pedo-climatico e svolgimento dei cicli biologici parassita-ri (Gasnier et al., 1997). Da ciò l’importanza dell’indagineepidemiologica e dell’elaborazione di mappe e modelli rela-tivamente alla diffusione ed alle dinamiche parassitarie neidiversi contesti locali.
Le mastiti nell’allevamento caprino: stato delle conoscenze
Le mastiti rappresentano un’altra problematica sanitariadi rilievo nell’allevamento caprino (Moroni et al., 2002; Pi-soni et al., 2003). Mastiti, soprattutto durante i primi giornidopo il parto, possono incidere negativamente sulla salutedei capretti allevati, con rilevanti perdite economiche del-l’allevamento, e possono veicolare microrganismi potenzial-mente patogeni per l’uomo sia direttamente (es. Salmonella,Lysteria monocytogenes) (Caracappa et al., 1994) o attraver-so tossine di loro produzione (es. Staphylococcus aureus)(Lodi et al., 1994; Mossel & Van Netten, 1990).
I dati a disposizione indicano che con il miglioramentodel management dell’allevamento caprino da latte, si hauna progressiva diminuzione dell’incidenza di infezioni daStaphylococcus aureus, causa delle mastiti gangrenosedella capra, mentre si osserva un concomitante aumentodelle forme provocate da germi di tipo ambientale (Con-treras et al., 1999; Deinhofer e Pernthaner, 1995; Poutrel,1984; Sheldrake et al., 1981; White & Hinckley, 1999).
Introduzione
12
Nel determinismo soprattutto di queste forme di mastite,giocano un ruolo fondamentale le difese immunitarie dellaghiandola mammaria; infatti, la loro riduzione di efficaciaesita in un aumento delle forme cliniche. Nei piccoli rumi-nanti le maggiori difficoltà si incontrano, oltre che nel tipodi secrezione, anche nella determinazione di un correttovalore soglia del contenuto in cellule somatiche che possaessere discriminante tra soggetti con mammella sana ed al-tri con stati patologici a carico della ghiandola mammaria.Nella diagnosi delle mastiti soprattutto di quelle subclini-che, cioè di quelle affezioni per cui la mammella e il latteapparentemente si presentano normali, è stato oggi intro-dotto un ulteriore parametro di valutazione, il conteggiodelle cellule somatiche del latte. Così come da tempo è sta-to adottato nel latte bovino, il contenuto in cellule somati-che del latte caprino, oltre a fornire importanti indicazionidiagnostiche, risulta di notevole utilità nella valutazionedelle caratteristiche igienico-sanitarie del latte (Contreraset al., 1996; Park e Humphrey, 1986). Va tenuto conto pe-rò che gli studi condotti fino ad oggi sulle caratteristichequali-quantitative delle cellule somatiche si riferiscono so-prattutto al latte bovino ed, in misura minore, al latte ovi-no, mentre scarsi e spesso contradditori appaiono i risulta-ti delle ricerche riguardanti il latte caprino (Moroni et al.,2002). Il termine cellule somatiche del latte identifica lacomponente cellulare della secrezione mammaria costitui-ta da elementi epiteliali di derivazione ghiandolare, ma so-prattutto da cellule fagocitarie (polimorfonucleati neutrofi-li e macrofagi) e da linfociti, di derivazione ematica. Il lo-ro numero può subire, durante la lattazione, variazioni fi-siologiche in funzione dell’attività secretoria mammaria(Das Maniak e Singh, 2000; Paape e Capuco, 1997; Whitee Hinckley, 1999; Zeng e Escobar, 1996), ma è special-mente nel corso di processi infiammatori che si osserva unloro notevole incremento (Contreras et al., 1997; Contreraset al., 1999; Deinhofer e Pernthaner, 1995; Las Heras etal., 1999; Poutrel et al., 1997; Poutrel, 1984; Sanchez etal., 1999; Sheldrake et al., 1981; White & Hinckley, 1999).Dal momento che le informazioni disponibili in letteratu-ra, circa l’individuazione di un corretto valore soglia dicellule somatiche che determini lo stato di salute dellamammella nella specie caprina, risultano frammentarie e,spesso, riconducibili a particolari situazioni territoriali eproduttive, risulta evidente come siano necessari opportu-ni approfondimenti al riguardo, che possano meglio chiari-re il dato a livello della produzione di latte caprino nellaregione Lombardia.
FINALITÀ DELLA RICERCA
Il progetto di ricerca “Allevamento caprino in Lombardia:stato igienico-sanitario e produzioni (SANCAPR)” è un con-tributo a due degli obiettivi specifici previsti dal Program-ma Regionale di ricerca in campo agricolo: miglioramentodell’efficienza degli allevamenti convenzionali e biologici edelle prestazioni produttive e riproduttive degli animali(comparto zootecnico e foraggicoltura) e miglioramento del-la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari (compartoproduzioni di origine animale).
Nell’ambito del primo obiettivo, lo scopo del progetto èstato quello di valutare lo stato sanitario dell’allevamento ca-prino lombardo attraverso lo studio delle infestazioni paras-sitarie, specificatamente del tratto gastroenterico, e delle in-fezioni dell’apparato mammario (mastiti), con il fine ultimodi fornire degli elementi pratici all’allevatore per implemen-tare quali-quantitativamente la produzione di latte caprino. Ilpiano di lavoro ha visto il coinvolgimento delle diverse real-tà produttive presenti sul territorio lombardo; in particolarelo studio è stato condotto su allevamenti medio-grandi e pic-coli, a gestione più tradizionale, che rappresentano una real-tà importante sia per lo sfruttamento del territorio sia perchélegati a produzioni tipiche o di nicchia.
Per quanto attiene gli aspetti parassitologici, come già evi-denziato in precedenza, le informazioni relative ai parassitisono particolarmente carenti nella nostra regione e in questaspecie ospite. Le indagini ad oggi effettuate, peraltro di tipopuramente conoscitivo sulla diffusione dei nematodi ga-strointestinali e broncopolmonari della capra, riguardano al-levamenti in provincia di Varese (Traldi e Franchi 1987) eanimali al pascolo in Valtellina (Genchi et al., 1984a e1984b). Si è pertanto ritenuto necessario effettuare uno stu-dio più approfondito ed analitico sulle infestazioni parassita-rie e in particolare sulle infestazioni da nematodi gastrointe-stinali, tenuto conto dell’impatto che le parassitosi hannosulle produzioni animali e soprattutto su quelle caprine. Lamancanza allo stato attuale di dati epidemiologici sulle pa-rassitosi dei caprini in Lombardia non consente, inoltre, diapplicare delle corrette strategie antiparassitarie.
Relativamente al secondo obiettivo, il progetto è stato fi-nalizzato a monitorare la produzione di latte caprino al finedi valutarne le principali caratteristiche igienico-sanitarie, agaranzia di salubrità del prodotto per i consumatori. La cre-scita dell’allevamento caprino da latte e l’aumentata doman-da di prodotti derivati dal suddetto allevamento richiedono,di fatto, maggiori controlli e monitoraggi più estesi, soprat-tutto in base al fatto che molti derivati del latte caprino nonvengono sottoposti in fase di lavorazione a temperature talida poter eliminare tutti i patogeni potenzialmente zoonosicipresenti. Particolare attenzione è stata, infatti, rivolta agliagenti zoonosici, attraverso la valutazione sul latte di massadella presenza di germi quali Salmonella e Listeria, che pos-sono sopravvivere nei prodotti caseari a lavorazione presa-mica causando problemi di salute pubblica.
Il controllo dello status batteriologico del latte degli ani-mali allevati, unitamente al monitoraggio del contenuto incellule somatiche, in rapporto con le infezioni mammarie, edal confronto di questi dati con l’eventuale presenza nel lattelavorato di batteri patogeni per i consumatori, risultano per-tanto i punti fondamentali per garantire la sanità pubblicacollegata al consumo di questi alimenti.
I risultati della ricerca permettono di incrementare le co-noscenze relative sia agli aspetti parassitologici sia alle infe-zioni dell’apparato mammario nell’allevamento caprino. Leinformazioni collezionate si configurano, peraltro, qualestrumento utile alla definizione di protocolli operativi da for-nire all’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia(ARAL) e alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA), fi-nalizzati ad una più proficua gestione sanitaria della mandriae ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
13
Enti coinvoltiIl Progetto si è avvalso della collaborazione dell’Associa-
zione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) in qua-lità di Ente consulente. La partecipazione di questo Ente è ri-sultata di fondamentale importanza in quanto ha consentitodi realizzare il Progetto e svolgere le attività previste in ma-niera più rispondente alla realtà produttiva dell’allevamentocaprino in Lombardia. Nello specifico, la partecipazione del-l’ARAL è stata determinante per la scelta degli allevamentiin cui effettuare il campionamento e per i dati relativi alla
Introduzione
produzione di latte degli animali. La consulenza dell’ARALè anche stata cruciale per l’effettiva possibilità di divulgareconoscenze, attraverso la consulenza fornita alle aziende daitecnici SATA, utili a rendere concreto l’utilizzo di correttiprotocolli sia per la sanità della mammella sia per il control-lo delle infestazioni da nematodi gastrointestinali.
Articolazione della ricercaIl progetto SANCAPR, iniziato nel 2005, ha avuto una du-
rata triennale e si è articolato in diverse linee di ricerca:
PRIMA PARTE: INDAGINI PARASSITOLOGICHE
Linea di ricerca 1 Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi in relazione alla ti-pologia d’allevamento, al management, alle caratteristiche territoriali.
Linea di ricerca 2 • Interazione tra infestazioni da nematodi gastrointestinali (STRONGYLIDA), produzioni e carat-teristiche igieniche del latte.
• Strategie di controllo dei nematodi gastrointestinali (STRONGYLIDA) nell’allevamento caprinolombardo.
Linea di ricerca 3 Presenza di farmacoresistenza ai nematodi gastrointestinali (STRONGYLIDA) nell’allevamentocaprino lombardo.
SECONDA PARTE: INDAGINI SULLE INFEZIONI MAMMARIE
• Diffusione delle mastiti negli allevamenti caprini in relazione alla tipologia di allevamento, al management, alle carat-teristiche territoriali.
• Definizione del valore soglia di cellule somatiche per definire qualitativamente il latte di capra.
• Indagine sul rapporto tra stato igienico-sanitario della capra da latte e presenza nel latte di massa di batteri patogeni peril consumatore.
15
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarienegli allevamenti caprini lombardi in relazionealla tipologia d’allevamento, al management, alle caratteristiche territoriali
INTRODUZIONE
In Italia i parassiti sono responsabili, a livello nazionale,del 6% delle perdite economiche in ambito agricolo. È statostimato che, nella pecora e nella capra, i parassiti sono coin-volti nell’80% delle patologie osservate (Torina et al., 2004).L’infestazione da parte di nematodi gastrointestinali ricondu-cibili a generi quali Teladorsagia, Haemonchus, Trichostron-gylus ed Oesophagostomum, che elettivamente, a seconda del-la specie, si localizzano nell’abomaso e/o nei vari tratti del-l’intestino, costituisce, di fatto, uno dei fattori sanitari limitan-ti più rilevanti nel sistema di produzione dei piccoli ruminan-ti con conseguenze che vanno dalla riduzione delle perfor-mances produttive alla mortalità (Sykes 1994, Waller 1999).
In ambito europeo, le perdite relative alla produzione dilatte riconducibili agli effetti del parassitismo variano tra il2,5% ed il 18,5% a seconda del contesto di allevamento. Pa-rallelamente ad un calo produttivo inteso come minore quan-tità di latte prodotto nel corso della lattazione e, più a lungotermine, in tutta la carriera produttiva (Hoste et al., 2005), èstato notato anche un peggioramento sostanziale nelle carat-teristiche compositive dello stesso latte prodotto, rilevandoun calo del tenore di grasso (29,9%), di proteina (23,3%) edi lattosio (19,6%) (Rinaldi et al., 2007). Tali perdite si os-servano di norma in situazioni di parassitismo subclinico.
Il meccanismo patogenetico generale in situazioni di pa-rassitismo subclinico può facilmente essere assimilato aquello di un disordine nutrizionale, nel senso che l’azionedegli elminti parassiti si manifesta attraverso un calo dell’in-gestione di sostanza secca, una diminuzione dell’efficienzadigestiva ed una deviazione dei nutrienti alimentari dallefunzioni di produzione ed omeostasi alla riparazione deidanni tissutali ed all’elaborazione delle risposte difensive(Rinaldi L. et al., 2007).
La conoscenza dell’epieziologia delle infestazioni paras-sitarie è un elemento indispensabile per il controllo sosteni-bile dei nematodi, in quanto questi parassiti interagisconocon l’ospite in uno specifico clima, ambiente di produzionee management.
In Lombardia, sono disponibili solo pochi dati sulla diffu-sione delle infestazioni parassitarie e sul loro reale impatto sul-la produzione di latte e carne negli allevamenti ovicaprini. Loscopo del lavoro è stato quello di valutare la diffusione delle in-
festazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi in re-lazione ai principali fattori di rischio, quali struttura e manage-ment aziendale e parametri individuali dei capi esaminati.
MATERIALI E METODI
Lo studio, finalizzato ad accertare la presenza dei parassi-ti gastrointestinali (G.I.) nelle capre e a valutarne la diffu-sione negli allevamenti della Lombardia, ha visto coinvolteprincipalmente le province dei settori alpini e prealpini conmaggior concentrazione di bestiame caprino (Bergamo, Bre-scia, Como, Lecco, Sondrio, Varese), in quanto più rappre-sentative per questo settore zootecnico; sono state inoltre in-cluse nel campionamento anche alcune aziende ricadentinella zona collinare dell’Oltrepò pavese.
È stata acquisita la banca dati regionale che, per le pro-vince coinvolte, include un totale di 3086 aziende caprine.Come base dati informativa territoriale, è stata acquisita laBase Dati Geografica di Sintesi della Regione Lombardia(vers. 1.2, 2003). In particolare, sono stati utilizzati gli stra-ti informativi relativi ai confini amministrativi (provinciali ecomunali) e i layer tematici su altimetria e uso del suolo.
Tutte le aziende presenti nell’area di studio sono stategeoreferenziate. È stata costruita una griglia 10x10 km di la-to per individuare le aree con maggiore concentrazione diaziende (Figura 1).
La scelta delle unità di campionamento (allevamenti) èavvenuta consultando sia il database regionale sia la bancadati del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SA-TA) per poter usufruire in fase operativa di un supporto tec-nico da parte dell’ARAL.
Sono stati selezionati 110 allevamenti; per ognuno di que-sti sono stati rilevati i dati su topografia, struttura (numero dicapi allevati e relative razze) e management aziendale (tipo-logia di allevamento, utilizzo del pascolo, separazione grup-pi produttivi, disinfezione strutture, tipo di rimonta) nonché,ove disponibili, i dati individuali dei capi esaminati, anchecon l’ausilio di appositi questionari consegnati ai proprietaridelle aziende incluse nello studio. Gli allevamenti sono statiraggruppati in 4 categorie di ampiezza: aziende a conduzio-ne familiare (meno di 30 capre), medio-piccole (31-60 ca-pre), medie (61-100 capre), grandi (più di 100 capre).
16
Sono stati raccolti i campioni fecali, con prelievo dall’am-polla rettale, su un totale di 2.554 capre; sono stati eseguitiesami copromicroscopici quali-quantitativi, mediante flotta-zione con soluzione di nitrato di sodio e zucchero (densi-tà=1300). La determinazione del numero medio di uova/g difeci (upg) (Raynaud 1970) è stata effettuata con una tecnicaquantitativa (McMaster modificata, MAFF, 1986). I valori diupg sono stati calcolati per tutti i nematodi, ad eccezione diSkrjabinema e Moniezia. L’identificazione delle uova è statafatta a livello di genere; solo per i cestodi si è arrivati al-l’identificazione di specie. L’infezione da Eimeria è stata va-lutata solo attraverso analisi qualitative.
Per la statistica descrittiva, l’analisi non parametrica e la re-gressione logistica è stato utilizzato il software SPSS vers.16.0. Uno screening univariato con metodi non parametrici èstato utilizzato per la scelta delle variabili indipendenti da uti-lizzare nei modelli di regressione logistica costruiti per analiz-zare il dato “presenza/assenza” dei parassiti gastrointestinali.
RISULTATI
Caratterizzazione aziendaleLe informazioni ottenute attraverso i questionari e i dati
estrapolati dalle analisi spaziali (altimetria e uso del suolo) han-no permesso di caratterizzare per tipologie di struttura e mana-gement le aziende caprine oggetto dello studio (Tabelle 1-2).
È emerso che il 90,8% delle aziende si trova a quote infe-riori ai 1000 m s.l.m. (min-max: 100-1300 m s.l.m.).
Per quanto concerne il sistema di allevamento e la consi-stenza delle greggi, differenze significative sono state ri-scontrate a livello provinciale (test di Kruskall Wallis: en-trambe p<0,01). In particolare, le aziende situate nelle pro-
vince più occidentali (Varese, Co-mo e Lecco) sono risultate preva-lentemente a conduzione familiareo di medie dimensioni (numeromedio di capre allevate ± SD, me-diana e range: Varese 55,3±37,1,43,0 e 8-140; Como 41,6±18,6,40,0 e 5-77; Lecco 43,0±46,3, 37,0e 9-161). Nella provincia di Son-drio e Bergamo la tipologia di alle-vamento principale è quella intensi-va e la consistenza di capi nelleaziende è mediamente più elevata(numero medio di capre allevate ±SD, mediana e range: Sondrio113,2±78,8, 87,5 e 24-283; Berga-mo 89,2±145,8, 55,0 e 18-840). Lerazze più comuni sono risultate laSaanen e la Camosciata (allevate ri-spettivamente nel 59,6% e 42,3%degli allevamenti oggetto di stu-dio), cosmopolite e con elevata vo-cazione alla produzione di latte.Tuttavia, in alcune aziende, si è re-gistrata la presenza anche di razzeautoctone quali la Nera di Verzasca(7,7% degli allevamenti), la Bionda
dell’Adamello (2,9%), la Frisa valtellinese (1,9%), la Laria-na (o di Livo) (1,9%) e l’Orobica (2,9%).
La maggior parte delle aziende medio-grandi effettuanotrattamenti disinfettanti; tale pratica risulta tuttavia inusualenegli allevamenti a carattere familiare con meno di 30 capre.
Il 60% degli allevatori durante il periodo di studio ha trat-tato almeno una volta le capre con un antielmintico.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 1 - Mappa coropletica sulla consistenza di aziende caprine in ciascun quadratodella griglia (10x10 km di lato) e distribuzione spaziale delle aziende esaminate (cerchi).
Caratterizzazione Aziende per consistenza di capreaziendale % (n°)
TABELLA 1 - Caratterizzazione aziendale secondo le diverseclassi di ampiezza (numero di capi allevati).
Consistenza capi 5-30 31-60 61-100 101-804capre capre capre capre
(n° aziende) (21) (51) (23) (15)
Quota < 500 52,4 (11) 45,1 (23) 39,1 (9) 73,3 (11)m s.l.m 501-1000 42,8 (9) 49,0 (25) 39,1 (9) 20 (3)
> 1000 4,8 (1) 5,9 (3) 21,8 (5) 6,7 (1)
Pascolo si 47,6 (10) 45,1 (23) 47,8 (11) 13,3 (2)
Tipologia Estensivo 19,0 (4) 15,7 (8) 13,0 (3) 6,7 (1)allevamento Intensivo 52,4 (11) 74,5 (38) 65,3 (15) 66,7 (10)
Semi-estensivo 9,5 (2) 5,9 (3) 13,0 (3) 20 (3)n.d. 14,3 (3) 5,9 (3) 8,7 (2) 6,7 (1)
Produzione si71,4 (15) 92,1 (47) 86,9 (20) 80 (12)latte/formaggio
Separazione no 47,6 (10) 35,3 (18) 17,4 (4) 13,3 (2)in gruppi Stalla 9,5 (2) 5,9 (3) 0 (0) 0 (0)
Box 9,5 (2) 13,7 (7) 4,3 (1) 13,3 (2)Entrambe 14,3 (3) 41,2 (21) 69,6 (16) 60 (9)n.d. 19,1 (4) 3,9 (2) 8,7 (2) 13,3 (2)
Disinfezione si 33,3 (7) 70,6 (36) 78,3 (18) 73,3 (11)
Trattamenti Entro66,7 (14) 74,5 (38) 65,2 (15) 60 (9)antielmintici 12 mesi
Terreno Bosco Boschi Foreste di Foreste di Pascolo Incolto Aree Area Totale
n° capiagricolo agricolo conifere latifoglie ad latifoglie sterili urbana
alto fusto deciduen° n° n° n° n° n° n° n° n° n°
17
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi
Parametro Indice Bergamo Brescia Como Lecco Sondrio Varese Pavia
TABELLA 2 - Caratteristiche degli allevamenti caprini esaminati in ciascuna provincia.
n° aziende n° 32 19 13 9 10 21 6
Quota Media 500 400 500 300 550 600 150m s.l.m. Min-max 100-1200 100-1000 200-1200 300-600 300-1300 300-1000 300-1000
Dimensione Media±DS 89,2±145,8 70,5±43,5 41,6±18,6 43,0±46,3 113,2±78,8 55,3±37,1 39,2±32,7del gregge Min-max 18-840 13-210 5-77 9-161 24-283 8-140 7-93
n° capre Media±DS 27,4±16,6 23,9±9,0 17,1±7,3 15,4±6,7 32,7±21,3 20,6±13,1 17,2±7,4esaminate Min-max 5-90 10-39 5-29 8-30 13-86 6-55 7-28
n° aziende Saanen 23 5 3 6 5 2 n.r.per razza Camosciata 12 12 10 3 9 16 n.r.allevata Nera di Verzasca 0 0 2 0 0 6 n.r.
Toggenburg 0 0 0 0 0 1 n.r.Di Livo 0 0 2 0 0 0 n.r.Orobica 2 0 0 0 1 0 n.r.Nubiana 1 0 0 0 0 0 n.r.Meticce - incroci 2 1 1 1 2 1 n.r.Bionda Adamello 0 3 0 0 0 0 n.r.Frisa Valtellinese 0 0 0 0 2 0 n.r.
n° aziende Estensivo 2 1 6 3 0 6 n.r.per tipologia Intensivo 30 16 6 6 5 12 n.r.allevamento Semi-estensivo 0 1 1 0 3 3 n.r.
n.d. 0 1 0 0 2 0 n.r.
Pascolo no 21 12 6 4 4 7 n.r.n° aziende si 11 5 7 5 4 14 n.r.
n.d. 0 2 0 0 0 0 n.r.
TABELLA 3 - Classificazione delle aziende secondo la dimensione del gregge e le caratteristiche ambientali dell’area circostante.
≤ 30 7 0 0 0 8 2 1 0 3 21(33,3%) (38,1%) (9,5%) (4,8%) (14,3%) (100%)
31-60 16 0 2 1 9 15 4 1 3 51(31,4%) (3,9%) (2%) (17,6%) (29,4%) (7,8%) (2%) (5,9%) (100%)
61-100 5 1 2 1 4 8 1 0 1 23(21,7%) (4,3%) (8,7%) (4,3%) (17,4%) (15,7%) (4,3%) (4,3%) (100%)
> 100 5 1 0 1 3 3 0 0 2 15(33,3%) (6,7%) (6,7%) (20%) (20%) (13,3%) (100%)
Totale 33 2 4 3 24 28 6 1 9 110(30%) (1,8%) (3,6%) (2,7%) (21,8%) (25,4%) (5,4%) (0,9%) (8,2%) (100%)
P: prevalenza (valore in percentuale); IC: intervallo di confidenza; A: abbondanza media; I: intensità media; DS: deviazione standard.
Parassita P (95% IC) A ± DS I ± DS Max upg
TABELLA 4 - Risultati degli esami copromicroscopici. Indici epidemiologici dei parassiti g.i. nelle capre esaminate (n° = 2554).
Moniezia benedeni 7,6 (6,7-8,7) – – –
Strongyloides spp. 17,5 (16,1-19,1) 13,1±79,9 117,5±211,7 2268
Strongylida 35,6 (33,8-37,5) 163,7±604,4 532,4±996,5 9171
Nematodirus spp. 10,8 (9,7-12,12) 6,1±184,3 53,5±52,9 433
Skrjabinema spp. 24,7 (23,1-26,4) – – –
Trichuris spp. 10,4 (9,2-11,7) 6,2±32,4 74,6±86,2 734
Capillaria spp. 0,5 (0,3-0,8) 0,2±2,2 33,3±0 33
Marshallagia spp. 0,1 (0,02-0,3) 0 – 0
Eimeria spp. 91,8 (90,3-92,4) – – –
Totale 96,0 (95,1-96,7) 230,9±530,0 410,3±855,7 9171
può essere considerata sporadica (prevalenze < 1%). I risul-tati sono riassunti in Tabella 5.
La distribuzione territoriale di Skrjabinema, Strongylida eMoniezia benedeni è risultata non uniforme tra le province(test di Kruskall Wallis: p<0,01, p<0,01 e p<0,05, rispettiva-mente), con prevalenze più elevate in quelle di Lecco, Vare-se e Como (Figg. 2-4).
Casi di co-infestazione si sono verificati nella quasi totalitàdelle aziende e nel 65% dei soggetti (media±DS=1,99±1,04;mediana=2,0; varianza=1,08) (Figure 5 e 6).
18
Per quanto attiene la caratterizzazione territoriale del-l’area circostante le aziende caprine è risultato che il 30% èsituato in aree coltivate, il 25,4% presso aree a pascolo, il21,8% in vicinanza di boschi cedui o aree urbane (9,1%),mentre la restante percentuale (14,6%) presso boschi di co-nifere o altre tipologie forestali oppure in aree incolte (Tab.3). Non sono state riscontrate differenze significative tra ilnumero di capre allevate per azienda e le varie tipologie re-lative alla copertura del suolo (Kruskall Wallis: p>0,05).
Quasi tutte le capre esaminate sono risultate infestate daparassiti (96%). Nei campioni fecalianalizzati sono stati rinvenuti i seguentitaxa parassitologici: Cestoda (Monieziabenedeni), Nematoda (Strongyloidesspp., Strongylida, Nematodirus spp.,Skrjabinema spp., Trichuris spp., Capil-laria spp., Marshallagia spp.) Coccidia(Eimeria spp.).
La prevalenza e il valore medio di upgsono stati calcolati per ciascun gruppo diparassita sul campione totale di capreesaminate (n° capi=2554) (Tab. 4).
È stata valutata, inoltre, la distribuzio-ne dei parassiti G.I. per unità di campio-namento (n° aziende=110). I coccidi (Ei-meria) sono risultati ad elevata diffusionein tutto il territorio considerato(P=91,8%), con prevalenze a livelloaziendale tra l’8,3% e il 100%. I generiSkrjabinema, Strongyloides, Nematodi-rus e Trichuris seppure meno comuni,hanno comunque fatto registrare local-mente valori di prevalenza anche supe-riori al 70-80%. La presenza di Marshal-lagia e Capillaria nelle capre lombarde
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Parassita Indice Media±DS Min-max Asimmetria Curtosi 1° quartile Mediana 3° quartile
TABELLA 5 - Statistica riassuntiva sulla distribuzione dei parassiti nelle unità di campionamento (n° = 110 aziende).
Moniezia benedeni A – – – – – – –P (%) 8,37±14,26 0-58,33 1,81 5,31 0 0 11,43
Strongyloides spp.A 9,32±20,92 0-131,81 3,76 18,87 0 1,5 7,94
P (%) 15,46±21,39 0-84,62 1,82 5,71 0 7,59 23,08
StrongylidaA 212,77±505,07 0-2984,8 3,39 14,93 0 17,17 137,04
P (%) 39,66±40,01 0-100 0,33 1,39 0 20,55 82,72
Nematodirus spp.A 1,88±6,18 0-48,36 5,34 35,35 0 0 1,08
P (%) 11,85±20,52 0-80 1,97 5,99 0 0 14,3
Skrjabinema spp.A – – – – – – –
P (%) 24,41±23,18 0-87,5 0,90 3,09 5 20 39,39
Trichuris spp.A 6,79±12,18 0-59 2,75 10,44 0 2,22 7,15
P (%) 12,12±15,44 0-70 1,68 5,58 0 6,67 18,18
Capillaria spp.A 0,17±0,65 0-4,76 4,64 27,10 0 0 0
P (%) 0,54±2,34 0-14,29 4,78 25,90 0 0 0
Marshallagia spp.A – – – – – – –
P (%) 0,07±0,76 0-8 10,34 108,01 0 0 0
Eimeria spp.A – – – – – – –
P (%) 91,94±17,26 8,33-100 -3,18 13,29 92 100 100
Totale A 230,94±503 0-2990,4 3,36 14,80 7,7 43,03 161,99P (%) 92,03±23,55 0-100 -3,41 13,28 97,44 100 100
A: abbondanza media; P: prevalenza; DS: deviazione standard.
FIGURA 2 - Mappa quantitativa sulla prevalenza di Moniezia benedeni e Nematodi-rus spp. nelle aziende lombarde.
Differenze significative sono emersetra le diverse province (test di KruskallWallis: p<0,001), con una maggiore ric-chezza in termini di numero di taxa/ca-po nelle aree più occidentali e in quellasettentrionale.
È stato inoltre calcolato il totale di ta-xa rinvenuti per ciascuna azienda e ne èstata valutata la frequenza di distribuzio-ne (Fig. 7).
Una correlazione altamente positiva èemersa tra la ricchezza per azienda e ilpascolo ma anche nel caso delle aziendeche praticano l’allevamento estensivo(test di Correlazione di Spearman: en-trambe p<0,001).
L’analisi quantitativa ha evidenziatodifferenze nel numero medio di escrezio-ne di uova (upg) tra le province considera-te, nel caso dei nematodi Strongyloides,Nematodirus e Strongylida (Tab. 6) chehanno presentato livelli di infestazionemaggiori nelle province di Varese e Son-drio. Le infestazioni parassitarie sono sta-te relazionate con i dati topografici azien-dali ricavati dagli strati informativi temati-ci (layer) su quote e copertura del suolo.Per quest’ultima variabile ambientale, pernessuno dei parassiti sono emerse diffe-renze significative tra le upg medie inazienda. I fattori significativamente asso-ciati alla presenza dei parassiti sono risul-tati: la tipologia di allevamento (M. bene-deni, Strongyloides), la consistenza nume-rica di capre in azienda (Strongyloides), laquota (M. benedeni, Nematodirus, Stron-gylida), il pascolo (Strongylida) e il fatto-re stagionale (M. benedeni).
Nelle Figure 8-13 si riportano le map-pe quantitative che mostrano il valoremedio di upg all’interno delle diversearee comunali.
Fattori di rischioAllo scopo di valutare quali fattori di
rischio siano in grado di influire sulla in-festazione parassitaria è stato utilizzato ilmodello di regressione logistica conside-rando i soggetti positivi/negativi per pa-rassiti (Tab. 7).
I fattori significativamente associati al-la presenza di parassiti sono stati il sistema d’allevamento(estensivo per Moniezia; semi-estensivo per Strongyloides);la dimensione dell’azienda (oltre 100 capre per Strongyloi-des); l’altitudine (tra i 500 m ed i 1000 m slm per Monieziae Strongylida; anche sopra i 1000 m slm per Nematodirus);il pascolo (Strongylida); la stagione (autunno per Moniezia);la separazione delle capre in gruppi (Skrjabinema).
I dati quantitativi relativi ai nematodi sono stati analizza-ti con un test statistico non parametrico per identificare qua-
19
li parametri relativi all’animale potrebbero essere maggior-mente associati con il livello di escrezione di uova di paras-siti (Tab. 8). I risultati hanno mostrato che le capre alla pri-ma lattazione erano significativamente più infestate daStrongylida e Trichuris rispetto alle pluripare (test di Kru-skall Wallis, in entrambi i casi p <0,001). L’escrezione diuova di Strongyloides è stata più elevata nelle femmine ingravidanza (test U di Mann Whitney: p<0,001). Delle diffe-renze sono emerse anche per Nematodirus e Strongylida
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi
FIGURA 3 - Mappa quantitativa sulla prevalenza di Strongylida e Trichuris spp. nelleaziende lombarde.
FIGURA 4 - Mappa quantitativa sulla prevalenza di Skrjabinema spp. e Strongyloidesspp. nelle aziende lombarde.
20
(test U di Mann Whitney: p<0,05 e p<0,001, rispettivamen-te), ma i valori upg relativi a questi nematodi sono risultatisignificativamente più elevati nei soggetti non gravidi. Il piùalto livello di infestazione da Strongylida è stato riscontra-to nelle capre in lattazione (test U di Mann Whitney:p<0,001), mentre le capre in asciutta sono risultate signifi-cativamente più infestate da Trichuris e Strongyloides (testU di Mann Whitney: p<0,05 e p<0,001, rispettivamente).Per tutti i nematodi sono state osservate differenze stagio-nali nell’eliminazione di uova, con i valori di upg significa-tivamente più elevati in estate per Strongylida ed in prima-vera per tutti gli altri nematodi.
Esami necroscopiciGli esami necroscopici hanno messo in evidenza la pre-
senza di nematodi gastrointestinali, appartenenti all’ordineStrongylida, superfamiglia Trichostrongyloidea, nell’85%degli abomasi ispezionati. Circa metà dei campioni esami-nati era caratterizzata da un’infestazione a carattere mono-specifico, mentre i campioni restanti possedevano un nume-ro di specie elmintiche compreso tra 2 ed 8.
Teladorsagia circumcincta risulta laspecie elmintica maggiormente diffusaall’interno del campione considerato,raggiungendo una prevalenza del 70%.Sia i valori di abbondanza media chequelli di intensità media sono a loro vol-ta elevati (99,75 e 142,5 rispettivamente),testimoniandone il ruolo di principale pa-rassita abomasale nella capra (Tab. 9).
I dati relativi all’infestazione intestina-le sono riportati nelle Tabelle 10 e 11.
L’esame necroscopico dei fegati haevidenziato la presenza di Dicrocoeliumdendriticum in 5 animali (prevalenza del38,5%); il 30,8% dei polmoni sono risul-tati essere parassitari da metastrongili(generi Muellerius e Protostrongylus).
Infine, in corso di necroscopia, sonostate repertate in due animali delle for-mazioni cistiche mesenteriche riconduci-bili a stadi larvali del cestode Taenia hy-datigena (cysticercus tenuicollis).
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 6 - Ricchezza parassitaria nelleaziende e nelle province.
Figura 6A - Le barre rappresentano per cia-scuna azienda la proporzione di capre perciascuna classe di ricchezza parassitaria(numero di taxa/capo) rispetto al totale dicapre esaminate nell’azienda.
Figura 6B - Il grafico a scatola mostra lamediana, il 1° e 3° quartile, i valori minimi emassimi della distribuzione della ricchezzaparassitaria (numero taxa/capo) nelle singo-le province.
FIGURA 5 - Frequenza del numero di taxa parassitari rinvenutiper capo.
6A
6B
21
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La presente ricerca ha permesso di tracciare un quadroaggiornato ed esaustivo a riguardo delleproblematiche parassitologiche del trat-to gastroenterico nel contesto dell’alle-vamento caprino lombardo.
Lo studio, condotto sugli allevamenticaprini delle diverse province, ha messoin evidenza una situazione particolar-mente importante dal punto di vista pa-rassitologico, caratterizzata da una preva-lenza d’infestazione del 98,9%, e che ve-de coinvolti allevamenti di varie tipologie(da quelli intensivi a quelli estensivi). Perquanto riguarda gli elminti sono risultateprevalenti le infestazioni da Strongylida.In particolare, tali parassitosi sono diffu-se anche nell’allevamento cosiddetto in-tensivo in cui gli animali sono allevati incompleta assenza di pascolo o l’esistenzadi un parchetto consente l’uscita quoti-diana degli animali. Sono presenti dun-que parassiti cui generalmente si imputa-no le minori produzioni che si osservanonell’allevamento caprino conseguenti al-la morte dell’animale, alla riduzione del-la produzione di lana e di carne, all’au-
mento del tempo richiesto per raggiungere il peso commer-ciale o quello riproduttivo ed al costo del controllo dei pa-rassiti stessi (Waller 1999). Altre parassitosi che appaiono
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi
FIGURA 7 - Frequenza della distribuzione della ricchezza parassitaria per azienda, con le statistiche riassuntive.
Provincia Strongyloides spp. Strongylida Nematodirus spp. Trichuris spp. Capillaria spp.A ± DS A ± DS A ± DS A ± DS A ± DS
TABELLA 6 - Abbondanza media di upg nelle capre rispetto alla provincia di provenienza (*** p<0.001).
BG (n°=876) 5,71±23,11 61,45±211,24 0,95±7,16 6,13±28,24 0,04±1,13
BS (n°=454) 7,51±36,76 105,13±526,56 2,58±24,32 3,90±17,52 0,15±2,21
CO (n°=218) 11,78±47,48 102,19±315,83 2,29±11,97 10,10±38,69 0,46±3,89
LC (n°=144) 29,41±194,84 36,13±136,43 0,23±2,78 3,47±15,63 0,00±0,00
PV (n°=103) 0,97±5,64 23,31±120,23 0,32±3,29 1,62±7,20 0,00±0,00
SO (n°=327) 36,41±125,59 75,88±318,72 4,90±18,56 5,81±38,88 0,10±1,84
VA (432) 14,28±93,17 591,27±1178,58 1,00±5,70 8,88±46,51 0,31±3,20
p-value *** *** *** n.s. n.s.
FIGURA 8 - Mappa coropletica con range di abbondanza totale di upg nei comuniindagati.
22
diffuse nell’allevamento intensivo sono quelle sostenute daigeneri Strongyloides e Skrjabinema. Il primo ha una migra-zione endogena complessa che vede coinvolti vari apparati e,soprattutto nei soggetti giovani che acquisiscono l’infesta-zione precocemente mediante ingestione delle larve infe-stanti contenute nel colostro e nel latte, può rappresentare unimportante patogeno di per sé, oltre a favorire l’insediamen-to di ulteriori microorganismi. Per quanto attiene Skrjabine-ma poco noti sono gli effetti patogeni e quelli sulla produ-zione di questo nematode. Alcuni autori segnalano irritazio-ni a livello cutaneo (nella regione perineale) che potrebbero
contribuire ad esacerbare gli effetti imputabili alla presenzadi altri parassiti.
Nello specifico, sono state riscontrate correlazioni alta-mente significative indicanti un diretto rapporto tra l’attivitàdi pascolo e l’andamento dell’escrezione parassitaria, convalori costantemente superiori negli animali stabulati, so-prattutto per quanto riguarda gli elminti appartenenti agliStrongylida. Il dato è in linea con quanto riportato in lavorieseguiti sia in zone limitrofe a quella di studio (Di Cerbo etal., 2006), che al di fuori del contesto nazionale (Gasnier etal., 1997; Vallade et al., 2000).
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 9 - Mappa corople-tica con range di abbondan-za di Strongylida nei comu-ni indagati.
FIGURA 10 - Mappa coro-pletica con range di abbon-danza di Strongyloides neicomuni indagati.
23
Sebbene i risultati di questa ricerca rappresentino un ap-profondimento rispetto ai dati precedenti, ancora moltiaspetti restano da indagare. Durante il periodo di indaginesia le osservazioni personali, sia il rapporto continuo e diret-to con gli allevatori ed i medici veterinari di campo, hannoevidenziato la presenza sul territorio di una serie ulteriore di“criticità” in campo parassitologico che meriterebbero di es-sere investigate approfonditamente.
Il reperto pressoché costante di protozoi del genere Eime-ria nella quasi totalità degli allevamenti campionati, unita-mente alla segnalazione di gravi e frequenti episodi patolo-
gici a carico dei giovani capretti, suggerisce la necessità diun approfondimento ulteriore per quanto riguarda diffusionee patogenicità di protozoi quali appunto Eimeria, ma ancheCryptosporidium e Giardia.
Per altro, la presenza di alcune specie di nematodi abo-masali tipiche di ruminanti selvatici è indice di una forte in-terazione tra ruminanti domestici e la fauna selvatica nel-l’area di studio. Tale fenomeno è documentato oltre che daidati parassitologici anche dalle osservazioni di campo.
I ruminanti selvatici rappresentano un serbatoio di paras-siti trasmissibili ai domestici e in primo luogo rientrano al-
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi
FIGURA 11 - Mappa coro-pletica con range di abbon-danza di Nematodirus neicomuni indagati.
FIGURA 12 - Mappa coro-pletica con range di abbon-danza di Trichuris nei comu-ni indagati.
24
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Parametro capraTest non
Strongyloides spp. Strongylida Trichuris spp. Nematodirus spp.parametrico
TABELLA 8 - Sintesi dei risultati del test non parametrico sui parametri individuali delle capre rispetto all’infestazione parassitaria.
Chi-quadrato 5,854 16,920 40,313 3,823Numero di lattazioni df 2 2 2 2
(p-value) (0,054) (0,000) (0,000) (0,148)
Chi-quadrato 357892,00 263759,500 367032,500 370577,500Gravidanza df 1 1 1 1
(p-value) (0,000) (0,000) (0,051) (0,027)
Chi-quadrato 413217,00 312857,000 408036,500 421109,000Lattazione df 1 1 1 1
(p-value) (0,027) (0,000) (0,001) (0,082)
Chi-quadrato 35,39 306,515 9,285 25,501Stagione df 3 3 3 3
(p-value) (0,000) (0,000) (0,026) (0,000)
Parassita Fattore di rischio Odds Ratio 95% CI Wald P-value
TABELLA 7 - Sintesi dei risultati del Test di Regressione logistica applicato ai parassiti G.I. rispetto ai fattori di management aziendale.
Stagione (Autunno) 0,21 0,061-0,74 0,015
Moniezia benedeni Allevamento estensivo 0,099 0,015-0,659 0,017
Altitudine (500-1000 m s.l.m.) 3,34 1,160-9,606 0,025
Strongyloides spp.Dimensione del gregge (>100 capre) 16,135 1,790-145,47 0,013
Allevamento semi-estensivo 0,102 0,014-0,756 0,025
StrongylidaPascolo 5,78 1,61-20,77 0,007
Altitudine (500-1000 m s.l.m.) 5,64 1,87-16,99 0,002
Nematodirus spp.Altitudine (500-1000 m s.l.m.) 3,348 1,357-8,259 0,009
Altitudine (>1000 m s.l.m.) 9,049 1,490-54,967 0,017
Skrjabinema spp. Separazione dei gruppi 3,718 1,246-11,093 0,019
FIGURA 13 - Mappa coro-pletica con range di abbon-danza di Capillaria nei co-muni indagati.
25
Linea di ricerca 1: Distribuzione delle infestazioni parassitarie negli allevamenti caprini lombardi
Specie parassitaNumero totale
Range PrevalenzaAbbondanza Intensità
di elminti media media
TABELLA 9 - Elmintofauna abomasale nelle capre.
Teladorsagia circumcincta 1.995 0 - 935 70% 99,75 142,5
Teladorsagia pinnata 15 0 - 10 10% 0,75 7,5
Teladorsagia trifurcata 5 0 - 5 5% 0,25 5,0
Haemonchus contortus 730 0 - 445 25% 36,5 146
Trichostrongylus axei 15 0 - 5 15% 0,75 5,0
Trichostrongylus colubriformis 10 0 - 5 10% 0,5 5,0
Ostertagia ostertagi 25 0 - 10 15% 1,25 8,3
Ostertagia leptospicularis 20 0 - 10 15% 1,0 6,6
Spiculopteragia mathevossiani 15 0 - 10 10% 0,75 7,5
Spiculopteragia spiculoptera 110 0 - 40 25% 5,5 22
Totale 2.940 0 - 935 75% 147 196
Specie parassitaNumero totale
Range PrevalenzaAbbondanza Intensità
di elminti media media
TABELLA 10 - Elmintofauna dell’intestino tenue nelle capre.
Bunostomum trigonocephalum 30 0 - 30 7,7% 2,3 30
Cooperia pectinata 10 0 - 10 7,7% 0,8 10
Nematodirus filicollis 5 0 - 5 7,7% 0,4 5
Nematodirus lanceolatus 115 0 - 115 7,7% 8,8 115
Nematodirus spathiger 10 0 - 10 7,7% 0,8 10
Moniezia spp. – – 61,5% – –
Totale (elminti maschi) 170 0 - 115 23,1% 13,1 56,7
Specie parassitaNumero totale
Range PrevalenzaAbbondanza Intensità
di elminti media media
TABELLA 11 - Elmintofauna dell’intestino crasso nelle capre.
Oesophagostomum spp. 10 0 - 10 11,1% 1,1 10
Skrjabinema caprae 68 0 - 65 22,2% 7,5 34
Trichuris spp. 10 0 - 10 11,1% 1,1 10
Totale (elminti maschi) 88 0 - 65 22,2% 9,8 44
cune specie di Strongylida. Nel corso dei campionamenti ef-fettuati nell’ambito dell’attività del progetto SANCAPR so-no emerse realtà patologiche connesse all’interazione tra do-mestici e selvatici. In particolare, sono stati rilevati alcunicasi (accertati o sospetti) della cosiddetta “malattia del cer-vo” nell’areale dell’alto varesotto (Sironi et al., 2006).
L’infestazione aberrante da parte di Elaphostrongyluscervi, nematode tipico del cervo e di altri selvatici, causanelle capre una sintomatologia prettamente nervosa dovutaalla localizzazione meningea del parassita. In genere, i sog-getti colpiti devono essere macellati a seguito della sinto-matologia paraplegica che rende impossibile il manteni-
mento dell’animale in allevamento.In definitiva, lo studio della composizione e della distri-
buzione locale dell’elmintofauna dell’abomaso e dell’inte-stino, le relazioni tra questa e gli aspetti produttivi e sanitaridella gestione delle greggi, la caratterizzazione stessa delmanagement aziendale, costituiscono validi supporti per laprosecuzione dell’attività di studio prevista dal piano SAN-CAPR, ovvero la sperimentazione di nuovi protocolli di trat-tamento e gestionali con il fine di raggiungere un miglior li-vello di controllo delle parassitosi in ambito di allevamento,garantendo al contempo la sanità animale, i livelli produttiviaziendali e la qualità dei prodotti.
27
Linea di ricerca 2: Interazione tra infestazionida nematodi gastrointestinali (Strongylida),produzioni e caratteristiche igieniche del latte
INTRODUZIONE
Come è stato già ribadito, i parassiti gastrointestinali, nel-lo specifico i nematodi Strongylida, sono in grado di interfe-rire con le produzioni di latte sia sul piano quantitativo sia suquello qualitativo in tutte le specie lattifere di interesse zoo-tecnico. Tuttavia, nella capra si evidenziano delle peculiari-tà proprie della specie; in particolar modo è tipica la rispostadella capra alla pressione parassitaria esercitata nell’ambien-te di allevamento. Appare ormai provato che quest’animale,soprattutto quando si considerano gli individui ad alto po-tenziale genetico e produttivo, ha una capacità inferiore ri-spetto alla pecora ed alla bovina di sviluppare nel corso de-gli anni un’adeguata risposta immunitaria alle infestazioniparassitarie (Hoste e Chartier, 1993; Chartier e Hoste, 1997;Attili et al., 2004). È stato da più parti notato che l’entità deldanno subito dai caprini a seguito dell’infestazione elminti-ca è tanto maggiore quanto più improvviso è il contatto diquesti con cariche parassitarie elevate. Il fenomeno si mani-festa in modo eminente negli allevamenti che gestiscono lecaprette da rimonta separatamente rispetto alle altre classi dietà fino al momento del primo parto. Gli animali in generenon accedono al pascolo per tutto il primo anno di vita equindi non hanno modo di sviluppare un’adeguata rispostaimmunitaria, con conseguenti maggiori livelli di parassiti-smo e maggiore eliminazione fecale di uova di elminti al pri-mo contatto con questi (Hoste et al., 2002). Il grado di pa-rassitismo è, peraltro, relazionato anche alla quantità di lar-ve infestanti ingerite insieme al foraggio e dipende dalle abi-tudini alimentari; quando le capre hanno la possibilità di ali-mentarsi di piante e arbusti, meno favorevoli per l’assunzio-ne di larve rispetto ai pascoli, esse risultano meno parassita-te delle pecore (Vercruysse 1983).
Il parassitismo gastrointestinale nella capra anche all’in-terno del sistema zootecnico lombardo è un fenomeno pato-
logico essenzialmente riconducibile a due fattori, ovvero ladiffusa pratica del pascolamento delle greggi e le peculiaricaratteristiche di resistenza/resilienza della specie caprinaall’infestazione parassitaria.
Agli indubbi vantaggi derivanti dalla pratica del pascolo,che permette da un lato il contenimento dei costi e dall’altrola valorizzazione di zone altrimenti non raggiungibili dallealtre pratiche colturali, si contrappone tuttavia il fondamen-tale ruolo che questo metodo di conduzione esercita nel-l’ambito della propagazione delle infestazioni all’interno etra le generazioni di animali ospiti (Gasnier et al., 1997; Val-lade et al., 2000).
Va sottolineato che, stanti i caratteri strutturali del com-parto, che determinano inevitabilmente il persistere delle pa-rassitosi all’interno del sistema produttivo caprino, l’obietti-vo che ci si deve prefiggere è quello non tanto dell’eradica-zione della fauna elmintica dalle greggi (di per sé impossibi-le finché permangono le condizioni di una continua reinfe-stazione) quanto quello del suo controllo, attraverso l’ado-zione di un’opportuna combinazione di trattamenti farmaco-logici e misure manageriali, in modo da mantenere le cari-che infestanti a livelli compatibili con le produzioni attese econ lo stato generale di salute del bestiame.
Con il fine ultimo di incentivare ma soprattutto di razio-nalizzare il controllo delle infestazioni del tratto gastroente-rico dell’allevamento caprino lombardo, sono stati persegui-ti i seguenti obiettivi:• dimostrare la relazione tra infestazioni parassitarie, produ-
zioni e caratteristiche igieniche del latte negli allevamenticaprini lombardi;
• individuare quale parte della popolazione caprina allevataè responsabile della contaminazione dei pascoli e manife-sta maggiormente una riduzione delle produzioni;
• individuare un protocollo di trattamento delle parassitosi ri-spondente alla realtà epidemiologica nel territorio lombardo.
Capre a elevato livello 1.226,13 1.245,06 242,27 656,28 2,62 3,25 3,28di parassitismo (216 capi) (1.530,90) (1.535,66) (42,11) (260,83) (0,82) (0,39) (0,25)
Capre a basso livello 0,00 13,98 263,18 772,89 2,91 3,12 3,29di parassitismo (175 capi) (0,00) (36,05) (29,40) (222,54) (0,71) (0,36) (0,25)
28
RISULTATI E DISCUSSIONE
Sulla base dei risultati dell’esame copromicroscopico quan-titativo, sono stati selezionati due gruppi di capre: uno di 216capi caratterizzati da un elevato parassitismo, legato alla pre-senza di nematodi Strongylida e l’altro di 175 capi con un bas-so livello d’infestazione determinato da nematodi non Stron-gylida. Le infestazioni negli animali appartenenti a questogruppo erano sostenute da nematodi del genere Strongyloidese Trichuris. I dati complessivi relativi a tutti i soggetti sono ri-portati in Tabella 1. Nelle Tabelle 2 e 3 sono illustrati i datiproduttivi relativi ai 2 gruppi di capre, a basso ed elevato li-vello di parassitismo, in relazione al numero di lattazione.
Le infestazioni parassitarie sono risultate in grado di in-terferire con alcuni parametri produttivi (Figura 1).
In particolare, i parametri caratterizzanti la produzione ef-fettiva di latte, quali durata della lattazione, litri di latte pro-dotto in totale e quantità giornaliera, percentuale di grassosono risultate significativamente diverse tra le capre con esenza infestazione da Strongylida (Test U di Mann-Whitney,p<0,001, p<0,001, p<0,005, p<0,005 rispettivamente). Inol-
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Parassiti Produzione effettiva
Strongylida Carica totaleDurata
% %(upg) (upg)
lattazione Litri totali Litri al giornodi grasso di proteine
Giorni
Media Media Media Media Media Media Media(DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS)
TABELLA 1 - Dati parassitologici e relativi alla produzione di latte in base al livello di parassitismo.
Parassiti Produzione effettiva
Strongylida Carica totaleDurata
% %N° Lattazione (upg) (upg)
lattazione Litri totali Litri al giornodi grasso di proteine
Giorni
Media Media Media Media Media Media Media(DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS)
TABELLA 2 - Andamento della produzione di latte in capre non parassitate da nematodi Strongylida in funzione del numero di lattazione.
1ª0 12,12 244,44 592,83 2,41 3,1 3,3
(0) (28,24) (34,49) (160,76) (0,56) (0,4) (0,23)
2ª0 19,15 268,27 795,49 2,95 3,1 3,29
(0) (49,04) (21,82) (209,77) (0,70) (0,39) (0,29)
3ª0 20,01 274,4 941,13 3,42 2,96 3,32
(0) (35,44) (19,10) (204,25) (0,69) (0,33) (0,20)
4ª0 4,9 274,67 876,34 3,18 3,23 3,30
(0) (18,59) (16,94) (176,76) (0,60) (0,28) (0,22)
5ª0 25,01 252,5 729,65 2,85 2,92 3,20
(0) (58,84) (47,67) (197,36) (0,46) (0,34) (0,30)
> 5ª0 2,23 271 757,87 2,80 3,03 3,23
(0) (8,61) (21,01) (141,30) (0,50) (0,17) (0,30)
MATERIALI E METODI
L’indagine è stata effettuata su 391 capre di razza Camo-sciata, Nera di Verzasca e Saanen, provenienti da 14 aziendedistribuite tra le province di Varese, Como e Bergamo. Perciascun gregge sono state campionate almeno il 25% dellecapre con le maggiori produzioni.
Su ogni soggetto è stato effettuato un prelievo di feci perla ricerca di parassiti gastrointestinali e per il calcolo delleupg (metodo McMaster); gli animali esaminati sono stati,quindi, classificati in base al livello di parassitismo. Oltre aidati parassitologici, sono stati considerati i dati quali-quan-titativi relativi alla produzione di latte. I dati sono stati ela-borati mediante software statistico (SPSS 16.0, SPSS Inc.,USA). In particolare, il confronto tra l’andamento delle cari-che di Strongylida e le caratteristiche quali-quantitative del-la produzione di latte è stato effettuato con il test di correla-zione non parametrico per ranghi di Spearman (r), per evi-denziarne il tipo di associazione. Il Test U Mann-Whitney èstato impiegato per mettere in rilievo eventuali differenzenella produzione di latte tra i due gruppi di capre.
Parte A: Relazione tra infestazioni parassitarie e produzioni
29
tre, la durata del periodo di lattazione, la produzione effetti-va e quella giornaliera di latte sembrano ridursi all’aumenta-re della carica di Strongylida e le correlazioni sono risultatestatisticamente significative (Test di correlazione per ranghidi Spearman - Tab. 4).
L’andamento delle cariche in funzione del numero di lat-tazioni e quindi dell’età dell’animale rispecchia l’andamen-to tipico dell’infestazione in questa specie animale (Tab. 3)(Figura 3). Elevato nelle classi più giovani, si riduce in quel-le centrali (3a e 4a lattazione) per elevarsi nuovamente in
quelle dalla 5a lattazione e oltre. Premesso che in tutte le ca-tegorie il livello di parassitismo è elevato come testimoniatodal valore di upg e che necessita di un controllo attivo,l’escrezione di uova da parte delle capre più giovani (primi-pare e secondipare) rispecchia da un lato la scarsa immuno-competenza di questi soggetti nei confronti delle infestazio-ni da nematodi gastrointestinali e appare in linea con i datiriportati da altri autori (Hoste et al., 2002). D’altra parte, ilriscontro di cariche elevate negli animali giovani è indicati-vo dell’elevata pressione parassitaria esistente nell’ambitodel sistema di allevamento. I dati riportati in Tabella 3 sotto-lineano che il calo produttivo nella capra non è solo la mi-nore quantità di latte prodotto nel corso della lattazione con-siderata; ma va inteso, più a lungo termine, come un calo chesi ripercuote su tutta la carriera produttiva dell’animale se siconfrontano i livelli di upg relativi a tutte le categorie pro-duttive (Hoste et al., 2005).
Linea di ricerca 2: Interazione tra infestazioni da nematodi gastrointestinali (Strongylida)
Parassiti Produzione effettiva
Strongylida Carica totaleDurata
% %N° Lattazione (upg) (upg)
lattazione Litri totali Litri al giornodi grasso di proteine
Giorni
Media Media Media Media Media Media Media(DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS) (DS)
TABELLA 3 - Andamento della produzione di latte in capre con elevato parassitismo da nematodi Strongylida in funzione del numerodi lattazione.
1ª1289,89 1330,23 216,90 473,27 2,12 3,28 3,31
(1597,17) (1599,19) (39,86) (190,27) (0,67) (0,45) (0,24)
2ª1338,17 1354,84 241,62 602,77 2,39 3,27 3,37
(1917,51) (1913,69) (47,56) (259,85) (0,78) (0,44) (0,32)
3ª922,94 930,69 252,04 793,12 3,11 3,15 3,32
(1117,14) (1112,63) (29,62) (212,06) (0,64) (0,30) (0,22)
4ª1021,14 1024,32 259 825,50 3,19 3,30 3,25
(1000,91) (1002,28) (34,24) (212,60) (0,81) (0,32) (0,26)
5ª1919,14 1919,14 251,72 735,91 2,81 3,31 3,16
(1766,18) (1766,18) (46,68) (308,12) (0,80) (0,47) (0,18)
> 5ª1320,95 1329,65 273,52 775,61 2,81 3,23 3,12
(1697,89) (1736,62) (27,19) (210,97) (0,66) (0,31) (0,19)
FIGURA 1 - Confronto tra durata della lattazione (giorni) e pro-duzione effettiva di latte (litri) in capre con o senza infestazioneda nematodi Strongylida.
R diSignificativitàSpearman
TABELLA 4 - Correlazione di Spearman tra carica di Strongylida(upg) e alcuni parametri produttivi.
Strongylida-0,274074 p<0,001vs durata lattazione
Strongylida vs Produzione-0,255609 p<0,001
di latte effettiva
Strongylida vs Produzione-0,197695 p<0,001
di latte giornaliera
Strongylida vs % grasso0,146832 p<0,005
calcolato sulla prod giornaliera
Strongylida vs % proteine-0,067246 n.s.
calcolato sulla prod giornaliera
Strongylida vs Produzione-0,169565 p<0,005
di latte a 150 gg.
Strongylida vs % grasso0,1059 p<0,005
calcolato sulla prod. a 150 gg.
Strongylida vs % proteine-0,116233 P<0,05
calcolato sulla prod. a 150 gg.
30
Tra le capre maggiori produttrici, quelle in 5a lattazionesono i soggetti che risultano più infestati e il loro grado diparassitismo potrebbe ripercuotersi negativamente sulle pro-duzioni, come si evidenzia dai dati relativi sia alla produzio-ne giornaliera sia alla durata di lattazione (Figure 2-3).
Al fine di verificare l’influenza delle caratteristiche del-l’ospite quali la razza e il numero di lattazioni, insieme allacarica parassitaria, sulla produzione di latte e sulla percen-tuale di grasso e proteine i dati sono stati analizzati tramiteil modello lineare generale (GLMs). I risultati evidenzianoche la produzione di latte giornaliera è dipendente dalla ca-rica parassitaria (Tab. 5) e quest’ultima è il fattore principa-le che influisce sulla riduzione della produzione di latte.
Differenze sono emerse, inoltre, tra le capre di razza Ca-mosciata e Nera di Verzasca quando è stato considerato l’ef-fetto combinato di carica, razza e numero di lattazione. Nel-
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 2 - Andamento della produzione effettiva di latte (mediagiornaliera) e delle upg in capre ad elevato parassitismo.
FIGURA 3 - Andamento della durata della lattazione e delle upgin capre ad elevato parassitismo.
Variabile Coefficiente Devianza g.l. p
TABELLA 5 - Modello minimale adeguato dell’effetto della ca-rica parassitaria e caratteristiche dell’ospite, sulla produzionedi latte.
upg 0,003 8,16 1 <0,001
Razza 56,24 2 <0,001Camosciata 0,599Saanen 0,745Verzasca -0,730
n° Lattazione 0,843 22,85 1 <0,001
upg* Razza 1,29 2 0,332Camosciata -0,004Saanen -0,005Verzasca -0,003
upg* n° Lattazione -0,004 0,78 1 0,149
Razza* n° Lattazione 2,65 2 0,072Camosciata -0,769Saanen -0,662Verzasca -0,682
upg* Razza* n° Lattazione 4,47 2 0,008Camosciata 0,004Saanen 0,005Verzasca 0,004
FIGURA 4 - Relazione tra produzione giornaliera di latte e cari-ca parassitaria nella capra Camosciata.
FIGURA 5 - Relazione tra produzione giornaliera di latte e cari-ca parassitaria nella capra Nera di Verzasca.
31
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto in 7 allevamenti in cui sono sta-ti prelevati 303 campioni di latte di pool delle due emimam-melle, previa disinfezione dei capezzoli ed eliminazione deiprimi getti, e 226 campioni di feci per le analisi parassitolo-giche. L’esame batteriologico è stato eseguito sui campionidi latte secondo le procedure indicate dalla FIL-IDF; il con-tenuto in cellule somatiche (SCC) è stato determinato me-diante conteggio fluoro-opto-elettronico (Bentley SOMA-COUNT 150, Bentley Instruments, USA). Le feci sono sta-te sottoposte ad esame copromicroscopico quantitativo (me-todo McMaster) e i risultati sono stati espressi in termini diupg (uova per g/feci). I dati sono stati elaborati mediantesoftware statistico (SPSS 16.0, SPSS Inc., USA).
RISULTATI E DISCUSSIONE
L’analisi batteriologica ha evidenziato come il 76,6% deicampioni risulti batteriologicamente negativo e il restante23,4% riveli la presenza di microrganismi mastidogeni. Diquesti il 69,2% è risultato positivo per stafilococchi coagula-si negativi, che si confermano come i microrganismi più dif-fusi nella specie caprina, il 26,4% è risultato positivo perStaphylococcus aureus, il 2,2% positivo per streptococchiambientali e il restante 2,2% positivo per altri microrgani-smi. Dei 226 campioni di feci, il 54,9% è risultato negativomentre il 33,6% dei campioni presentava uova di Strongyli-da all’esame copromicroscopico per flottazione. I campionibatteriologicamente positivi hanno evidenziato contenuti dicellule somatiche significativamente superiori rispetto aquelli negativi (p<0,01), mentre il contenuto totale in paras-siti e quello in Strongylida è risultato all’incirca doppio ne-gli animali con infezioni mammarie (p=0,07) (Tab. 1).
Analizzando la relazione tra infestazioni parassitarie,presenza di germi mastidogeni rispetto alle varie caratteri-stiche aziendali e al management, si evidenzia come il con-tenuto in parassiti sia significativamente inferiore negli al-levamenti intensivi (p<0,001) che per lo più hanno un mag-gior numero di capi rispetto alle aziende che conducono lecapre al pascolo, dove non si effettua pascolo (p<0,01), ne-gli allevamenti che separano gli animali in box diversi(p=0,01) e che utilizzano soprattutto rimonta esterna(p<0,01), come riportato in Figura 1. Per quanto attiene ilcontenuto in cellule somatiche, dopo aver qualificato icampioni come infetti o non infetti in base alla soglia di750 SCC*1000/ml, effetti altamente significativi sonoemersi con la carica parassitaria, la quantità di latte pro-dotto al giorno, con la presenza di pascolo e il tipo di alle-vamento (Figura 2). In particolare, il valore di SCC apparecorrelato positivamente con quello di upg dei nematodiStrongylida (Correlazione per ranghi di Spearman r=0,28p<0,001). Questo dato è di difficile interpretazione, perchéapparentemente non esiste una relazione diretta tra numerodi cellule somatiche e infestazioni da nematodi gastrointe-stinali. Tuttavia, è necessario sottolineare e ribadire quantoriportato nella parte introduttiva che le infestazioni parassi-tarie del tratto gastroenterico soprattutto in situazioni di pa-
Linea di ricerca 2: Interazione tra infestazioni da nematodi gastrointestinali (Strongylida)
Numero di lattazioneupg totale
% upgper gruppo lattazione
TABELLA 6 - Escrezione di uova di Strongylida per numero dilattazione e valore percentuale.
1ª 79.973,3 34,33
2ª 42.821,4 18,38
3ª 39.686,5 17,03
4ª 18.976,15 8,14
5ª 21.110,55 9,06
6ª 14.007 6,01
7ª- 8ª 16.374,85 7,0
Parte B: Relazione tra infestazioni parassitarie e caratteristicheigieniche del latte
Carica
Batteriologia SCC*1000/ml parassitaria
latte media ± DS totaleupg
media ± DS
TABELLA 1 - Contenuto in cellule somatiche, parassiti totali eStrongylida in base allo status batteriologico del latte.
Negativo 741,5±1.267,0 256,9±870,8 246,8±867,4
Positivo 1.574,6±1.612,4 509,8±1110,7 498,5±1.005,9
lo specifico, si è osservato che le capre di razza Camoscia-ta in 1a e 2a lattazione risentono maggiormente della pres-sione parassitaria sulla produzione di latte; in questi sog-getti, infatti, la produzione di latte si riduce all’aumentaredelle upg rispetto alle capre delle lattazioni successive chenon sembrano essere influenzate dall’effetto del parassiti-smo (Figura 4).
Per quanto riguarda le capre di razza Verzasca, la caricaparassitaria appare influire negativamente sulle produzionidi latte in misura minore rispetto alle Camosciate e tale ef-fetto si ripercuote su tutti gli animali lo stesso modo indi-pendentemente dal numero di lattazione come è dimostratodall’andamento delle rette di regressione (Figura 5).
Infine, è stata considerata l’escrezione complessiva di uo-va di Strongylida per ciascun gruppo di lattazione; i sogget-ti appartenenti ai gruppi di prima e seconda lattazione risul-
tano quelli che eliminano più uova (rispettivamente 34,3% e18,4%) e sono quindi i gruppi maggiormente responsabilidella disseminazione dei parassiti nell’ambiente (Tab. 6).
NematodiStrongylida
upgmedia ± DS
32
rassitismo subclinico manifestano un meccanismo patoge-netico generale che può facilmente essere assimilato aquello di un disordine nutrizionale, nel senso che l’azionedegli elminti parassiti si manifesta attraverso un calo del-l’ingestione di sostanza secca, una diminuzione dell’effi-cienza digestiva ed una deviazione dei nutrienti alimentaridalle funzioni di produzione ed omeostasi alla riparazionedei danni tissutali ed all’elaborazione delle risposte difen-sive (Rinaldi et al., 2007). È chiaro, quindi che, nella si-tuazione parassitologica emersa nel corso del progetto acarico degli allevamenti caprini della Lombardia, le infe-stazioni parassitarie possono favorire l’insediamento o lamoltiplicazione di germi mastidogeni soprattutto in quellecapre che gravate da pesanti cariche parassitarie, che peraltro perdurano per tutta la carriera produttiva del soggetto,non riescono a manifestare in maniera adeguata una rispo-sta difensiva efficace non solo nei confronti dei parassitima anche di altri agenti patogeni.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 2 - Andamento del contenuto in cellule somatiche inrapporto all’uso del pascolo.
FIGURA 1 - Andamento del conte-nuto in cellule somatiche, parassititotali (upg) e Strongylida (upg) inrapporto a vari fattori gestionali.
33
Linea di ricerca 2: Strategie di controllo dei nematodi gastrointestinali (Strongylida)nell’allevamento caprino lombardo
L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’effica-cia di trattamenti antielmintici in gruppi di capre utilizzan-do dei protocolli adatti alla realtà epidemiologica locale. Lostudio è stato preceduto quindi dalla determinazione del pe-riodo dell’anno in cui gli animali sono sottoposti al mag-giore rischio d’infestazione; per questo alcune greggi sonostate seguite stagionalmente con esami copromicroscopiciquantitativi.
MATERIALI E METODI
Al fine di individuare un protocollo il più possibile adattosi è tenuto conto di diversi elementi tra cui il tipo di mole-cola registrata per le capre ed il dosaggio specifico per i ca-prini nonché l’epidemiologia dei nematodi gastrointestinaliin questa specie nell’area di studio. Il periodo di rischio diinfestazione da nematodi Strongylida per le capre sui pasco-li lombardi è stato determinato effettuando prelievi stagiona-li di feci (primavera, estate, autunno, inverno) in 2 alleva-menti a conduzione estensiva (provincie di Como e Brescia).Sono stati effettuati complessivamente 219 esami copromi-croscopici così suddividisi: 41 invernali, 41 primaverili, 56estivi e 81 autunnali.
I trattamenti antielmintici sono stati effettuati su tre alle-vamenti di capre da latte di razza camosciata di cui uno aconduzione estensiva (gregge 1) e due a conduzione semi-estensiva (greggi 2 e 3) con infestazioni da nematodi gastro-intestinali ricorrenti.
Le molecole utilizzate sono state albendazolo impiegatosia alla dose indicata dall’azienda farmaceutica (3,8 mg/kg)sia al dosaggio specifico per la capra attualmente consiglia-to in tutti i protocolli terapeutici (7,6 mg/kg) ed eprinomec-tina (1000 mcgr/kg). L’albendazolo è stato impiegato per ef-fettuare i trattamenti invernali nelle capre a fine gestazionein quanto ha un periodo di sospensione per il latte di 5 gior-ni. L’eprinomectina è stata invece utilizzata nei trattamentiestivi nelle capre in lattazione in quanto priva di periodo disospensione.
Sono stati eseguiti prelievi di feci al tempo 0 (giorno incui è stato effettuato il trattamento), al giorno 8-10 se gli ani-mali erano stati trattati con albendazolo e al giorno 14 se glianimali erano stati trattati con eprinomectina. In ogni greg-ge è stato individuato un gruppo di controllo costituito dallecapre non trattate e quindi è stato determinato il valore diupg (n° di uova/g di feci) per tutte le capre controllo e quel-le trattate. Per determinare l’efficacia del trattamento è statoquindi applicato il test di riduzione del n° di uova (FECRT)
eliminando dalla valutazione tutti i soggetti che al tempo 0presentavano valori di upg ≤ 200. I valori di FECRT sonostati ottenuti mediante le seguenti formule:
• FORMULA DI COLES = (1-[T2/C2])*100
• FORMULA KOCHAPAKDEE = (1-T2/T1)*100
• FORMULA DASH = (1-[T2/T1]*[C1/C2])*100
• FORMULA CABARET E BERRAG senza gruppo dicontrollo = 1/n* ∑[100*(1-(t2/t1)]
in cui T1 e T2 sono rispettivamente i valori di upg del pri-mo e secondo prelievo dei soggetti trattati, C1 e C2 quellidei controlli e n il numero degli animali sottosposti allaprova.
Albendazolo: protocolli di trattamento utilizzati
Protocollo I: trattamento di tutte le capre del gregge con dosaggi del farmaco differenti
Sono stati costituiti i seguenti gruppi:• Gruppo a: controllo (non trattati).• Gruppo b: capre trattate secondo il dosaggio consigliato
dall’azienda farmaceutica (3,8 mg/kg).• Gruppo c: animali trattati a dosaggio consigliato per le ca-
pre (7,6 mg/kg).
Protocollo II: trattamento di tutti i soggetti del gregge con un unico dosaggio del farmaco• Gruppo a: controllo (non trattati).• Gruppo b: animali trattati a dosaggio consigliato per le ca-
pre (7,6 mg/kg).
Protocollo III: trattamento delle capre che eliminano maggiori quantità di uova (trattamento selettivo)
In questo caso, le capre destinate alla prova sono statescelte in base agli esiti degli esami copromicroscopici e alnumero di lattazioni. Sono stati inclusi nella prova i seguen-ti gruppi di animali costituiti da almeno 15 capre ognuno:• Gruppo a: controllo (non trattati).• Gruppo b trattato: capre alla 1ª lattazione.• Gruppo c trattato: capre tra la 2ª e la 5ª lattazione.• Gruppo d trattato: capre oltre la 5ª lattazione.• Gli animali sono stati trattati a dosaggio consigliato per le
capre (7,6 mg/kg).
In ciascun gregge è stato applicato un solo protocollo equindi il protocollo 1 nel gregge 1 (estensivo), il protocollo2 nel gregge 2 e il protocollo 3 nel gregge 3 (semi-estensivi).
Eprinomectina: protocolli di trattamento utilizzati
In ciascuno dei tre allevamenti sono stati costituiti ungruppo di controllo e un gruppo di capre trattate con eprino-mectina. Nel terzo allevamento il gruppo di trattati era costi-tuito da 3 sottogruppi, capre alla 1ª lattazione, capre tra la 2ªe la 5ª lattazione, oltre la 5ª lattazione. I trattamenti sono sta-ti effettuati tra il 17 luglio e l’8 agosto 2007.
Tutti gli animali sono stati trattati utilizzando il dosaggiodi 1000 mcgr/kg.
Nell’azienda n° 3 sono stati effettuati dei prelievi stagionali.
RISULTATI E DISCUSSIONE
In base ai prelievi effettuati stagionalmente, su animali alpascolo, le cariche di nematodi gastrointestinali (Strongyli-da) hanno mostrato ampie variazioni; quelle più elevate so-no state osservate nel periodo estivo (Fig. 1). Tuttavia, negliallevamenti posti nella parte occidentale della regione già intarda primavera si possono riscontrare delle cariche consi-stenti e più elevate rispetto a quelle regi-strate negli allevamenti delle aree orien-tali. I pascoli quindi rappresentano un ri-schio per le capre soprattutto in questoperiodo dell’anno.
Nella Tabella 1 sono riportati i dati re-lativi alle infestazioni parassitarie delletre aziende prima dell’effettuazione deltrattamento con albendazolo e il numerodelle capre incluse nelle prove.
I risultati degli esami copromicrosco-pici indicano una situazione parassitolo-gica, perlomeno sul piano quantitativo,abbastanza simile tra le diverse aziendeindipendentemente dal tipo di conduzio-ne. La somministrazione dell’antielmin-tico in date diverse nei tre allevamentiscelti è dipeso dal momento differente dientrata in asciutta delle capre.
I risultati del test FECRT calcolato conle diverse formule (Tab. 2) sono abba-stanza concordanti e indicano comunqueuna maggiore efficacia nel gregge 3 incui quasi tutta la popolazione parassitariaè stata eliminata. Negli altri 2 greggi in-vece il farmaco è risultato parzialmenteefficace in quanto percentuali elevate diparassiti (>20%) non hanno subito l’ef-fetto della molecola somministrata e per-ciò ancora presenti nell’ospite.
Nella Tabella 3 sono riportati i valoridi upg relativi al secondo trattamento coneprinomectina. I prelievi sono stati ef-
fettuati nel periodo estivo in cui le cariche sono normalmen-te elevate e i valori massimi dimostrano la presenza di sog-getti con cariche molto al di sopra dei valori ritenuti indica-tivi di una infestazione grave.
In particolare nel gregge 1 sono stati riscontrati valorimassimi di upg molto elevati. Ciò potrebbe essere anche im-putabile alla maggiore esposizione delle capre al rischio di
34
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 1 - Andamento stagionale delle cariche da nematodigastrointestinali (Strongylida) in allevamenti caprini in tutta l’areadi studio.
upg upg n° capre n° Periodo delmedio Range (min-max) trattate controlli trattamento
TABELLA 1 - Situazione parassitologica nelle 3 aziende prima dei trattamenti.
Gregge 1/b* 705,7 200,1-1.667,5 2911 Febbraio
Gregge 1/c** 968,2 200,1-3.435,05 31
Gregge 2 466,9 166,75-1.133,9 13 20 Dicembre
Gregge 3 720,2 266,8-2.267,8 42 9 Gennaio
*Albendazolo a dose singola (3,8 mg/kg). **Albendazolo a dose doppia (7,6 mg/kg).
Formula di Formula di DashFormula di
Formula di ColesKochapakdee (1-[T2/T1]*
Cabaret e Berrag(1-[T2/C2])*100
(1-T2/T1)*100 [C1/C2])*1001/n* ∑[100*(1-(t2/t1)]
TABELLA 2 - Risultati del test di riduzione (FECRT) relativamente al trattamento conalbendazolo nelle 3 aziende.
Gregge 1/b 81,83 82,8 64,1 83,5
Gregge 1/c 77,9 83,6 64,6 82,9
Gregge 2 ND 50,6 ND 60,2
Gregge 3 100 98,6 97,4 98,8
upg upg n° capre n° Periodo delmedio Range (min-max) trattate controlli trattamento
TABELLA 3 - Situazione parassitologica nelle 3 aziende all’atto della prova coneprinomectina.
Gregge 1 913,8 166,75-7.170,25 40 10 Agosto
Gregge 2 1.514,8 201,05-3.835,25 19 20 Luglio
Gregge 3 489,6 166,75-1.167,25 26 7 Luglio
35
infestazione in quanto i prelievi sono sta-ti effettuati a fine agosto in questo greg-ge e a metà luglio negli altri due.
Il test di riduzione delle uova (FECRT)indica una elevata efficacia dell’eprino-mectina solo nei greggi 1 e 2 (Tab. 4).
Al fine di verificare un effetto dellacarica rispetto all’efficacia dell’alben-dazolo e dell’eprinomectina e quindi sulrisultato del test di riduzione (FECRT)abbiamo scomposto il gruppo del greg-ge 1 trattato a dose doppia con albenda-zolo (gregge 1c) in tre sottogruppi infunzione del numero di upg (Tabb. 5 e6). I valori del FECRT calcolato con lediverse formule indicano come l’effica-cia dell’albendazolo sia influenzata dal-l’entità della carica e ciò sembra verifi-carsi in misura maggiore rispetto al-l’eprinomectina. In particolare, il valoredi FECRT calcolato secondo Coles indi-ca una forte riduzione dell’efficacia del-l’albendazolo all’aumentare della caricadi parassiti.
Nelle Figure 2 e 3 sono illustrati gliandamenti delle upg del gregge 1 e 3 esono indicati i periodi in cui sono stati ef-fettuati i due trattamenti rispettivamentea base di benzimidazolo (albendazolo) eavermectina (eprinomectina). In partico-lare nel grafico della Figura 3 si eviden-zia come il secondo trattamento con epri-nomectina abbia contribuito a mantenerele cariche nettamente inferiori rispetto aicontrolli. Gli animali trattati arrivano adicembre con valori di upg che sono cir-ca la metà di quelli dei controlli.
Per altro i valori di upg riferiti a capre a differente stadiodi lattazione (Figura 4) mostrano un andamento simile finoal prelievo di ottobre poi nei prelievi successivi il livello di
Linea di ricerca 2: Strategie di controllo dei nematodi gastrointestinali (Strongylida) nell’allevamento caprino lombardo
Formula di Formula di DashFormula di
Formula di ColesKochapakdee (1-[T2/T1]*
Cabaret e Berrag(1-[T2/C2])*100
(1-T2/T1)*100 [C1/C2])*1001/n* ∑[100*(1-(t2/t1)]
TABELLA 4 - Risultati del test di riduzione (FECRT) relativamente al trattamento coneprinomectina nelle 3 aziende.
Gregge 1 97,5 97,4 76,4 97,3
Gregge 2 100 100 ND 100
Gregge 3 74,9 81,7 85,0 79,1
Formula di Formula di Formula di DashFormula di
Coles Kochapakdee (1-[T2/T1]*Cabaret e Berrag
(1-[T2/C2])*100 (1-T2/T1)*100 [C1/C2])*1001/n* ∑[100*(1-(t2/t1)]
TABELLA 5 - Influenza delle upg sul valore di FECRT. Risultati del test di riduzio-ne relativamente al trattamento con albendazolo a dose doppia nel gruppo c delgregge 1.
Tutto il gruppo 77,9 83,6 64,6 82,9
< 300 upg 92,3 75,0 57,9 75,0
> 300 < 600 upg 83,6 74,8 57,8 76,4
> 600 upg 71,4 85,3 65,9 88,8
Formula di Formula di Formula di DashFormula di
Coles Kochapakdee (1-[T2/T1]*Cabaret e Berrag
(1-[T2/C2])*100 (1-T2/T1)*100 [C1/C2])*1001/n* ∑[100*(1-(t2/t1)]
TABELLA 6 - Influenza delle upg sul valore di FECRT. Risultati del test di riduzionerelativamente al trattamento con eprinomectina nel gruppo c del gregge 1.
Tutto il gruppo 97,9 97,8 76,5 96,6
< 300 upg 98,7 96,2 75,1 96,2
> 300 < 600 upg 98,4 97,4 76,1 97,6
> 600 upg 96,3 96,1 76,9 97,7
upg differenzia significativamente i soggetti dei 3 gruppiproduttivi. Nello specifico le capre più giovani (1ª lattazio-ne) presentano nel prelievo di dicembre delle cariche addi-rittura superiori ai controlli, ad indicare una scarsa resisten-
FIGURA 2 - Andamento delle upg nel gregge n° 1 sottoposto adentrambi i trattamenti.
FIGURA 3 - Andamento delle upg nel gregge n° 3 sottoposto adentrambi i trattamenti.
36
za nei confronti delle reinfestazioni. È possibile che questisoggetti siano stati sottoposti ad un’elevata pressione paras-sitaria tale da impedire loro di elaborare un’adeguata rispo-sta difensiva. Le capre dalla 5ª lattazione in poi mostrano unandamento delle cariche pressoché analogo a quello deglianimali in 1ª lattazione ma le loro cariche registrate in di-cembre sono nettamente inferiori.
CONCLUSIONI
Secondo la guida all’interpretazione dei livelli d’infesta-zione da nematodi gastrointestinali nell’allevamento dei pic-coli ruminanti riportata in Tabella 7 in molti allevamenti ca-
prini lombardi a carattere estensivo o semiestensivo sonopresenti cariche nettamente al di sopra dei valori che indica-no un rischio zootecnico e che determinano già a questi li-velli un calo delle produzioni.
In effetti differenze di produzione sono state riscontrateconfrontando due gruppi di capre infestate e non infestate danematodi Strongylida; quelle più marcate riguardano la pro-duzione di latte giornaliera e la durata della lattazione. Lecapre infestate da Strongylida hanno presentato una minoreproduzione di latte giornaliera pari al 37,1% nei soggetti al-la 1ª e 2ª lattazione considerate insieme.
Per altro nelle capre infestate è risultata una correlazionepositiva tra l’infestazione parassitaria e il numero di cellulesomatiche.
Ne consegue la necessità di migliorare la gestione degliallevamenti caprini razionalizzando il controllo delle infe-stazioni parassitarie sia negli allevamenti a carattere esten-sivo sia in quelli semi-estensivi. In particolare, la pressioneparassitaria a cui sono sottoposti gli animali è tale che so-no necessari perlomeno 2 interventi farmacologici permantenere le cariche infestanti a livelli inferiori a quello dirischio zootecnico. Gli allevatori lombardi hanno invece laconsuetudine di effettuare al massimo un unico trattamen-to nelle capre in asciutta come indicano i dati raccolti tra-mite questionario. Purtroppo un solo trattamento non ap-porta un gran beneficio agli animali; infatti, le capre tratta-te una sola volta, nel periodo invernale, vengono a trovarsinel momento di maggior rischio con cariche analoghe aquelle dei controlli. Il secondo trattamento, soprattutto seeffettuato nel mese di luglio, fa sì che le cariche dei sog-
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 4 - Andamento delle upg nel gregge n° 3, gli animali trattati sono raggruppati in base allo stadio di lattazione.
Gradod’infestazione Livello di upg
TABELLA 7 - Interpretazione dei livelli d’infestazione da nema-todi gastrointestinali nell’allevamento dei piccoli ruminanti.
Infestazione modesta1 < 100 - 150 ma indicativa di necessità
di attenzione
2 150 - 400Infestazione già indicativadi rischio zootecnico
3 400 - 600/700Infestazione sicuramenteimportante
4 600/700 - 1000/1200Infestazione valutabilecome marcata
5 > 1000/1200 Infestazione grave
37
getti trattati raggiungano dei livelli molto inferiori rispettoa quelle dei controlli e conservino tali valori per tutto il pe-riodo autunno-invernale successivo. Dai nostri dati emergeanche che il secondo trattamento effettuato a fine agostopotrebbe essere troppo tardivo in quanto consente alle ca-pre di accumulare nei mesi precedenti una carica parassita-ria elevata che oltre a incidere maggiormente sulle produ-zioni può influire anche sulla capacità della molecola di ri-durre il numero di parassiti. Intervenendo con un secondotrattamento in tarda primavera-inizio estate si ottengonodue effetti: da una parte si elimina sia la parte di popola-zione parassitaria eventualmente rimasta nell’ospite nelcorso del primo trattamento sia le infestazioni subite daglianimali dopo l’inizio del pascolo. In questo periodo del-l’anno il ciclo esogeno dei nematodi gastrointestinali e an-che quello endogeno avvengono molto rapidamente (peralcune specie le uova vengono prodotte dopo solo tre setti-mane dall’ingestione della larva infestante), i pascoli sicontaminano molto velocemente e gli animali arrivano adaccumulare cariche molto elevate proprio quando le richie-ste energetiche sono accentuate perché le capre sono nelfieno della lattazione.
Inoltre, nell’ottica di ridurre gli interventi farmacologiciper rispondere alle esigenze degli allevatori sia convenzio-nali sia biologici, i dati ottenuti nel corso delle prove indica-no in generale la possibilità di concentrare gli interventi suisoggetti più giovani e su quelli dalla 5a lattazione. Tuttavia,il trattamento delle capre giovani appare indispensabile so-prattutto negli allevamenti semi-estensivi in quanto rispettoa quelli estensivi l’area pascoliva è molto ridotta, di conse-guenza il carico parassitario del pascolo è meno diluito e lecaprette assumono dosi infestanti maggiori rispetto a quelleallevate in sistema estensivo.
È chiaro che il presupposto principale è quello di monito-rare l’allevamento e le varie categorie in produzione per sta-bilire le migliori possibilità d’intervento. La situazione pa-rassitologica varia infatti sensibilmente nelle diverse aziendeper quanto riguarda sia la popolazione allevata, nel suo com-
plesso, sia i singoli gruppi produttivi. Un corretto esame pa-rassitologico, effettuato secondo una metodica quantitativanon tanto a livello individuale ma anche per gruppo, dovreb-be rientrare tra i controlli di routine in qualsiasi tipologia diallevamento al pari dei controlli funzionali.
Per quanto riguarda il tipo di farmaco, premesso che intutti i casi le molecole devono essere impiegate al dosaggiospecifico per le capre, un benzimidazolo o comunque unamolecola a largo spettro come l’albendazolo potrebbe esse-re un principio attivo di scelta perché agisce non solo sui ne-matodi gastrointestinali, ma anche sulle altre categorie di pa-rassiti presenti nelle capre al pascolo (cestodi intestinali, ne-matodi broncopolmonari e trematodi epatici) ed è indicatoper il trattamento invernale. Infatti, l’albendazolo è utilizza-bile nelle capre in asciutta eliminando i problemi dei residuinel latte e al dosaggio consigliato non mostra conseguenzesulle femmine in gravidanza.
Per quanto attiene il secondo trattamento, da applicare apascolo iniziato (nel caso le capre siano state stabulate nelperiodo invernale) o nel periodo dell’anno corrispondente adun rischio medio-alto d’infestazione, l’unica possibilità almomento compatibile con le esigenze dell’allevamento chein questi periodi vede le capre nel pieno della lattazione, èl’impiego dell’eprinomectina che viene utilizzata in deroganella capra, in quanto in Italia è registrata solo nel bovino, eoffre il vantaggio di non lasciare residui nel latte.
Infine, una importante evidenza emersa nel corso del no-stro studio è quella relativa alla differente risposta nei con-fronti dell’infestazione parassitaria da parte della razza Ca-mosciata e Nera di Verzasca. Sebbene la valutazione delledifferenze di razza non rientrasse tra gli obiettivi che ci era-vamo proposti, le analisi statistiche sottolineano che la Neradi Verzasca sembra essere capace di contrastare l’impatto deiparassiti sulle produzioni in misura maggiore rispetto allaCamosciata. È un aspetto molto interessante degno di even-tuali approfondimenti che potrebbe fornire un ulteriore con-tributo al controllo dei nematodi gastrointestinali nelle capreal pascolo.
Linea di ricerca 2: Strategie di controllo dei nematodi gastrointestinali (Strongylida) nell’allevamento caprino lombardo
39
Linea di ricerca 3: Presenza di fenomeni di farmacoresistenza dei nematodigastrointestinali (Strongylida) nell’allevamentocaprino lombardo
INTRODUZIONE
L’allevamento caprino in Lombardia è costituito preva-lentemente da un sistema produttivo di tipo semi-intensivo,tipico delle aree collinari/montane (affiancato da un ridottonumero di realtà produttive intensive in zone di pianura); inuna tale realtà zootecnica il parassitismo gastrointestinalepermane una problematica peculiare ed ineliminabile, an-dando a costituire uno dei fattori sanitari limitanti più rile-vanti. Il controllo di tale problematica, per la sua comples-sità e gravità, deve pertanto prevedere un approccio integra-to che comprenda quantomeno una corretta gestione del pa-scolo, degli aspetti igienici dell’allevamento e l’utilizzo dicorretti schemi di trattamento farmacologico (Waller,1999). Quest’ultimo punto rimane sempre d’importanzastrategica nell’allevamento caprino: nella pratica, infatti, ilsolo utilizzo di metodi di controllo non chimici consente diottenere, al massimo, un effetto parziale se non nullo (Be-sier, 2007); studi anche molto recenti, che si prefiggevano diverificare l’efficacia di strategie alternative nel controllodelle parassitosi (anche in un’ottica di metodi di allevamen-to biologico/integrato), hanno dimostrato come siano adesempio risultate inefficaci le integrazioni della dieta conaglio e papaia o solfato di rame nel ridurre le infestazioni danematodi gastro-intestinali nella capra e negli agnelli (Bur-ke et al., 2009; Burke e Miller, 2008). Il frequente ricorso atrattamenti antielmintici richiesto dall’allevamento caprinopone in maniera inevitabile la questione dell’insorgenza difenomeni di farmacoresistenza. La situazione appare, infat-ti, complessa: segnalazioni di antielminticoresistenze nel-l’allevamento caprino riguardano già tutte le categorie difarmaci antielmintici attualmente in uso, anche se la classedi farmaci che sembra essere maggiormente coinvolta èquella dei benzimidazoli (Carta e Scala, 2004; Genchi,2006). Allo stato attuale la realtà italiana appare ancora re-lativamente poco interessata da tali fenomeni: da un recen-te studio effettuato su un allevamento caprino del Sud Italia,con una storia di ripetute introduzioni di individui non con-trollati da un punto di vista parassitologico e con ripetutitrattamenti effettuati con diverse tipologie di farmaci (ben-zimidazolo, levamisolo e ivermectina), è emerso che solouna specie di nematode gastroenterico (Trichostrongyluscolubriformis) presentava fenomeni di farmacoresistenzaunicamente nei confronti del benzimidazolo (Cringoli et al.,2007). La situazione però resta da non sottovalutare: da unlato perché la descrizione del fenomeno in Italia è fram-
mentaria e probabilmente sottostimata, dall’altro perché alivello internazionale esistono segnalazioni di realtà moltoproblematiche che potrebbero presentarsi anche da noi; talisituazioni sono da considerare preoccupanti non solo per lafrequenza di fenomeni di resistenza ai lattoni macrociclici eagli imidazotiazoli, ma anche per la comparsa di resistenzamultispecifica e/o multipla (Carta e Scala, 2004). In Sviz-zera è segnalata resistenza multispecifica all’ivermectina inHaemonchus contortus e Trichostrongylus spp e resistenzamultipla di Haemonchus contortus a ivermectina e meben-dazolo (Schnyder et al., 2005; Artho et al., 2007); in Olan-da Teladorsagia circumcincta è risultata resistente a iver-mectina, oxfendazolo e levamisolo e Haemonchus contor-tus all’oxfendazolo (Eysker et al., 2006). Molto recente-mente in un allevamento in Francia è stata messa in eviden-za un’antielmintico-resistenza multipla e multispecifica. Inquesto caso sia Trichostrongylus capricola che Teladorsa-gia circumcincta sono risultati resistenti al levamisolo e alfenbendazolo; in tale studio le due molecole si sono rivela-te inefficaci contro T. capricola anche se usate in associa-zione (Paraud et al., 2009). Situazioni analoghe sono segna-late anche in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Danimarca e Ger-mania (Gopal et al., 1999; Mortensen et al., 2003; Maingi etal., 1996; Bauer 2001), solo per fare alcuni esempi. Tuttoquesto diventa ancor più allarmante se si considera che lemolecole registrate in Italia per la specie caprina sono sola-mente tre, di cui una non può essere somministrata nel cor-so della lattazione; tutte le altre molecole sono registrate perovini e bovini e, quando utilizzate nella capra, sovente ven-gono somministrate a dosaggi inferiori rispetto a quanto sa-rebbe necessario per essere efficaci in questa specie.
Gli obiettivi di questa linea di ricerca sono stati l’indivi-duazione di fenomeni di farmacoresistenza ai nematodi ga-strointestinali e la raccolta d’informazioni relativamente allestrategie di controllo nei confronti di questi parassiti in termi-ni di molecole utilizzate, dosaggi e tipologia di intervento.
ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONEDI FARMACORESISTENZA
Materiali e metodiPer questa attività sono state prescelte aziende con pasco-
lo o di tipo semiestensivo esposte al rischio d’infestazione danematodi gastrointestinali. Il campionamento ha coinvolto1288 capi; le capre, tutti soggetti adulti, hanno subito il trat-
40
tamento antielmintico secondo indicazione del veterinarioaziendale. Gli animali, per ciascuno dei greggi, sono stati di-visi in due gruppi: quello di controllo, costituito da circa 10soggetti e quello dei trattati formato possibilmente da un nu-mero non inferiore a 20 soggetti. È stato quindi effettuato unprimo prelievo di feci al giorno 0 (corrispondente al giornoin cui veniva eseguito il trattamento) su tutti gli animali e unsecondo prelievo dopo un intervallo di tempo dipendente dalprincipio attivo utilizzato per il trattamento. Nello specifico,il secondo prelievo è stato eseguito al giorno 3-7, 8-10 o 14-17 per gli animali trattati rispettivamente con levamisolo,benzimidazoli o probenzimidazoli e lattoni macrociclici.
Complessivamente sono stati effettuati campionamenti in33 aziende. Per ciascun campione di feciè stato determinato il valore di upg (uo-va/g di feci) (pre e post-trattamento) eapplicato il FECRT test (test di riduzionedel numero di uova) utilizzando secondole più recenti indicazioni due formule dicui una prevede il confronto tra il nume-ro di uova escrete dai trattati e quelleescrete dai controlli al T2 (secondo pre-lievo) e l’altra effettua il confronto tra leuova escrete dagli animali trattati al tem-po T2 con quelle escrete dagli stessi ani-mali al T0 (primo prelievo). È stato quin-di calcolato il valore medio. Le formuleutilizzate sono state le seguenti: FOR-MULA DI CABARET E BERRAG sen-za gruppo di controllo = 1/n* ∑[100*(1-
(t2/t1)] (iFECR2) e FORMULA DI COLES [100x(1-(T2/C2)]. Entrambe restituiscono un valore percentuale cheesprime l’entità dell’efficacia del farmaco. In accordo con ilvalore di FECRT, gli allevamenti sono stati considerati su-scettibili (FECRT > 90%), mediamente resistenti (FECRT41-64%) e altamente resistenti (FECRT < 40%) all’azionedel farmaco benzimidazolo o probenzimidazolo. Lo stessocriterio è stato applicato agli allevamenti che hanno utilizza-to farmaci contenenti come principio attivo un lattone ma-crociclico. Il valore di FECRT è stato calcolato per ogni ani-male trattato estrapolando poi il valore medio per il gregge,escludendo tutti gli animali con cariche particolarmente bas-se che avrebbero potuto alterare il risultato.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Formula di Formula FECRTGregge Provincia Cabaret e Berrag di Coles Medio Principio attivo
iFECR2 % % %
TABELLA 1 - Risultati del test di riduzione delle uova (FECRT) nelle greggi campionate e trattate con benzimidazoli e probenzimida-zoli distinti per principio attivo e per azienda (n° capi trattati = 437).
1 VA 82,3 NC NC
2 BG 83,3 97,1 90,2
3 BG 100,0 100,0 100,0
4 BG 82,7 78,9 80,8 ALBENDAZOLO
5 BS 100,0 100,0 100,0
6 CO-LC 88,0 86,0 87,0
7 SO 100,0 100,0 100,0
8 BG 67,1 NC NC
9 CO-LC 99,0 99,0 99,0FENBENDAZOLO
10 BG 67,1 NC NC
11 CO-LC 99,0 99,0 99,0
12 BS 99,0 95,1 97,1
13 BS 98,4 94,4 96,4 OXFENDAZOLO
14 BS 99,0 99,0 99,0
15 VA 89,6 NC NC
16 VA 97,4 NC NC
17 VA 87,9-98,0 NC NC NETOBIMIN
18 VA 97,4 98,6 97,9
19 VA 96,4 NC NC
20 BG 76,5 61,4 68,9FEBANTEL
21 BG 92,7 83,3 88,1PR
OB
EN
ZIM
IDA
ZO
LIB
EN
ZIM
IDA
ZO
LI
TABELLA 2 - Risultati del test di riduzione delle uova (FECRT) nelle greggi trattatecon lattoni macrociclici distinti per principio attivo e per azienda (n° capi trattati = 175).
FormulaFormula FECRT
Provinciadi Cabaret
di Coles Medio Principio attivoe Berrag% %iFECR2 %
1 VA 98,5-99,7 NC NCMOXIDECTINA
2 SO 92,0 87,0 89,50
3 VA 99,1 NC NC
4 BG 97,23 NC NC
5 BG 74,0 86,0 80,0 EPRINOMECTINA
6 BS 99,6 99,9 99,7
7 CO-LC 99,0 94,0 96,5
8 BG 96,7 NC NCIVERMECTINA
9 BS 99,6 NC NC
AV
ER
ME
CT
INE
MIL
BE-
MIC
INE
ProdottoRegistrato Tempo di sospensione (giorni)
commercialePrincipio attivo n° aziende % in Italia per
i caprini carne latte
TABELLA 6 - Antielmintici utilizzati in Lombardia per il controllo delle infestazioni da endoparassiti negli allevamenti caprini.
Hapadex 5% netobimin 20 24,69 Si 21 3
Panacur fenbendazolo 18 22,22 Si 28** 9**
Valbazen albendazolo 17 20,99 No 21** 3**
Oxfenil 2,265% oxfendazolo 7 8,64 Si 30 6
Rintal 10% febantel 4 4,94 No 13** 5**
Gardal 1,9% albendazolo 3 3,70 No 35** 6**
Elmipur fenbendazolo 2 2,47 No 28** 9**
Eprinex pour-on eprinomectina 1 1,23 No 15*** 0***
Oramec ivermectina 1 1,23 Si 14 No latt*
nd nd 8 9,88 nd nd nd
*È vietato l’utilizzo in animali in lattazione - **Calcolato sull’ovino - ***Calcolato sul bovino.
41
Risultati e discussioneSecondo il valore di FECRT 10 allevamenti sono risultati
sensibili (FECRT > 90%) ai farmaci benzimidazoli e proben-zimidazoli, in 3 allevamenti potrebbe essere sospettata unaforma di resistenza (FECRT < 90% ma > di 67%) e un soloallevamento può essere incluso nel gruppo moderatamente re-sistente (FECRT = 68,98%). Per tutti gli altri allevamenti incui non abbiamo potuto calcolare entrambi i valori in quantogli animali del gruppo dei controlli non sono stati distinti al 2°prelievo non è possibile dare un giudizio definitivo. In questocaso, forme di resistenza potrebbero essere sospettate in 2 al-levamenti con valore di iFECR2 = 67,14%.
Sulla base dei valori di iFECR2 tutti gli allevamenti sonorisultati completamente sensibili (FECRT > 90%) ai lattonimacrociclici ad eccezione di un’azienda in provincia di Ber-gamo in cui si potrebbe ipotizzare una forma di resistenza aqueste molecole.
ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONEDELLE STRATEGIE DI CONTROLLODEI NEMATODI GASTROINTESTINALIADOTTATE DAGLI ALLEVATORI LOMBARDI
Le strategie di controllo adottate dagli allevatori lombardisono state desunte dalle informazioni fornite da 104 aziendetra quelle aderenti al Servizio di Assistenza Tecnica agli Al-levamenti (SATA) raccolte tramite un questionario (Tab. 3).Dall’inchiesta è emerso che il 75,73% delle aziende intervi-state pratica il trattamento antielmintico annuale (Tab. 4) e diqueste solo il 5,1% effettua un secondo trattamento ma inmodo discontinuo. Per altro, anche il trattamento annuale nonviene applicato regolarmente e in genere non è effettuato sul-la base di dati oggettivi (esame parassitologico quantitativo)o, quando questi sono presenti, non sono stati rilevati in cor-rispondenza del periodo del trattamento. I principi attivi piùfrequentemente utilizzati (87,65%) sono quelli appartenential gruppo dei benzimidazoli (albendazolo, fenbendazolo eoxfendazolo) e probenzimidazoli (netobimin e febantel). Leavermectine (eprinomectina e ivermectina) sono impiegatesolo nel 2,47% dei casi (Tab. 5). Relativamente ai prodotticommerciali impiegati, il 46,91% delle aziende utilizza due
prodotti registrati per i caprini (netobimin e fenbendazolo)ma in larga parte il trattamento antielmintico è effettuato conprodotti non registrati specificatamente per la capra (Tab. 6).Il trattamento viene effettuato in generale tra la fine di otto-bre e la prima metà di gennaio in funzione del tipo di azien-da, dell’area climatica e dello stato fisiologico delle capre.
Linea di ricerca 3: Presenza di fenomeni di farmacoresistenza dei nematodi gastrointestinali (Strongylida)
n° aziende %
TABELLA 3 - Numero di questionari distribuiti finalizzati allaraccolta di informazioni relativamente ai trattamenti antielmintici(n° 104 aziende).
BG 32 30,77
CO 13 12,50
LC 9 8,65
SO 10 9,62
BS 19 18,27
VA 21 20,19
n° aziende che ripetonoil trattamento con regolarità
SI NO ND
TABELLA 4 - Frequenza del trattamento antielmintico (n° aziende).
SI78 4 70 4
(75,73%) (3,88%) (89,74%) (3,88%)
NO21
– – –(20,39%)
nd4
– – –(3,88%)
Principi attivi n° aziende
TABELLA 5 - Frequenza dei principi attivi utilizzati per effettua-re il trattamento antielmintico.
Benzimidazoli e probenzimidazoli68
(87,65%)
Avermectine2
(2,47%)
nd8
(9,88%)
n° aziendeche praticano il
trattamento annuale
42
CONCLUSIONI
Le considerazioni complessive che si possono trarre daquesta parte della ricerca indicano, per quanto riguarda gliaspetti di farmacoresistenza, una situazione che necessitadi un monitoraggio continuo dell’attività del farmaco nonsolo nei confronti dei benzimidazoli e probenzimidazolima anche per i lattoni macrociclici i quali possono an-ch’essi determinare la comparsa di forme di resistenza sianegli ovini sia nei caprini. Certamente, tenuto conto del lar-go impiego di derivati benzimidazoli negli allevamenti ca-prini lombardi, una maggiore attenzione deve essere rivol-ta a migliorare l’utilizzo di questi prodotti. Un aspetto im-portante da sottolineare è la mancanza, nella totalità dei ca-si, di specifici esami parassitologici prima della sommini-strazione del trattamento antielmintico a cui fanno eccezio-ne pochissime aziende (quelle che hanno effettuato un se-condo trattamento). Tali considerazioni scaturiscono anchedal riscontro di un elevato numero di capi risultati posse-dere cariche parassitarie molto basse (<200 upg) al primoprelievo e che per evitare di avere valori di FECRT alteratisono stati esclusi dal calcolo di tale valore. Ciò è indicati-vo di come i trattamenti antielmintici, in generale, venganoapplicati indiscriminatamente, alla cieca, senza una realeconoscenza del grado di infestazione delle greggi da tratta-
re. L’esame parassitologico, d’altra parte, consente, se ef-fettuato utilizzando metodiche quantitative e di elevata sen-sibilità, di decidere l’opportunità o meno del trattamentoantielmintico e di prevenire, appunto, forme di resistenzaantielmintica. Inoltre, sulla base del numero di uova escre-te è possibile scegliere gli animali da trattare (trattamentiselettivi) abbattendo i costi che dovrebbe sostenere l’alle-vatore per sverminare l’intero allevamento e riducendol’eliminazione di residui di farmaco nell’ambiente. Il mo-nitoraggio parassitologico delle greggi permetterebbe, infi-ne, di avere indicazioni utili sulla scelta della molecola piùidonea da impiegare e da applicare al corretto dosaggioevitando quei fenomeni di irrazionalità evidenziati in nu-merose greggi con infestazioni da nematodi gastrointesti-nali quali Trichuris e Strongyloides che sono sensibili a po-che delle molecole antielmintiche utilizzate generalmentedagli allevatori lombardi. Infatti, nei confronti di questi pa-rassiti è attiva l’ivermectina che non trova un largo impie-go a causa del divieto d’uso in lattazione.
Il controllo parassitologico è consigliato su tutti i sogget-ti che vengono immessi in allevamento al fine di impedirecontemporaneamente l’introduzione di ceppi di nematodi re-sistenti. Ciò è fortemente auspicabile tenuto conto cheun’elevata percentuale di aziende caprine lombarde effettuarimonta esterna.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
43
Indagini sulle infezioni mammarie
INTRODUZIONE
La realtà dell’allevamento caprino, pur contando su mino-ri investimenti strutturali e sulla maggiore resistenza fisiolo-gica di questi animali, presenta comunque notevoli differen-ze con l’allevamento bovino, sia dal punto di vista gestiona-le che zootecnico, ma la crescente richiesta del mercato peravere prodotti di qualità certificata, non può prescindere daun buon stato sanitario dell’animale. L’utilizzo del latte dicapra nell’alimentazione umana sta poi assumendo maggiorimportanza e diffusione anche a causa dell’aumento, sia neibambini che nelle persone adulte, di allergie ed intolleranzealle proteine del latte vaccino. È stato infatti statisticamenterilevato che circa il 2,5% dei bambini presenta intolleranzaalle proteine del latte vaccino nei primi tre anni di età (Bel-lini-Busico et al., 1999).
Sicuramente le mastiti rappresentano una delle principaliproblematiche sanitarie di questi allevamenti (Moroni et al.,2002; Pisoni et al., 2003). Mastiti, soprattutto durante i pri-mi giorni dopo il parto, possono incidere negativamente sul-la salute dei capretti allevati, con rilevanti perdite economi-che dell’allevamento, e possono veicolare microrganismi po-tenzialmente patogeni per l’uomo sia direttamente (es. Sal-monella, Lysteria monocytogenes) (Caracappa et al., 1994) oattraverso tossine di loro produzione (es. Staphylococcus au-reus) (Lodi et al., 1994; Gilmour e Harvey, 1990; Mossel eVan Netten, 1990).
MATERIALI E METODI
Nella prima fase del progetto è stata valutata la diffusioneterritoriale dei principali agenti patogeni mammari degli al-levamenti della Lombardia. L’analisi è stata effettuata prele-vando mensilmente il latte di massa di 77 allevamenti, inconcomitanza con i prelievi del Progetto “Monitoraggio del-la qualità del latte caprino” gestito dal SATA e dall’ARAL,su cui sono stati valutati la presenza di diverse categorie dimicrorganismi, attraverso conteggi differenziali, medianteutilizzo di terreni selettivi.
Staphylococcus aureus è stato quantificato mediante semi-na su terreno Baird-Parker agar, incubato in termostato a 37°Cper 48 ± 2 ore. Le colonie tipiche appaiono nere, lucenti, con-vesse e con diametro fino a circa 3 mm, con una sottile zonadi opacità circondata da un alone chiaro. Tutte le colonie conquesto aspetto sono state poi seminate su agar-sangue e testa-te per verificarne la produzione di coagulasi attraverso l’ino-culo dei ceppi isolati in microtubi contenenti plasma di coni-glio, successivamente incubate a 37°C e osservate a 4 e 24 hdi incubazione. Tutti gli altri stafilococchi presenti sono staticonsiderati ai fini del contenuto in stafilococchi coagulasi ne-gativi (SCN), mentre per i microrganismi ambientali si è pro-
ceduto alla semina su Chromocult® coliform agar (Merck,Darmstadt, Germany), per la quantificazione di coliformi to-tali e su terreno Agar Kanamicina Esculina Azide (KAAagar), per il contenuto in streptococchi fecali.
Oltre al monitoraggio del latte di massa per presenza dipatogeni mammari e cellule somatiche, si è proceduto alcontrollo dell’eventuale presenza di microrganismi zoonosi-ci (Salmonella, Lysteria monocytogenes). In questo caso leanalisi sono state effettuate solo sulle aziende che hannoaderito al SATA, usufruendo del pool di dati qualitativi for-niti dall’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia(ARAL) nell’ambito del Progetto Qualità Latte Caprino. Icampioni di latte di massa sono stati analizzati mediante lametodica tradizionale microbiologica, molto più complessae indaginosa, ma che fornisce un dato più preciso sulla rea-le presenza di germi vivi e vitali presenti nel latte. Per la ri-cerca di Salmonella è stato utilizzato il Metodo StandardHPA, emesso da Standards Unit, Evaluations and StandardsLaboratory, in cui l’isolamento della Salmonella è condottopertanto con colture di arricchimento su un peso o volumedefinito di alimenti, di solito 25 g. Le procedure standarddello Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratorysono state utilizzate anche per la ricerca di Listeria monocy-togenes, la cui presenza è dovuta principalmente alla capaci-tà del microrganismo di moltiplicarsi durante la conserva-zione refrigerata ove raggiunge concentrazioni significative.Per questi alimenti è richiesta una ulteriore procedura di ar-ricchimento per determinare la presenza o assenza del mi-crorganismo in una determinata quantità di alimento.
Nella seconda fase sono stati individuati allevamenti pecu-liari per caratteristiche strutturali, gestionali e sanitarie, su cuisi è prelevato il latte individuale degli animali allevati al finedi monitorare lo stato sanitario durante varie fasi della latta-zione, cercare di stabilire un valore soglia per poter discrimi-nare emimammelle infette da quelle sane e individuare fattoridi rischio, associati o meno alla presenza di determinati pato-geni. I prelievi sono stati effettuati secondo quanto indicatodalla International Dairy Federation. In particolare sono statiprelevati 10 ml circa di latte in contenitori sterili monouso,previa disinfezione dei capezzoli con fazzoletti monouso im-bevuti di clorexidina ed eliminazione dei primi getti di latte. Iprelievi così ottenuti sono stati trasportati in regime di freddoal laboratorio dove sono state effettuate le analisi cito-batte-riologiche. Più precisamente 0,01 ml di latte sono stati semi-nati mediante ansa calibrata su agar base addizionato con il5% di sangue bovino defibrinato. Dopo incubazione a 37°Cper 18-24 ore sono state isolate le colonie di crescita e suc-cessivamente identificate mediante prove biochimiche comu-nemente usate per diagnostica batteriologica.
Una emimammella viene definita batteriologicamente po-sitiva quando sulla piastra di semina del campione si osser-vano: presenza di coltura pura di microrganismi, indipen-
44
dentemente dalla loro natura, presenza almeno di una colo-nia di Staph. aureus, presenza di non più di due tipi di colo-nie con almeno una delle due specie presenti in quantità su-periore a 500 UFC/ml alla quale si attribuisce la responsabi-lità dell’infezione. I campioni in cui è stata osservata la cre-scita di più di due specie batteriche sono stati definiti batte-riologicamente contaminati e, quindi, non considerati ai finidei risultati della prova. Tutti gli altri campioni di latte sonostati definiti come batteriologicamente negativi.
La determinazione del contenuto in cellule somatiche dellatte è stata effettuata mediante conteggio con apparecchia-tura SOMACOUNT 150 (Bentley Instruments, USA). L’ap-parecchiatura è completamente automatica e sfrutta il prin-cipio della citometria di flusso, il campione di latte vieneaspirato attraverso una sonda e il DNA delle cellule vienecolorato con etidio bromuro. Il valore soglia di cellule so-matiche per discriminare emimammelle sane da quelle infet-te è stato determinato attraverso l’utilizzo dei valori dellecellule somatiche in base alla positività o negatività alla pre-senza dei patogeni mammari ricercati, analizzati attraversole curve R.O.C. (Receiver Operating Characteristic) con ilsoftware statistico MedCalc® (MedCalc, Belgio).
RISULTATI
Per quanto riguarda la prima fase della sperimentazionesono stati campionati complessivamente 385 campioni dilatte di massa. I risultati della distribuzione degli allevamen-ti e dei valori di cellule somatiche, sono riportati nella Ta-bella 1. Il dato che emerge è estremamente eterogeneo, convalori che si attestano attorno al milione di cellule somaticheper ml, con situazioni di eccellenza, per quanto riguarda gliallevamenti della provincia di Varese, dove l’allevamento ca-prino è da anni seguito sul territorio con costante attenzionealla qualità del latte prodotto, e situazioni non proprio otti-mali per quanto riguarda gli allevamenti testati nella provin-cia di Brescia. Il dato di cellule somatiche rilevato è comun-que in linea con quanto riportato in letteratura (Koop et al.,2009; Min et al., 2007; Moroni et al., 2005a).
Per quanto riguarda la positività alle analisi batteriologi-che effettuate, i risultati sono riportati nella Tabella 2 e sonogeoreferenziati nelle successive Figure 1-6.
La percentuale di campioni che non hanno evidenziatocrescite significative di patogeni mammari e la presenza re-lativamente limitata di Staph. aureus, indica un complessivobuono stato igienico-sanitario degli allevamenti testati.
Le relazioni tra la presenza dei diversi patogeni mammarie il contenuto in cellule somatiche del latte di massa, in ba-se ai dati riportati nella Tabella 3, mostrano come i micror-ganismi Gram negativi siano responsabili di significativirialzi cellulari, seguiti dallo Staph. aureus in accordo con iltrend già segnalato in bibliografia per la specie bovina e ca-prina (Breen et al., 2009; Bronzo, 2007; Luengo et al., 2004;Moroni et al., 2005).
La ricerca di Salmonella spp e Lysteria monocytogenes hadato esito sempre negativo, a conferma della bontà igienico-sanitaria del latte caprino prodotto in Lombardia.
Per quanto attiene le analisi relative alle caratteristicheigienico-sanitarie del latte prodotto in alcune aziende, sele-zionate all’interno di quelle valutate attraverso il latte dimassa, sono stati campionati 13 allevamenti, per un totale di735 animali e 1467 campioni di latte di singola emimam-mella. I risultati della distribuzione totale delle infezioni so-no riportati nella Figura 7, mentre i dati per singolo alleva-mento sono riportati nella Tabella 4. I risultati complessiva-mente evidenziano un buono stato sanitario degli animali,con solo circa il 12% di campioni positivi per microrganismipatogeni mammari, di cui solo 3,3% di Staph. aureus; men-tre gli SCN rappresentano la classe di microrganismi mag-giormente rappresentata (Moroni et al., 2005a).
I dati relativi alle correlazioni tra infezioni mammarie e ti-pologia di infezione, riportati nella Tabella 5, confermano unvalore di poco superiore al milione di cellule per ml nei cam-pioni batteriologicamente negativi, mentre il microrganismomaggiormente legato a significativi rialzi cellulari è Staph.aureus, a conferma del suo ruolo di patogeno maggiore, so-prattutto per la specie caprina (Hall e Rycroft, 2007; Moro-ni et al., 2005b).
Per la valutazione dei valori soglia di cellule somatiche,da considerare ai fini di una eventuale normativa simile a
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Provincia n° allevamenti Media SCC/ml*1000 DS
TABELLA 1 - Distribuzione degli allevamenti e contenuto in cel-lule somatiche del latte di massa.
BG 23 1.219,43 1.606,00
BS 12 2.435,50 5.919,56
CO 9 1.014,00 1.489,34
LC 9 1.032,33 618,79
SO 4 1.017,75 780,91
VA 20 683,10 913,01
Totale 77 1.213,29 2.577,80
ProvinciaBatt. Negativo Coliformi totali Streptococchi fecali SCN Staph. aureus
n° % n° % n° % n° % n° %
TABELLA 2 - Analisi batteriologica del latte di massa nei diversi allevamenti.
BG 70 35,00 25 50,00 20 21,05 – – – –
BS 30 15,00 10 20,00 15 15,79 – – 5 20,00
CO 25 12,50 5 10,00 5 5,26 10 66,67 – –
LC 20 10,00 5 10,00 15 15,79 5 33,33 – –
SO 5 2,50 5 10,00 5 5,26 – – 5 20,00
VA 50 25,00 – – 35 36,84 – – 15 60,00
Totale 200 51,9 50 13,00 95 24,70 15 3,90 25 6,50
45
Indagini sulle infezioni mammarie
FIGURA 2 - Distribuzione territoriale degli allevamenti positivi nel latte di massa per patogeni mammari ambientali.
FIGURA 1 - Distribuzione territoriale degli allevamenti positivi nel latte di massa per stafilococchi coagulasi negativi.
46
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
FIGURA 4 - Distribuzione dei comuni positivi nel latte di massa per stafilococchi coagulasi negativi.
FIGURA 3 - Distribuzione territoriale degli allevamenti positivi nel latte di massa per Staphylococcus aureus.
47
Indagini sulle infezioni mammarie
FIGURA 6 - Distribuzione dei comuni positivi nel latte di massa per Staphylococcus aureus.
FIGURA 5 - Distribuzione dei comuni positivi nel latte di massa per patogeni mammari ambientali.
48
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
quella per il latte vaccino, i risultati relativi alle nostre inda-gini hanno evidenziato un dato di circa 600.000 cell/ml, co-me riportato in Figura 8, ma con indici di sensibilità e speci-ficità piuttosto bassi (66,2% e 67,7%, rispettivamente), quin-di non applicabili in una realtà di campo.
Associando i dati ottenuti con l’algoritmo utilizzato daitecnici del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamentigestito dall’A.R.A.L., si sono migliorate le performance deltest, ottenendo un valore soglia di 723.000 cell/ml con buo-ne percentuali di sensibilità e specificità (rispettivamente79,8% e 86,0%), come riportato in Figura 9 e che quindi,con le dovute valutazioni, può essere considerato per un suoeventuale utilizzo sul campo.
Un ulteriore aspetto dell’indagine svolta ha riguardato lapresenza e la diffusione dei patogeni mammari in relazionead alcuni fattori di rischio sanitari e gestionali delle diverseaziende analizzate. In particolar modo sono stati consideratila dimensione della mandria, la tipologia di allevamento (in-tensivo, estensivo), l’utilizzo del pascolo, la separazione deigruppi produttivi e sanitari degli animali all’interno dell’al-levamento, la tipologia di rimonta, l’utilizzo di protocolli didisinfezione e terapeutici sistematici, la presenza dell’infe-zione da virus dell’artrite-encefalite caprina (CAEV). Inseri-ti questi parametri in tabelle di contingenza a risposta multi-pla per stabilirne il grado di associazione con la presenza dipatogeni mammari e il superamento del valore soglia di cel-lule somatiche ritenuto opportuno, in base a quanto emersodalle indagini svolte nel progetto (750.000 cell/ml), nessuno
dei parametri considerati ha espresso valori statisticamentesignificativi, tranne la tipologia di rimonta e la presenza diinfezioni da CAEV. Nello specifico, gli allevatori che utiliz-zano strettamente la rimonta interna hanno un numero di cel-lule somatiche inferiore, che avvicina la significatività stati-stica (p=0,06), oltre ad avere anche una minore presenza dipatogeni mammari (p=0,05). Per quanto riguarda l’infezioneda CAEV, negli allevamenti indenni o con sieroprevalenzainferiore al 10%, la presenza di patogeni mammari è signifi-cativamente inferiore (p=0,036). Mentre per altri fattori con-siderati, quali l’utilizzo di pascolo o la presenza di infezionimammarie che avevano mostrato chiari effetti sul contenutoin parassiti delle mandrie osservate (Manfredi et al., 2008),il loro effetto sembra essere marginale, o quantomeno menoimportante, per quanto riguarda i parametri sanitari del latteprodotto.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Le infezioni mammarie risultano essere regolarmente fon-te di rialzi cellulari del latte, ma non sempre comportano ilraggiungimento di valori che ci garantiscano la corretta di-scriminazione degli animali, sulla base del dato cellulare, e,da quanto osservato, occasionalmente causano significativeriduzioni della produzione, a conferma delle diversità fisio-logiche esistenti tra specie bovina e caprina, ripetutamentesegnalate in letteratura. La crescente domanda di prodotti a
Esito batteriologico Media SCC/ml*1000 DS
TABELLA 3 - Contenuto in cellule somatiche in base allo statusbatteriologico del latte di massa.
Negativo 604,68 828,80
Coliformi totali 3.599,30 6.211,24
Streptococchi fecali 1.156,37 1.698,94
SCN 1.084,67 340,13
Staph. aureus 1.603,60 1.246,35
Totale 1.213,29 2.577,80
FIGURA 7 - Distribuzione delle infezioni mammarie rilevate incampioni di latte di singola emimammella.
Azienda Negativi SCN Staph. aureusStreptococcus
Altriambientali
TABELLA 4 - Distribuzione delle infezioni mammarie per azien-da rilevate tramite le analisi batteriologiche.
1 89,1% 5,8% 5,1% 0,0% 0,0%
2 89,1% 4,7% 6,3% 0,0% 0,0%
3 94,3% 4,3% 1,4% 0,0% 0,0%
4 80,0% 5,0% 12,5% 2,5% 0,0%
5 92,6% 3,5% 2,7% 0,8% 0,4%
6 94,5% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0%
7 78,9% 12,2% 7,8% 1,1% 0,0%
8 85,6% 12,3% 1,4% 0,0% 0,7%
9 88,9% 3,7% 7,4% 0,0% 0,0%
10 89,7% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0%
11 83,6% 15,1% 0,6% 0,0% 0,6%
12 66,3% 28,8% 3,8% 0,0% 1,3%
13 90,5% 6,8% 2,7% 0,0% 0,0%
Analisi batteriologica n° Media DS
TABELLA 5 - Contenuto in cellule somatiche in base allo statusbatteriologico del latte di singola emimammella.
Negativi 1.285 1.125,88 1.704,07
SCN 126 1.317,86 1.575,54
Staph. aureus 48 3.628,00 2.810,99
Streptococcus. ambientali 4 2.564,25 2.871,89
Altri 4 2.394,50 2.485,66
Totale 1.467 1.231,62 1.801,35
49
Indagini sulle infezioni mammarie
base di latte di capra, spesso lavorato crudo e senza il rag-giungimento di temperature sufficienti a garantire l’inattiva-zione dei più comuni germi zoonosici, ha posto l’attenzionesulla qualità igienico-sanitaria del latte prodotto negli alle-vamenti lombardi, anche sulla recente enfasi della potenzia-le pericolosità del latte vaccino crudo commercializzato allastalla. La mancanza di rilevazioni di positività a Listeria mo-nocytogenes e Salmonella spp, associata alla relativa diffu-sione di Staph. aureus riscontrata, ha fornito un quadro ab-bastanza rassicurante circa la qualità igienico-sanitaria dellatte prodotto in Lombardia. I dati relativi all’identificazionedi un valore soglia di cellule somatiche che possa discrimi-nare emimammelle sane da quelle infette, ha evidenziato co-me il dato delle 750.000 cell/ml, segnalato in letteratura(Luengo et al., 2004), possa risultare un valore soglia soddi-sfacente per quanto riguarda la specie caprina, nella prospet-tiva della messa a punto di un sistema di valutazione dellaqualità igienica del latte, sul modello di quello bovino. I fat-tori di rischio aziendali analizzati per la presenza e diffusio-ne delle infezioni mammarie, ha evidenziato valori signifi-cativi solo per l’utilizzo della rimonta esterna e la presenzadi infezioni da CAEV. Il dato relativo alla rimonta può esse-re interpretato con una minore capacità immunitaria deglianimali acquistati, che si tramuta in un aumento di rischio diinfezione mammaria (cellule somatiche più alte e maggiorpresenza di patogeni mammari), così come in un aumento dirischio di introduzione di nuovi patogeni mammari in alle-vamento (maggior presenza di patogeni mammari). Questofattore di rischio è stato più volte segnalato in letteratura per
la specie bovina (Sato et al., 2008; Steeneveld et al., 2008) esembra che la capra non faccia eccezione, così come la pre-senza di infezioni da CAEV sembra avere influenza negati-va sulla sanità della mammella. A questo proposito, il datorisulta controverso in quanto alcuni autori sostengono chenon vi siano relazioni (Nord, 1997), mentre altri hanno os-servato influenze soprattutto su un aumento del contenuto incellule somatiche e sulla diminuzione della produzione(Sanchez et al., 2001; Leitner et al., 2009). La relativa rusti-cità degli animali allevati, soprattutto nelle aree pedemonta-ne, e la spinta produttiva non ancora a livelli estremi, comesi registra invece per la specie bovina, sembrano minimizza-re gli effetti della gestione dell’allevamento, specificatamen-te per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del lattee la sanità della mammella, anche per quanto riguarda la pre-senza di patogeni zoonosici e di eventuali enterotossine dan-nose per la salute umana. La situazione che emerge, lasciaquindi ancora margini di sicurezza sanitaria abbastanza si-gnificativi per la produzione di latte caprino in Lombardia.Certamente, però, in previsione di un ulteriore sviluppo del-l’allevamento, in relazione all’eventuale aumento della do-manda di prodotti caseari a base di latte di capra, deve co-munque impegnare gli operatori del settore a migliorare glistandard igienici degli allevamenti per evitare che, una spin-ta produttiva maggiore e il conseguente stress che ne potreb-be derivare per gli animali, possa favorire la diffusione di pa-togeni zoonosici o produttori di tossine che, in passato e at-tualmente, hanno creato diversi problemi per il compartoproduttivo del latte vaccino.
FIGURA 8 - Valore soglia di cellule somatiche per discriminareemimammelle sane da infette (dato DIPAV, UNIMI).
FIGURA 9 - Valore soglia di cellule somatiche per discriminareemimammelle sane da infette (dato DIPAV, UNIMI X ARAL).
51
Conclusioni generali
Il progetto SANCAPR ha prodotto dei risultati che appor-tano al SATA un importante bagaglio di conoscenze da uti-lizzare per l’implementazione di programmi gestionali rivol-ti al miglioramento dello stato sanitario e delle produzionidell’allevamento caprino lombardo.
In particolare, le attività svolte nell’ambito del progettorelative alle infestazioni da nematodi gastrointestinali hannoevidenziato il ruolo di questi agenti patogeni nell’alleva-mento caprino lombardo che, in sintesi, sono risultati diffu-si, con cariche elevate soprattutto negli animali al pascolo eappaiono in grado di influire sulla produzione di latte e sulnumero di cellule somatiche. Il SATA potrebbe dare un ap-porto fondamentale al controllo di queste parassitosi, innan-zitutto, in termini di sensibilizzazione degli allevatori neiconfronti di tale problematica e delle prassi più corrette perottenere un controllo ponderato.
Occorre, però, premettere che il controllo delle infestazio-ni da nematodi gastrointestinali è complesso e deve essere fi-nalizzato sostanzialmente a contenere le popolazioni paras-sitarie a livelli compatibili con uno stato di benessere del-l’animale, con delle buone produzioni in termini quali-quan-titativi e con i costi sostenuti dall’allevatore.
A rendere ancora più difficile la gestione delle parassitosigastrointestinali si aggiunge la scarsa disponibilità di pro-dotti antielmintici che possano essere usati nella capra du-rante il periodo di lattazione, quando si riscontrano le cari-che più elevate. I prodotti attualmente disponibili sul merca-to prevedono dei tempi di sospensione che vietano nell’ali-mentazione umana l’uso del latte (o dei prodotti derivati)proveniente da animali trattati per un numero di giorni infunzione del prodotto.
Tuttavia, l’introduzione dell’esame copromicroscopicoper monitorare l’andamento quali-quantitativo delle parassi-tosi nel gregge contribuirebbe a ridurre sensibilmente questedifficoltà in quanto consente di determinare:• quali parassiti sono presenti e quindi indirizza sul prodot-
to da utilizzare,• l’entità delle cariche e quindi indica se il trattamento è ne-
cessario o meno;• quali gruppi di soggetti sono più parassitati e la possibili-
tà di rivolgere i trattamenti a quegli animali che elimina-no più parassiti; dai dati emersi le capre più giovani (1ª e2ª lattazione) in generale hanno le cariche maggiori. Inquesto caso, se si è costretti ad effettuare il trattamento inlattazione lo si potrebbe indirizzare su un numero minoredi animali riducendo la quantità di latte che non può es-sere utilizzata.I dati ottenuti nel corso del progetto indicano come prio-
ritaria la diagnosi parassitologica che deve però essere effet-tuata tramite un esame copromicroscopico di tipo quantitati-vo, con una tecnica appropriata e sensibile e rivolto a dia-
gnosticare non solo le infestazioni da nematodi gastrointe-stinali ma anche quelle da trematodi e cestodi che spesso so-no associate alle prime.
Per altro, l’esame copromicroscopico può essere eseguitoanalizzando un pool di feci relativo a ciascun gruppo pro-duttivo e questo lo rende un’analisi poco costosa e di scarsoimpegno (perché non è necessario campionare tutti gli ani-mali) pur rimanendone elevato il valore predittivo.
L’uso della diagnosi delle infestazioni parassitarie comepratica di routine e soprattutto prima di effettuare il tratta-mento offre quindi numerosi vantaggi che si riflettono posi-tivamente sia sugli animali, in quanto possono essere preve-nute situazioni di maggiori infestazioni, sia sugli allevatori,per i minor costi derivanti dall’impiego di trattamenti nonstrettamente necessari o per i maggiori guadagni derivantidall’incremento delle produzioni degli animali trattati.
Il riscontro di fenomeni di antielminticoresistenza in alcu-ne aziende lombarde, seppur molto limitati, e il largo uso dirimonta esterna suggeriscono l’impiego dell’esame copro-microscopico su tutti i capi che vengono acquistati da altreaziende al fine di prevenire l’ingresso anche di ceppi di ne-matodi Strongylida resistenti.
Nel corso del progetto, le attività connesse alle infesta-zioni parassitarie hanno consentito, inoltre, di individuare,tra le razze maggiormente rappresentate nel campiona-mento, la Nera di Verzasca come quella più resistente ainematodi gastrointestinali. Sebbene questa osservazionedebba essere convalidata da ricerche specifiche, è un datocomunque molto interessante e indicativo di come l’uso disoggetti appartenenti a determinate razze può essere unvalido strumento per contrastare le infestazioni parassita-rie e i loro effetti soprattutto per quelle greggi che sfrutta-no aree pascolive di scarsa qualità e in zone piuttosto im-pervie che richiederebbero animali con minori esigenzemetaboliche.
Nell’ambito del controllo dei parassiti, un aspetto nontrascurabile che dovrebbe essere considerato con adeguataattenzione sia da parte degli allevatori sia dei tecnici è l’im-portanza del fattore alimentare in quanto l’apporto di unarazione equilibrata aiuta gli animali a sviluppare una rispo-sta immunitaria normale o l’introduzione di alimenti conte-nenti sostanze che possono avere un’azione diretta sui ne-matodi gastrointestinali quali ad esempio fieni ricchi di tan-nini condensati.
Nell’ambito del SATA sarà possibile rafforzare l’offerta diuna consulenza finalizzata al controllo delle infestazioni pa-rassitarie, con il supporto di strumenti diagnostici evoluti,sperimentati nel corso del progetto. I tecnici potranno cosìproporre in allevamento azioni di intervento mirate ed effi-caci che garantiscano risultati misurabili a vantaggio del red-dito dell’allevatore e della salubrità dei prodotti.
53
Bibliografia
Artho R., Schnyder M., Kohler L., Torgerson P.R., HertzbergH. (2007). Avermectin-resistance in gastrointestinal ne-matodes of Boer goats and Dorper sheep in Switzerland.Vet. Parasitol., 144(1-2):68-73.
Attili A.R., Ayala C., Traldi G., Furbetta R., Habluetzel A.(2004). Endoparasitic infection patterns in angora goatsand merino sheep in a fibre animal farm in Central Italy.Parassitologia 46 (suppl. 1): 23.
Bauer C. (2001). Multispecific resistance of trichostrongylesto benzimidazoles in a goat herd in Germany, DeutschTierarztl Wochenschr., 108(2):49-50).
Bellioni-Businco, B. Paganelli, R. Lucenti, P. Giampietro, P.G. Perborn, H. Businco (1999). Allergenicity of goat’smilk in children with cow’s milk allergy. Journal of Aller-gy & Clinical Immunology 103:6, 1191-1194.
Besier B. (2007). New anthelmintics for livestock: the timeis right, Trends Parasitol., 23(1):21-4.
Breen J.E., Green M.J., Bradley A.J. (2009). Quarter andcow risk factors associated with the occurrence of clinicalmastitis in dairy cows in the United Kingdom. J DairySci., 92(6):2551-2561.
Brian, R.P., Kerr, J.D., (1989). The relation between the na-tural worm burden of steers and the fecal egg count diffe-rentiated to species. Vet. Parasitol. 30:327-334.
Bronzo V. (2007). Infezioni mammarie: aspetti epidemiolo-gici e fattori di rischio. Atti del IX Congresso NazionaleS.I.V.A.R., Cremona, 11-12 maggio: 16.
Burke J.M., Miller J.E. (2008). Dietary copper sulphate forcontrol of gastrointestinal nematodes in goats. Vet. Parasi-tol., 154(3-4):289-293.
Burke J.M., Wells A., Casey P., Miller J.E. (2009). Garlicand papaya lack control over gastrointestinal nematodesin goats and lambs, Vet. Parasitol., 159(2):171-174.
Cabaret J. (2000). Anthelmintic resistance in goats: from fic-tion to facts. 7th International Conference on Goats, Tours15-18th May, 793-794.
Cabaret J., Anjorad N., Leclerc C. (1984). Typologie des ex-ploitations caprines en Touraine selon les niveaux de pro-duction et le parasitisme. Les colloques de l’INRA N°28:47-53.
Caracappa S., Riili S., Prato F., Stancanelli A., Di Marco V.,Loria G.R., Manfredi M.T. (1994). Indagine sulla faunaelmintica abomasale in ovini e caprini siciliani. Dati pre-liminari. Atti XI Congresso Nazionale “Progressi scienti-fici e tecnologici in tema di patologia e di allevamento de-gli ovini e dei caprini” S.I.P.A.O.C., Perugia 1-4 giugno;287-290.
Caracappa S., Colonna V., Russo Alesi E.M., Noto A.M., diPiccininno G. (1994). Quantitative analysis of L. monocy-togenes in some foodstuffs: 1st note. Industrie Alimentari.33:325, 400-402.
Carta A., Scala A. (2004). Recenti acquisizioni sulla geneti-
ca della resistenza ai nematodi gastro-intestinali dei rumi-nanti. Parassitologia, 46(1-2):251-255.
Chartier C., Etter E., Hoste H., Pors I., Mallereau M.P., Bro-qua C., Mallet S., Koch C., Masse A. (2000). Effects ofthe initial level of milk production and of the dietary pro-tein intake on the course of natural nematode infection indairy goats. Vet Parasitol. 10:1-13.
Chartier C., Hoste H. (1997). La thérapeutique anthelmin-thique chez les caprins. Point Vét 28:1907-1914.
Chartier C,. Soubirac F., Pors I., Silvestre A., Hubert J., Cou-quet C., Cabaret J. (2001). Prevalence of anthelmintic re-sistance in gastrointestinal nematodes of dairy goats underextensive management conditions in southwestern France.J Helminthol., 75(4):325-30.
Coles G.C., Bauer C., Borgsteede F.H.M., Geerts S., KleiT.R., Taylor M.A., Waller P.J. (1992). World Associationfor the Advancement of Veterinary Parasitology (WA-AVP). Methods for the detection of anthelmintic resistan-ce in nematodes of veterinary importance. Vet Parasitol44:35-44.
Contreras A., Corrales J.C., Sanchez A. & Sierra D. (1997) -Persistence of subclinical intramammary pathogens in go-ats throughout lactation. Journal of Dairy Science80(11):2815-2819.
Contreras A., Paape M. J. & Miller R. H.(1999). Prevalenceof subclinical intrammary infection caused by Staphylo-coccus epidermidis in a commercial dairy goat herd.Small Ruminant Research 31:203-208.
Contreras A., Sierra D., Corrales J.C., Sanchez A. &. MarcoJ. (1996). Physiological threshold of somatic cell countand California Mastitis Test for diagnosis of caprine sub-clinical mastitis. Small Ruminant Research 21: 259-264.
Coyne, M.J., Smith, G., Johnestone, C., (1991). Fecundity ofgastrointestinal trichostrongylid nematodes of sheep inthe field. Am. J. Vet. Res. 52:1182-1188.
Cringoli G., Veneziano V., Rinaldi L., Sauvé C., Rubino R.,Fedele V., Cabaret J. (2007). Resistance of trichostrongy-les to benzimidazoles in Italy: a first report in a goat farmwith multiple and repeated introductions. Parasitol Res.,101(3):577-81.
Cringoli G., Rinaldi L., Veneziano V., Pennacchio S., Gor-goglione M., Santaniello M., Schioppi M., Fedele V.,(2008). Gastrointestinal strongyle Faecal Egg Count ingoats: circadian rhythm and relationship with worm bur-den Vet. Res. Commun. 32 (Suppl. 1): S191-S193.
Das Mainak, Singh M. (2000). Variation in blood leucocytes,somatic cell count, yield and composition of milk of cros-sbred goats. Small Ruminant Research 35:169-174.
Deinhofer M., Pernthaner A. (1995) - Staphylococcus spp. asmastitis-related pathogens in goat milk. Veterinary Micro-biology 43:161-166.
Dubeuf J-P. (2004). Situation, changes and future of goats
54
industry around the world. Small Ruminant Research51(2):165-173.
Eysker M., van Graafeiland A.E., Ploeger H.W. (2006). Re-sistance of Teladorsagia circumcincta in goats to iver-mectin in the Netherlands, Tijdschr Diergeneeskd.,131(10):358-61.
Garippa G., Bufano G., Caroli A., Carta A., Cringoli G., DeNardo F., Filippini G., Leori S.G., Moniello G., Ronchi B.(2008). Realtà e prospettive dell’allevamento dei piccoliruminanti in Italia. Large Animal Rev. (4 suppl.) 40-43.
Genchi C., Manfredi M.T., Bossi A. (1984a). Les infesta-tions naturelles par les strongles digestifs sur les pâturagesde haute montagne: interaction entre la chèvre et le cha-mois. Les colloques de l’INRA, 28:501-505.
Genchi C., Manfredi M.T., Sioli C. (1984b). Les infestationsnaturelles des chèvres par les strongles pulmonaires enmilieu alpin. Les colloques de l’INRA, 28:347-352.
Genchi C. (2006). Schemi terapeutici e antielmintico-resi-stenza. Parassitologia, 48:423-431.
Giannetto S., Niutta P.P., Giudica E. (1994). Reperto di Ca-licophoron microbothrium (Fischoeder, 1901) in ovi-ca-prini della provincia di Messina. Atti XI Congresso Na-zionale “Progressi scientifici e tecnologici in tema di pa-tologia e di allevamento degli ovini e dei caprini”S.I.P.A.O.C. , Perugia 1-4 giugno 1994; 307-310.
Gilmour A. & Harvey J. (1990) Staphylococci in milk andmilk products. Journal of Applied Bacteriology Sympo-sium Supplement 19:147-166.
Gopal R.M., Pomroy W.E., West D.M. (1999). Resistance offield isolates of Trichostrongylus colubriformis and Oster-tagia circumcincta to ivermectin. Int J Parasitol.29(5):781-6.
Gorski P., Niznikowski R., Strzelec E., Popielarczyk D., Ga-jewska A., Wedrychowicz H. (2004). Prevalence of proto-zoan and helminth internal parasite infections in goat andsheep flocks in Poland. Arch. Tierz., Dummerstorf 47(Special Issue): 43-49.
Hall S.M., Rycroft A.N. (2007). Causative organisms andsomatic cell counts in subclinical intramammary infec-tions in milking goats in the UK. Vet Rec., 160(1):19-22.
Hoste H., Chartier C. (1993). Comparison of the effects onmilk production of concurrent infection with Haemonchuscontortus and Trichostrongylus colubriformis in high andlow producing dairy goats. Am. J Vet Res 54:1886-1893.
Hoste H., Chartier C., Etter E., Goudeau C., Soubirac F., Le-frileux Y. (2000). A questionnaire survey on the practicesadopted to control gastrointestinal nematode parasitism indairy goat farms in France.Veterinary Research Commu-nications 24:459-469.
Hoste H, Le Fryleux Y, Goudeau C, Chartier C, Pors I, Bro-qua C, Bergeaud JP (2002). Distribution and repeatibilityof nematode faecal egg counts in dairy goats: a farm sur-vey and implication for worm control. Research in Veteri-nary Science: 72, 211-215.
Hoste H., Leveque H., Dorchies P. (2001). Comparison ofnematode infections of the gastrointestinal tract in Ango-ra and dairy goats in a rangeland environment: relationswith the feeding behaviour. Vet Parasitol 101:127-135.
Hoste H., Torres-Acosta J.F., Paolini V., Aguilar-CaballeroA., Etter E., Lefrileux Y., Chartier C., Broqua C. (2005).
Interactions between nutrition and gastrointestinal infec-tions with parasitic nematodes in goats. Small Rumin.Res. 60:141-151.
Jackson F., Coop R.L. (2000). The development of anthel-mintic resistance in sheep nematodes. Parasitology120:S95-S107.
Koop G., Nielen M., van Werven T. (2009). Bulk milk so-matic cell counts are related to bulk milk total bacterialcounts and several herd-level risk factors in dairy goats. JDairy Sci., 92(9):4355-4364.
Lodi R., Brasca M., Malaspina P., Nicosia P. (1994). Il mi-glioramento della qualità microbiologica del latte di capramediante trattamento UV. Atti XI Congresso Nazionale“Progressi scientifici e tecnologici in tema di patologia edi allevamento degli ovini e dei caprini” S.I.P.A.O.C. , Pe-rugia 1-4 giugno 1994; 427-430.
Luengo C., Sánchez A., Corrales J.C., Fernández C., Con-treras A. (2004). Influence of intramammary infection andnon-infection factors on somatic cell counts in dairy go-ats. J Dairy Res., 71(2):169-174.
Madonna, M., Traldi, G., (1989). Efficacia degli esami co-promicroscopici nei ruminanti domestici e selvatici. Attidella Soc. It. Sci. Vet. 43:1209-1211.
Maingi N., Bjørn H., Thamsborg S.M., Bøgh H.O., NansenP.A.(1996). Survey of anthelmintic resistance in nemato-de parasites of goats in Denmark. Vet Parasitol., 66(1-2):53-66.
Michel, J.F., 1969. Observations on the faecal egg count ofcalves naturally infected with Ostertagia ostertagi. Para-sitology 59:829-835.
Min B.R., Tomita G., Hart S.P. (2007) Effect of subclinical in-tramammary infection on somatic cell counts and chemicalcomposition of goats’ milk. J Dairy Res., 74(2):204-210.
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAAF), 1986.Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techni-ques. HMSO, London, 160 pp.
Morand-Fehr P., Boutonnet J.P., Devendra C., Dubeuf J-P.,Haenlein G.F.W., Holst P., Mowlem L., Capote J. (2004).Strategy for goat farming in the 21st century. Small Rumi-nant Research 51(2):175-183.
Moroni P., Antonini M., Luzi F., Cattaneo D., Savoini G.,Bronzo V. (2002). Prevalence of Coagulase Negative Sta-phylococci (CNS) and correlation with somatic cellcounts in Italian dairy goat herds. Journal of Dairy Scien-ce. 85(1):292.
Moroni P., Pisoni G., Ruffo G., Boettcher P.J.( 2005a). Riskfactors for intramammary infections and relationship withsomatic-cell counts in Italian dairy goats. Prev Vet Med.,69(3-4):163-173.
Moroni P., Pisoni G., Vimercati C., Rinaldi M., CastiglioniB., Cremonesi P., Boettcher P. (2005b) Characterizationof Staphylococcus aureus isolated from chronically infec-ted dairy goats. J Dairy Sci., 88(10):3500-3509.
Moroni P., Bronzo V., Cuccuru C., Luzi F., Cattaneo D., Sa-voini G. (2001). Organic dairy goat farming: intramam-mary infections, milk production and quality (EAAP Pu-blication No. 106). Proceedings of a joint internationalconference organised by the Hellenic Society of AnimalProduction and the British Society of Animal Science,Athens, Greece, 4-6 October 2001. 2002. 153-156.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
55
Mortensen L.L., Williamson L.H., Terrill T.H., Kircher R.A.,Larsen M., Kaplan R.M. (2003). Evaluation of prevalenceand clinical implications of anthelmintic resistance in ga-strointestinal nematodes in goats. J Am Vet Med Assoc.,223(4):495-500.
Mossel, D.A.A. & Van Netten P. 1990 Staphylococcus aureusand related staphylococci in foods: ecology, proliferation,toxinogenesis, control and monitoring. Journal of AppliedBacteriology Symposium Supplement 19:123S-145S.
Nord K., Adnøy T. (1997). Effects of infection by caprine ar-thritis-encephalitis virus on milk production of goats. Ac-ta Vet Scand., 38(2):197-199.
Paape M.J., Capuco A.V. (1997). Cellular defence mecha-nisms in the udder and lactation of goats. Journal of Ani-mal Science 75(2):556-565.
Paape M.J., Nelson T.K., Bowman M.E., Contreras A. & Ko-bayashi H. (1999). Will bromelain reduce milk somatic cellcounts for goats as it did for cows? Atti della 16a JornadasNacionales y 1a Internacionales de Tecnicos Especialistasen Mamitis y Calidad de Leche, Murcia, Spagna, 9.
Paraud C., Kulo A., Chartier C. (2009). Resistance of goatnematodes to multiple anthelmintics on a farm in France.The Veterinary Record, 164(18):563.
Park Y.W. & Humphrey R.D. (1986). Bacterial cell counts ingoat milk and their correlations with somatic cell counts,percent fat, and protein. Journal of Dairy Science69(1):32-37.
Pisoni G., Ruffo G., Moroni P. (2003). Epidemiology of mam-mary infections in dairy goat farms: impact on the somaticcell count. Obiettivi e Documenti Veterinari. 24:2, 11-16.
Poutrel B. (1984). Udder infection of goat by coagulase-nega-tive staphylococci. Veterinary Microbiology 2: 131-137.
Poutrel B., de Cremoux R., Ducelliez M. & Verneau D.(1997). Control of intramammry infection in goats: im-pact on somatic cell counts. Journal of Animal Science75(2):566-570.
Pralomkarn W., Pandey V.S., Ngampongsai W., Choldum-rongkul S., Saithanoo S., Rattaanachon L., Verhulst A.,(1997). Genetic resistance of three genotypes of goats toexperimental infection with Haemonchus contortus. Vet.Parasitol. 68:79-90.
Prestera G., Zacometti L., Lia R., Puccini A. (1994). Indagi-ne parassitologica sugli allevamenti ovi-caprini delle co-munità montane della provincia di Potenza. Atti XI Con-gresso Nazionale “Progressi scientifici e tecnologici in te-ma di patologia e di allevamento degli ovini e dei caprini”S.I.P.A.O.C., Perugia 1-4 giugno 1994 279-282.
Raynaud J.P., 1970. Etude de l’efficacité d’une technique decoproscopie quantitative pour le diagnostic de routine et lecontrôle des infestations parasitaires des bovins, ovins,équins et porcins. Ann. Parasitol. Hum. Comp. 45:321-342.
Rinaldi L., Veneziano V., Cringoli G., 2007. Dairy goat pro-duction and the importance of gastrointestinal strongyle pa-rasitism. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 101:745-746.
Sánchez A., Contreras A., Corrales J.C., Marco J.C. (2001).Relationships between infection with caprine arthritis ence-phalitis virus, intramammary bacterial infection and soma-tic cell counts in dairy goats. Vet Rec., 148(23):711-714.
Sànchez A., Contreras A., Corrales J.C. (1999) - Parity as arisk factor for caprine subclinical intramammary infec-tion. Small Ruminant Research 31:197-201.
Sato K., Bartlett P.C., Alban L., Agger J.F., Houe H. (2008).Managerial and environmental determinants of clinicalmastitis in Danish dairy herds. Acta Vet Scand., 50:4.
Schnyder M., Torgerson P.R., Schönmann M., Kohler L.,Hertzberg H. (2005). Multiple anthelmintic resistance inHaemonchus contortus isolated from South African Boergoats in Switzerland. Vet Parasitol., 128(3-4):285-90.
Sheldrake R.F., Hoare R.J., Woodhouse V.E. (1981). Relation-ship of somatic cell count and cell volume analysis of goa-t’s milk to intramammary infection with coagulase-negati-ve staphylococci. Journal Dairy Research 48(3):393-403.
Steeneveld W., Hogeveen H., Barkema H.W., van den BroekJ., Huirne R.B. (2008).The influence of cow factors on theincidence of clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci.,91(4):1391-1402.
Sykes A.R. (1994). Parasitism and production in farm ani-mals. Anim. Prod. 59:155-172.
Torina A., Dara S., Marino A.M.F., Sparagano O.A.E., Vita-le F., Reale S., Caracappa S. 2004. Study of Gastrointesti-nal Nematodes in Sicilian Sheep and Goats. Ann. N.Y.Acad. Sci. 1026:187-194.
Traldi G., Franchi C. (1987). Indagine sulla diffusione delleelmintiasi nell’allevamento ovino e caprino in provinciadi Varese. Selezione Veterinaria 28:1485-1491.
Vallade S., Hoste H., Goudeau C., Broqua C., Lazard K., Le-frileux Y., Chartier C., Etter E., (2000). Relationship bet-ween nematode parasitism of the digestive tract and thecharacteristics of dairy goat farms in two French regions.Revue Méd. Vét. 151:1131-1138.
Veneziano V. (2004). Il controllo delle strongilosi gastro-in-testinali dei ruminanti. Parassitologia 46:245-250.
Vercruysse J. (1983). A survey of seasonal changes in ne-matode faecal egg count level of sheep and goats in Sene-gal. Vet Parasitol 13:239-244.
Waller P.J. (1997). Anthelmintic resistance. Vet Parasitol72:391-412.
Waller P.J. (1999). International approaches to the conceptof integrated control of nematode parasites of livestock.Int.J. Parasitol. 29:155-164.
Wilson D.J., Stewart K.N., Sears P.M. (1995). Effects of sta-ge of lactation, production, parity and season on somaticcell counts in infected and unifected dairy goats. SmallRuminant Research 16(2):165-169.
Zeng S.S. & Escobar E.N. (1996). Effect of breed and mil-king method on somatic cell count, standard plate countand composition of goat milk. Small Ruminant Research19:169-175.
Bibliografia
57
Linee guida per la gestione delle infestazioni da nematodi gastrointestinalinell’allevamento caprino
Le indagini svolte nell’ambito del progetto SANCAPRhanno consentito di evidenziare l’elevata diffusione delle in-festazioni da nematodi gastrointestinali, in particolare diquelli appartenenti alla famiglia Trichostrongylidae (ordineStrongylida) che causano cali di produzione negli allevamen-ti di capre della Lombardia. Tali parassitosi colpiscono prin-cipalmente le aziende al pascolo, estensivo o semiestensivo.Gli allevamenti a carattere intensivo non sono scevri da que-ste problematiche ma le infestazioni sono risultate differentisia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo. Le analisihanno dimostrato che le capre più parassitate provenienti daallevamenti estensivi o semiestensivi mostrano alterazioninelle produzioni di latte e il numero di cellule somatiche è au-mentato. Per altro, l’analisi della gestione attuale di questeendoparassitosi ha messo in evidenza numerosi punti critici eirrazionalità relative soprattutto ai trattamenti antielmintici.
Il rischio parassitario risulta particolarmente importanteper gli allevamenti caprini in Lombardia e si rende pertantonecessario intervenire con dei piani di profilassi volti a limi-tare l’impatto del parassitismo ad un livello economicamenteaccettabile tenuto conto anche della debole risposta immuni-taria che le capre manifestano nei confronti dei parassiti.
Le strategie di controllo delle infestazioni parassitarie sibasano essenzialmente sull’utilizzo dei trattamenti antiel-mintici applicati nei periodi più a rischio, quali primavera eautunno. Negli allevamenti che effettuano il pascolo, l’effica-cia dei trattamenti può avere effetti a lungo termine se conte-stualmente sono applicate misure sanitarie volte a una gestio-ne ragionata dei pascoli per ridurre il rischio parassitario.
Il punto cruciale per il controllo delle infestazioni da ne-matodi gastrointestinali è il monitoraggio costante dell’alle-vamento attraverso esami parassitologici copromicrosco-pici il cui esito è fondamentale per decidere qualsiasi tipo diintervento relativamente al trattamento (trattare o meno, ef-fettuare uno o due trattamenti, trattare tutti i soggetti o solouna parte, ecc.). L’esame parassitologico delle feci deve es-sere sempre effettuato prima di somministrare qualsiasi tipodi trattamento antielmintico.
Un ulteriore aiuto diagnostico è l’esame autoptico che con-sente di effettuare l’esame parassitologico diretto del tratto ga-strointestinale e identificare, più facilmente della coprocoltu-ra, i generi parassitari presenti (Haemonchus, Ostertagia, Tri-chostrongylus, Oesophagostomum, Chabertia). Possono esse-re utilizzati a questo scopo animali destinati alla macellazio-ne, il cui tratto gastrointestinale è prelevato e analizzato da unlaboratorio specializzato. Molto utili sono anche gli animalideceduti per morte naturale. In entrambi i casi gli organi pre-levati possono essere congelati e analizzati successivamente.
PUNTI CRITICI DA CONSIDERAREPER UNA CORRETTA DIAGNOSI DI LABORATORIO
1) CampionamentoIl prelievo delle feci da sottoporre ad esame può essere di
gruppo o individuale a seconda che si voglia conoscere lo sta-to parassitario del gregge o la diversità di parassiti presenti.
CAMPIONAMENTO DI GRUPPO: il prelievo, diretta-mente dal retto, deve essere fatto su almeno 5 soggetti percategoria o stadio di lattazione e con le feci raccolte si costi-tuisce un pool per ciascuna categoria di animali presente inallevamento. L’esame copromicroscopico è eseguito sul po-ol opportunamente mescolato e l’esito è relativo a ciascunacategoria di soggetti campionati.
CAMPIONAMENTO INDIVIDUALE: il prelievo vie-ne effettuato su singoli individui (becchi, animali sintomati-ci) allo scopo di ottenere una diagnosi individuale; ognicampione è analizzato singolarmente mediante esame co-promicroscopico. I campioni di feci individuali possono es-sere impiegati per esami specifici (coprocolture) che con-sentono di identificare i generi di parassiti coinvolti e quindivalutare correttamente gli effetti patogeni dell’infestazione.
2) Conservazione dei campioniTra +4°C e +8°C (in frigorifero) fino al trasporto in labo-
ratorio. Soprattutto se le feci sono campionate in tarda pri-mavera o in estate, la mancata refrigerazione provoca la pre-coce schiusa delle larve. Le feci non devono essere congela-te in quanto il congelamento altera la parete dell’uovo pro-vocandone la rottura. In entrambi i casi è elevata la probabi-lità di avere dei risultati falsi negativi che sottostimano am-piamente il livello reale di infestazione.
Il trasporto in laboratorio deve essere tempestivo, pos-sibilmente lo stesso giorno del prelievo.
ESAME COPROMICROSCOPICO
L’esame copromicroscopico consente di stabilire:• l’entità delle cariche;• le categorie di soggetti più infestate;• i generi parassitari coinvolti (le capre sono parassitate
da numerosi nematodi gastrointestinali, alcuni deiquali sono molto patogeni).
58
3) Tecnica utilizzata per l’esame copromicroscopico
L’esame copromicroscopico è l’esame che consente didiagnosticare le infestazioni da nematodi gastrointestinaliintra vitam; sono da preferire gli esami quantitativi che per-mettono di determinare il numero di uova escrete dai paras-siti e presenti nelle feci degli animali infestati (upg= uovaper grammo di feci). Il tecnico o l’allevatore devono preten-dere il calcolo di questo indice per poter prendere decisionicorrette in merito al trattamento.
Occorre affidarsi ad un laboratorio specializzato che uti-lizzi metodiche attendibili (McMaster, FLOTAC) e altamen-te sensibili.
4) Analisi dei risultati dell’esame copromicroscopico
In generale si possono considerare, su campionamento digruppo, 3 livelli d’infestazione:• livello inferiore o uguale a 300 upg
Le cariche parassitarie sono molto basse, il trattamentonon è strettamente necessario tranne quando gli anima-li rientrano alla fine della stagione di pascolo.
• Livello superiore a 1000 upgIl trattamento è decisamente necessario.
• Livello compreso tra 300 e 1000 upgIl trattamento viene deciso dopo aver preso in considera-zione le produzioni degli animali e il loro stato sanitario.Questi livelli di infestazione sono comunque da rapporta-
re al periodo dell’anno in cui è stato fatto il prelievo, all’etàdegli animali e al loro stato fisiologico. Se il prelievo è ef-fettuato all’inizio della stagione di pascolo le cariche sononecessariamente basse e sono destinate ad aumentare a ma-no a mano che gli animali utilizzeranno il pascolo. Gli ani-mali giovani, le caprette, sono meno parassitate; le caprenel periodo del periparto (da 2 settimane prima a 8 settima-ne dopo il parto) eliminano un maggior numero di uova.L’entità della carica dipende anche dall’alimentazione chericevono gli animali; le capre con un apporto nutritivo cor-retto (senza carenze) eliminano meno parassiti. Ne consegueche ogni allevamento costituisce un caso specifico, non sipossono traslare informazioni da un’azienda all’altra anchese molto vicine dal punto di vista territoriale e anche nel-l’ambito della stessa azienda l’andamento delle infestazionivaria negli anni e con la composizione del gregge.
5) Identificazione del livello di rischioSITUAZIONI A BASSO RISCHIO: Greggi al primo an-
no di pascolo su pascoli di nuovo impianto, privi di contatticon altre greggi caprine o anche ovine. Gli ovini sono un fat-tore di rischio in quanto hanno gli stessi parassiti delle capre.
SITUAZIONI IN CUI IL RISCHIO È MODERATO OELEVATO: Riguarda gli allevamenti:• al primo anno di pascolo che hanno contatti diretti (pa-
scolamento sulla stessa parcella) o indiretti (pascolamen-to su parcelle affiancate) con altre greggi;
• che effettuano il pascolo da 2-3 anni minimo;• che possiedono animali provenienti da aziende che prati-
cano il pascolo e che non sono stati trattati al loro arrivo; • con problemi di parassitismo diagnosticati in precedenza.
TRATTAMENTI ANTIELMINTICI
I trattamenti parassitari nell’allevamento caprinoI principi attivi per il trattamento dei nematodi gastrointe-
stinali dei caprini sono in numero minore rispetto a quelli di-sponibili per le altre specie animali. Nella Tabella 1 sono ri-portati solo i farmaci registrati in Italia per i caprini e per iquali sono indicati chiaramente i tempi di sospensione, valea dire la durata del periodo di tempo in cui il latte o la carnedegli animali trattati non sono utilizzabili per il consumoumano. Tuttavia è possibile utilizzare in deroga anche mole-cole registrate per altre specie di ruminanti.
I dosaggi riportati nella Tabella 1 sono quelli indicati dal-le aziende sia per la pecora sia per la capra. È molto impor-tante, invece, nell’eseguire il trattamento antielmintico ri-spettare i dosaggi indicati per la specie caprina (Tab. 2) siaper consentirne la completa efficacia sia per evitare i rischidel sottodosaggio ovvero la comparsa di forme di antielmin-tico resistenza.
PUNTI CRITICI DA CONSIDERAREPER APPLICARE UN CORRETTOTRATTAMENTO ANTIELMINTICO
1) Fattori che influiscono sull’efficacia del trattamentoLa capra possiede un particolare metabolismo che deter-
mina una eliminazione rapida dei farmaci. Per avere una ef-ficacia del trattamento comparabile a quella degli ovini, nel-la capra è necessario aumentare la posologia (il doppio deldosaggio utilizzato nella pecora).
Le modalità di somministrazione influiscono sul tratta-mento come nel caso dei benzimidazoli che possono esseredati all’animale:• in un’unica somministrazione della dose richiesta (cioè il
dosaggio ovino raddoppiato),• in due somministrazioni della dose richiesta a 12 o 24 ore
d’intervallo. La biodisponibilità (cioè la quantità di prin-cipio attivo presente nell’organismo) in questo caso èmaggiore ed è possibile ottenere un guadagno fino al 30%di efficacia.Il digiuno prima del trattamento consente anch’esso un
guadagno del 30% di efficacia; questa pratica è raccoman-data al momento della messa in asciutta del gregge.
2) Resistenza agli antielminticiNei piccoli ruminanti la presenza di nematodi resistenti
agli antielmintici è ben conosciuta e riguarda in modo parti-colare i farmaci benzimidazoli.
Nelle situazioni in cui forme di resistenza sono conferma-te, i trattamenti effettuati utilizzando tali principi attivi sonoscarsamente efficaci.
Sebbene negli allevamenti lombardi fenomeni di resisten-za diffusa non siano stati riscontrati (in Francia ben il 70%delle aziende caprine sono colpite dal fenomeno), questo pro-blema non deve essere sottostimato e deve quindi essere ve-rificata la validità del trattamento applicando il test della ri-duzione delle uova (FECRT) che consiste nel comparare ilnumero di uova escrete prima e dopo il trattamento. Poiché ilsottodosaggio è tra le cause che determinano la comparsa di
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
59
fenomeni di resistenza, la dose totale da somministrare deveessere calcolata se possibile sul peso esatto della capra oppu-re su quello dei soggetti più pesanti all’interno del gruppo.
3) La decisione di effettuare il trattamento si deve basaresempre sui risultati dell’esame copromicroscopico.
4) Allo scopo di ottenere il massimo del beneficio, il trat-tamento dovrebbe essere eseguito sugli animali in stalla etrattenuti per 48 ore prima di rimandarli al pascolo in quan-to le capre eliminano ancora uova di parassiti durante questoperiodo. Dopo aver effettuato il trattamento, gli animali van-no immessi su una parcella sana.
Linee guida per la gestione delle infestazioni da nematodi gastrointestinali nell’allevamento caprino
Classe Farmacologica/ Nome SpecieDosaggio Tempo di
Principio Attivo Commerciale animale(mg/kg pc)/Via di Parassiti sensibili sospensionesomministrazione (gg.)
TABELLA 1 - Antielmintici attivi nei confronti dei principali endoparassiti registrati in Italia per i caprini (aggiornati fino a dicembre 2010).
IMIDAZOTIAZOLI
Levamisolo Cloridrato PAMIZOLE-L O, C, B 7,5 mg Dictyocaulus filaria spp., Carne 14SC, IM Haemonchus spp., Teladorsagia, No in lattazione
Trichostrongylus spp., Cooperia spp.;Bunostomum spp.; Strongyloides papillosus,Oesophagostomum spp., Trichuris ovis,Chabertia ovina, Moniezia spp
AMIDINICI
Morantel Tartrato MORANTEL TARTRATO O, C, B 10 mg Nematodi gastrointestinali Carne 28 (O), 4% LIQUIDO OS 42 (C)
Latte: 2 (O), 5 (C)
BENZIMIDAZOLI
Fenbendazolo PANACUR 2,5% O, C 5 mg Nematodi Dictyocaulus filaria, Haemonchus spp., Carne 28Sospensione 10 mg Cestodi Teladorsagia spp., Trichostrongylus spp., Latte 9
OS Cooperia spp., Nematodirus spp.,Bunostomum spp.; Strongyloides papillosus,Oesophagostomum spp., Trichuris ovis,Chabertia ovina, Gaigera pachycelisMoniezia spp.
Oxfendazolo OXFENIL 2,265 O, B, C 5 mg/kg pc Infestazioni da parassiti polmonari e Carni 44Sosp. orale gastrointestinali, Cestodi (Moniezia spp.) Latte 9
PROBENZIMIDAZOLI
Netobimin HAPADEX 5% O, C 7,5 mg Nematodi gastrointestinali e Carne 21Sospensione OS broncopolmonari Latte 3
SALICILANILIDI
Nitroxinil TRODAX 34% O, C, B 10 mg Fasciola hepatica e gigantica Carne 59Iniettabile SC No in lattazione
AVERMECTINE
Ivermectina ORAMEC O, C 200 µg/kg Haemonchus spp., Teladorsagia spp., Carne 5 (O)Soluzione orale OS Trichostrongylus spp., Cooperia spp., 14 (C)
Nematodirus spp., Bunostomum spp.; No in lattazioneStrongyloides papillosus, e nei 28 gg.Oesophagostomum spp., Trichuris ovis, prima del partoChabertia ovina, Gaigera pachycelisOestrus ovis, Psoroptes ovis; D. filaria(Ad., L3, L4)
TOLOMEC O.S. O, C 200 µg/kg D. filaria, P. rufescens, Haemonchus spp., Carne 30OS Teladorsagia spp., Trichostrongylus spp., No in lattazione
Cooperia spp., Nematodirus spp., e nei 60 gg.Bunostomum spp.; Strongyloides papillosus, prima del partoOesophagostomum spp., Trichuris ovis,Chabertia ovina, Gaigera pachycelis,Oestrus ovis, Psoroptes ovis
ASSOCIAZIONI
Levamisolo + TOLOXAN O, C, B 15 mg/3 kg Fasciola hepatica, Fasciola gigantica e Carne 42Ossiclozanide Sospensione orale 30 mg/3 kg Fascioloides magna, Trichuris ovis, No in lattazione
OS Haemonchus sp., Ostertagia sp.,Trichostrongylus sp., Cooperia sp.,Nematodirus sp., Bunostomum sp.,Oesophagostomum sp., Chabertia ovina,Strongyloides papillosus, Dictyocaulus spp.,Paramphistomidi
Specie animale: B = bovino, O = ovino, C = caprino - Via di somministrazione: OS = orale, SC = sottocutanea, IM = intramuscolare.
60
• quelli che apparentemente sono più colpiti dal parassiti-smo (caduta del latte in rapporto alla produzione abituale,dimagramento, diarrea, …).Questo tipo di trattamento interesserà circa 2/3 del gregge
e la scelta dei soggetti dovrà basarsi sugli esiti degli esamicopromicroscopici. Il trattamento mirato è consigliabile su-gli animali durante la stagione di pascolo; il trattamento alritorno in stalla alla fine dell’autunno riguarda al contrariotutti gli animali del gregge.
ALTERNATIVE PER IL FUTURO
Considerando in generale il rischio dell’aumento di resi-stenza agli antielmintici nell’allevamento caprino, la ne-cessità di garantire al consumatore alimenti sempre più si-curi dal punto di vista dei residui e provenienti da animaliallevati secondo il metodo biologico e, non ultima la nor-mativa europea che raccomanda il minor uso di farmaci, lagestione del parassitismo sempre più dovrà basarsi sullacombinazione di soluzioni multiple che tengano conto deiseguenti punti:• agire sui nematodi presenti nell’ospite (nuovi antielmintici);• aumentare la capacità della risposta immunitaria (stimola-
re la risposta immunitaria) o ridurre le fonti d’infestazio-ne (risanamento dei pascoli);
• sfruttare la resistenza di capre autoctone nei confronti del-le infestazioni parassitarie: numerose ricerche hanno di-mostrato che molte razze di capre sono naturalmente resi-stenti agli endoparassiti;
• nuove sostanze con proprietà antielmintiche.Recenti studi, hanno provato che alcune piante ricche di
tannini condensati, quali quelle della famiglia delle legumi-nose (trifoglio, lupinella ecc.), possono contribuire a limita-re le conseguenze del parassitismo e a modulare l’epidemio-logia delle infestazioni da nematodi gastrointestinali appar-tenenti alla famiglia dei Trichostrongylidae.
Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e produzioni
Classe farmacologica/ Dosaggio pecora Dosaggio capraPrincipio Attivo (mg/kg p.v) (mg/kg p.v.)
TABELLA 2 - Dosaggio raccomandato negli ovini e nei capriniper le principali molecole antielmintiche appartenenti alle classifarmacologiche dei benzimidazoli, imidazotiazoli, tetraidropirimi-dine, avermectine e salicilanilidi.
BENZIMIDAZOLI E PRO-BENZIMIDAZOLI
Albendazolo 3,8 7,6
Febantel 5 10
Tiabendazolo 50 100
Mebendazolo 15 30
Fenbendazolo 5 10
Netobimin 7,5 15
Oxfendazolo 5 10
IMIDAZOTIAZOLI/TETRAIDROPIRIMIDINE
Levamisolo 7,5 12
Pyrantel 20 40
AVERMECTINE
Eprinomectina 0,5 0,5 fino a 1
Ivermectina 0,2 0,4
SALICILANILIDI
Closantel 10 10
5) In alternativa al trattamento di massa rivolto a tutti gliindividui del gregge, è possibile effettuare un trattamentomirato (selettivo) limitato alle capre maggiormente infesta-te. Tale modalità ha il vantaggio di ridurre il numero di trat-tamenti nel gregge, il rischio di comparsa di fenomeni di an-tielminticoresistenza e di limitare / ridurre l’escrezione di re-sidui di farmaci nell’ambiente. Il principio su cui si basa èquello per cui il 20-30% del gregge è responsabile del 70-80% della contaminazione della parcella pascolativa.
Gli animali da trattare sono:• quelli che potenzialmente eliminano più uova (primipare
e/o forti produttrici al picco di lattazione);
61
Linee guida per la gestione delle infestazioni da nematodi gastrointestinali nell’allevamento caprino
Misure di prevenzione Punti di sorveglianza
Linee guida per la gestione delle infestazioni da nematodi gastrointestinali nell’allevamento della capra da latte: fattori di rischio, misu-re di prevenzione e punti di sorveglianza.
FATTORI DI RISCHIO LEGATI AGLI ANIMALI
Età Evitare di mescolare caprette e capre adulte. Se si mescolano gli animali giovani con quelliadulti: sono da controllare in modo particolare lostato generale e l’accrescimento delle caprette. Esame copromicroscopico se è necessario.
Stadio fisiologico Verificare che gli animali non siano parassitati Esame copromicroscopico in asciutta.al momento del parto. Il trattamento deve essereeffettuato in stalla o su parcelle pulite(“senza parassiti”). Trattamento consigliatoin asciutta con un antielmintico diverso daibenzimidazoli (avermectine).
Livello di produzione Le capre buone produttrici sono più recettive e Sorveglianza particolare delle migliori capresensibili al parassitismo. Sono animali «sentinella» del gregge.per il resto del gregge. Determinare la curva di lattazione individuale.
Esame copromicroscopico su questi soggetti.
Alimentazione Equilibrare la razione.Evitare carenze nutrizionali in modo particolareper la parte proteica.
Altre patologie associate Evitare l’associazione con altre parassitosi. Esame copromicroscopico esteso anche agli altripotenziali parassiti (nematodi broncopolmonari,cestodi).
Introduzione di altri individui Anche per i nematodi gastrointestinali si può Esame copromicroscopico su tutti i soggettiprovenienti da allevamenti esterni applicare il principio della quarantena: immessi in allevamento.(acquisto di nuovi soggetti, capre 1) Verificare mediante esame copromicroscopico Verificare l’efficacia del trattamento antielminticoo becchi, becchi in prestito il livello di infestazione prima di effettuare il applicando il FECR test.per la monta) trattamento degli animali.
2) Trattare gli animali introdotti.
Presenza di altre specie animali Evitare di mescolare ovini e caprini. Se sono presenti bovini o equini è necessarioin allevamento Le associazioni con bovini o equini sono piuttosto verificare in questi animali la presenza di
favorevoli. infestazioni da trematodi epatici.
FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA GESTIONE DEL PASCOLO
Carico del pascolo/ha Evitare il sovraccarico.
Messa al pascolo Evitare di mandare al pascolo animali parassitati; Esame copromicroscopico prima e dopo ilè necessario trattare prima. trattamento per verificarne l’efficacia.
Periodo di pascolamento nel corso Evitare il pascolamento prolungato di un’area Il pascolo dovrebbe essere suddiviso in parcelledell’anno pascoliva. affinché gli animali utilizzino una parcella alla volta
e che ci sia un tempo sufficiente per far riposare leparcelle tra un periodo di pascolamento e l’altro daconsentire il loro risanamento.
Periodo di pascolamento nell’arco Evitare la precoce uscita mattutina ed un tardivo Ricoverare gli animali nelle ore notturne.della giornata rientro serale al fine di ridurre l’assunzione di larve
infestanti dei nematodi gastrointestinali che in talimomenti della giornata sono concentrate all’apicedella vegetazione.
Tipo di pascolo Un pascolo naturale è più a rischio di un pratopascolo coltivato, come uno di vecchio impiantoè più a rischio di uno nuovo. Un erbaio costituitoda leguminose e/o graminacee può essere arischio in considerazione del microclima che siinstaura a livello del terreno in seguito alleconcimazioni e soprattutto alle irrigazioni.
Pascolo promiscuo Evitare il pascolamento contemporaneo di greggidiverse e di animali di categorie differenti.
Cura agronomica del pascolo I prati naturali vecchi non sottoposti a nessuna Erpicatura, decespugliamento, spietramento, cura agronomica sono una maggiore fonte di concimazioni e drenaggio rendono l’habitat meno rischio per la presenza di muschio, erbe a ciuffo, adatto allo sviluppo e sopravvivevza delle forme cespugli ecc. infestanti diminuendo l’infestività del pascolo.
Il reimpianto del pascolo e la semina di foraggerecon i relativi interventi agronomici preliminari neprovocano la “sterilizzazione”.
62
Linee guida per la sanità della mammella
Nell’ambito dell’indagine svolta non è stata evidenziata lapresenza di alcuna positività a Salmonella e Listeria, limi-tando quindi ai minimi termini, la possibilità di contamina-zione del latte caprino prodotto, da parte degli animali. Sta-phylococcus aureus, responsabile di gravi mastiti nella caprae potenziale produttore di enterotossine dannose per la salu-te umana, è stato invece ritrovato in poco più del 3% degliallevamenti testati, rappresentando quindi un fattore di ri-schio identificato e, nei confronti del quale, diventa necessa-rio applicare, ove presente, opportune misure di controllo,vista la prerogativa di trasmissibilità diretta o mediata, prin-cipalmente attraverso la mungitura, meccanica o manualeche sia, determinata dalla contagiosità dell’infezione.
CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI
Il controllo delle infezioni mammarie da Staphylococcusaures si basa fondamentalmente sui seguenti punti:1) Blocco della diffusione dell’infezione2) Riduzione dei fattori che favoriscono l’infezione3) Cura delle infezioni durante l’asciutta4) Controllo della sintomatologia e contenuto in cellule so-
matiche del latte durante la lattazione.
1) Blocco della diffusione dell’infezioneIl concetto chiave è quello di impedire la diffusione del-
l’infezione da un animale malato ad un animale sano. Que-sto obiettivo è attuabile solo separando gli animali infetti daquelli sani, creando un gruppo a parte che dovrà essere mun-to per ultimo.
Tale separazione può provocare dei problemi logistici,formazione di più gruppi di animali, creazione di più gruppialimentari, maggiori tempi di mungitura ecc., ma gli aspettinegativi sono compensati dagli ottimi risultati che si otten-gono dal punto di vista sanitario della mandria.
2) Riduzione dei fattori che favoriscono l’infezione
La riduzione di tali fattori si esplica applicando le basila-ri norme igieniche riguardanti le operazioni di mungitura ela gestione della lettiera. Queste operazioni interessano siagli animali in lattazione che gli animali in asciutta.
Per quanto riguarda gli animali in lattazione, le attenzionivanno rivolte all’igiene della lettiera, programmando inter-
valli di rimozione subordinata al monitoraggio periodicodelle condizioni della stalla (polverosità, odori, umidità rela-tiva); l’eventuale impiego di ammendanti (paraldeide, calcespenta, perfosfato) con azione batteriostatica, può rappre-sentare, in tal senso, un valido aiuto soprattutto in casi di fo-colai di mastite gangrenosa.
Per quanto riguarda la mungitura, si auspica un utilizzo si-stematico, da parte del personale addetto, di guanti di lattice,minimizzando la contaminazione ambientale, tramite l’eli-minazione dei primi getti di latte, mediante raccolta in appo-siti recipienti. La pulizia dei capezzoli con salviettine mo-nouso a perdere, imbevute di soluzione disinfettante, e la di-sinfezione dei capezzoli dopo la mungitura possono rappre-sentare ulteriori misure di biocontenimento nei confrontidella diffusione del patogeno in questo ambito.
3) Cura delle infezioni durante l’asciuttaUn’efficace cura delle infezioni va concentrata soprattutto
durante la fase di asciutta, in quanto il tasso di guarigione do-po il trattamento in questo periodo è significativamente più al-to rispetto ad un eventuale trattamento fatto in lattazione.
L’eliminazione delle infezioni nella fase di asciutta, com-porta un ottimale rinnovo del tessuto mammario secernente,garantendo nella lattazione successiva, una lattazione otti-male, evitando contaminazione del latte e disseminazione diagenti patogeni contagiosi.
Il trattamento deve essere applicato utilizzando un prodot-to mirato, per cui si consiglia sempre l’effettuazione di pe-riodiche analisi batteriologiche del latte e l’esecuzione di an-tibiogrammi per acquisire le informazioni necessarie circal’utilizzo di principi attivi efficaci. I capi che risultano infet-ti dopo il parto sono da ritenersi cronici, devono essere inse-riti nel gruppo di animali infetti e vanno considerati comesoggetti passibili di riforma anticipata.
4) Controllo della sintomatologia e contenuto in cellule somatiche del latte durante la lattazione
La terapia in lattazione deve essere applicata ai soli casiclinici, utilizzando un farmaco a cui il patogeno sia sensibi-le; al trattamento antibiotico può essere associato un tratta-mento antiinfiammatorio. La probabilità di eliminare total-mente gli agenti patogeni è inferiore al 50% se il trattamen-to viene applicato in lattazione; tuttavia i valori di cellule so-matiche si abbassano e i segni clinici della mastite possonoregredire.
RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano il Dott. Guido Bruni, la Dott.ssa Katia Stradiotto e il Dott. Giorgio Zanatta delServizio di Assistenza Tecnica agli Allevatori (ARAL Lombardia) per il prezioso supporto nellosvolgimento delle attività del progetto Sancapr, i Medici veterinari Dott.ri Fabio Bencetti, Ger-mana Cioccarelli, Claudio Gelmini, Antonio Ranieri, Ivano Robustelli, Mario Villa e il Dott. Mas-simo Milanesi per la fattiva collaborazione alla raccolta dei campioni, e tutti gli Allevatori chehanno messo a disposizione le loro aziende per l’effettuazione dei prelievi.