"Nascita di un’economia del consumo?", Il rinascimento europeo e l'Europa, 3, Produzioni e...
-
Upload
univ-paris-diderot -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "Nascita di un’economia del consumo?", Il rinascimento europeo e l'Europa, 3, Produzioni e...
IL RINASCIMENTO ITALIANO E L’EUROPA
volume terzo
Produzione e tecnichea cura di Philippe Braunstein e Luca Molà
eangelo colla ditore
© 2007 Fondazione Cassamarca - Angelo Colla Editore, Treviso - Costabissara (Vicenza)ISBN 88-89527-19-6 978-88-89527-19-1www.fondazionecassamarca.itwww.angelocollaeditore.it
Redazione: Anna ZangariniSegreteria di redazione e ricerca iconografica: Luca RaminSegreteria organizzativa: Patrizia FioriGrafica: Studio Bosi, Verona
Nascita di un’economia del consumo?
mathieu arnoux
Tripudio della forma, trionfo dell’innovazione tecnica, gloria dei creatorie dei produttori: rare sono le rievocazioni del Rinascimento che non lo presen-tino come un momento di grazia in cui si sviluppa un’economia dell’offerta,mentre non si contano più i racconti in cui appare il personaggio inedito dell’ar-tista-creatore, da Cimabue ad Arnolfo di Cambio, Michelangelo e Leonardo.L’ingegno e la capacità di inventare nuovi procedimenti tecnici che distingue ta-li figure sono addirittura temi di meditazione per i contemporanei, alla streguadelle loro creazioni: Filarete non esita a inserire la descrizione di un altofornonel suo progetto di città ideale e il disegnatore Heinrich Gross svela al duca diLorena, nei minimi dettagli, la struttura di una miniera.
Circondato da un’aura di ammirazione, il Rinascimento sembra trascurarela domanda e i consumatori, a meno che non si tratti di celebrare individualmen-te qualche figura eroica di mecenate o committente, elevato quasi allo stesso li-vello dell’artista creatore. Oggi, abituati come siamo a fruire attraverso la vista el’immaginazione degli innumerevoli oggetti, testimoni di quel momento dellastoria, ci è difficile restituirli ai loro destinatari originari, riporli nel contesto peril quale furono creati e ridare vita agli scambi di cui furono la merce. Eppure èoramai risaputo che, nel lungo periodo, non vi è offerta che non risponda a unadomanda, né produttore che possa fare a meno di un consumatore.
Da molto tempo la storia dell’economia si è interessata a questa difficilequestione e si è interrogata sulla paradossale coincidenza tra una fase di splen-dore artistico e intellettuale e la più grave depressione demografica della storiaeuropea, nonché sul legame tra tale fase e una congiuntura economica contras-segnata da una lunga crisi. È indubbio che, nell’Europa degli ultimi decenni delQuattrocento, la consapevolezza di una ritrovata abbondanza, in grado di ren-dere più facile la vita, comporta l’esaltazione di nuove idee e forme. Il ritornodell’abbondanza assume aspetti assai concreti e caratterizza molte descrizionidelle grandi città dell’Occidente. Quando descrive Venezia, Enea Silvio Picco-
70, 72-75
36 fra tradizione e modernità
lomini non manca di notare che «vi si trovano merci provenienti da tutto ilmondo e non v’è in Europa piazza più rinomata. I mercanti vi portano i prodot-ti di tutto l’Occidente e vi acquistano quelli orientali».1 Ciò che colpisce, nellecittà dell’Europa del Nord, è la profusione di prodotti alimentari: nel 1474, os-servando la Senna dalla finestra del palazzo reale, Commynes rimane estasiatodavanti al numero di imbarcazioni che giungono a Parigi cariche di cibo.2 Unagenerazione dopo, nel 1504, il giovane Tommaso Moro si lamenta con John Co-let per l’onnipresenza del cibo nelle strade di Londra, che lo sottrae alle sue me-ditazioni: «Ovunque lo sguardo vaghi, non riesci a vedere altro che venditori didolciumi, pescivendoli di mare, macellai, cuochi, salumieri, pescivendoli di acquadolce, pollivendoli che offrono la loro materia alla pancia, al mondo e al Diavo-lo, suo principe».3
Queste e altre testimonianze facilmente elencabili sono per lo più poste-riori alla metà del Quattrocento: prima di tale spartiacque cronologico un simi-le consenso sul tema dell’abbondanza non è riscontrabile tra gli osservatori. Tut-tavia sarebbe errato vedere in questo diffuso apparire di testimonianze solo l’ecolettararia di una mutazione della congiuntura economica europea. Qualunque siala data proposta per l’uscita dalla crisi economica, in quegli anni la ripresa è lun-gi dal riportare la prosperità in tutta Europa. Del resto, gli stessi autori ci hannolasciato per quel periodo anche racconti di carestie e allusioni a orde di misera-bili che errano per le strade delle città di cui si celebra l’abbondanza. Ciò che no-tano i nostri testimoni, attestato dall’insieme delle fonti, non è un ritorno cicli-co dell’abbondanza insito in una dinamica malthusiana, bensì un cambiamentonei comportamenti e negli atteggiamenti relativi al consumo. Non si tratta tan-to dei primi momenti di una nuova età, quanto dell’epilogo di un’evoluzione cul-turale, sociale ed economica, la cui spiegazione si inserisce in una storia assai piùvasta dei modi di consumare.
1. Enea Silvio Piccolomini, I commentarii, a cu-ra di L. Totaro, Milano 1984, l. III, 30, vol. 1, p.566: «Merces huc ex toto fere orbe convehen-tur neque est in Europa tota nobilius empo-rium. Negociatores totius Occidentis huc resdeferent et orientales accipiunt merces».
2. Philippe de Commynes, Mémoires, I, 8: «Atout prendre, c’est la cité que jamais je veis-se avyronnée de meilleur pays et plus plantu-reux, et est chose presque increable que desbiens y arrivent. Je y ay esté depuis ce tempsla avecques le roy Loys demy an sans bougerlogié aux Tournelles, mangeant et couchantavecques luy ordinairement et depuis son
trespas vingt moys malgré moy, tenu prison-nier en son palais, ou je veoye de mes fene-stres arriver ce que montoit contermont lariviere de Seyne, du costé de Normandie.Du dessus en vient sans comparaison plusque je n’eusse jamais pensé ne creu ce quej’en ay veu».
3.The Correspondence of sir Thomas More, a cu-ra di E.F. Rogers, Princeton 1947, 3, p. 7:«Quocumque tuleris oculos, quid aliud vi-deas quam cupedinarios, cetarios, lanios, co-quos, fartores, piscatores, aucupes, qui mate-riam ventri ministrant ac mundo et principieius diabolo?».
37nascita di un’economia del consumo?
Storie del consumo
L’interesse dimostrato dalla storiografia per l’analisi della domanda inquanto tale è recente; non altrettanto si può dire dello studio dei consumi e deilivelli di vita, che si avvale di una tradizione più antica, forgiata sulle raccolte deiprezzi e dei salari, risalenti agli inizi della storia economica. A lungo praticata suscala regionale, la storia economica dei livelli di vita ha generato ricerche origi-nali e consentito di ottenere importanti risultati, come testimoniano i lavori diUlf Dirlmeier per l’Alta Germania, di Charles de La Roncière per Firenze o diLouis Stouff per la Provenza, per non menzionare che qualche titolo.4 Le recen-ti pubblicazioni di Christopher Dyer per l’Inghilterra e di Richard Goldthwaiteper l’Italia sono di particolare interesse in quanto si inscrivono in un ambito na-zionale più vasto, il che consente agli autori di formulare ipotesi per una vera epropria storia comparata dei livelli di vita e dei consumi.5
Le loro indagini, condotte su terreni e periodi diversi, hanno prospettivedistinte: il sottotitolo del libro di Dyer, Social change in England, rende esplicital’ipotesi secondo cui le pratiche dei consumi e i ‘livelli di vita’ corrispondenti re-gistrano e confermano le dinamiche del cambiamento sociale. Analogamente aiconflitti politici e religiosi, le scelte economiche dei consumatori rivelano dun-que le evoluzioni dei rapporti di forza e delle identità collettive. Attraverso lacronologia scelta dallo storico inglese, la ricerca si inscrive nella prospettiva diuna storia della nazione inglese, tra la dissoluzione dell’‘impero plantageneta’ eil grande sviluppo dello stato monarchico cinquecentesco. Concentrandosi sul-lo spazio italiano, il libro di Richard Goldthwaite non rientra in una prospetti-va di storia nazionale e il suo oggetto non è direttamente sociale, bensì cultura-le. Si tratta, in effetti, di una storia economica del Rinascimento che mira a sot-tolineare le condizioni di un sempre più diffuso mercato degli oggetti d’arte inquella regione europea in cui essi si sono potuti trovare al centro di un propriosettore della vita economica. Osservando un fenomeno europeo all’interno del-le tante città-stato e dei tanti stati territoriali della penisola, Goldthwaite è por-tato a riflettere sui caratteri originali dell’economia italiana in rapporto all’eco-nomia-mondo europea e a insistere, in particolare, sulle asimmetrie nell’orga-nizzazione occidentale della produzione e dei mercati che favoriscono la con-
4. U. Dirlmeier, Untersuchungen zu Einkom-mensverhältnissen und Lebenshaltungskosten inoberdeutschen Städten des Spätmittelalters (Mit-te 14. bis Anfang 16. Jahrhunderts), Heidel-berg 1978 (Abhandlungen der HeidelbergerAkademie der Wissenschaften, 1); Ch.-M. deLa Roncière, Prix et salaires à Florence au XIV e
siècle (1280-1380), Roma 1982; L. Stouff, Ra-
vitaillement et alimentation en Provence aux XIV e
et XV e siècles, Paris-La Haye 1970.
5. Chr. Dyer, Standards of living in the laterMiddle Ages. Social change in England c. 1200-1520, Cambridge 19922; R.A. Goldthwaite,Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Ita-lia dal Trecento al Seicento: la cultura materialee le origini del consumismo, Milano 1995.
38 fra tradizione e modernità
centrazione nelle mani delle élites italiane di notevoli ricchezze monetarie, passi-bili quindi di venire investite nei mercati del lusso e dell’arte.
Benché diverse per l’oggetto di studio e per le prospettive in cui si inseri-scono, le due ricerche, se considerate come contributi alla storia europea deimercati e dei consumi, giungono a risultati ampiamente convergenti. Entrambe,a loro modo, descrivono una società disuguale e fortemente gerarchizzata, in cuile scelte relative ai consumi costituiscono per gli individui segni di appartenenzasociale. Dalla fine del XIII secolo agli inizi del XIV secolo, periodo comune a en-trambi gli studi, i due autori insistono sulla forte instabilità – soprattutto politi-ca ed economica – che contraddistingue l’insieme delle strutture, nonché sul-l’importante mobilità sociale che ne consegue. Lungi dal limitarsi a essere segnid’identità, le pratiche inerenti ai consumi sono anche la posta in gioco per gli at-tori della crisi. Il miglioramento dei livelli di vita e l’incremento dei consumi rap-presentano un altro punto in comune tra le due opere, in cui si sottolinea il con-sistentissimo aumento dei consumatori e i cambiamenti che di conseguenza si in-nescano nell’organizzazione dei mercati: apertura geografica e convergenza deimodi di consumare. Nel complesso, il confronto tra le due inchieste mette in evi-denza un fenomeno europeo che, pur assumendo forme proprie nei diversi spa-zi del continente, si presenta abbastanza omogeneo sia nella cronologia che nel-le relative conseguenze. Ammessa l’ipotesi della coerenza di tale fenomeno, è ne-cessario interrogarsi sulle dinamiche interne di cui è il risultato, non più su sca-la regionale o di un insieme di regioni, ma al livello più vasto delle società del-l’Europa occidentale.
Lavoro e consumo nelle società di ordini
Un’inchiesta di questo tipo non può ovviamente fondarsi su una raccoltadi esempi di prezzi, di salari e di transazioni, di cui, già da un secolo, è stata sot-tolineata da numerosi storici l’estrema difficoltà metodologica e il carattere po-co probante. In un sistema di mercati separati e poco coordinati, non è chiaroquale logica globale possa mai emergere da una raccolta empirica. Tenendo con-to delle rappresentazioni della società, quali appaiono nelle opere letterarie o neitesti teorici, si può invece cogliere un livello più generale dell’organizzazione so-ciale, tanto più che l’Europa occidentale presenta un alto grado di unità intellet-tuale, religiosa e artistica e i sistemi di rappresentazione e gli schemi narrativi cir-colano facilmente da una regione all’altra. Un rapido esame conferma l’interes-se di tale approccio per lo studio dei modelli sociali relativi al consumo, nella mi-sura in cui l’esecuzione di un lavoro materiale e la capacità di consumare vi ap-paiono chiaramente come indicatori sociali. Per rendercene conto rivolgiamo lanostra attenzione ad alcuni celebri scritti.
39nascita di un’economia del consumo?
Il primo esempio è tratto dal Meier Helmbrecht, poema didascalico alto-te-desco risalente probabilmente agli anni Ottanta del Duecento: vi si racconta latragica storia di un giovane contadino che vuole farsi cavaliere ma diventa unfuorilegge e viene miseramente condannato e ucciso per i suoi misfatti. La pri-ma parte del testo mette in scena il progetto di ascesa sociale che comporta ladescrizione dettagliata di diversi elementi – abiti, cane da caccia, cavallo –, riven-dicati dal protagonista come segni della sua prestigiosa identità. Gli sta di fron-te il padre, ironico e moralista al tempo stesso. Avvertito in sogno del sinistrodestino a cui sarebbe andato incontro il figlio qualora avesse messo in opera isuoi progetti, lo scongiura di seguire il modo di vita di tutti i contadini:
Figlio caro, non andare a Corte. I suoi costumi non convengono a colui che nonli ha praticati sin dall’infanzia. Figlio caro, dirigi i buoi ed io spingerò l’aratro, oallora prendi tu stesso le stegole e insieme areremo la nostra tenuta. Anche tu tiavvierai, allora, alla tomba come me, da onest’uomo, perché credo di esser statofedele, leale e non aver mai mancato alla parola data; tutti gli anni ho debitamen-te versato la decima e ho vissuto la mia vita senza suscitare odio o invidia.6
Come vuole una morale conformista e tragica, Helmbrecht morirà permano dei contadini a cui aveva rubato le sostanze. Prima però verrà mutilato eaccecato dal prevosto e respinto dal padre, ormai indifferente alla sua sorte.
Non diversa è la visione della vita e dell’ambiente rurale espressa neglistessi anni dall’autore francese del Roman de Renart, anche se un’indubbia iro-nia pervade la descrizione del buon contadino Liétard, futura vittima della vol-pe: egli «di buon mattino aggiogò i buoi per arare una vasta superficie di terra.Ecco che ha l’impressione di essere arrivato assai tardi nel terreno debbiato, ep-pure il giorno comincia appena a spuntare. Ma né riposo, né benessere, né sva-ghi, né divertimento interessano al villano. A lui poco importa di restare a let-to: dopo il sorgere del sole, niente riposo per il villano. Vuole solo recarsi al la-voro, perché il villano resiste alla fatica».7 Sarebbe facile trarre dagli scritti cir-colanti in Europa citazioni in cui il contadino appare legato alla gleba più dauna devozione senza limite al lavoro dei campi che da uno statuto istituzionaledi dipendenza.
Lo schema dei tre ordini, analizzato nella sua genesi da Georges Duby inun libro memorabile,8 costituisce l’espressione più coerente e compiuta di que-
6. Wernher der Gartenaere, Meier Helmbrecht,vv. 242-258; cfr. C. Hayden Bell, Peasant life inold German epics, New York 1931, pp. 43-44.
7. Le Roman de Renart, a cura di N. Fukumo-to, N. Harano e S. Suzuki, Paris 2005, 424-
427, branche 28, vv. 27-34, Histoire de l’oursBrun, du Renart et du vilain Liétard. La tradu-zione è nostra.
8. G. Duby, Lo specchio del feudalesimo. Sacer-doti, guerrieri e lavoratori, Roma-Bari 1980.
40 fra tradizione e modernità
sta rappresentazione del mondo contadino. Elaborato in Francia e in Inghilter-ra all’inizio dell’XI secolo, tale schema divenne alla fine del secolo successivo ilsistema di rappresentazione sociale e politica dominante in buona parte del con-tinente europeo, dove si ritrova fino agli ultimi secoli del Medioevo. Presenteesplicitamente o implicitamente in numerosi testi letterari e di riflessione politi-ca o morale, è spesso interpretato come uno strumento ideologico voluto dalgruppo dominante, chierici e cavalieri, per legittimare e riprodurre il loro pote-re sul ceto contadino. I testi meritano tuttavia di essere analizzati con maggioreattenzione in quanto non si piegano a una lettura così sbrigativa. Soffermiamociin particolare sulla notevole descrizione della società tripartita presentata da Be-nedetto di Sainte-Maure nella sua Histoire des Normands, redatta intorno al 1170su richiesta del re d’Inghilterra Enrico II Plantageneta:9 l’assimilazione dei tre or-dini con i tre piedi dello sgabello su cui poggia la società cristiana esclude, alme-no in termini logici, una visione gerarchica. La distinzione delle funzioni socialiassegnate dalla Provvidenza a ogni gruppo riserva certo agli uomini di preghie-ra e ai guerrieri l’esclusività del consumo, e agli uomini di fatica l’esclusività del-la produzione, ma assicura anche eguale certezza della salvezza eterna e simile di-gnità sociale. Il riconoscimento della dignità del lavoratore dei campi non è inquesto testo una parola vana, e troppo spesso si tralascia di dire che tale dignitàimpegna il gruppo di produttori poiché assegna loro un posto essenziale nell’im-magine della società.
Lo schema dei tre ordini non appartiene solo al mondo immaginario, maè anche alla base di un sistema economico concreto, i cui principali elementi so-no i dispositivi assistenziali e l’organizzazione dei mercati. Non è questo il luo-go per esporre nei particolari la varietà e l’efficacia dei dispositivi di ridistribu-zione e di assistenza attuati dalle società medievali. Notiamo semplicemente chein molti testi, tra cui l’Helmbrecht sopra citato, il regolare pagamento della deci-ma entra nella definizione dell’identità sociale del contadino. Il posto centraledei mercati negli spazi medievali è ormai un fatto attestato, eppure altrettanta at-tenzione dovrebbe essere rivolta allo studio della loro funzione nell’organizza-zione sociale. Un testo dimenticato di Henri Pirenne ne dà un’acuta descrizio-ne: «[La legislazione delle città medievali] si propone prima di tutto di assicura-re alla popolazione un approvvigionamento a più buon mercato possibile. L’idea-le cui tende, e che ha raggiunto, è quello di lottare contro il carovita e di stabili-re per ogni cosa il ‘giusto prezzo’, in altri termini, il prezzo minimo. Come èriuscita a risolvere il problema? In modo tanto semplice quanto radicale: attra-verso la soppressione degli intermediari. Tra produttore e consumatore ha stabi-
9. Benoît de Sainte-More, Chronique des ducsde Normandie, a cura di C. Fahlin, Uppsala1967-1979, II, 13242-13287.
41nascita di un’economia del consumo?
lito un rapporto diretto. Mediante una regolamentazione estremamente com-plessa, il legislatore ha creato un meccanismo assai semplice: l’incontro direttotra colui che ha bisogno di un certo bene e colui che lo produce».10 Questo di-spositivo d’economia morale, che distingue quel che riguarda propriamente lasussistenza e l’assistenza, per cui vige la normativa per combattere l’usura, daquel che appartiene al mondo del consumo e del commercio (in particolare lematerie preziose e gli oggetti di lusso), permette di capire come, nella praticaquotidiana, si articoli la distinzione tra l’ordine dei laboratores, che ottiene la ga-ranzia di una giusta sussistenza in cambio di un suo consenso all’imperativo dellavoro, e i gruppi di oratores e bellatores, che godono, come contropartita delle lo-ro funzioni sociali, di un diritto esclusivo al consumo.
Un modello in crisi
La coscienza che i contemporanei hanno potuto avere di tale funziona-mento e delle logiche economiche e morali che lo fondano non traspare solo daitesti filosofici, teologici o didattici. In parecchi scritti della seconda metà delTrecento tale principio organizzativo era ancora perfettamente comprensibile,per quanto fortemente minacciato dagli sconvolgimenti della società. Ne è illu-strazione uno dei best-sellers della letteratura in volgare scritto tra il 1360 e il1385: il Piers Plowman di William Langland. Il sogno allegorico che costituiscela trama della narrazione descrive una società inglese travolta da una profondacrisi morale, la cui manifestazione è la splendida e scandalosa cerimonia del ma-trimonio di Dama Corruzione (Lady Mede) con Messer Falsità (Lord Falsity), ilquale dichiara di sposarla unicamente per il suo denaro. Solo il pellegrinaggio alsantuario di Verità (Truth) potrebbe far ritrovare il senso e i valori a un popoloin preda allo smarrimento. Nessuno però ricorda il cammino per giungervi, nes-suno tranne Piers the Plowman. Questo accetta di buon grado di guidare i pelle-grini, ma prima deve finire di arare il suo campo. Per far pazientare gli uominie le donne già pronti per il viaggio e perché siano ben disposti, il contadino dàloro precise istruzioni:
Nel vostro interesse, donne, alcune di voi, disse Piers, dovrebbero rammendare ilsacco di grano in modo da impedirne la fuoriuscita. E voi, belle dame dalle lun-ghe dita, a tempo debito (whan tyme is), lavorerete la seta e lo zendale, per faredelle casule ai cappellani e fare onore alle nostre chiese. Donne e vedove, filate la
10. H. Pirenne, Le consommateur au MoyenÂge, in AA.VV., Histoire économique de l’Occi-dent médiéval, Bruges 1951, pp. 532-534.
42 fra tradizione e modernità
lana e il lino, cucite gli abiti e insegnate a fare ciò alle vostre figlie, perché Veritàci ordina di aiutare i poveri e di vestire gli ignudi. Quanto a me, per tutta la vita,finché la terra darà i suoi frutti, darò loro da mangiare per amore del nostro Si-gnore dei cieli. Voi tutti, uomini di tutte le condizioni che vivete dei prodotti del-la terra, aiutate a lavorare il meglio possibile chi ricava quanto serve per nutrirvi.(vv. 9-20)
Piers rifiuta i servigi del cavaliere che si offre di condurre insieme a lui l’a-ratro e gli raccomanda di compiere con esattezza i doveri del suo stato:
Certamente, messer cavaliere, disse Piers, sgobberò, suderò e seminerò per noi, acondizione che tu vegli sulla santa Chiesa, mi protegga dai banditi e da quelli chedistruggono il mondo. Andrai a caccia della lepre, della volpe, del cinghiale e delcervo che rompono le mie siepi, e il tuo falco saprà uccidere gli uccelli selvaggiche rubano il grano dal mio campo ... Promettimi di non maltrattare i tuoi conta-dini; quando infliggerai loro la punizione meritata, Misericordia ne fisserà la quo-ta e Umiltà ti guiderà, senza intervento di Dama Corruzione ... Non maltrattare ituoi servi (bondmen) perché ciò è nel tuo interesse: se in questo mondo ti sono in-feriori, forse in cielo avranno un posto migliore del tuo, anche se oggi conduci unavita gradevole ... E ricordati che nell’ossario della chiesa è difficile distinguere leossa del servo da quelle del cavaliere, o quelle della regina da quelle della puttana(a knight from a knaue, a quean from a queen). (vv. 24-32, 37-54)11
Certo è difficile non intravvedere nel discorso il moralismo e il sostegnoal conservatorismo sociale conforme agli interessi dei gruppi dominanti; d’altrocanto, non si può ignorare l’orgoglio che fonda questa ferma proclamazione diidentità: ciò spiega perché, fuori dal suo universo allegorico, Piers Plowman fi-guri in prima fila nella rivolta contadina del 1381, come indica il proclama scrit-to da uno dei capi, John Ball.12 Se l’incertezza continua a regnare sui sentimentie l’impegno dell’autore William Langland, non vi è, invece, alcun dubbio sul si-gnificato del suo discorso che non predica tanto la rassegnazione quanto un’ade-sione disperata a un modello sociale in crisi.
Nel Prologo generale dei Racconti di Canterbury, una delle maggiori operedella letteratura rinascimentale, Geoffrey Chaucer13 offre la migliore evocazionedella crisi che provoca un profondo smarrimento nel mondo contadino. Come ilsuo compatriota Langland, egli sceglie quale cornice del racconto un pellegri-
11. W. Langland, Piers Plowman, versione B,Passus VI, vv. 3-70. La traduzione è nostra.
12. The letter of John Ball, in Medieval EnglishPolitical Writings, a cura di M. Dean, Kalama-
zoo 1996, l. 5, p. 135.
13. G. Chaucer, I racconti di Canterbury, a cu-ra di V. La Gioia, introduzione di P. Boitani,Milano 1990.
43nascita di un’economia del consumo?
naggio, quello che va da Southwark, alle porte di Londra, fino alla tomba di sanThomas Becket, nel coro della cattedrale di Canterbury. Non riapriremo qui ildibattito senza fine sull’esistenza storica dei 29 personaggi riunitisi la sera del 17aprile nella Tabard’s Inn. Sono in molti a identificare il potere di fascinazione del-l’opera con l’arte della composizione e del particolare, che attribuisce a ogni ri-tratto, perfettamente individualizzato, un proprio posto nell’immagine di grup-po dell’intera società inglese. Annunciando l’intenzione di «descrivere la lorocondizione, / dicendo come ognuno ... appariva / e di che grado, in quella comi-tiva. / Nel dirvi pure dell’abbigliamento» (vv. 38-41), Chaucer riesce a dare unafisionomia precisa, come si accorda alla ‘ragione’, ai vari clienti del grande mer-cato della distinzione sociale. Nella presentazione delle dignità sociali, i tre or-dini sono ancora identificabili. Sono i bellatores ad aprire il corteo: un cavaliereappena tornato dalla crociata, accompagnato dal figlio, giovane scudiero, e dauno yeoman, l’arciere-guardiacaccia che maneggia con bravura arco e frecce. Se-guono gli oratores, qui limitati al clero regolare: una priora che viaggia insieme aun’altra suora e un cappellano, e un monaco. Bisogna attendere l’ultima partedella descrizione per veder apparire i laboratores: il contadino che «Di ciò che la-vorando guadagna / intere le sue decime versava» (vv. 539-540). Egli viaggia conil fratello, «Parroco di un piccolo villaggio. / Nel fare e nel pensare era pietoso»(vv. 578-579), qui presentato come membro del mondo rurale piuttosto che delclero. Pure figure funzionali, il cavaliere, il prete e il lavoratore dei campi sonodefiniti attraverso il loro ruolo, mentre i loro abiti sono appena evocati, diversa-mente dal sontuoso abbigliamento degli ecclesiatici, il quale viene a confortarela squisita distinzione della priora e il prestigio feudale del monaco.
Qui però le tre funzioni sono solo le vestigia di un ordine evanescente, dicui gli altri pellegrini non sembrano più curarsi. Alcuni sono gli attori-testimo-ni dello sviluppo dell’economia urbana e del commercio internazionale che fan-no affluire nelle loro mani ricchezze guadagnate con facilità: il mercante, padro-ne dell’informazione e delle scelte gestionali, il marinaio, uomo d’azione, maanche fine conoscitore delle rotte e delle coste, dal Mediterraneo al mare delNord, e gli uomini dei mestieri – tintore, merciaio, carpentiere, tessitore e tap-pezziere – che portano, pomposamente, la livrea della loro confraternita, e so-no accompagnati dal loro cuoco. Le figure del «fisico dottore» e dello «studen-te in logica» illustrano il posto sempre più importante occupato dagli uomini dicultura. Si sarebbe tentati di inserire in questo gruppo lo straordinario perso-naggio della borghese di Bath, senza rivali a Ypres o Gand nell’arte della drap-peria, ma la sua abilità nello scovare mariti ricchi e compiacenti la pone anchetra le persone capaci di approfittare delle risorse che una società destabilizzataoffre a chi sa sfruttarle. Bravo parlatore, poco portato all’austerità, il frate que-stuante è il testimone di una società cristiana dove ormai tutto può essere mo-netizzato. È il primo di un gruppo di predatori, abituati a stanare le risorse of-
44 fra tradizione e modernità
ferte da una società in crisi a chi la sa scrutare: l’uomo di legge, l’allodoliere, ilmugnaio, lo spenditore, l’apparitore e l’indulgenziere, tutti esperti nelle diversearti della seduzione, dell’estorsione e dell’inganno. Ognuno di loro indossa abi-ti e ornamenti che ne testimoniano l’accesso al mondo dell’apparenza, del lussoe del superfluo: il talento di Chaucer nel descrivere lo splendore dei tessuti edelle fogge trova qui un terreno fecondo per esercitarsi. Come, di fronte a un si-mile sfolgorio, non attribuire un ruolo simbolico al «trasandato giubbone di fu-stagno» macchiato di ruggine dalla cotta d’arme, vero abito da guerriero indos-sato dal cavaliere, oppure al «tabarro», lungo e pesante, che protegge il conta-dino dal cattivo tempo, durante i lavori invernali. E soprattutto come non nota-re che il luogo dove si svolgono i pasti si chiama Locanda del Tabarro: qui il con-tadino è, in un certo modo, a casa, e qui tutti i pellegrini mangiano a sue spese.Il cavaliere, portatore dell’antico ideale della crociata, il parroco, buon pastorededito al servizio del suo gregge, e il lavoratore dei campi erano a loro agio nelmondo utopico immaginato da William Langland. Nell’universo reale descrittodalla penna ironica ma non priva di tenerezza di Chaucer, questi appaiono comei monumenti di un passato ormai tramontato di fronte alle ambizioni e ai desi-deri degli attori del mondo nuovo.
Sulle cause di un simile cambiamento i pellegrini hanno le loro idee, cheesprimono volentieri. Paladino della vecchia cavalleria, sensibile al merito deicontadini, Chaucer non risparmia i religiosi. Elegantemente vestito, grasso eprospero, il monaco preferisce la caccia all’uffizio liturgico e non apprezza mol-to l’opus divinum: «Perché da libri farsi logorare / e al modo di Agostino fatica-re? / La fatica, Agostino se la tenga, / e l’impegno mondano a noi ben venga!»(vv. 185-188). Il frate mendicante non è trattato molto meglio. Votato, in lineadi principio, alla povertà, si mostra esigente sulla qualità delle proprie frequen-tazioni: «... e bettole frequenta, in confidenza / con osti, locandiere, e amiconi, /lontano da lebbrosi e barboni. / Di certo non si addice al suo valore / e non glipuò tornare a grande onore / trattare quella gente in confidenza / nel praticarecon nullatententi / invece che con ricchi e possidenti» (vv. 240-248). Attento al-la monetarizzazione di ogni cosa, egli conosce il valore, prettamente mercantile,della penitenza: «Alquanto mite nella confessione, / è sempre incline a dare as-soluzione / con una penitenza non severa, / se l’offerta gli pare esser sincera. Adun Ordine povero donare, / è già volersi bene confessare, / e a quel che dona di-ce egli contento / che lo toccò verace pentimento» (vv. 221-228).
Sarebbe errato attribuire queste crudeli osservazioni all’anticlericalismodel poeta, poiché stanno a testimoniare di un effettivo adattamento della praticaecclesiastica alle evoluzioni sociali. Pur avendo pienamente colto, come i conta-dini insorti nel 1381, il ruolo degli istituti monastici nel Manorial system, di cui ilMonaco sa approfittare così bene, Chaucer è anche perfettamente conscio del-l’evoluzione che porta i Mendicanti da una pratica della povertà assoluta a un’at-
45nascita di un’economia del consumo?
tenzione indulgente, poi interessata, alle forme più nuove della monetizzazionee del mercato.14 Sa quanto poco valga agli occhi dei teologi il sistema dei tre or-dini che non accorda alcun primato spirituale o sociale al clero. Di fronte all’u-nione degli umili, rappresentati dal parroco e dal contadino, anche il gruppo de-gli uomini dei mestieri, con addosso la lussuosa livrea della loro confraternita,testimoniano della ricezione da parte dei laici del pragmatismo dei chierici: «Perl’imponenza ognuno aveva aspetto / di chi trovasse posto sul palchetto / dellaCorporazione della Stanza, / e tra gli anziani per la sua importanza. / Di rendi-te godevano e di censo, / e delle mogli avevano il consenso / ché non poteva es-sere il contrario: / sentirsi dir ‘madama’ fa elitario, / come durante processioneal Santo / aver qualcuno che ti regga il manto» (vv. 369-378).
Buon suddito e cristiano fedele, Chaucer non trascinerà nella derisionenessun ufficiale o signore di alto rango e si guarderà bene dal punzecchiare i ve-scovi. Tra i suoi pellegrini, molti sono quelli che vivono della generosità di unostato in piena crescita e delle varie forme di fiscalità introdotte dalla monarchiafeudale inglese. L’uomo di legge che vende le proprie consulenze, lo spenditoreretribuito dal collegio giuridico del Tempio, l’allodoliere, antico giudice reale, ilfattore, giunto dal suo maniero signorile del Norfolk, l’apparitore, tutti nutriti evestiti abbondantemente, e talvolta sontuosamente, da un sistema signorile, ec-clesiastico o fiscale, che Chaucer può difficilmente ignorare esser stato il bersa-glio delle rivolte del 1381.
Crisi e novità
Da tempo abbiamo imparato a distinguere i diversi elementi della crisi del-l’ordine sociale di cui Langland e Chaucer, tra gli altri, ci offrono la diagnosi. Nu-merosi sono gli studi che hanno approfondito l’analisi del ruolo e dell’interazio-ne tra le dinamiche dell’economica rurale, del commercio internazionale, dellediverse forme di fiscalità, della guerra e della mortalità nella genesi di ciò cheÉdouard Perroy aveva chiamato «un’economia contratta».15 La complessità del-lo sviluppo rinascimentale e dell’accelerazione dei processi di modernizzazione èal centro del dibattito sull’esistenza di un’«economia del Rinascimento», che ov-viamente va oltre l’ambito di questo saggio.16 Eppure, se affrontata dal punto divista del consumo e dell’evoluzione della domanda, la crisi economica è difficile
14. G. Todeschini, Ricchezza Francescana.Dalla povertà volontaria alla società di mercato,Bologna 2004.
15. É. Perroy, À l’origine d’une économie con-tractée: les crises du XIV e siècle, «Annales ESC», IV(1949), pp. 167-182.
16. F. Franceschi, L. Molà, L’economia delRinascimento: dalle teorie della crisi alla ‘prei-storia del consumismo’, in Il Rinascimento ita-liano e l’Europa, I, Storia e storiografia, a curadi M. Fantoni, Treviso-Costabissara 2005,pp. 185-200.
46 fra tradizione e modernità
da cogliere. Non che la sua realtà sia da mettere in dubbio: le fonti di tutte le re-gioni europee attestano la generalizzazione della miseria e dei fallimenti che indi-cano le profonde difficoltà attraversate dalla società occidentale nel corso del Tre-cento. Ma le fonti rivelano al tempo stesso e in eguale quantità gli indici di un ge-nerale processo di modernizzazione e d’innovazione, osservabile in tutti i settori,le cui componenti sono l’incremento della produttività e delle rese, l’aumentodell’alfabetizzazione e il miglioramento qualitativo della cultura materiale. È pro-prio l’unione paradossale tra una crisi congiunturale di un’estrema violenza e ilperdurare di un processo di sviluppo economico a conferire alla storia del XV e XVI
secolo quei tratti a un tempo interessanti e di difficile interpretazione. Alcuni di questi processi sono anteriori alla crisi e hanno contribuito, sin dal-
la seconda metà del XIII secolo, a far vacillare le strutture della società feudale. Ciriferiamo in particolare alla crescita delle forme urbane dell’economia e alla costru-zione di quello che si è preso l’abitudine di chiamare «Stato moderno». Si tratta difenomeni storici di grande importanza, la cui descrizione supera certo i limiti del-la nostra analisi, ma le cui conseguenze sulle modalità del consumo devono essereprese in considerazione. Il recente saggio di Giacomo Todeschini sulla Ricchezzafrancescana fornisce un ottimo approccio al primo aspetto della questione. Concen-trandosi sulla persona di Francesco d’Assisi e sul pensiero dei primi Francescani, lostorico mostra come l’ordine mendicante, figlio delle città mercantili italiane e delcommercio della Via Francigena, si sforzi di ‘giustificare’ moralmente e teologica-mente la figura dell’intermediario commerciale, tradizionalmente escluso dal‘buon’ funzionamento dei mercati 17. Il lavoro d’analisi economica che sottende lariflessione teologica dei Mendicanti porta all’individuazione di un settore commer-ciale in cui la pratica dei mercanti non è assimilabile all’usura in quanto i loro ser-vizi aumentano il valore dei beni che scambiano e i benefici di cui gode tutta la co-munità. Al mercato dei beni di sussistenza senza mediazione alcuna, organizzatomediante la rigida applicazione del giusto prezzo, viene ad affiancarsi un mercatoanimato da mercanti professionisti, in cui i prezzi sono liberi e i profitti leciti.
Naturalmente, la frontiera tra questi due spazi non è né stabile, né ben defi-nita: non si può impedire agli intermediari di accedere al mercato dei viveri, in par-ticolare nei momenti di ristrettezza o quando si tratta dell’approvvigionamento del-le città: 18 la prima metà del Trecento, segnata da gravi crisi, quali la carestia che sidiffonde attraverso l’Europa nordoccidentale nel 1315-1317 o le ripetute penuriedegli anni 1330-1340 in Italia, vede l’apparizione di un vero e proprio commerciointernazionale dei cereali, animato dai mercanti sotto il controllo degli stati.19 Peral-
17. Todeschini, Ricchezza francescana, cit.
18. G. Pinto, Il libro del biadaiolo. Carestie eannona a Firenze dalla metà del ’200 al 1348,Firenze 1978.
19. W.C. Jordan, The Great Famine. NorthernEurope in the Early Fourteenth Century, Prin-ceton 1996.
47nascita di un’economia del consumo?
tro non è da escludere che sia esistito un giusto prezzo anche per i prodotti delcommercio internazionale: nei maggiori centri della produzione e del commerciodei panni, prezzi e salari sono oggetto di una precisa regolamentazione che mira ascoraggiare la speculazione.20 In complesso, non si possono sottostimare le conse-guenze sull’ordine sociale dello sviluppo di questo tipo di mercato, dapprima tolle-rato, poi incoraggiato, in quanto il suo buon funzionamento appare assolutamenteessenziale per la prosperità della città. Il Frate Mendicante e il Mercante dei Rac-conti di Canterbury, convinti del carattere altamente lodevole della competenza eco-nomica e della ricchezza che essa genera, s’inscrivono pienamente in tale prospet-tiva, generalmente accettata alla fine del Trecento. Anche la loro partecipazione alconsumo delle ricchezze così prodotte è perfettamente lecita, a partire dal momen-to in cui un insieme di pratiche ridistributive consentono di rendere evidente il van-taggio della loro attività per i poveri della città.
Un processo analogo, e legato in molti modi al precedente, porta a fon-dare sulle numerose possibili forme di prelievo fiscale, ecclesiastico, comunale,reale o imperiale un vero settore economico urbano, connesso con il commer-cio internazionale. Alle spese tradizionalmente richieste dalla ridistribuzione delprodotto del lavoro dei laboratores verso i consumatori degli altri due ordini siaggiungono, a partire da metà Duecento, altre forme di prelievo, fondamentaliper la costruzione delle istituzioni statali. Una buona parte dei valori monetarimessi a disposizione dei membri delle diverse amministrazioni contribuisce allespese per il lusso ostentato, caratteristiche dei gruppi dominanti, permettendocosì ai nuovi ricchi di ogni tipo di integrarsi nell’aristocrazia.
Sarebbe però un grave errore ridurre le conseguenze della crescita del-lo stato al semplice moltiplicarsi delle diverse forme di corruzione degli uffi-ciali pubblici. L’incremento della spesa pubblica, osservabile negli ultimi duesecoli del Medioevo, è anche generatore di innovazioni, le cui maggiori testi-monianze si hanno in campo tecnico: la domanda di metalli monetabili, di ar-mi o di fortificazioni è all’origine di tecniche minerarie, di nuovi procedimen-ti metallurgici, di forme architettoniche inedite. Uno degli aspetti più caratte-ristici di tale tendenza è l’emergere di un gruppo di specialisti delle soluzionitecniche al servizio esclusivo dei sovrani. La presenza di questi ingegneri, chepadroneggiano macchine e apparecchi, è attestata nel regno d’Inghilterra sindalla seconda metà del XIII secolo e in tutti gli stati italiani il secolo successi-vo. Uomini d’azione e di cultura, essi partecipano, grazie alle loro migrazioniattraverso l’Europa, alla diffusione delle innovazioni tecniche che caratterizzala fine del Medioevo.21
20. A. Sapori, Il taccamento dei panni france-schi a Firenze, in Id., Studi di Storia econo-mica. Secoli XIII-XIV-XV, I, Firenze 1955, pp.239-264.
21. M. Arnoux, P. Monnet, Le technicien dansla cité en Europe occidentale, 1250-1650, Roma2004 (Collection de l’École française de Ro-me, 325).
48 fra tradizione e modernità
L’inventario delle diverse creazioni suscitate dalla domanda statale è lungidall’essere completo. La recente pubblicazione delle carte miniate trecenteschedella cancelleria dei re di Francia testimonia di questa sorprendente creatività. Idiplomi, impreziositi dalle miniature, creati in particolare per il re Carlo V e lasua corte, non erano destinati a essere esposti in pubblico, bensì ad essere con-servati nei cassetti del Trésor des Chartes. Miniati alla perfezione da eccellentiartisti al servizio del sovrano, gli atti – contratti di matrimonio, donazioni a isti-tuti religiosi, accordi e trattati conclusi con i vassalli o con le città del Regno –contengono sovente nei loro preamboli veri e propri trattati sulla natura della so-vranità e della maestà reale, redatti dai migliori giuristi del re. Gioielli discretidestinati alla contemplazione di un piccolo gruppo di fedeli, i preziosi documen-ti traducono le esigenze artistiche e gli ideali politici del primo Umanesimo fran-cese: non deve quindi stupire che uno dei più belli rechi la firma di un suo illu-stre rappresentante, il filosofo e consigliere reale Nicole Oresme. L’esigenza in-tellettuale che traspare dalla loro redazione e la ricerca di qualità estetiche ma-nifestata nella scrittura e nell’ornamentazione ricordano i magnifici manoscritticoevi, realizzati per diffondere la traduzione dei principali trattati aristotelici aopera dello stesso Nicole Oresme e su richiesta dello stesso sovrano. Nelle altrecancellerie europee si ritrovano simili sperimentazioni intellettuali e artisticheche fanno dei diversi stati altrettanti laboratori in cui si inventano le forme piùvarie dell’Umanesimo europeo.22
Numerosi sono gli elementi di continuità che consentono di collegare icambiamenti nei consumi alle dinamiche di mobilità sociale osservabili sin dallafine del Duecento; non si può tuttavia sottostimare il ruolo fondamentale dellaPeste Nera nell’accelerazione di tali mutamenti. La pandemia del 1348 haprofondamente segnato gli animi e le sue enormi conseguenze sono state ampia-mente analizzate: oggi si è d’accordo nel valutare le vittime ad almeno il 50%della popolazione europea e nell’attribuire alle recidive, che colpiscono a partiredagli anni Sessanta del Trecento, una responsabilità essenziale nel crollo demo-grafico del periodo 1348-1440. Più che l’ampiezza del cataclisma, ciò che susci-ta in noi lo stupore è la capacità delle società europee di sopravvivere e di adat-tarsi. In una ricerca esemplare sull’agricoltura inglese, Bruce Campbell ha potu-to evidenziare la rapidità e la vastità della conversione economica che fa passarele campagne inglesi da una cerealicoltura intensiva a un sistema di colture esten-sive, in cui le diverse forme di allevamento hanno oramai un posto essenziale.23
La causa dello smarrimento di Piers e di tutti i contadini d’Inghilterra e d’altro-
22. Gh. Brunel, Images du pouvoir royal. Leschartes décorées des Archives Nationales, XIIIe-XV e
siècles, Parigi 2005.
23. S. Cohn Jr., The Black Death transformed.Disease and Culture in early Renaissance Euro-
pe, London 2002; O.L. Benediktow, TheBlack Death (1346-1353). The complete Hi-story, Woodbridge 2004; B.M.S. Campbell,English Seigniorial Agriculture, 1250-1450,Cambridge (MA) 2000.
49nascita di un’economia del consumo?
ve va cercata, appunto, in questo rivolgimento che li ha condotti alla disoccupa-zione e alla perdita di un ruolo sociale qualificante. Gli effetti della pandemia so-no dunque imprevedibili e paradossali. Uno dei più sorprendenti è dovuto all’e-norme ridistribuzione patrimoniale operata da un flagello che attacca il corpo elascia i beni disponibili per i sopravvissuti, come ha perfettamente descritto Mat-teo Villani in una celebre pagina della sua Cronica:
Credettesi che lli uomini i quali per grazia Idio avea riserbati in vita, avendo ve-duto lo sterminio di loro prossimi e tutte le nazioni del mondo, udito il simiglian-te, che divenissono di migliore condizione, umili, vertudiosi, cattolici, guardas-sonsi delle iniquità e da’ peccati e fossono pieni di carità l’uno contra l’altro. Madi presente, apparve il contrario. che li uomini trovandosi pochi, e abondanti perl’eredità e successione de’ beni terreni, dimenticando le cose passate come statenon fossono, si dierono a ppiù sconcia e disonesta vita che prima non avieno usa-ta. Però che vacando in ozio usarono dissolutamente il peccato della gola, i con-viti, taverne e dilizie con dilicate vivande e giuocchi, scorrendo alla lussuria san-za freno, trovando ne’ vestimenti strane e disusate fogge e disoneste maniere, mu-tando nuove forme agli aredi. E ’l minuto popolo, uomini e femine, per la soper-chia abondanza si trovarono delle cose, non volieno lavorare alli usati mestieri; elle più care e dilicate vivande volevano per loro vita e a llibito si maritavano, ve-stendo le fanti e lle vili femine tutte le care e belle robe delle orrevoli donne mor-te. E sanza alcun ritegno tutta la nostra città scorse alla disonesta vita; e così epeggio l’altre città e province del mondo.24
Perfettamente tradizionale nell’interpretazione religiosa del cataclisma,segno della giusta ira divina contro l’empietà degli uomini,25 il testo non lo è, in-vece, nella descrizione del rovesciamento completo dei valori economici e socia-li tra i superstiti. Inaugura una lunga serie di testimonianze di ogni genere chesottolineano, il più delle volte per condannarla, l’avidità e il gusto del piacereimmediato caratteristici degli uomini dei tempi nuovi. È opportuno tuttavia di-stinguere le componenti della situazione venutasi a creare. L’improvviso arric-chimento dei sopravvissuti, eredi delle vittime della malattia, è un evento digrande portata ma che non si rinnoverà nelle medesime proporzioni in occasio-ne delle successive epidemie. Una delle sue più importanti conseguenze consi-ste nella brutale perdita di valore delle proprietà fondiarie, ormai in eccesso, e ilcui rendimento è condizionato dalla capacità di sfruttamento mediante il lavo-ro: la forza-lavoro rappresenta ormai un valore notevole e ricercato dal proprie-
24. M. Villani, Cronica, a cura di G. Porta,Parma 1995, pp. 15-17.
25. Il riferimento a Is. 9 è un classico nei rac-
conti di carestia; cfr. Rodolfo il Glabro, Crona-che dell’anno mille. Storie, l. 4, 13, a cura di G.Cavallo e G. Orlandi, Milano 1991, p. 221.
50 fra tradizione e modernità
tario terriero. La rottura è dunque profonda rispetto ai tempi precedenti, ma nonè la sola. Più durevole e di natura diversa è il gusto del piacere e della novità inmateria di beni di consumo: si tratta, infatti, di un cambiamento di comporta-mento più che di statuto e non è necessariamente associato all’abbondanza. Unsecolo e mezzo più tardi, per descrivere lo stato d’animo dei contadini ridotti al-la miseria, cacciati dalle loro fattorie in seguito all’introduzione delle recinzionie costretti a emigrare nelle città, Tommaso Moro usa espressioni del tutto ana-loghe a quelle di Villani:
Senonché a questa povertà, a questa miserevole indigenza si aggiunge un lussoinopportuno. Non solo chi è a servizio di nobili, ma anche operai, ma starei perdire anche gente di campagna, ogni classe infine, ostenta una pompa sfacciata nel-le vesti, un lusso eccessivo nel tenore di vita. Ora, bettole, taverne, bordelli e, nuo-vi bordelli, spacci di vino e birrerie, e poi tanti giochi immorali, giochi d’azzardo,carte, bossoli, pallone, bocce, disco, non sono uno spreco di danaro? Non mandaquesto per la più breve chi vi è dedito a rubare in qualche luogo?26
Ciò che sottolineano Matteo Villani, Thomas More e molti altri contem-poranei è l’importanza che il mercato e il denaro assumono nella vita di tutti e,in particolare, delle classi lavoratrici. Immemori dell’antica divisione delle fun-zioni che assegnava ai laboratores una sussistenza garantita in cambio di un im-pegno senza riserve nell’attività produttiva, dopo la peste, i lavoratori usano aloro vantaggio lo squilibrio nuovo del mercato del lavoro e reclamano il dirittodi godere delle innumerevoli risorse lasciate vacanti dalle devastazioni dell’epi-demia. Le molteplici ordinanze emesse dopo il 1348 dai sovrani per regolamen-tare prezzi e salari sono la testimonianza che, ovunque in Europa, i mercati su-biscono gravi sconvolgimenti. Tali interventi non possono, tuttavia, riportare alloro antico stato settori economici profondamente trasformati, né tanto menofar mutare l’atteggiamento assunto dall’insieme della popolazione nei confron-ti del ciclo della vita, e in particolare dello statuto del lavoro e della relazionesalariale. Lo conferma l’incapacità dei tribunali inglesi a frenare la fuga dei con-tadini dai manieri, impegnati in contratti annuali con i loro signori, verso lecittà, dove la moltiplicazione dei contratti di breve durata mette il salariato nel-la posizione di rinegoziare costantemente salario e condizioni di lavoro.27 Ecco,tra mille esempi analoghi, due casi presentati al Tribunale di pace del Lincoln-shire nel 1375:
26. T. Moro, Utopia, a cura di T. Fiore, Ro-ma-Bari 1981, l. I, p. 27.
27. N. Ritchie, Labor Conditions in Essex in the
Reign of Richard II, in Essays in Economic Hi-story, a cura di E.M. Carus-Wilson, I, Londra1962, pp. 91-102.
51nascita di un’economia del consumo?
I giurati della Hundred di Wallescroft fanno sapere che Robert Rauly, di MiddleRasen, falciatore, si è assentato dal suddetto villaggio e ha soggiornato in diversiluoghi di questo paese per guadagnare salari più elevati, a dispetto dell’ordinanzareale, nel 1374. Item, fanno sapere che William Notel, di Middle Rasen, lavora-tore, e Margaret Pyper, dello stesso luogo, si rifiutarono nell’autunno dell’anno1374 di compiere il loro servizio nel suddetto villaggio e si assentarono per sog-giornare in tutti i luoghi del paese per guadagnare un salario più alto, a dispettodella volontà e dell’editto del loro signore.28
Come molti altri, questi due contadini non saranno né perseguiti né con-dannati. Non minimizziamo tuttavia l’importanza e le conseguenze globali di si-mili scelte individuali. La disaffezione dai lavori dei campi e l’opzione per il sa-lariato urbano sfocia in alcuni casi in situazioni critiche di disequilibrio: peresempio, nel 1369, nella regione di Caen, un’ordinanza del re Carlo V imponeai magistrati locali di requisire nelle città degli operai tessili per inviarli a taglia-re il grano che altrimenti rischierebbe di marcire nel campo («demourer etpourrir sur les terres»).29 Spesso accusati di agire sotto l’impulso di una cupidi-gia incompatibile con gli obblighi dei sudditi cristiani, questi uomini e donne ciappaiono oggi come gli esploratori di un mercato del lavoro in piena formazio-ne, in cui i salariati si determinano in funzione delle offerte che vengono fatteloro. Attirati dai salari monetari pagati in città e dai beni che possono acquista-re con il denaro, costoro partecipano alla distruzione dell’antico ordine, in cuigli statuti e le funzioni definivano il ruolo di ciascuno, per abbozzare un mondonuovo strutturato dalle passioni e dagli interessi.
Arlotto nel paese delle mercanzie
Lo sviluppo di una cultura del consumo è innanzitutto caratterizzato dallaproliferazione degli oggetti. Una delle singolarità del drammatico periodo dellafine del Trecento e della prima metà del Quattrocento è appunto l’invasione de-gli oggetti e delle merci sulla scena delle azioni umane. Una recente mostra sul-le attività economiche parigine durante il regno di Carlo VI (1380-1422) ha mes-so in luce le sfaccettature della creazione artistica di un grande centro produtti-vo, che inviava merci in tutta Europa. Non è tanto il raffronto tra dipinti, scultu-re e miniature di artisti noti a costituire la vera sorpresa della mostra, quanto lapresenza di un’arte composita che associa l’oreficeria, il tessile e le diverse formedi disegni e di pittura nell’elaborazione di oggetti di un virtuosismo stupefacen-
28. Some sessions of the peace in Lincolnshire, acura di R. Sillem, Hereford 1937, p. 22 (42).
29. M. Nortier, Documents normands du règnede Charles V, Paris 2000, p. 108, n. 452.
52 fra tradizione e modernità
te: al di là delle figure dei grandi creatori, si può intravvedere un gruppo di tecni-ci dei metalli, dei colori, dei tessuti e delle pietre dure, che operano insieme percreare capolavori, quali le figure sacre d’Altötting, di Valenza o di Montalto.30 Si-mili prodotti presuppongono l’esistenza di un mercato artistico europeo, il solo ingrado di finanziarne la fabbricazione, e di un mercato del lavoro della stessa am-piezza, necessario all’ingaggio e alla formazione di operai capaci di tali imprese. Èproprio la circolazione di questi oggetti, delle forme che sono loro associate e del-la maniera di fruirne e di goderne, a costituire la novità del Quattrocento. E nonsi tratta di una circolazione che investe solo i capolavori ma l’insieme della cultu-ra materiale. Arlotto Mainardi, eroe faceto della Firenze della metà Quattrocen-to, è uno dei migliori osservatori dello sviluppo di una cultura dell’oggetto.
Nato probabilmente intorno al 1396 da una famiglia popolare del conta-do fiorentino, Arlotto fu dapprima istruito nell’arte della lana, da cui però si al-lontanò ben presto per farsi chierico: nel 1426 divenne pievano di San Cresci aMaciuoli, nella diocesi di Fiesole. Non per questo rinunciò alla vita secolare: pa-re che per molti anni abbia viaggiato come cappellano sulle galere dirette a Na-poli e in Sicilia, in Provenza, a Londra e a Bruges. Era ancora in vita quando lesue battute di spirito e le sue facezie31 furono messe per iscritto e fornirono lamateria di un libro stampato nei primi anni del Cinquecento, testimonianza sen-za pari sulla società fiorentina quattrocentesca. In questi brevi racconti e dialo-ghi, Arlotto fa uso della sua diretta conoscenza dei diversi paesi europei legati aFirenze, nonché delle diverse componenti della società fiorentina, allo scopo difornire un quadro critico, anche se il più delle volte indulgente, verso i compor-tamenti dei suoi contemporanei. Ostile a ogni tipo di discorso astratto o genera-le, egli fonda le sue osservazioni sugli aspetti più concreti della vita materiale efa degli oggetti e del loro uso gli indizi privilegiati per capire i rapporti tra gli uo-mini. Il mondo che si apre al lettore ha in Firenze il suo centro, mentre le piaz-ze commerciali europee e la campagna fiorentina svolgono, ciascuna a suo mo-do, ruoli periferici.
Viaggiatore e mercante di lungo corso, Arlotto ama citare le proprie espe-rienze grazie alle quali ha potuto constatare quali differenze di usi e costumi visiano tra i diversi popoli d’Europa. Degli inglesi nota con disapprovazione che«quando vanno a tavola, dimoranno a mangiare tre ore o più»,32 mentre del re-gno di Napoli sa che «a volerli dare il suo epiteto e vero nome si vorrebe chia-marlo il paradiso terrestro e per cagione produca tanta innumerabile copia eabondanza di tanti beni e di tante nobile maniere di frutti per il vitto e governoe sostenimento del’uomo», ma che la sua aria «produce gli uomini cattivi e pie-
30. Paris 1400. Les arts sous Charles VI, a curadi E. Taburet-Delahaye, Paris 2004.
31. Motti e Facezie del Piovano Arlotto, a cura
di G. Folena, Milano-Napoli [1953] 1995.
32. Ivi, 5, p. 16.
53nascita di un’economia del consumo?
ni di tradimenti».33 Mostra anche di essere conscio del fatto che certi usi non sipossono esportare: a un mercante sconsiderato che credeva di poter vendere fa-cilmente a Firenze quelle «palle piccole» tanto apprezzate tra gli abitanti di Bru-ges, egli racconta la storia del Genovese mercante e delle gatte, che induce il ne-goziante alla prudenza e predice il fallimento di colui che non fa il necessariosforzo di informarsi. Quando egli stesso pratica un’attività mercantile dà provadi grande discernimento: in particolare acquista per conto altrui solo quando haricevuto un anticipo.34 In quest’ottica, la scelta delle mercanzie importate a Fi-renze o acquistate a Londra o a Bruges diventa un elemento importante dell’a-neddoto. Se i tessuti di seta fiorentini, i panni di lana inglesi o i drappi e gli araz-zi fiamminghi hanno un posto importante, Arlotto sa che prodotti meno presti-giosi, quali i rami e i peltri reperibili a Bruges o i saponi profumati che un cata-lano accorto vende a Firenze, in via de’ Martelli, possono assicurare importantiprofitti.35 All’occorrenza non esita a inventare i prodotti, come quei venti flaco-ni colmi di spezie colorate realizzati appositamente per lui in città, presso la«fornace de’ bicchieri» a forma di organo sessuale maschile (battistei) «belli na-turali e onorevoli di piena mano» e destinati ai giovani impiegati del banco de’Medici di Bruges, una parte dei quali sarà acquistata dal duca di Borgogna peroltre cento scudi d’oro.36
Pur sapendo, meglio di tanti altri, mettere in luce gli incessanti movimen-ti dei prodotti e le reti di scambi che, grazie a essi, collegano Firenze al resto delcontinente, Arlotto è anche sensibile all’uso di tali oggetti nel suo universo fa-miliare, che collega il Mugello alle strade fiorentine e che osserva dal suo tavo-lo dell’Osteria dell’Uccellatoio. Cibo e vestiti rappresentano nei suoi racconti ilsupporto di una costante lezione di morale pubblica, di gerarchia sociale e diambizioni individuali che di volta in volta si combattono o si confortano. Mode-sto chierico di origine popolare quando è ammesso alla tavola dei patrizi, il Pio-vano si trasforma in notabile agiato quando discute con il suo fedele gregge. Du-rante una discussione con un suo compagno, prete e priore di San Sano del Mu-gello, ricorda all’interlocutore, colpevole di avidità, la situazione privilegiata deichierici con queste parole:
Avete più che ducati 70 della prioria d’entrata l’anno: ché volete più briga all’ani-ma e al corpo? Non vi basta egli vivere come un onorato prete? Sono in Firenzegrande numero di uomini dabbene i quali non ascendono alla somma di tanta en-
33. Ivi, 150, p. 212.
34. Ivi, 126, p. 183.
35. Ivi, 153, p. 216.
36. Ivi, 83, p. 130; Arlotto non è il solo adoperare in questo mercato. Nel Ragionamento
della Nanna e della Antonia, l’Aretino parla di«quei frutti di vetro che si fanno a Murano diVinegia alla similitudine del K, salvo che han-no duo sonagli che ne sarebbe orrevole ognigran cembalo»: P. Aretino, Sei giornate, a cu-ra di G. Aquilecchia, Bari 1975, p. 14.
54 fra tradizione e modernità
trata l’anno e nondimeno vivono civilmente con la donna e tre e quatro figliuoli.Credete a me, credete a me, che si vòle procurare di avere di rendita insino in fio-rini cinquanta o al più insino in cento; come voi passate il segno de’ cento voi ave-te a tenere maggiore istato, il disidèro cresce e l’ambizione.37
In tutti questi esempi Arlotto si mostra sensibile alla disuguaglianza che siinstaura tra i personaggi, di cui descrive perfettamente i sintomi. Pastore atten-to, sa tradurre il disagio e la reticenza dei parrocchiani di fronte alla curiosità in-discreta dei chierici che li interrogano sulla loro vita sessuale.38 Conscio, inoltre,della condizione di precarietà dei contadini, non esita a esonerare uno di lorodalla partecipazione a una festa che lo priverebbe del salario. Poiché ritiene chele rendite della sua pieve, incrementate grazie alla sua gestione accorta, siano al-la base di una rete creditizia locale di cui c’è estremamente bisogno39 e in cui siimpegna personalmente,40 sa ricordare a uno dei suoi debitori che solo la restitu-zione del capitale permette di rinnovare il prestito.41 Di fronte ai potenti, si er-ge, inoltre, a difensore dei contadini, il cui lavoro, afferma, è il fondamento del-la prosperità della città. A Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico,che davanti a lui elogia la carità dei patrizi verso la gente del popolo e lo sfida atrovare un’elemosina più encomiabile del corredo che ha appena offerto a unafanciulla, non teme di replicare: «Io ve ne dirò una che è assai migliore, la qua-le è questa: non torre la roba d’altri, né la fatica, né il sudore di persona, massi-me de’ poveri uomini».42
Sociologo e moralista, Arlotto sa che ciascuno, a cominciare da se stesso,è anche l’abito che indossa e il modo di indossarlo. Elementi essenziali, i suoi ve-stiti appaiono talvolta come la posta in gioco di una discussione, talvolta comeveri e propri personaggi. Ne è un esempio il suo mantello, oggetto di svariate fa-cezie, che viene descritto con una certa precisione. Per aver preso sulla sua ca-valcatura i mantelli dei cinque compagni con cui si reca in pellegrinaggio a San-ta Maria del Sasso di Casentino, egli perde «miracolosamente» il suo «catalanoa buche». Un altro mantello costituisce uno dei punti centrali dell’elogio dellacarità in occasione di una gara di eloquenza tenutasi a Bruges con un cappellanoveneziano: «Per questa cagione, questa mattina di nuovo vi conforto a questa piaopera: considerate e vedete che io non ho altro che questo tristo mantello, vede-
37. Motti e Facezie, cit., 113, p. 175; per lamedesima ragione, egli tiene a pagare scru-polosamente le tasse impostegli dal Comune:148-149, pp. 208-212.
38. Ivi, 76 e 77, pp. 117-123.
39. Davanti al suo vescovo, Arlotto non esitaa difendere la necessità del prestito a usura(115, p. 175): «Diceva di volere sostenere
contro a ogni collegio di dottori come il pre-stare a usura non era peccato, ancora que fus-si a cinquanta per cento, ma che il peccatograve era il rivolere il capitale e lo interesse».
40. Ivi, 112, pp. 172-173.
41. Ivi, 163, p. 227; 193, p. 255.
42. Ivi, 47, p. 80.
55nascita di un’economia del consumo?
te che è tutto rotto e consumato e più non mi istà indosso. Pertanto, dilettissi-mi miei, levate le vostre mente in alto e pensate di quanta magnificienzia, gloriae merito sia la santa limosina: quello glorioso principe de’ confessori, santo Mar-tino benedetto per uno mezzo mantello dette per amore di Dio guadagnò il rea-me del cielo!».43 La forza dell’argomentazione gli varrà un dono di «30 bracciadi panno di Mellina» da parte dell’avversario. Un’altra volta, grazie alla capacitàdi convincere il papa Niccolò V a lasciargli il suo beneficio, otterrà da Roma «undegno mantello e cappuccio [e] una buona vesta».44
Il mantello non è solo oggetto di premio ma, per i diversi significati chesottende, è anche vettore di rapporti sociali. Quando domanda udienza al cardi-nale legato Giulio della Rovere per denunciare le manovre di un altro chiericoche vorrebbe impadronirsi del suo beneficio e ridurlo in miseria, si presenta ve-stito di «mantello di panno verde bruno», il che gli permette di dire a Lorenzoil Magnifico, venuto a salutarlo, «sono condotto al verde».45 L’abito può ancheavere un significato all’insaputa di colui che lo indossa: uno dei suoi compagnidi viaggio con cui si è recato a Bruges è aggredito dagli abitanti della città peraver indossato per vanità la «vesta da manigoldo» carica di vistosi ornamenti cheArlotto, perfidamente, gli aveva consigliato di acquistare. E il brutto tiro che gliha giocato un gruppo di fiorentini sarà vendicato macchiando d’olio i loro man-telli.46 Il sarto Zuta, che suole rubare della stoffa quando cuce i mantelli deiclienti, riconosce, nello stendardo variopinto, che nei suoi incubi gli indica la di-rezione dell’inferno, il frutto dei suoi furti.47
Il mantello indossato da Arlotto per recarsi a Roma in occasione del giu-bileo del 1475 è l’elemento centrale attorno a cui si articola una delle più lun-ghe e complesse facezie della raccolta.48 Ospite del suo nobile amico Falcone Si-nibaldi, il Piovano fu invitato in sua compagnia a pranzare dal cardinale di Pa-via, l’umanista Iacopo Ammannati, presso il quale però si presentò con reticen-za. Durante uno scambio di battute piuttosto teso, Arlotto oppone la sua sere-nità di prete di campagna, pago della sua condizione, alla frustrazione di non po-ter accedere al soglio pontificio manifestata dal suo ospite: «del libro de’ con-tentamenti, voi non siete alla lettera del C e io sono alla lettera del R. Avete mol-te dignità e ora siete a quella del cardinalato, né ancora vi contentate, ché vor-resti ascendere a quella del papato». Furioso e sprezzante, il cardinale se la pren-de allora con il mantello di Arlotto: «Quando il Cardinale ebbe udito alquantoil Piovano, disse “Voi non sapete perché avete detto tante cose sono in voi”:Voltossi verso il Piovano, con la mano accennò verso il suo mantello e disse:
43. Ivi, 3, p. 12.
44. Ivi, 82, p. 129.
45. Ivi, 89, p. 141.
46. Ivi, 197, p. 257.
47. Ivi, 59, pp. 93-94; 67, p. 104 (il sarto in-delicato è probabilmente lo stesso citato a p.101).
48. Ivi, 111, p. 164-172.
56 fra tradizione e modernità
“Perché voi avete recato le ragioni del canto vostro”». Davanti ai convitati in-terdetti, Arlotto si appresta allora a raccontare l’aneddoto del figlio di un calzo-laio, ambientato nelle Fiandre. Accolto tra i nobili, egli si tradì come uomo delpopolo, inadatto a frequentare la nobiltà, a causa del suo occhio troppo acutonello scoprire i difetti di cucitura nei calzoni di uno dei suoi compagni, e fu igno-miniosamente cacciato dalla festa. Perfettamente capito dal suo interlocutore, ilsignificato della lezione sfugge agli amici del Piovano, i quali, dopo il pasto, glichiedono spiegazioni. Questi rivela allora di aver incontrato Iacopo Ammannatianni addietro, quando per sfuggire alla miseria faceva commercio del propriocorpo nelle strade di Firenze: «e come io lo avevo veduto poverissimo andare inzoccoli di maggio per lo asciutto e co’ panni rattoppati indosso e rivolti sotto so-pra». Giunto ai vertici della società, egli non aveva potuto fare a meno di far no-tare ad Arlotto la modestia della sua riuscita, indicando il mantello logoro, por-tato a lungo da un lato, poi rivoltato e portato dal lato della fodera: «Come uo-mo dispettoso, fisò verso di me l’occio e posemi mente il mio mantello che io hoindosso e rimproverommi che io l’avevo rivolto ritto rovescio – e diceva il veroperche n’era intendente – e con dirmi “Voi non sapete perché in voi sono tantecose, solo perché vi avete recate le ragioni del canto vostro” cioè il mantello ri-volto ritto rovescio». Vendicatosi contro l’arricchito indelicato, Arlotto può al-lora concludere dando al suo compagno ingenuo e facoltoso una piccola lezionedi sociologia dell’abbigliamento: «Voi siete nobile uomo e siete nato e allevato enutrito ricco, in modo non potete essere intelligente della arte né accorgervi delmio mantello, che è rivolto proprio come lui dice: e giudicò bene come quelloche ne aveva veduti e portati più d’uno rivolto a suoi dì. Messer Falcone mio dabene, voi vi fate un mantello e portatelo uno anno o diciotto mesi, e poi lo ven-dete e voi lo donate e rifatevene uno nuovo né però non vi potete avvedere néessere della arte a intendervi dei panni rivolti».
Questo duello sulle apparenze in cui Arlotto e il cardinale si affrontanocopertamente può essere interpretato in vari modi, tanto più che il testo, ripre-so nella raccolta di Facezie di Angelo Poliziano, sembra esser circolato assai ra-pidamente negli ambienti fiorentini. Non è impossibile che, attraverso la figu-ra ambigua del cardinale di Pavia, il Piovano mirasse, con le sue osservazioni as-sassine, a colpire l’intero gruppo degli umanisti medicei. Il significato moraledell’aneddoto va comunque al di là della vita fiorentina. Rivendicando la mode-stia delle ambizioni e delle apparenze, Arlotto fa l’elogio di una società gerar-chizzata, dove ognuno ha il dovere di mantenere il proprio rango, modesto oelevato che sia, senza cercare di sconvolgere, con le proprie ambizioni, quelledisposizioni sociali che danno a tutti, dal semplice contadino al patrizio, dignitàe stima di sé. Nel mondo instabile e al tempo stesso regolato minuziosamentedescritto nelle facezie, rango sociale, abbigliamento e comportamenti definisco-no la condizione di ciascuno e designano alla pubblica esecrazione e al disprez-
57nascita di un’economia del consumo?
zo colui che si permette di trasgredire le regole comuni perché crede che la ric-chezza legittimi l’uso e lo sfoggio di vesti sofisticate. In un mondo in cui il mer-cato sembra trionfare sulle antiche regolamentazioni, l’amara saggezza di Ar-lotto spiega a suo modo quella stabilità sociale che le leggi suntuarie e gli sta-tuti lasciano intravvedere.*
* Traduzione di Ida Giordano.

























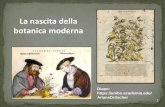



![La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312e0d5fc260b71020ed6a6/la-nascita-della-scienza-giuridica-in-lantichita-roma-a-cura-di-umberto-eco.jpg)















