(Cura e traduzione di) E. Falque, Metamorfosi della finitezza. Saggio filosofico sulla nascita e la...
Transcript of (Cura e traduzione di) E. Falque, Metamorfosi della finitezza. Saggio filosofico sulla nascita e la...
EMMANUEL FALQUE
Metamorfosi della finitezza
Saggio sulla nascita e la risurrezione
A cura e traduzione di Francesco Valerio Tommasi
Metamorfosi della finitezza.indb 3 30/07/14 15.00
Titolo originale dell’opera Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la résurrection
© 2004 Les Éditions du Cerf www.editionsducerf.fr 29, boulevard La Tour-Maubourg - 75340 Paris Cedex 07
Traduzione dal francese e curatela di Francesco Valerio Tommasi
© EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., 2014 Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) www.edizionisanpaolo.it Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l. Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
ISBN 978-88-215-9343-7
Metamorfosi della finitezza.indb 4 30/07/14 15.00
PREFAZIONE ALLA TRADUZIONE ITALIANA
Metamorfosi della finitezza costituisce il secondo capitolo di una trilogia che si apre con Le passeur de Gethsémani e si chiude con Les Noces de l’Agneau. L’intero percorso è sorret-to da una convinzione di fondo: le verità teologiche del triduo pasquale (passione, risurrezione, eucarestia) hanno bisogno di una esperienza filosofica che le spieghi, e che si può rinveni-re, rispettivamente, nei fenomeni dell’angoscia, della nascita e del corpo. Il contributo della fenomenologia francese, ben noto anche in Italia, rappresenta l’orizzonte di sfondo dell’a-nalisi; a partire dalla fenomenologia si può infatti affrontare in modo nuovo, da un punto di vista filosofico, la teologia. Ma per altro verso è necessario altresì osare un «passaggio del Rubicone» – tanto più significativo per un autore francese tra-dotto in italiano! – che permetta alla teologia di parlare alla filosofia e di offrirle nuova linfa. Non si tratta tanto, quindi, di legarsi a una specifica corrente di pensiero. Ogni novità, in filosofia come in teologia, può essere espressa solo a partire dall’antico: perciò il testo prende in considerazione tutta la tradizione del pensiero, per cercare di descrivere al meglio la questione della risurrezione per noi oggi1.
Occorre tuttavia precisare che questo «triduo filosofico» non si rivolge solo ai filosofi, o ai teologi, e neanche ai soli cre-denti. Gli enunciati del cristianesimo sono in rapporto stret-
1 Su questo punto rinviamo al nostro recente lavoro: Passer le Rubicon: Philosophie et théologie, essai sur les frontières, Lessius, Bruxelles 2013.
Metamorfosi della finitezza.indb 5 30/07/14 15.00
6 Metamorfosi della finitezza
tissimo con lo sviluppo della cultura. Il compito di un filoso-fo cristiano non consiste solo nello spiegare un dogma a cui è possibile credere (croyable); egli deve anche renderlo piena-mente credibile, nel senso di convincente (credible). Nelle ve-rità di fede infatti non è contenuto solo qualcosa a cui si deve «credere», ma anche qualcosa che permette di «sapere». Nei secoli passati ci si è sforzati di non rinunciare mai a svilup-pare questo rapporto (Ireneo, Tertulliano, Agostino, Tommaso d’Aquino, Bonaventura ecc.). Sarebbe quindi davvero singo-lare abbandonare l’impresa oggi, con la scusa magari che il cristianesimo versa in stato di difficoltà e rappresenta un me-ro affare del passato.
Il filosofo può assumere invece una posizione nuova, so-prendente per alcuni, confortante per altri. Oggi infatti sembra superato il tempo dei «filosofi della soglia», che si arrestano di fronte al portale della teologia, considerandola questione non di loro pertinenza. La forza di Bergson, di Blondel, di Scheler, di Gabriel Marcel o di Paul Ricoeur è stata certo il di-vieto autoimposto di fare teologia, lasciando ad altri il com-pito di sviluppare quanto, nelle loro opere, essi stessi non ave-vano forse neppure intuito (il mistero del soprannaturale, ad esempio, da Maurice Blondel a Henri de Lubac). Ma oggi, so-prattutto in Francia, le frontiere si sono decisamente spostate.
La questione dunque va affrontata nuovamente: finalmen-te è possibile, almeno in determinati contesti e circostanze, presentarsi contemporaneamente come filosofo e come teolo-go. Chi si occupa di filosofia, infatti, comprende meglio dove e quando è strettamente filosofo proprio allorché si permette anche, in altre circostanze, ma magari anche in una stessa opera, di fare teologia. Ecco il paradosso: più si fa teologia e meglio si fa filosofia (plus on théologise, et mieux on philoso-phe). Procedendo in entrambi i campi, infatti, si ha più chiaro che cosa appartenga all’uno o all’altro versante, anche all’in-
Metamorfosi della finitezza.indb 6 30/07/14 15.00
Prefazione 7
terno di uno stesso scritto. La vera distinzione tra filosofia e teologia non va perseguita separando lavori e testi, come vor-rebbe una suddivisione del corpus che la fenomenologia fran-cese conduce sin troppo, ma nella «pratica congiunta» di en-trambe, che garantisce la loro differenza assumendola in ogni passaggio.
Il lettore italiano e magari, in tutti i sensi, «romano», tro-verà in queste pagine la traduzione di Métamorphose de la fi-nitude. Grazie a questa traversata intellettuale arriverà al cuo-re, forse non del mistero di fede e della sua espressione filo-sofica e teologica, ma almeno del nostro trittico: Metamorfo-si della finitezza (nascita e risurrezione) si può infatti leggere in modo del tutto indipendente rispetto a Le passeur de Gethsémani (angoscia, sofferenza e morte) e a Les Noces de l’Agneau (corpo ed eucarestia). L’opera è stata concepita e strutturata, infatti, in modo da essere autonoma, grazie alla ripresa e al ridispiegamento di un «compendio della finitezza» che serve da orizzonte alla possibile trasformazione apporta-ta dalla risurrezione. Il lettore quindi non ha necessità di pre-occuparsi di ciò che viene prima o dopo, nell’attesa che anche gli altri due volumi vengano tradotti; ma può procedere nel cammino dello studio assieme all’autore, incrociandone esi-stenzialmente l’esperienza. La lettura è anche condivisione di vita: tra colui che scrive e colui che legge, senza dubbio; ma anche forse con Colui, la cui «metamorfosi» emerge, come car-dine del cristianesimo, al cuore dell’opera.
Non ci sarebbe lettura, infine, senza un atto di passaggio, di trasferimento e di trasmissione permesso dalla traduzione. Il traduttore, studioso di filosofia della religione e di storia delle idee, sa bene di che cosa si parli quando si chiama in causa il confronto possibile e necessario tra la filosofia e la teologia. La «finitezza» serve qui da tratto di fondo comune per designare l’uomo contemporaneo (filosofia). La risurrezio-
Metamorfosi della finitezza.indb 7 30/07/14 15.00
8 Metamorfosi della finitezza
ne, espressa nei termini della nostra cultura, interviene per abitare altrimenti e trasformare la finitezza, «salvando» così la nostra vita (teologia). Sono profondamente riconoscente a Francesco Valerio Tommasi per l’amicizia e il rigore del suo lavoro di traduzione, e sono molto grato alle Edizioni San Paolo per aver avviato l’opera di pubblicazione del trittico in un paese che è alle radici della cristianità.
Mettray, nella solennità di Ognissanti,1 novembre 2013.
Emmanuel FalqueDecano della Facoltà di Filosofia
Institut catholique de Paris
Metamorfosi della finitezza.indb 8 30/07/14 15.00
Nota introduttiva del curatore per il lettore italiano
Nelle righe di prefazione, l’Autore ha già detto l’essenziale. Né d’altronde sono veramente possibili introduzioni, in filo-sofia. Il lettore italiano è invitato a tuffarsi direttamente nelle acque del testo. Quello che è possibile fornire qui, in uno spa-zio breve, è solo un rapido vademecum: coordinate di ausilio al confronto con un’opera forse non facile, ma di certo affa-scinante; e spunti per ulteriori approfondimenti.
Oltre a ricordare come Metamorfosi della finitezza sia par-te di un «trittico» modellato attorno al triduo pasquale, ma al contempo possa leggersi autonomamente, Falque ha già chia-mato in causa due elementi. Una tradizione di lunghissima durata, il nesso tra filosofia e teologia; e un contesto specifi-co che l’attualizza: la fenomenologia, in particolare la sua de-clinazione francese degli ultimi decenni. Si tratta della cosid-detta «svolta teologica della fenomenologia francese». L’espres-sione, usata originariamente con un’accezione polemica da Dominique Janicaud, rende conto, al di là di ogni valutazione, di un fatto: da alcuni lustri in Francia temi della tradizione religiosa e teologica sono presentissimi, innervano o inquina-no – con una osmosi il cui controllo metodico e la cui valu-tazione sono appunto oggetto di acceso dibattito – la tradi-zione filosofica inaugurata da Husserl1. Janicaud individua un momento simbolicamente decisivo nel 1961, anno di pubbli-
1 D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Éd. de l’Éclat, Combas 1991.
Metamorfosi della finitezza.indb 9 30/07/14 15.00
10 Metamorfosi della finitezza
cazione di Totalité et infini e della morte di Merleau-Ponty, che assieme a Sartre è identificato quale capofila di una feno-menologia francese inizialmente «atea»2.
Tuttavia la storia è più lunga e complicata e il problema della contaminazione teologica della fenomenologia rimonta alle origini stesse di questa corrente di pensiero; certo è un paradosso per una scuola che fa dell’assenza di presupposti e della ricerca del punto di vista neutrale di uno spettatore di-sinteressato i propri cardini. Ma probabilmente non si tratta di un caso: il (presunto?) realismo delle Logische Untersuchun-gen e l’impostazione riassunta nel motto che invitava al «ri-torno alle cose stesse» (zurück zu den Sachen selbst!), in po-lemica con neokantismo, positivismo e idealismo, conducono da subito Husserl a subire l’accusa di voler fondare «una nuo-va scolastica»; così egli incrocia, o magari persino genera, per-corsi teorici in cui si riscontra una rinnovata apertura alla metafisica, oppure è centrale il tema religioso.
Si pensi, tra gli altri, ad autori quali Scheler, Reinach, von Hildebrand, Stein o Conrad-Martius; ma anche – decisivi per la Francia – a Koyré e Héring. Significativamente, molti di lo-ro si avvicinano proprio alla tradizione cattolica, che del re-alismo ha fatto una bandiera. Ma già nella formazione dello stesso Husserl, d’altronde, aveva giocato un ruolo decisivo Franz Brentano. Di impronta ancora più marcatamente e rigi-damente neoscolastica sono anche gli studi giovanili di Mar-tin Heidegger, che muove i primi passi in fenomenologia con analisi dedicate alla «vita religiosa»; ben presto però – un al-tro paradosso? – egli propone una declinazione del metodo husserliano in cui si radicalizza l’orizzonte intrascendendibi-le della finitezza. Tuttavia, secondo un ennesimo ribaltamen-
2 Per una storia dettagliata della ricezione e dello sviluppo della fenomenologia in Francia cfr.: C. Dupont, Phenomenology in French Philosophy. Early Encounters, Springer, Dordrecht 2014.
Metamorfosi della finitezza.indb 10 30/07/14 15.00
Nota introduttiva 11
to di quanto ci si potrebbe ingenuamente aspettare, è altresì superfluo sottolineare quanto l’impostazione heideggeriana, proprio nella chiusura alla trascendenza concepita in senso classico, abbia poi permesso decisivi progressi alla teologia: basti citare figure come Rudolf Bultmann o Karl Rahner, o an-che Bernhard Welte.
Ancora, proprio sulla scorta di una concezione della filo-sofia e della fenomenologia quale «scienza rigorosa», obietti-va e universale, lo stesso Heidegger giudica un controsenso ogni possibile sua connotazione specifica, e quindi anche l’idea di «filosofia cristiana» che nella neoscolastica di ambito fran-cese si andava sviluppando in quei decenni. Se si escludono sporadiche incursioni personali, come quelle di Erich Przywa-ra, è però proprio quello stesso ambiente francese il primo contesto cattolico a recepire organicamente la fenomenologia, a partire da un incontro organizzato dalla Societé Thomiste a Juvisy nel 1932, cui presero parte anche Gilson, Maritain, Mandonnet, Roland-Gosselin, Gouhier, Feuling, Söhngen, Koyré e Stein; l’anno seguente la stessa sede ospiterà un ana-logo convegno della stessa Società dedicato proprio all’idea della «filosofia cristiana». Il rapporto o il conflitto tra fenome-nologia e teologia sembra quindi possedere tratti di struttura-lità. Paradossale, è tanto irrisolto quanto fecondo.
La questione di soglia disciplinare tra filosofia e teologia si intreccia anche, come abbiamo iniziato ad accennare, con la questione di passaggio linguistico: è zona di confine Fri-burgo, dove si reca Emmanuel Levinas dal 1928 ad ascoltare Husserl e Heidegger; ma è zona di confine Strasburgo, dove egli aveva appreso la fenomenologia da Héring. Tanto che sin da questi esordi vi sarebbe motivo di mettere in questione il carattere originalmente «francese» della fenomenologia im-portata al di là del Reno. Sino al momento decisivo in cui pro-prio Levinas traduce le Cartesianische Meditationen tenute da
Metamorfosi della finitezza.indb 11 30/07/14 15.00
12 Metamorfosi della finitezza
Husserl nell’anfiteatro Descartes della Sorbona nel 1929. Tan-ti, cominciando da Paul Ricoeur, ma poi anche Michel Henry, Jean-Yves Lacoste, Jean-Luc Chretien e Jean-Luc Marion, han-no impresso alla fenomenologia in Francia una direzione che si nutre del confronto serrato – fino appunto a una vera e propria fusione di orizzonti – con la teologia e l’ambito reli-gioso più in generale.
A nulla di meno che a una storia così lunga e nobile si de-ve almeno far cenno quando si vuole avvicinare l’opera di un autore come Emmanuel Falque, che è certamente inquadrabi-le in questa cornice. Attualmente Decano della Facoltà di Fi-losofia dell’Institut Catholique di Parigi – dove peraltro hanno operato di recente o sono ancora attive figure affini a questa costellazione, come Jean Greisch, Francis Jacques e Philippe Capelle –, egli possiede però un profilo dotato di tratti di ori-ginalità di cui anche si deve, pur rapidamente, far menzione3. Prendiamo le mosse cronologicamente dalla fine, ossia dal la-voro più recente, che Falque stesso cita in apertura della sua prefazione, evidenziandolo come un punto di arrivo del pro-prio percorso. In Passer le Rubicon (2013) si riscontra un ten-tativo di riflessione metodica e di messa a punto proprio del complicato rapporto tra fenomenologia e teologia. In partico-lare viene analizzato compiutamente il senso del principio nel quale Falque sembra sintetizzare la propria linea teorica: «più si fa teologia e meglio si fa filosofia» (plus on théologise, et mieux on philosophe), e si descrivono sia le potenzialità del metodo fenomenologico per la teologia, sia il fecondo «con-traccolpo» (choc en retour) della teologia sulla filosofia.
Che cosa significa, concretamente? Anzitutto che il dato teologico, per un verso, viene appunto rischiarato dalla feno-
3 Come studio introduttivo all’opera di Falque si può altrimenti segnalare A. Saudan, Penser Dieu autrement: introduction à l’oeuvre d’Emmanuel Falque, Germina, Meaux 2013.
Metamorfosi della finitezza.indb 12 30/07/14 15.00
Nota introduttiva 13
menologia. In Metamorfosi della finitezza, la risurrezione è compresa a partire dal fenomeno della nascita. Falque propo-ne una interpretazione analogica e non dualistica del brano giovanneo di Nicodemo, secondo una direzione né materiali-stica né spiritualistica; strumenti decisivi di questa operazione sono la categoria hedeiggeriana di «evento», filtrata original-mente dalla lettura di Claude Romano, e soprattutto la distin-zione husserliana tra «corpo» e «carne» – ossia corps e chair, traduzioni francesi di Körper e Leib, a marcare la differenza tra la corporeità degli oggetti fisici e quella umana; anche se proprio Falque sottolinea l’organicità anche del Körper e pro-pende per una interpretazione che sfumi la contrapposizione, radicalizzatasi definitivamente con Michel Henry, e arrivando poi in Les Noces de l’Agneau a proporre la necessità di intro-durre anche la nozione di corps epandu («corpo espanso», che richiama il cartesiano corps etendu, «corpo esteso»)4.
La fenomenologia è dunque utilizzata per dare nuova vita alla teologia, secondo quanto Falque non solo tenta di prati-care, ma invoca programmaticamente in queste pagine, richia-mando l’attenzione sulla possibile spendibilità di questa linea francese per i teologi, dopo la stagione ermeneutica e dopo la grande influenza hegeliana, che sottenderebbe secondo lui tutta la grande teologia tedesca del Novecento. Reciprocamen-te, le acquisizioni della filosofia contemporanea ricevono spes-sore, secondo Falque, se lette alla luce del dogma di fede cri-stiano. La risurrezione si rivolge anzitutto al dato centrale del
4 Notiamo incidentalmente come i due termini Körper e Leib vengano resi talora in italiano anche con «corpo» e «corpo vivente» (o «corpo proprio»), ma, dopo la diffusione nel nostro paese dei lavori non solo di Merleau-Ponty, ma altresì di Didier Franck, il bino-mio «corpo» e «carne», che si utilizzerà qui, risulta oramai consolidato. La questione cui abbiamo accennato è esemplificativa del portato teorico che accompagna il problema lin-guistico, nel dover rendere una tradizione francese che a sua volta fa riferimento a una scuola di pensiero tedesca, elaborandola poi autonomamente: simili questioni saranno se-gnalate, nel corso del testo, da note del traduttore, o da riferimenti tra parentesi ai termi-ni tecnici dell’originale francese, e talora anche al tedesco.
Metamorfosi della finitezza.indb 13 30/07/14 15.00
14 Metamorfosi della finitezza
pensiero moderno, la finitezza, per trasformarla e «metamor-fizzarla». Non si tratta, come il testo ribadisce più volte, di trovare l’infinito nel finito, dedurre la temporalità dall’eterni-tà, riproporre un «metodo dell’immanenza» o un presunto «dramma dell’umanesimo ateo», secondo noti riferimenti, an-cora, alla tradizione d’oltralpe. Piuttosto, si tenta di valutare se e come il discorso cristiano e in particolare, simmetrica-mente, proprio la sua pretesa fondamentale – la risurrezione – abbiano qualcosa da dire a un’esistenza il cui orizzonte va concepito definitivamente e inesorabilmente come chiuso e senza sbocco. All’essenza della modernità, la finitezza, viene dunque affiancata l’essenza del cristianesimo, la risurrezione.
Pubblicato nel 2004, Metamorfosi della finitezza va dun-que al cuore delle questioni attorno cui gravitano gli interes-si di Falque, e volendo accostarsi al «trittico», ma più in ge-nerale alla sua opera, sembra un punto di partenza privilegia-to. Mentre Le passeur de Gethsémani (1999) era dedicato a un’analisi della passione nei termini fenomenologici ed esi-stenziali di angoscia, sofferenza e morte, qui il rischio teorico è forse maggiore e il metodo giunge a piena compiutezza. La questione è delicata e sull’equilibrio di questo filo sottile sta o cade la proposta di Falque. Si tratta infatti di mettere in que-stione la finitezza senza ricorrere all’infinito o a un qualsivo-glia deus ex machina, ma tenendo come dati acquisiti non so-lo la «morte di Dio», ma anche la «morte del cristianesimo».
Questo è il tentativo dell’autore. Se già nel testo preceden-te il contraccolpo teologico radicalizzava il dato filosofico e fenomenologico e la finitezza era condotta alle sue estreme conseguenze, qui si pretende anche di «metamorfizzarla». Pri-ma era in questione un «passaggio» nei termini di assunzione su di sé dell’umanità e di attraversamento della sua finitezza, e che mostrava come il com-patire possa essere uno sbocco di senso per la finitezza umana e una risorsa per una teologia
Metamorfosi della finitezza.indb 14 30/07/14 15.00
Nota introduttiva 15
che non pensi più in termini di sostituzione vicaria. Ora ne va invece di un passaggio che è metamorfosi. La novità va inte-sa in termini di radicalizzazione. Insistendo sulla finitezza, si scopre, a partire dalla nascita, come alcuni tratti che ne ac-centuano il carattere, senza smentirlo, costituiscono contem-poraneamente anche motivo di apertura; e come un dato teo-logico nuovo e sconvolgente, la risurrezione, ne ponga radi-calmente in questione il senso.
L’opera che invece segue cronologicamente la presente, va-le a dire Les Noces de l’Agneau (2011), applicherà dal canto suo il reciproco fecondarsi di filosofia e teologia alla questio-ne della corporeità, dell’intersoggettività e della sessualità, vi-ste alla luce dell’eucarestia e delle nozze. Il trittico è presen-tato da Falque in un’ottica profondamente unitaria e persino sistematica, come la lettura di queste pagine, che presentano continui richiami all’indietro e in avanti, mostrerà: «l’uomo con il suo corpo si dà infatti al passato (la nascita), al presen-te (la sessualità) e al futuro (la morte)». Anche questo schema sistematicamente cronologico (una cronologia cioè di princi-pio, non la cronologia di fatto con cui sono state scritte le tre opere) invita allora a prendere le mosse dal passato, dalla na-scita, dalla Metamorfosi della finitezza.
Spetta certo al lettore l’autonoma valutazione della tenuta di questo ardito tentativo di confrontare (coniugare? contrap-porre? confondere?) filosofia e teologia; di «passare» costan-temente dall’una all’altra. Qui rileva metterne in luce tutta la portata. Sin dalle primissime righe anche di questo testo, co-me già nel titolo del Passeur… e in quello di Passer…, essa è condensata icasticamente nel termine «passaggio», etimologi-camente implicato nel significato stesso di quella «Pasqua» che fa da sfondo al trittico. Come una sorta di prisma, capace di rifrangere e di moltiplicare i piani di lettura, il «passaggio» chiama in causa infatti il rapporto tra autore e lettore, tra espe-
Metamorfosi della finitezza.indb 15 30/07/14 15.00
16 Metamorfosi della finitezza
rienza di vita e speculazione teorica, tra elaborazione tecnica e quotidianità ordinaria, tra uomo e Dio, ma anche tra tempo ed eternità, e poi nella vita intratrinitaria fra le persone del Padre, del Figlio e dello Spirito, e, volendo, tra lingua e lin-gua, e così via… secondo una serie di temi che sono pretta-mente fenomenologici, ma anche più latamente filosofici, non-ché squisitamente teologici.
Altro tratto originale della riflessione di Falque, infatti – e ci ricongiungiamo così, chiudendo, a quanto si diceva in aper-tura –, è la volontà di rivolgersi all’intera storia del dibattitto tra filosofia e teologia, e in particolare il tentativo esplicito di avviare una pratica fenomenologica sistematica della patristi-ca e della scolastica. Un volume dedicato a Bonaventura ne ha rappresentato un primo esempio (Saint Bonaventure et l’en-trée de Dieu en théologie, 2001): significativa è la prossimità di Falque alla tradizione francescana, vista come paradigma-tica di una teologia «dal basso» richiamata più volte anche in queste pagine. L’autore la propone anche come possibile «con-trocanto» del pensiero di Jean-Luc Marion, che, segnato da profonde nervature balthasariane, sarebbe piuttosto espressio-ne di una teologia della gloria, «dall’alto».
Un più imponente volume costituisce poi l’esempio com-piuto della lettura fenomenologica del pensiero cristiano, va-le a dire Dieu, la chair et l’autre (2008), in cui Falque rinvie-ne in autori classici (Ireneo, Tertulliano, Agostino, Scoto Eriu-gena, Bonaventura, Duns Scoto e Meister Eckhart) prodromi di istanze fenomenologiche; ma ancora una volta anche all’in-verso, in quello scritto le categorie fenomenologiche vengono utilizzate per chiarificare i pensatori citati. Tracce dei saggi che compongono quest’opera più corposa sono ben presenti in Metamorfosi della finitezza. Di essa, inoltre, è in corso d’o-pera una traduzione italiana grazie al lavoro di Silvia Geraci per l’editore Le Lettere.
Metamorfosi della finitezza.indb 16 30/07/14 15.00
Nota introduttiva 17
Si tratta di un segno ulteriore dell’attenzione crescente che Emmanuel Falque sta riscontrando negli ultimi anni nel no-stro paese: diverse volte egli ha preso parte ai «Colloqui Ca-stelli» di filosofia della religione a Roma, che grazie all’opera di Marco Maria Olivetti sono stati un luogo importante di ela-borazione della fenomenologia francese, e che vengono più volte richiamati anche nelle note di queste pagine; e la sua opera ha ricevuto attenzione soprattutto a Macerata, per me-rito del lavoro di Carla Canullo, che recentemente gli ha de-dicato anche un prezioso volume collettaneo di studi, curato assieme a Paul Gilbert5. Si vedrà ora se e quale choc en retour sarà in grado di fornire alla Metamorfosi della finitezza un più ampio pubblico fenomenologico, filosofico, teologico, ma an-che non specialistico, italiano.
Francesco Valerio Tommasi
5 Cfr. C. Canullo - P. Gilbert (a cura di), Emmanuel Falque. Tra fenomenologia della finitezza e teologia dell’incarnazione, Le Lettere, Firenze 2014.
Metamorfosi della finitezza.indb 17 30/07/14 15.00
INDICE
Prefazione alla traduzione italiana pag. 5Nota introduttiva del curatore per il lettore italiano » 9
SOGLIA: LA PALA DI BEAUNE O «LA GERMINAZIONE DEI RISORTI» » 25
INTRODUZIONE: «ESSERE TRASFORMATO» » 29 § 1. Dalla morte alla nascita » 31 § 2. Il colloquio con Nicodemo » 35 § 3. Percorso euristico ed esposizione didattica » 38
PRIMA PARTECOMPENDIO DELLA FINITEZZA
CAPITOLO I: L’IMMANENZA INAGGIRABILE » 51 § 4. L’immanenza in questione » 51 § 5. La prelazione dell’infinito » 54 § 6. Specifico cristiano e ordinarietà carnale » 58
CAPITOLO II: IL TEMPO DAL TEMPO » 63 § 7. La deriva del tempo » 65 § 8. Il passare del tempo » 69 § 9. Il peso del tempo » 73
CAPITOLO III: C’È UN DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO? » 79 § 10. Morte di Dio o morte del cristianesimo? » 80
Metamorfosi della finitezza.indb 277 30/07/14 15.00
278 Metamorfosi della finitezza
§ 11. L’ateismo visto dal teologo pag. 84 § 12. Il divieto del «perché» » 89
SECONDA PARTEVERSO UNA METAMORFOSI
CAPITOLO IV: RISURREZIONE E «SOVRA-RISURREZIONE» DEL CORPO » 107 § 13. Il dibattito con Nietzsche » 107 § 14. La corporeità in Paolo » 117 § 15. Un corpo a corpo fenomenale » 123
CAPITOLO V: LA RISURREZIONE CAMBIA TUTTO » 131 § 16. La prova del Padre » 134 § 17. La trasposizione appercettiva del Figlio » 141 § 18. Lo Spirito come metaformosi del Figlio
da parte del Padre » 153
CAPITOLO VI: L’UOMO INCORPORATO » 163 § 19. L’ipotesi monadologica » 163 § 20. L’incorporazione trinitaria » 167 § 21. Colui che vede e colui che corre » 174
TERZA PARTEFENOMENOLOGIA DELLA RISURREZIONE
CAPITOLO VII: IL MONDO DIVENUTO ALTRO » 183 § 22. La terra e i cieli » 183 § 23. Creazione e separazione » 188 § 24. Un’altra maniera di vivere lo stesso mondo » 194
CAPITOLO VIII: DAL TEMPO ALL’ETERNITÀ » 211 § 25. L’istante di eternità » 211
Metamorfosi della finitezza.indb 278 30/07/14 15.00
Indice 279
§ 26. La gioia della nascita pag. 217 § 27. Conoscenza e nascita (La con-naissance) di Dio » 231
CAPITOLO IX: UNA CARNE PER RINASCERE » 237 § 28. Nascita e rinascita » 239 § 29. Corpo carnale e corpo risorto » 250 § 30. Ritiro del corpo e manifestazione della carne » 261
CONCLUSIONE: L’ATTESA DELLE CARNI » 271
Metamorfosi della finitezza.indb 279 30/07/14 15.00
























![Il pensiero filosofico occidentale e la morte [Western Philosophy on Death]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a0bb63847156ac06b685/il-pensiero-filosofico-occidentale-e-la-morte-western-philosophy-on-death.jpg)
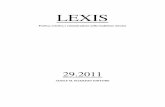







![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)







