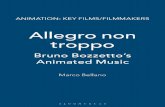COLPO I. 2012, “Fai gli dei troppo potenti, se credi che diano e tolgano forma alla gente”....
Transcript of COLPO I. 2012, “Fai gli dei troppo potenti, se credi che diano e tolgano forma alla gente”....
ANTENOR QUADERNI
Direzione
Irene Favaretto, Francesca Ghedini
Comitato sCientifiCo Maria Stella Busana, Jacopo Bonetto, Paolo Carafa, Marie Brigitte Carre, Heimo Dolenz, Christof Flügel, Andrea Raffaele Ghiotto, Giovanni Gorini, Stefania Mattioli Pesavento, Mauro Menichetti, Athanasios Rizakis, Monica Salvadori, Daniela Scagliarini, Alain Schnapp, Gemma Sena Chiesa, Desiderio Vaquerizo Gil, Paola Zanovello, Norbert Zimmermann
CoorDinamento sCientifiCo Isabella Colpo
segreteria reDazionale
Matteo Annibaletto, Maddalena Bassani
Layout del testo: Matteo Annibaletto
Il Volume è stato realizzato nell’ambito del progetto MArS. Mito, Arte, Società. Padova centro di eccel-lenza per lo studio del linguaggio delle immagini nel mondo antico, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che lo ha selezionato tra i migliori progetti di ricerca presentati nell’edi-zione 2008-2009 del Bando “Progetti di Eccellenza”.
Università degli Studi di PadovaDipartimento dei Beni CulturaliPiazza Capitaniato, 7 – 35139 [email protected]
ISBN 978-88-97385-31-8© Padova 2012, Padova University PressUniversità degli Studi di Padovavia 8 febbraio 1848, 2 - 35122 Padovatel. 049 8273748, fax 049 8273095e-mail: [email protected] www.padovauniversitypress.itTutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.
In copertina: fronte di sarcofago con strage dei Niobidi (particolare). Venezia, Museo Archeologico Nazionale (inv. 24). Da: Metamorfosi. Miti d’amore e di vendetta nel mondo romano, catalogo della mostra, a cura di I. Colpo, F. Ghedini, G. Salvo, Padova 2012, fig. 59.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVADIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
ANTENOR QUADERNI 28
IL GRAN POEMA DELLE PASSIONI E DELLE MERAVIGLIE
oviDio e il repertorio letterario e figurativo fra antiCo e risCoperta Dell’antiCo
ATTI DEL CONVEGNO(PADOVA, 15-17 SETTEMBRE 2011)
a cura di Isabella Colpo, Francesca Ghedini
PADOVA UNIVERSITY PRESS
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
SOMMARIO
franCesCa gheDini, Ovidio 2011: presentazione ........................................................................7
OVIDIO TRA TESTO E IMMAGINI
isabella Colpo, «Fai gli dei troppo potenti, se credi che diano e tolgano forma alla gente». Figurare la metamorfosi nel mondo classico ............................................................................11
miChel e. fuChs, Ovide et l’instant de la Metamorphose: un modele pictural pour l’empire ... 29
gianluigi balDo, Non aliter vidi. Visività del codice epico ovidiano ......................................43
ClauDia Cieri via, niColette manDarano, Liceat adspicere: guardare con gli occhi, guardare con la mente. Riflessioni sul libro terzo delle Metamorfosi di Ovidio ..................53
mauro meniChetti, Magica arma (Ov. met. 5 197). Il volto e il riflesso di Medusa tra letteratura e arti figurative in Grecia ......................................................................................65
gian luCa grassigli, Magica arma (Ov. met. 5 197). Il volto e il riflesso di Medusa tra letteratura e arti figurative a Roma .........................................................................................73
emilio pianezzola, Io, figlia di Inaco: metamorfosi e retrometamorfosi .................................85
franCesCa gheDini, Io, Argo, Ermes e la zampogna .................................................................93
moniCa salvaDori, Penteo, vittima dilaniata ...........................................................................111
sabina toso, Pignora da generis: Fetonte e il carro del padre .................................................121
moniCa baggio, Il ratto di Proserpina nelle Metamorfosi di Ovidio: tra racconto e immagini ..................................................................................................................................135
giulia salvo, Meleagro e la caccia Calidonia: echi ovidiani nel repertorio iconografico ......149
giulia salvo, La resurrezione di Ippolito da parte di Esculapio su un medaglione ad applique gallo-romano ............................................................................................................161
marianna Colusso, La fanciulla e la cerva. Il mito di Ifigenia in Ovidio ............................167
leonarDo sebastiani, Prometeo, metafora dell’artista creatore .............................................175
eliana mugione, Il mito di Atteone. Una riconsiderazione ...................................................183
gemma sena Chiesa, La tela di Aracne (Ovidio Metamorfosi 6, 1-145)................................195
maria elisa miCheli, La sfida al telaio (Met. 6, 1-145)...........................................................211
tiziana D’angelo, Mirroring Eyes: Narcissus and the others in Pompeian wall paintings ....223
matteo CaDario, L’immagine di Ermafrodito tra letteratura e iconografia .........................235
viviana trafiCante, Neque sine numine vincis: le nozze di Thetis .......................................247
Chiara torre, Percorsi topografici intorno a un topos epico: gli inferi ovidiani ...................253
roberto niColai, Orfeo da Virgilio a Tiziano: dalle arti figurative al testo e ritorno .........265
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
6 sommario
marCello barbanera, Daedalus invidit (Ov. met. 8, 236-259). Dedalo, la pernice e il topos dell’artista assassino ...................................................................................................................... 279
TESTI OVIDIANI NELLA PRODUZIONE FIGURATIVA POST-CLASSICA
irene favaretto, Ercole a San Marco: metamorfosi di un mito ..............................................295
laura pasquini, Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio (Inf. XXV, 97): le metamorfosi dantesche tra fonte letteraria e tradizione figurativa............................................................307
marCella De paoli, ...Vicinaque sidera fecit (Met. 2, 507). La stanza di Callisto a Palazzo Grimani, Venezia ....................................................................................................................319
giulio boDon, Metamorfosi in villa: immagini di continuità e rinascita dell’antico. Osservazioni sul caso di Villa Godi a Lonedo .......................................................................331
moniCa Centanni, A pedibus tracto velamine: il satiro e la ninfa addormentata. Un mitologema in versione ovidiana nel Festino degli dei di Bellini e Tiziano ........................345
alessanDra pattanaro, L’“Ovidio metamorfose” di Ippolito II d’Este e la fortuna delle “transfiguraccione” alla corte degli Este ................................................................................365
lia Camerlengo, Dosso, Romanino e Ovidio nel palazzo del principe vescovo di Trento ...379
elena smoquina, Le ultime poesie di Tiziano e le Metamorfosi di Ovidio ..........................393
Chiara mataloni, Dario iaColina, Sotto la pelle di Marsia. Una nuova lettura del mito tra arte, scienza e fede .............................................................................................................401
giulia masone, maria D’aDDuogo, Marte, Venere e il gioco degli scacchi. Come l’amore sconfigge la guerra ...................................................................................................................409
giulia borDignon, Rustica numina tra Firenze e Venezia, XV-XVI secolo .........................417
fabrizio magani, “Metamorfosi” venete in età barocca: la sfida di Apollo ed Ercole ..........425
Dario iaColina, Chiara mataloni, niColette manDarano, ICONOS: viaggio interattivo nelle Metamorfosi di Ovidio ...............................................................................433
TRA LETTERATURA E ARTE FIGURATA
giorgio bejor, Fu ferito ad una gamba: tra epos e pittura .....................................................443
antonio stramaglia, Una novella perduta nella Roma di Augusto .....................................451
Daniele manaCorDa, Per una lettura iconografica delle tre Grazie ......................................463
OVIDIO E LE ALTRE MUSE
maurizio harari, Una metamorfosi al ginnasio di Salisburgo. Amadé tra Ovidio e padre Widl ..........................................................................................................................................479
Caterina barone, Orfeo e le Metamorfosi del Novecento tra letteratura cinema e teatro ..493
ruDi De sanDre, Uno, nessuno e centomila Orfeo ...................................................................505
isabella Colpo, giulia salvo, sabina toso, Metamorfosi: la pubblicità cambia forma ....513
franCesCa gheDini, “Il gran poema delle passioni e delle meraviglie”. Spunti di riflessione a margine del convegno ..........................................................................................................521
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti,se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente»
figurare la metamorfosi nel monDo ClassiCo
Isabella Colpo
«“Racconti fandonie, Acheloo, e fai gli dei troppopotenti, se credi che diano e tolgano forma alla gente”.
Allibirono tutti, disapprovando un tale discorso,e Lelege, maturo di mente e di anni, fu il primo
a dire: “Immensa è la potenza del cielo e non ha fine,e tutto ciò che gli dei vogliono, si compie”»
(ov. met. 8, 614-619)
Sassi, fiumi, alberi, fiori, divinità, mostri, animali; animali che saltano, animali che striscia-no, alcuni volano, altri nuotano. Ovidio narra, nel suo poema, ben 129 metamorfosi, descriven-do nel dettaglio il progressivo mutare delle forme: piedi che pietrificano, unghie che diventano radici, braccia che si coprono di fronde, occhi che si chiudono coperti dalla corteccia, i capelli cadono, il pelo e le piume ricoprono l’intero busto, la voce si fa incapace di parlare, il corpo in-tero si scioglie, ma il pensiero rimane. Giocando con i numeri (tab. 1), ma escludendo i camuf-famenti degli dei quando si recano da mortali, sono 49 le trasformazioni in animali, oltre alle narrazioni dei prodigi di Circe; 17 in vegetali (alberi o fiori), cui si aggiunge il gelso che cambia colore alla morte dei due amanti; 19 in “minerali” (intendendo con questo pietre, sassi, ma an-che statue); 2 donne si dissolvono in aria; 4 cambi di genere, da donna a uomo o viceversa; una la statua che prende vita; 4 le nuove stirpi di uomini che sono generati dalla terra o da pietre; 5 personaggi diventano nuovi dei, e tra questi le navi di Enea; una casa diventa un tempio; 3 sono gli esseri mostruosi originati dalle trasformazioni, 6 le fonti o stagni; 6 anche gli esseri, divini o mortali, capaci di prendere le forme più diverse; 4 i catasterismi e 3 le apoteosi. A questi vanno aggiunti inoltre il ringiovanimento di Esone, la Sibilla “condannata” a vita eterna ma ad eterna vecchiaia sino a dissolversi anche lei in pura voce, gli oggetti trasformati in oro da Mida e le sue orecchie d’asino, e per finire i sassolini che mutano colore al momento del giudizio di Miscelo.
Le modalità della trasformazione narrata sono state già oggetto di ricorrenti studi che della me-tamorfosi hanno indagato valenze letterarie e simbolismo filosofico, come ad esempio i bei lavori di E. Pianezzola1 e G. Tronchet (1998), o, da ultimi, il saggio di Ch. Segal in apertura del primo volume della recente edizione Valla del poema ovidiano, a cura di A. Barchiesi2 e il lavoro di H. Vial (2010).
1 pianezzola 1979 [1999]; ma v. anche pianezzola in questa sede. Devo l’idea di questa ricerca ad una matti-na di lavoro con Maria Grazia Ciani; a lei, al suo raffinato insegnamento e alla sua profonda sensibilità umana, mi è caro dedicare queste pagine.
2 segal 2005. Si useranno qui le traduzioni dell’edizione Valla per i libri già pubblicati: 1-2 (L. Koch, vol. I, 2005), 3-4 (L. Koch, Vol. II, 2007), 5-6 (G. Chiarini, vol III, 2009), 7-9 (G. Chiarini, vol IV, 2011). Per i libri 10-15 si seguirà invece la traduzione a cura di P. Bernardini Marzolla.
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
12 isabella Colpo
Ma cosa succede nel momento in cui dal testo del poeta di Sulmona ci si rivolga invece al mondo delle immagini? Per studiare la metamorfosi nel repertorio figurato – un lavoro ampio, di cui si propongono qui le prime riflessioni – è necessario riconsiderarlo nella sua totalità, a partire cioè dal mondo greco arcaico sino alle più tarde attestazioni romane. Eppure, nonostante l’ampio arco cronologico che si va ad esaminare, nel mettere in sistema le immagini relative a tutti i miti di metamorfosi trattati da Ovidio colpisce come, se si escludono quei monstra che sono parte fonda-mentale del repertorio figurativo di tutti i tempi3, nonché tutti quei personaggi che prendono, nel-la nuova forma, sembianze troppo generiche e comuni4, di fatto immagini del cambiamento non
3 Medusa, che sconta la pena per essere stata violentata da Plutone in un tempio di Minerva (ov. met. 4, 793-803; v. grassigli e meniChetti in questa sede), Scilla punita da una gelosa Circe (ov. met. 14, 59-67) e le Sirene, compagne di Proserpina al tempo del suo rapimento (ov. met. V, 551-563).
4 Donne sciolte in fonti (Aretusa, Ciane), che entrano nel repertorio – prevalentemente monetale e con precisa coerenza topografica – come generiche personificazioni; i mortali fattisi divinità, che assumono ricorrenti fattezze di esseri marini con busto umano e coda di pesce (Glauco, Ino); Ippolito stesso, che una volta divenuto Virbio di fatto è un uomo (LIMC II, s.v. Artemis/Diana, n. 51).
tipo soggetti totale
Animali Acmone e i greci; Alcione e Ceice; Antigone; Aracne; Ardea; Ascàlabo; Ascàlafo; Atteone; Botro; Cadmo e Armonia; Callisto; Ceneo; Cerasti; Cercopi; Cicno (con le Eliadi); Cicno; Cigno; Combe; i contadini di Licia; Cornacchia; Dedalione; Derceti; le donne tebane; Ecuba; Esaco; i figli del re dei Molossi; le figlie di Anio; il figlio di Cefiso; Galantide; Gerana; i giovani; Io; Ippomene e Atalanta; Licaone; Linco; i marinai; Memnone; Menefrone; Minieidi; Niso; Ociroe; Perdice; Perseo (dal sangue di Medusa); Pico; Pieridi; Procne, Filomela, Tereo; Scilla (figlia di Niso); Semiramide; Meleagridi
49
Vegetali Adone; Aiace; Atti; Baccanti; Ciparisso; Clizia; Croco e Smilace; Dafne; Driope; Eliadi; Filemone e Bauci; Giacinto; Leucotoe; Mirra; Narciso; il pastore dell’Apulia; Siringa
17
Minerali Aglauro; Anassarete; Atlante; Batto; Celmi; Dafni; Deucalione e Pirra; le donne tebane; le figlie di Cinira; i guerrieri di Fineo contro Perseo; il lupo; Lica; la nave di Alcinoo; Niobe; Oleno e Letèa; Perimele; Prope-tidi; Rodope ed Emo; il serpente
19
Aria Canente, Eco 2Cambi di genere Ceni/Ceneo; Ermafrodito; Ifi; Sitone 4Statua Pigmaglione 1Uomini nuovi Cadmo; Deucalione e Pirra; le figlie di Orione; Mirmidoni 4Nuovi dei Aci; Glauco; Ino e il figlio; Ippolito; le navi di Enea 5Casa in tempio Filemone e Bauci 1Esseri mostruosi Medusa; Scilla; le Sirene 3Fonti o stagni Aretusa; Biblide; Ciane; Egeria; Irie; Marsia 6Esseri proteiformi Acheloo; le figlie di Anio; Mestra; Periclimeno; Proteo; Teti 6Catasterismi Callisto e Arcade; la corona di Arianna; Cesare; Erigone 4Apoteosi Enea; Ersilia; Romolo 3Altro Esone; Sibilla; Mida; i sassolini di Miscelo 4
Tab. 1: Le metamorfosi narrate nel testo ovidiano.
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 13
sono così frequenti; per meglio precisare, pur ricorrendo in gran numero i miti che prevedono la metamorfosi del protagonista al termine della vicenda, la scelta del momento da mettere in scena è assolutamente difforme e in pochi casi ad essere raffigurato è l’essere nella sua nuova forma.
i tipi Della metamorfosi figurata
Un primo livello di classificazione considera quindi cosa viene rappresentato: riprenden-do le categorie nelle quali sono state distinte le metamorfosi descritte da Ovidio (tab. 2), i tipi di trasformazione attestati in immagine sono in animale (13), vegetale (5), minerale (2), aria (1), acqua (1) e la nascita di una nuova stirpe di uomini (1).
i modi Della metamorfosi figurata
Passiamo al come: quali sono i modi figurativi cui ricorrono gli artigiani per la resa del cam-biamento? Nella traduzione in immagine dei corpi che mutano, l’immediata comprensibilità della raffigurazione è ottenuta mediante il ricorso ad una pluralità di soluzioni figurative che andremo qui a esaminare considerandone il progressivo coinvolgimento della figura del perso-naggio, da quelle più “esterne” a quelle che ne interessano l’aspetto e finanche lo schema, per chiudere con la presenza nella stessa immagine di entrambe le figure, quella umana e quella tra-sformata. Proviamo a rivederli, seguendo per ognuno di essi le presenze nel corso del tempo.
1. inserimento nel Contesto Di un partiColare Che rimanDa alla nuova forma
Il modo più semplice, che non prevede alcun intervento sulla figura del protagonista, con-siste nell’inserire, all’interno della composizione figurata, un elemento che rimanda alla meta-morfosi del soggetto dell’episodio.
Le più antiche attestazioni di questo modo di figurare sono nella Lesche degli Cnidi, nel-la quale Callisto nell’aldilà era seduta su una pelle d’orsa che doveva ricordarne la metamorfosi5, particolare che ritorna in un cratere da Ruvo, più tardo di circa un secolo6 (fig. 1); e sempre nella
5 paus. 10, 28, 1-31. Sul mito di Callisto in Ovidio, cfr. Colpo 2011a; per un esempio di stretta tangenza tra immagini del mito e testo ovidiano, seppur in altro contesto storico-artistico, v. qui De paoli.
6 Cratere a calice a Cremona (LIMC V, s.v. Arkas, n. 2; frontisi-DuCroux 2003, p. 154).
tipo soggetti
Animale Aracne; Atteone; Callisto; Cicno; Circe; Gerana; Ifigenia; Io; Meleagridi; Memnoidi; Mida; i pirati; Procne, Filomela e Tereo
Vegetale Atti, Dafne, Eliadi, Mirra, Syrinx
Minerale Niobe, Polidecte
Aria Eco
Uomini nuovi Deucalione e Pirra
Acqua Ciane
Tab. 2: Le metamorfosi attestate nel repertorio figurato.
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
14 isabella Colpo
Lesche Memnone doveva essere rappresentato abbigliato con un mantello decorato da uccelli, a ricordo dei due stormi che presero forma dal-le ceneri levatesi dalla sua pira, destinati a rin-contrarsi e scontrarsi una volta all’anno, in oc-casione dell’anniversario della morte dell’eroe7. Memnonidi che forse sono riconoscibili già in un cratere da Berna databile al primo venticin-quennio del VI secolo a.C., negli uccelli che accompagnano Achille e Memnone, preludio dell’esito fatale dello scontro8.
Alla metà del V secolo a.C. si colloca un cratere attico con l’immagine del momento del-la pietrificazione di Polidecte da parte di Perseo, che brandisce la testa di Medusa9: in luogo dell’u-suale trono su cui abitualmente siede il re nelle altre occorrenze del soggetto10, compare qui una roccia, ad alludere all’imminente trasformazione.
Il medesimo tipo è nelle immagini del sa-crificio di Ifigenia11, laddove, in un esempio va-scolare attico, la cerva destinata a sostituire la giovane è recata in mano da Artemide presente al momento del sacrificio12, modalità che ritor-nerà anche nel celebre quadro dalla Casa pom-peiana del Poeta tragico13.
Il ricorso all’inserimento di particolari nel contesto che rimandano alla nuova forma vie-
ne ampiamente utilizzato dal repertorio romano di età imperiale14: sono gli alberi che popolano il paesaggio nel quale si svolge la vicenda di Apollo e Dafne negli affreschi da area vesuviana15, come il pino che sovente è associato ad Atti, allusione alla sua prossima trasformazione16; an-cora, nelle rappresentazioni su sarcofago del mito di Fetonte, la futura trasformazione delle tre Eliadi che piangono la morte del fratello è allusa dall’albero posto tra di esse17 (fig. 2).
7 ov. met. 13, 600 ss. Sul personaggio nella Lesche, cfr. paus. 10, 31, 5-6 (LIMC, s.v. Memnonides, n. 1).8 A meno di non interpretarli come motivo riempitivo; cfr. LIMC VI, s.v. Memnon, n. 30 e s.v. Memnonides, n. 2.9 LIMC VII, s.v. Polydectes, n. 7; frontisi-DuCroux 2003, p. 202.10 LIMC VII, s.v. Polydectes, pp. 427-428. ov. met. V, 248-249.11 Sul soggetto in Ovidio, v. Colusso in questa sede, con bibliografia precedente.12 Oinochoe attica a Kiel, datata al 430-420 a.C. (LIMC V, s.v. Iphigeneia, n. 1).13 tomei 2010, pp. 81-82. 14 In questo senso G. L. Grassigli interpreta la scarpa femminile presente in un sarcofago del Museo Nazionale
Romano con mito di Achille a Sciro, proprio come “segno chiaro della metamorfosi che si sta per concludere”, ossia non preludio del nuovo stato, bensì richiamo, testimonianza, di quello di fanciulla appena abbandonato dall’eroe. Cfr. grassigli 2007, pp. 230-231.
15 ov. met. 1, 548-556. I quadri dalle case pompeiane del Camillo, di Meleagro, della Venere in Conchiglia, e dalla Villa di Arianna a Stabia con la dichiarazione di Apollo a Dafne e la cattura finale della giovane; cfr. gheDini 2008, passim.
16 ov. met. 10, 103-105: «…e il pino dall’ispido capo, con la chioma tirata su, il pino caro a Cibele, la madre degli dei, se è vero che Atti per lei si spogliò della sua figura di uomo indurendo in quel tronco». Ben evidente nell’af-fresco dalla Casa di Pinarius Cerialis (cfr. LIMC III, s.v. Attis, n. 435), è diffuso anche nel rilievo di età imperiale e ritorna in un contorniato (ibidem, n. 100).
17 ov. met. 2, 346-366. Cfr. ad esempio LIMC VII, s.v. Eridanos I, n. 3 e s.v. Phaeton I, nn. 16, 18 per gli esem-pi più chiari. Sul mito di Fetonte, v. qui toso.
Fig. 1 – Cremona, Musei Civici. Cratere a calice da Ruvo con Callisto seduta su una pelle d’orsa (LIMC V, s.v. Arkas, n. 2).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 15
Non solo vegetali, ma anche oggetti che con quei vegetali vengono fabbricati: l’attenta let-tura del mito di Syrinx, condotta da Francesca Ghedini, ha portato a riconoscere il mito in un paio di quadri dalla Casa pompeiana di Adone ferito, sulla base della presenza in essi di una si-ringa ben visibile nei pressi dei protagonisti18.
2. raffigurazione Di un partiColare Del nuovo stato
La modalità che gode di maggiore fortuna iconografica in assoluto è quella dell’inserimento di un particolare del nuovo stato sulla fisionomia del protagonista della vicenda, che lo connota forte-mente veicolandone il riconoscimento; segni esteriori del cambiamento che compaiono nel reper-torio figurato solo con gli inizi del V secolo a.C. Così, nel repertorio di Atteone – che tra fine del VI secolo a.C. e inizi del V è rappresentato privo di elementi connotanti la trasformazione, come un uomo assalito dai cani in presenza di Artemide, nella doppia versione di vinto o combattente19 –, il cacciatore viene in un primo tempo vestito di una pelle di cervo, legata alle spalle e talora porta-ta anche sul capo, ovvero indossata come una tunica20, forse in dipendenza da un passo di Stesicoro che descrive Artemide che lo copre, appunto, di una pelle di cervo21; è solo con la metà del V secolo a.C., invece, che nelle stesse immagini con la muta di cani all’assalto, Atteone appare connotato dal-le corna di cervo – in un primo tempo associate anche ad orecchie animali22 – che caratterizzeranno l’immaginario del personaggio senza soluzione di continuità fino a tutta l’età romana23.
Peraltro, la medesima soluzione della pelle animale sulle spalle del personaggio ad indicar-ne il nuovo stato, già vista per Atteone, è adottata dal repertorio italiota anche per i giovani che incorrono nella magia di Circe24.
18 gheDini 2011. Cfr. ov. met. 1, 705-706.19 ov. met. 3, 193-203. Sul mito, cfr. leaCh 1981; LIMC I, s.v. Aktaion, pp. 454-469; narDelli 2000; fronti-
si-DuCroux 2003, pp. 97-143; Colpo 2010, pp. 91-102. V. anche, in questa sede, il contributo di e. mugione.20 Cfr. LIMC s.v. Aktaion, sezione C; mugione 2000, p. 192, n. 541.21 Così in paus. 9, 2, 3.22 V. ad es. mugione 2000, p. 192, nn. 542 (solo orecchie), 544 e 547 (orecchie e corna).23 È di Polluce la notizia dell’esistenza di una maschera teatrale raffigurante un Atteone kerasphoros (IV, 141).24 Cfr. mugione 2000, p. 208, nn. 756, 757, 759.
Fig. 2 – Roma, Villa Borghese. Sarcofago con la caduta di Fetonte: a sinistra le tre Eliadi che piangono la morte del fratello; al centro Cicno trasformato in cigno (LIMC VII, s.v. Phaeton I, n. 18).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
16 isabella Colpo
E nella stessa produzione vasco-lare di V-IV secolo a.C. un altro per-sonaggio del mito inizia ad essere con-notato da corna sulla fronte e talora orecchie bovine, ossia quella Io ama-ta da Zeus/Giove e da lui trasformata in giovenca per difenderla dalla gelo-sia della moglie25; anche in questo caso, le orecchie animali scompariranno con questa produzione26, e a partire dall’età ellenistica e in tutta la produzione ro-mana permarranno solo le due piccole corna ad ornare la fronte della giovane.
È solo a partire dalla fine del I seco-lo a.C. che questo modo trova attestazio-ne anche nella resa delle metamorfosi ve-getali: le Eliadi in una matrice di coppa
aretina, dalle cui spalle si levano rami27, e Dafne, che nelle immagini della fuga e del raggiungimento da parte di Apollo reca fronde che spuntano da braccia, spalle e testa, particolare che è ampiamen-te utilizzato negli affreschi di IV stile da area vesuviana, con meno successo nel più tardo mosaico28.
3. trasformazione parziale Del soggetto
Testa animale su corpo umano ovvero testa umana su corpo di animale: la trasformazione parziale del soggetto nella nuova natura ha le sue prime occorrenze nelle immagini di VI-V secolo a.C. del mito di Circe, con la maga affiancata dagli uomini di Ulisse (presente o meno nella scena) già trasformati29; e alla fine del VI secolo si colloca anche un’hydria etrusca da Toledo nella qua-le i pirati che ingannano Dioniso giovinetto sono rappresentati come delfini con le gambe umane, ovvero con busto d’uomo e coda pisciforme, che si gettano nel mare30 (fig. 3), modalità che ritor-nerà in un rilievo funerario da ambito tarantino nella seconda metà del IV secolo a.C.31, nonché nel secondo quarto del III secolo d.C., in un mosaico romano da Thugga, nelle figure dei pirati – la parte inferiore del corpo mutata in pesce – che affiancano la nave di Dioniso32.
25 ov. met. 1, 610-611; 738-746. Yalouris 1986, nn. 14-15, 17, 19, 21-24. Sul mito in generale e sulle soluzio-ni figurative adottate per rendere la metamorfosi della giovane, cfr. Yalouris 1986; LimC v, s.v. Io; gheDini 1986; gheDini e pianezzola in questa sede.
26 Yalouris 1986, nn. 14, 22.27 LIMC VII, s.v. Phaeton I, n. 24.28 Nell’affresco (quadri dalle case di Apollo e Coronide, dell’Efebo, dei Capitello colorati, e dalla Villa di San
Marco a Stabia; gheDini 2008, passim), nel mosaico (da Thysdrus e Theveste; gheDini, Colpo, salvo 2011, pp. 627-628 e nota 52), nelle arti minori (LIMC III, s.v. Daphne, n. 38).
29 Cfr. ov. met. 14, 279-284; 302-305; 406-415. Nella quasi totalità delle ricorrenze si tratta di uomini con la testa animale, mentre assai meno attestato è il caso di corpi animali con testa umana: si veda ad esempio un’anfora cal-cidese da Vulci, del 530 a.C. circa, nella quale Ulisse e Circe si fronteggiano al centro, mentre alle loro spalle ci sono due figure ibride nelle due soluzioni differenti; peraltro, quella con testa umana su corpo animale è rappresentata stante sulle zampe posteriori. LIMC VI, s.v. Kirke, Circe, pp. 48-60; frontisi-DuCroux 2003, pp. 61-76.
30 Cfr. ov. met. 3, 662-686. frontisi-DuCroux 2003, p. 83. 31 Cfr. romizzi 2002, p. 54 con bibliografia.32 Casa di Dioniso e Ulisse, corte 2; cfr. romizzi 2002, pp. 53-56; novello 2007, p. 253. Parzialmente trasforma-
to è anche un pirata in una pelike dalla Tunisia, IV secolo d.C. (romizzi 2002, p. 54). Anche Filostrato Maggiore (im. I, 19) descrive i pirati in parte trasformati in delfini nel quadro con Dioniso. V. anche salvaDori in questa sede.
Fig. 3 – Toledo, hydria etrusca con i pirati tirreni trasformati in delfini (frontisi-DuCroux 2003, p. 85, fig. 20).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 17
Rare, quando non singole, sono poi le occorrenze di questa soluzione in associazione ai miti di Io, per la quale è noto un solo caso di ambito lucano33 (fig. 4), e di Atteone34.
La trasformazione talora interessa non tutto il capo, ma solo alcuni dettagli significativi della figura: le orecchie e le mani di Callisto35 e le orecchie di cervo di Atteone36 in alcuni esemplari ita-lioti della prima metà del IV secolo a.C. (fig. 5); le orecchie, questa volta d’asino, che caratterizza-no Mida in talune immagini vascolari attiche e in due produzioni monetali focesi del V-IV secolo a.C.37, orecchie che pure caratterizzano il re nel quadro descritto da Filostrato Maggiore (im. I, 22).
A una parziale trasformazione del corpo nella nuova forma ricorre il repertorio vascolare apulo per la messinscena dei miti di Polidecte – il re stante davanti a Perseo, con la parte infe-riore delle gambe ormai racchiusa nella roccia38 – e di Niobe, così fiera della propria progenie da peccare di hybris nei confronti di Latona39: collocata all’interno di un naiskos, forse allusivo alla tomba dei figli, Niobe è fatta di pietra, come indica la sovraddipintura bianca che le ricopre i piedi, ovvero tutta la parte inferiore del corpo, a partire dai fianchi, quando questa non venga del tutto sostituita da una roccia40.
Sin qui animali e pietre; ma anche nella resa delle metamorfosi in pianta si assiste alla parzia-le vegetalizzazione del protagonista: il modello della Dafne Borghese, copia forse augustea di un originale ellenistico, con le gambe già chiuse nella rigidità del tronco e avvolte da fronde (fig. 6), è all’origine di una serie di traduzioni del mito tra II e IV secolo d.C.41. Come già a suo tempo aveva
33 Oinochoe lucana, 440-430 a.C; cfr. Yalouris 1986, n. 13; LIMC V, s.v. Io I, n. 33.34 Cfr. LIMC s.v. Aktaion, sezione E. In particolare, si tratta di un rilievo di terracotta da Locri del II quarto del V
secolo a.C. (frontisi-DuCroux 2003, p. 110-112); un frammento di vaso a rilievo da Agrigento; un mosaico dalla pom-peiana Casa VI Ins. Occ., 19-26, del quale resta solo una riproduzione dell’epoca della scoperta (Colpo 2010, p. 97).
35 LIMC V, s.v. Kallisto, nn. 5, 7 e LIMC II, s.v. Arkas, n. 1; mugione 2000, p. 211, nn. 803-805.36 V. ad es. mugione 2000, p. 192, nn. 543, 544, 547.37 ov. met. 11, 174-179. LIMC VIII, s.v. Midas, nn. 1, 38-40.38 Neck-anfora campana, 440-420 a.C. (LIMC VII, s.v. Polydectes, n. 8). 39 ov. met. 6, 301-312. Sul mito, LIMC VI, s.v. Niobe, pp. 908-915; frontisi-DuCroux 2003, pp. 192-202; salvo 2009.40 Cfr. salvo 2009, pp. 101-102 con bibliografia precedente.41 Mosaici da Marino, dalla Casa di Dioniso di Cipro, da Torre de Palma, da Piazza Armerina e dalla Casa del
A sinistraFig. 4 – Boston, Museum of Fine Arts. Oinochoe lucana con Io dalla testa umana su corpo di giovenca (LIMC V, s.v. Io I, n. 33).
SopraFig. 5 – Collezione privata. Frammento di cratere con Cal-listo, mani e orecchie da orsa
(LIMC II, s.v. Arkas, n. 1).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
18 isabella Colpo
giustamente osservato il Müller42, e come ripreso in tempi più recenti da Maurizio Harari in un articolo sulle Donne fogliu-te, donne fiorite, accanto alla completa trasformazione delle gambe in tronco, la vegetalizzazione della giovane è resa an-che con una seconda soluzione figurativa, ossia con Dafne che quasi “esce” da un cespo di fronde che l’avvolgono: è, questa seconda soluzione, quella che sembra godere di più duratura fortuna, con attestazioni che arrivano sino al VI secolo d.C.43.
Si tratta di una metamorfosi che Filostrato Maggiore de-scrive nel dettaglio per le Eliadi, al momento della morte di Fetonte, in un passo che pare contraddirsi per lasciare spazio alla suggestione delle immagini, giacché, dice il retore, le don-ne «non sono divenute alberi», ma il «dipinto conosce i fat-ti: gettate infatti le radici alle estermità, sono già alberi fino all’ombelico e ramoscelli arrivano fino alle mani» (philostr. im. I, 11). E non a caso, nella scultura funeraria una delle so-relle presenta le gambe totalmente mutate in tronco (fig. 2). E ancora, la soluzione della donna che si fa albero è in una produzione monetale licia dell’epoca di Gordiano con Mirra: l’intera parte inferiore del corpo della donna è sostituita da un tronco da cui si levano due ampi rami, mentre il padre Cini-ra furioso, scoperto l’inganno della figlia perdutamente inna-morata di lui, sta cercando di colpirla con l’ascia44.
Merita infine qui richiamare anche l’immagine del ratto di Proserpina su sarcofago dai Vaticani e da Palazzo Giusti-niani: nel busto di donna che compare sotto le zampe del ca-vallo di Plutone si può forse riconoscere Ciane, con la parte inferiore del corpo ormai trasformata in fonte45.
4. trasformazione totale Del soggetto
Quella della totale trasformazione del soggetto non è una modalità frequente nel reperto-rio figurato: Io in forma di giovenca compare tra VI e V secolo a.C.46, quando è attestata anche la versione della giovane in forma di toro47, e così era raffigurata, stando alle parole di Pausania (III, 18, 12) sul trono di Amicle48; la forma zoomorfa della fanciulla si ritroverà poi, a distanza di secoli, nella glittica di età imperiale49.
Menandro ad Antiochia (gheDini, Colpo, salvo 2011, pp. 628-631). M. Harari (2007, p. 38) cita a confronto un in-teressante passo dalla Storia vera di Luciano (1, 8).
42 müller 1929. L’A. distingue quattro tipi: il primo ad anatomia femminile completa, con rami che fuoriesco-no da braccia, testa, spalle; il secondo sul modello della Dafne Borghese, con una parziale vegetalizzazione del corpo; nel terzo le gambe sono fatte totalmente di legno e con il quarto Dafne sembra “uscire” dalla pianta che la avvolge.
43 müller 1929; harari 2007, che riprende e discute più dettagliatamente la classificazione del Müller; ghe-Dini, Colpo, salvo 2011, pp. 628-631.
44 LIMC VI, s.v. Myrra, nn. 3a-c.45 ov. met. 5, 425-437: «e prima delle altre si liquefanno le parti più esili: le chiome azzurre, e le dita, le gam-
be, i piedi». Cfr. Zanker, ewalD 2008, p. 91, fig. 73 (Vaticani) e robert 1919 (Palazzo Giustiniani); si veda M. bag-gio in questa sede.
46 Yalouris, 1986, nn. 1-7, 10, 13; LIMC V, s.v. Io I, nn. 1-7, 11-13.47 Yalouris, 1986, n. 8.48 paus. 3, 18, 12.49 toso 2007, p. 132, nota 41.
Fig. 6 – Già a Roma, Villa Borghese. Daf-ne in parziale trasformazione (LIMC III, s.v. Daphne, n. 1).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 19
E nello stesso arco di tempo, i pirati ormai trasfor-mati in delfini sono forse da riconoscere nei sette delfini che affiancano la nave di Dio-niso nella celebre coppa di Exechias50, come in un delfi-no dalla formella centrale del rilievo Lansdowne con tema dionisiaco, e in alcuni esem-pi di età imperiale provenien-ti dal nord-Africa51.
Nel restante repertorio, nella nuova forma sono raf-figurate solo Callisto e Io in un mosaico da Italica con gli amori di Giove52; per Callisto, in particolare, è qui rappresentato, caso unico, il momento in cui Arcade cacciatore sta per col-pire la madre, preludio al catasterismo dei due da parte di Giove53. E Cicno, il fratellastro di Fe-tonte per parte di madre a lui legato da grande affetto, forse riconoscibile nel cigno che compare in numerosi sarcofagi di età imperiale (fig. 2), anche se non sono mancate interpretazioni dello stesso come il fiume Eridano nel quale muore Fetonte, ovvero come il precettore di questi ri-cordato nel Fetonte di Euripide54.
E ancora gli uomini nuovi nati dalle pietre scagliate da Deucalione e Pirra a seguito del dilu-vio universale55: si tratta di un soggetto che nel mondo delle immagini non ha riscontro, se si ec-cettua un rilievo dalla tomba di P. Aelius Maximus, a Ostia, datato alla prima metà del II secolo d.C.56 (fig. 7). In esso, Deucalione e Pirra (soggetti che di per sé non hanno tradizione figurata) sono rappresentati davanti a un altare, in piena rispondenza alla pietas già celebrata da Ovidio, e alle loro spalle una figura stante e una inginocchiata, sotto lo sguardo di Minerva assisa, sono de-finite HOMINES NATI dall’iscrizione che le sovrasta57. Non più pietre, dunque, ma già uomini.
Totalmente vegetalizzata è anche Syrinx in una moneta severiana da Thelpousa, nella quale Pan «mentre… già è convinto di avere acchiappato Siringa, fra le mani si trova, invece del corpo della ninfa, dei giunchi palustri»58. Meno certa è invece la lettura come Dafne del ramo di allo-ro stretto da Apollo in una gemma da Berlino di fine I secolo a.C., interpretazione cui sembra ostare il capo del dio volto in senso opposto all’albero-amata59.
50 LimC iii, s.v. Dionysos, p. 489, n. 788. V. anche la discussione di m. salvaDori in questa sede.51 LIMC III, s.v. Dionysos/Bacchus, nn. 237-238; romizzi 2002, p. 55.52 blanCo freijeiro 1978, pp. 25-26. II metà del II secolo d.C.53 Sul catasterismo di Callisto (ov. met. II, 505-507) e, più in generale, sulle trasformazioni in stelle nelle Me-
tamorfosi, cfr. gheDini, Colpo 2010.54 ov. met. 2, 373-380. Sulla discussa interpretazione di questo cigno, cfr. LIMC VIII, s.v. Kyknos II, pp. 767-
768 e più in generale per le immagini.55 ov. met. 1, 400-415.56 mielsCh 1975, p. 161, K 90; LIMC III, s.v. Deukalion I, pp. 384-385, n. 1; pressoché perduto, il rilievo è
noto solo grazie a un disegno che ne documenta i pochi tratti visibili.57 ov. met. 1, 411-413: «così, per volere celeste, in breve tempo le pietre gettate dal pugno dell’uomo assunsero
aspetto di uomini e rinacque la donna da quelle che ha lanciato la donna».58 ov. met. 1, 705-706; BMC Peloponnesus, p. 204, tav. XXXVII, 23; LIMC VIII, s.v. Pan, p. 931, F; gheDi-
ni 2011, p. 471.59 gheDini 2009, p. 179.
Fig. 7 – Restituzione del rilievo dalla tomba di P. Aelius Maximus, a Ostia, con Deucalione e Pirra al momento della trasformazione dei sassi in Homi-nes nati (LIMC III, s.v. Deukalion I, n. 1).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
20 isabella Colpo
A queste, si può aggiungere un’immagi-ne di discussa lettura dalla pompeiana Casa dei Dioscuri60 (fig. 8): qui, alcune donne as-sistono alla nascita di un bimbo tenuto in braccio da una di esse, al di sopra di un rivo d’acqua, elemento che ne ha suggerito una lettura legata al mito di Achille. La presenza di un albero in secondo piano ha fatto tutta-via ipotizzare che possa trattarsi della nascita di Adone dalla madre Mirra, ormai del tutto tramutata in pianta, una pianta che «sembra avere le doglie», nella quale alla fine, grazie all’intervento di Lucina pietosa, «compaio-no delle crepe, e dalla corteccia squarciata l’albero dà alla luce un essere vivo»61. E al medesimo soggetto è convincentemente da riferirsi un quadro dalle Terme di Tito, nel quale Venere e Proserpina assistono alla na-scita di un bimbo tenuto in braccio da una levatrice, evidentemente Adone appena par-torito dal sottile albero che la dea dell’amo-re stringe con la sinistra62 (fig. 9).
Il caso della geranomachia dei pigmei, per finire, fa mondo a sé: presente icono-graficamente già nella produzione vasco-lare attica, divenuto quindi un motivo di repertorio ricorrente, il soggetto trova
trattazione mitografica solo in alcuni scrittori di epoca imperiale, tra i quali appunto Ovidio, che riconoscono nello scontro tra pigmei e gru l’esito della metamorfosi in uccello della loro re-gina, Gerana, venerata come dea e quindi punita per questo atto d’hybris da Giunone o Diana63.
5. gesti Di metamorfosi
Eco, la ninfa che per la vana passione per Narciso si strugge in sola voce, non ha mai imma-gini certe e iconograficamente definite: difficile e forse forzato volerla riconoscere nella figura femminile che in alcuni quadri pompeiani affianca Narciso intento a specchiarsi, la cui generi-cità lascia spazio a una interpretazione come Ninfa, fonte o Osservatore. Ma in una ricorrenza dal triclinio (49) della Casa dei Dioscuri (fig. 10), la fanciulla adagiata sulle rocce che sovrasta-no il giovane compie un gesto cui sembra potersi riconoscere una forte valenza semantica, ossia con l’indice della mano destra accenna alle proprie labbra, rimandando al campo della parola e della voce, nel quale appunto si svolge la vicenda di Eco64.
60 LIMC I, s.v. Adonis, n. 3; LIMC VI, s.v. Myrra, n. 4; PPM IV, p. 918, fig. 108.61 ov. met. 10, 508, 512-513.62 LIMC VI, s.v. Myrra, n. 5; cfr. anche LIMC I, s.v. Adonis, n. 2a.63 LIMC VII, s.v. Pygmaioi; Le fonti che ne trattano sono ael. nat. XV, 29; athen. IX, 393e-f; ant. lib. met.
16; ov. met. VI, 90-92: «… il commovente destino della madre pigmea: Giunone la sconfisse e la condannò a diven-tare una gru e a portare guerra al suo popolo» per riavere il proprio figlio Mopso.
64 Non è un caso che in questo quadro anche il campo del visivo, caratteristico invece di Narciso, sia partico-larmente enfatizzato, dal momento che in luogo della solita fonte d’acqua è un bacile nel quale un erote sta versando acqua da un’hydria, con un preciso riferimento all’amore nefasto del giovane per se stesso.
Fig. 8 – Pompei, VI 9, 6.7 Casa dei Dioscuri, oecus (43). Quadro con nascita di Adone da Mirra trasformata in albe-ro (PPM IV, p. 918, fig. 108).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 21
Gesto di metamorfosi, dunque, questo di Eco. Altri gesti merita tuttavia qui segna-lare, che se pure non esclusivi e portatori tal-volta di significati ben codificati dalla tradi-zione figurata, assumono valenza nuova, in qualche modo ambigua, quando ricorrono associati a miti di cambiamento.
Ristudiando il piatto d’argento dorato rinvenuto ad Aquileia e conservato a Vienna (fig. 11), F. Ghedini65 ha per prima posto la dovuta attenzione sulla figura femminile che ne occupa la parte inferiore, riconoscendola come Io in virtù della presenza della gioven-ca accovacciata accanto ma soprattutto attri-buendo grande valenza semantica al gesto da ella compiuto, ossia lo scostare il manto che av-volge le gambe; gesto che, nell’iconografia del personaggio, ricorre anche in una serie di raf-figurazioni della prigionia di Io presso Argo66.
Questo stesso gesto di svelamento, che nel linguaggio delle immagini è tradizional-mente indice di seduzione, è forse qui allusi-vo anche allo “spogliarsi dalle fattezze uma-ne per assumere nuova forma”67.
Il gesto è stato identificato sempre da F. Ghedini anche in un affresco dalla Casa di Holconius Rufus, nel quale Dafne, ormai rag-giunta da Apollo, è rappresentata inginoc-chiata a terra, mentre un erote scosta con en-trambe le mani un lembo del suo manto che si apre in ampia velificatio alle sue spalle68; e identica valenza sembra da attribuire anche all’atto compiuto, questa volta, dal dio in persona in un quadro dalla Casa dei Capitelli colorati. A questi si possono aggiungere altre tre attestazioni (case del Camillo, di Melea-gro e dell’Efebo), riferibili invece al momen-to del corteggiamento di Apollo, nelle quali è la stessa Dafne a scostare il manto, gesto qui indubbiamente ambiguo: partendo dal pre-supposto che nella creazione di queste im-
65 gheDini 1986, in particolare pp. 32-33 per l’analisi iconografica del personaggio.66 Una coppa in oro tarantina, un cammeo da Leningrado e i quadri vesuviani dalle Case del Citarista e di Me-
leagro, IX 9, d, dal Macellum e dal Tempio di Iside; cfr. gheDini 1986 e eaD. in questa sede. 67 Sul gesto dell’anakalypsis come simbolo dell’anima che si spoglia del “chitone” corporale, in un contesto di
carattere misterico, cfr. harari 1988, pp. 177-178. Ringrazio M. Harari per la cortese segnalazione.68 Da questo modello derivano anche le repliche dalle case di M. Lucretius e dei Dioscuri, nelle quali tuttavia
manca l’erote (rispettivamente, PPM IX, p. 301, fig. 243 e PPM IV, p. 938, fig. 154). Per l’identificazione del gesto, cfr. gheDini 2008, pp. 369-370.
Fig. 9 – Riproduzione di Reinach del quadro con la nasci-ta di Adone da Mirra trasformata in albero da Roma, Ter-me di Tito (LIMC VI, s.v. Myrra, n. 5).
Fig. 10 - Pompei, VI 9, 6.7 Casa dei Dioscuri, triclinio (49). Riproduzione del quadro con Narciso ed Eco (ppm IV, pp. 952-953).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
22 isabella Colpo
magini abbia influito il poema ovidiano, l’unico appunto a narrare questo momento del mito con dovizia di particolari (situazione ovidiana)69, pos-siamo escludere con una certa sicurezza una vo-luta seduzione del dio da parte della fanciulla, che Ovidio descrive come una seguace di Diana, che «aborrisce le fiaccole nuziali come un delitto»70; resta quindi il dubbio che il gesto possa in que-sti casi alludere al potere seduttivo della bellezza di Dafne, o piuttosto, come piace credere, sia pro-dromo della metamorfosi a cui è destinata.
Diverso invece il caso di Narciso, sicuramen-te colto nell’estremo momento della seduzione in quelle immagini con il giovane semireclinato pro-no sulla fonte, sollevato su un braccio, nel quale già si è identificata, attraverso una puntuale lettura del testo delle Metamorfosi, una chiara iconografia ovi-diana: procubuit… humi positus… fusus in herba… paulatim levatus… summa vestem deduxit ab ora71.
A queste è forse possibile aggiungere una quarta metamorfosi per la quale viene adottato il motivo dello svelamento: abbiamo visto che in alcuni sarcofagi di età imperiale che riproducono l’episodio della caduta di Fetonte che per troppa hybris tenta, in maniera fallimentare, di guidare il carro del padre, vengono introdot-te anche le figure piangenti delle Eliadi, sue sorelle; le tre donne presentano an-cora fattezze umane e ad alludere alla prossima metamorfosi è la presenza di cespugli; ma una di loro è sempre rap-presentata con il manto che si apre in una velificatio alle sue spalle, così come nei casi già visti per Dafne72 (fig. 2).
Lasciando ora lo svelamento – se-duzione e metamorfosi –, a più riprese Ovidio descrive i mortali che solleva-no le braccia al cielo impotenti, a sup-plicare gli dei nell’attimo estremo prima della metamorfosi: questo gesto è sug-gestivamente possibile riconoscere eter-nato nell’immagine di Mirra vegetaliz-zata dalla Casa dei Dioscuri (fig. 8) e nei due mosaici con Dafne in parte mutata in albero da Torre de Palma e da Mari-no. Gesto di supplica tutto umano che avvicina donne e alberi in quelle braccia alzate che si trasformano in rami.
69 gheDini 2008, pp. 366-367.70 ov. met. 1, 483.71 Colpo 2006, 2007.72 Cfr. ad esempio, LIMC VII, s.v. Eridanos I, n. 3 e s.v. Phaeton I, nn. 16, 18, ma sono solo alcuni esempi.
Fig. 12 - Pompei, VI 2, 4 Casa di Sallustio, viridarium (32). Ri-produzione del quadro con Diana e Atteone (PPM Disegnatori, p. 94, fig. 31).
Fig. 11 – Vienna, Kunsthistorisches Museum. Piatto d’argento dorato rinvenuto ad Aquileia: nel tratto infe-riore, Io (pirzio biroli stefanelli 1991, p. 185, fig. 179)
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 23
Nella categoria dei gesti delle metamorfosi possiamo annoverare anche i gesti di condan-na degli dei nei confronti dell’hybris dei mortali: così è per quelle attestazioni nelle quali Diana, incautamente osservata al bagno da Atteone, «prese quello che aveva, l’acqua, e buttandola in faccia al volto maschile» lo muta in cervo73, gesto figurativamente reso dal braccio alzato della dea74 (fig. 12); e allo stesso modo nell’unica attestazione nota del mito di Aracne dal fregio del Foro Transitorio, con l’abile tessitrice inginocchiata succube dell’ira di Minerva che incombe su di lei, gesto che, unitamente alla collocazione del mito all’interno della lunga composizione che celebra le arti della dea, ne permette il riconoscimento75.
6. DupliCazione Degli elementi
In alcuni esempi vascolari della prima metà del V secolo a.C., Procne e Filomela sono raf-figurate mentre fuggono l’ira di Tereo (fig. 13); sovrasta il capo dei tre personaggi una figura di volatile, preludio, allusione, immagine della metamorfosi a cui i tre andranno incontro nel cor-so dell’inseguimento76: è questo un esempio di un modo raffinato cui gli artigiani – in pochi casi in realtà – ricorrono per figurare la metamorfosi, ossia la duplicazione degli elementi, l’accosta-mento in una stessa scena della figura umana e di quella mutata. La rappresentazione delle due forme sta a significare figurativamente la doppia natura del protagonista: così per Ifigenia in un cratere apulo dal British Museum, con la fanciulla figurativamente sovrapposta all’animale77 (fig. 14); così per Io, quando accanto alla giovane è accovacciata la giovenca, come nel piatto di Aqui-
73 ov. met. 3, 189-190.74 Si vedano i quadri dalle case vesuviane IX 7, 12, di M. Loreius Tiburtinus, di L. Epidius Sabinus, di Sallustio
e dalla Villa di Gragnano.75 ov. met. 6, 139-145. LIMC II, s.v. Arachne, n. 2. Sul mito, cfr. frontisi-DuCroux 2003, pp. 248-272. In
questa sede, i due interventi di sena Chiesa e miCheli.76 ov. met. 6, 667-674. F. Frontisi-Ducroux (2003, p. 222) cita un’anfora attica a figure nere da Napoli, 500 a.C.
ca (ABV 510, 25), un frammento di hydria a figure rosse a Reggio Calabria, del 470 a.C. (ARV2, 594, 55), e un cratere a colonnette da Siracusa, collezione Pirandello, della medesima epoca. Più in generale, cfr. frontisi-DuCroux 2003, pp. 221-248 sul mito, per il quale cfr. anche LIMC VII, s.v. Prokne et Philomela, che tuttavia non ricorda i tre esemplari.
77 Secondo venticinquennio del IV secolo a.C.; cfr. LIMC V, s.v. Iphigeneia, n. 11; frontisi-DuCroux 2003, pp. 148-150.
Fig. 13 – Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Anfora attica a figure nere con Procne e Filomela mentre fuggono l’ira di Tereo (frontisi-DuCroux 2003, pp. 223, fig. 54).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
24 isabella Colpo
leia (fig. 11) – nel quale peraltro la compresenza dell’animale e del gesto di scostare il manto è stata letta da F. Ghedini come allusione alla doppia metamorfosi della fanciulla, prima in gioven-ca e poi di nuovo in donna – e negli affreschi da area vesuviana con il momento della liberazio-ne da Argo78; ancora, su un lato corto di un sarcofago fiorentino, che presenta le sorelle di Me-leagro che piangono la morte del fratello, mentre dalla tomba uccelli si alzano in volo79 (fig. 15).
forme Che Cambiano
Aggiunta di elementi nel contesto; caratterizzazione dei corpi, zoomorfia, pietrificazione e vegetalizzazione parziali o totali; gestualità specifica; duplicazione delle figure: la semantica della metamorfosi presenta segni che di volta in volta compaiono e scompaiono con alterna for-tuna, per poi magari riapparire a distanza di secoli in un percorso assolutamente non lineare.
Ma qualche riflessione è possibile fare.Se proviamo ad associare i modi della metamorfosi ai soggetti, di fatto otteniamo una ri-
sultato falsato: se pure vediamo infatti che la gran parte dei miti è caratterizzata dall’uso di un unico modo, è doveroso tener presente che in quasi tutti i casi si tratta di occorrenze singole o comunque poco numerose, attestate in archi cronologici e ambiti produttivi ben circoscritti; di contro, quando si considerino i soggetti che hanno più duratura fortuna nel repertorio, quali Io, Dafne e Atteone, ecco che si assiste nel tempo all’uso di molteplici soluzioni figurative.
Allo stesso modo, non è possibile identificare un modo unico di rappresentare il cambia-mento specifico per ogni tipo; non fanno ovviamente testo le metamorfosi in aria (Eco), acqua (Ciane) e uomini nuovi, che annoverano una sola immagine per tipo.
Ancora, non porta ad alcun risultato il tentativo di associare modi e momenti della meta-morfosi (prima, durante, dopo), per verificare se vi siano scelte preferenziali, chiaramente esa-minando in questo caso anche il tema delle immagini.
Qualche dato in più pos-siamo invece ottenere quan-do analizziamo la comparsa e scomparsa di tipi e modi in una prospettiva cronologica.
Se riconsideriamo la pre-senza dei singoli tipi della me-tamorfosi nel corso del tempo, è evidente come mentre la trasfor-mazione in animale è tema ico-nograficamente attestato a par-tire già mondo greco arcaico, e continua la sua fortuna sino ad epoca tarda, la metamorfosi in pietra compare in ambito atti-co alla metà del V secolo a.C.
78 Casa del Citarista, Tempio di Iside.79 ov. met. 8, 542-546. koCh 1975, pp. 121-122, n. 118; LIMC VI, s.v. Meleagros, n. 156; un secondo esempla-
re è oggi perduto. V. anche salvo in questa sede.
Fig. 14 – London, British Museum. Cratere apulo con mito di Ifigenia (LIMC V, s.v. Iphigeneia, n. 11).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 25
(Polidecte) e poi nella produ-zione vascolare apula (Polidecte, Niobe)80, mentre i cambiamenti in albero e la nuova stirpe di uo-mini (nell’unico esempio noto) hanno inizio in età ellenistica (Dafne) e sono caratteristici del mondo romano, specificatamen-te di età primo e medio imperia-le. Fatto quest’ultimo che ben si spiega se si considera la fortuna dei racconti eziologici di origi-ne ellenistica nel primo impero, il cui riflesso sono le narrazioni di mitografi quali, appunto, Ovi-dio ma anche Igino.
Passando invece ai modi della rappresentazione, notiamo co me la grecità arcaica e classica rappre-senti un momento di particolare favore per i miti di metamorfosi, che va a rappresentare ricorrendo a tutte le soluzioni figurative indi-viduate, ad eccezione del gesto: nelle attestazioni più antiche sono la totale o parziale trasforma-zione del soggetto (Io; Circe, i pirati – fig. 3) e la duplicazione (Procne e Filomela – fig. 13), men-tre l’aggiunta di un particolare del nuovo stato – specificatamente corna, orecchie o pelle animali (Atteone e Io) – nonché l’inserimento nel contesto di elementi allusivi alla metamorfosi (Callisto, Memnone, Ifigenia, Polidecte – fig. 1) compaiono solo attorno alla metà del V secolo a.C.
Alcuni soggetti che nascono in ambito classico (Io, Atteone, Callisto, Ifigenia) si ritrovano con le stesse modalità figurative anche nell’ambiente italico, quando si segnala anche l’introdu-zione della metamorfosi di Niobe con la parziale trasformazione in pietra, caso unico che non avrà fortuna nelle epoche successive.
È singolare invece notare come l’epoca ellenistica sostanzialmente non ami particolarmen-te le immagini di metamorfosi, fatti salvi Atteone e Io con le loro corna animali – la cui fortuna nel mondo delle immagini di fatto non viene mai meno – e Dafne, che compare qui per la prima volta in una forma (con le gambe vegetalizzate in una parziale trasformazione) che sarà model-lo importante per la tradizione figurativa imperiale romana (fig. 6).
La grande stagione delle immagini di corpi che cambiano è indubbiamente quella primo e medio-imperiale romana. Nel corso del I secolo si moltiplicano i miti che vengono rappresentati, anche con l’introduzione di soggetti che precedentemente erano del tutto ignoti al repertorio fi-gurativo (Mirra, Aracne, Eco, Syrinx, le Eliadi)81, mediante il ricorso a tutti i modi del rappresenta-
80 Forti dubbi lascia il tentativo di riconoscere la pietrificazione di Atlante da parte di Perseo in alcune rappresen-tazioni: l’anonima figura indicata come Atlante in un’hydria attica con l’uccisione di Medusa è del tutto priva di elemen-ti caratterizzanti che la connotino con chiarezza (LIMC III, s.v. Atlas, n. 20), e parimenti troppo generica pare la roccia collocata nel giardino delle Esperidi in alcune attestazioni vascolari del IV secolo a.C., tanto più se si considera che solo a partire da Diodoro Siculo Atlante è identificato come padre delle Esperidi stesse (LIMC III, s.v. Atlas, nn. 26-28 e p. 14).
81 È il repertorio pittorico di età neroniano-vespasianea, in particolare, il più ricco di “nuovi miti”; tra quelli di metamorfosi, che presentano sempre forti tangenze con il testo ovidiano, vanno ricordati Narciso, Ciparisso, Ado-ne, Piramo e Tisbe, Arianna (cfr. balDassarre 1981; gheDini, Colpo 2007; Colpo 2011b).
Fig. 15 – Firenze, Museo Archeologico. Lato di sarcofago con l’imma-gine delle Meleagridi che piangono la morte del fratello (koCh 1975, tav. 102, n. 118).
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
26 isabella Colpo
re: una netta predilezione è per l’aggiunta di elementi esterni nel contesto (Dafne, Ifigenia, Syrinx, quindi Atti e le Eliadi) o di particolari del nuovo stato (Atteone e Io, Dafne, le Eliadi), e soprattut-to per i gesti di metamorfosi, da quello specifico di Eco che si indica le labbra, a quello di scostare il manto (Io, Dafne, le Eliadi), alle braccia/rami sollevate al cielo (Mirra e Dafne), per finire con i gesti di condanna delle dee; sporadiche occorrenze si hanno per la duplicazione degli elementi (Io, Meleagridi). A partire dal II secolo si assiste anche ad una progressiva fortuna dei modi della tra-sformazione parziale (Dafne, le Eliadi, Mirra, Mida, i pirati e il caso di Ciane) o totale del corpo (Cicno e, con attestazioni uniche, Callisto, Io, gli uomini nuovi, Syrinx), quest’ultimo totalmente dimenticato dopo le occorrenze di Io-giovenca/toro in V secolo a.C.82
Nel sostanziale oblio in cui cade l’immagine della metamorfosi nel tardo impero, l’unica che sembra sopravvivere è Dafne, nelle forme della donna tra i rami; attraverso la mediazione dei codici medievali, tipi e modi della metamorfosi arriveranno quindi all’età rinascimentale e barocca per trovare nuova fortuna in nuove forme delle quali la Dafne del Bernini, simbolo di questo convegno, rappresenta senza dubbio l’esempio più raffinato.
riassunto
Spesse volte, nelle Metamorfosi, Ovidio indugia nel racconto delle membra che cambiano, con pas-si che ancor oggi colpiscono la fantasia del lettore per la forte valenza visiva ed evocativa del narra-re. Ma cosa succede quando dal racconto ovidiano spostiamo l’attenzione al mondo delle immagini? quali sono i miti di metamorfosi che trovano riscontro anche nel repertorio figurato? e come vengo-no figurate le mutatas formas nell’antichità classica, quali le modalità a cui ricorrono gli artigiani per rappresentare il cambiamento? A queste domande si cercherà di dare risposta ripercorrendo le im-magini di metamorfosi tra mondo greco e mondo romano, cercando di individuarne specificità e ve-rificando, in ultima analisi, se sia possibile riconoscere una modalità figurativa tipicamente “ovidia-na”, nell’accezione che a questo termine ha dato il progetto MArS.
abstraCt
In Ovid’s Metamorphoses, the author often lingers on the changing of limbs, with passages which still today strike the reader’s imagination with their visual forcefulness and evocative narration. But what happens when we move our focus from Ovid’s tales to the world of images? What metamor-phic myths are depicted in the figurative field? And how are the mutatas formas represented in clas-sic antiquity, what means do craftsmen use to portray change? We will try to answer these questions, tracing metamorphic images within the Greek and Roman worlds, pointing out specific features and ultimately testing the possibility to recognise a typically “Ovidian” figurative mode, in the sense gi-ven by the MArS project.
82 Si soprassiede qui su Gerana per la particolarità della situazione: come si è visto, le immagini in questo caso precedono di diversi secoli la tradizione mitografica.
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
«fai gli Dei troppo potenti, se CreDi Che Diano e tolgano forma alla gente» 27
bibliografia
balDassarre i. 1981, Piramo e Thisbe: dal mito all’immagine, in L’art décoratif à Rome à la fin de la république et au début du principat, Table Ronde organisée par l’École française de Rome (Rome, 10-11 mai 1979), Rome, pp. 337-351.
barChiesi a. (a cura di) 2005, Ovidio. Metamorfosi, I, Milano.blanCo freijeiro A. 1978, Mosaicos romanos de Italica, (I), in Corpus de mosaicos romanos de
Espana, III, Madrid.Colpo I. 2006, Quod non alter et alter eras. Dinamiche figurative nel repertorio di Narciso in
area vesuviana, in Antenor. Miscellanea di studi di archeologia, 5, Padova, pp. 51-85.Colpo I. 2007, Il mondo degli specchi e delle illusioni: immagini del canto di Narciso, in I. Col-
po, G. L. Grassigli, F. Minotti, Le ragioni di una scelta. Discutendo attorno alle immagini di Narciso a Pompei, in Eidola. International Journal of Classical Art History, 4, pp. 73-79.
Colpo I. 2010, Ruinae... et putres robore trunci. Paesaggi di rovine e rovine nel paesaggio nella pittura romana (I secolo a.C.-I secolo d.C.), Antenor Quaderni 17, Roma.
Colpo i. 2011a, Ninfe violate: il mito di Callisto nelle Metamorfosi di Ovidio, in Tra protosto-ria e storia. Studi in onore di Loredana Capuis, Antenor Quaderni 20, Roma, pp. 473-484.
Colpo i. 2011b, Tutte le Arianne di Ovidio, in Tra testo e immagine. Riflessioni ovidiane, Gior-nata di Studi (Padova, 24 maggio 2010), in Eidola. International Journal of Classical Art History, 8, pp. 65-77.
Frontisi-DuCroux f. 2003, L’homme-cerf et la femme araignée. Figures grecques de la méta-morphose, Paris.
gheDini F. 1986, La figura recumbente del piatto di Aquileia e l’eleusinismo alessandrino, in RdA, X, pp. 31-42.
gheDini f. 2008, Ovidio e la cultura figurativa coeva: Apollo e Dafne, in Tracce dei luoghi. Tracce della storia. L’Editore che inseguiva la Bellezza. Scritti in onore di Franco Cosimo Panini, Modena-Roma, pp. 357-377.
gheDini F. 2009, Temi ovidiani nel repertorio glittico: il ruolo di Eros nel mito di Apollo e Dafne, in Aquileia e la glittica di età ellenistica e romana, Atti del Convegno Il fulgore delle gemme (Aquileia, 19-20 giugno 2008), a cura di G. Sena Chiesa, E. Gagetti, Trieste, pp. 171-182.
gheDini F. 2011, Ninfe braccate: il mito di Syrinx nelle Metamorfosi di Ovidio, in Tra protosto-ria e storia. Studi in onore di Loredana Capuis, Antenor Quaderni 20, Roma, pp. 465-472.
gheDini f., Colpo I. 2007, Schema e schema iconografico: il caso di Ciparisso nel repertorio pompeiano, in Eidola. International Journal of Classical Art History, 4, pp. 49-71.
gheDini f., Colpo I. 2010, Mito e razionalità nel cielo di Ovidio, in Mensura caeli. Territorio, città, architetture, strumenti, Atti dell’VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Archeo-astronomia (SIA) (Ferrara, 17-18 ottobre 2008), a cura di M. Incerti, Ferrara, pp. 280-306.
gheDini f., Colpo i., salvo g. 2011, Echi di iconografie ovidiane nel repertorio musivo medio e tardo-imperiale, in Marmoribus Vestita. Studi in onore di Federico Guidobaldi, a cura di O. Brandt, Ph. Pergola, Roma, pp. 613-634.
grassigli G. L. 2007, Achille allo specchio. Riflessioni su un insolito soggiorno a Sciro, in Sertum Pe-rusinum Gemmae oblatum. Studi in onore di Gemma Sena Chiesa, Napoli, pp. 225-258.
harari M. 1988, Le gardiens du paradis, in NumAntCl, 17, pp. 169-193.Harari m. 2007, Alle origini di Dafne. Donne fogliute, donne fiorite nell’immaginario greco-
romano, in Eidola. International Journal of Classical Art History, 4, pp. 29-48.koCh g. 1975, Die mythologischen Sarkophage. Meleager, Berlin.leaCh e. w. 1981, Metamorphoses of the Acteon myth in Campanian painting, in RM, 88, pp.
307-327.
Il gran poema delle passioni e delle meraviglie
28 isabella Colpo
mielsCh h. 1975, Römische Stuckreliefs, RM Abteilung 21, Heidelberg.mugione e. 2000, Miti della ceramica attica in Occidente. Problemi di trasmissioni iconografi-
che nelle produzioni italiote, Taranto.müller v. 1929, Die Typen der Daphnedarstellungen, in RM, 44, pp. 59-86.narDelli m. 2000, Raffigurazioni mitologiche nella decorazione parietale dell’area vesuviana:
Diana e Atteone, in Antenor. Miscellanea di studi di Archeologia, Padova, 2, pp. 53-88.novello m. 2007, Scelte tematiche e committenza nelle abitazioni dell’Africa Proconsolare. I
mosaici figurati, Biblioteca di Eidola, Series maior, 1, Pisa-Roma.Pianezzola E. 1979 [1999], La metamorfosi ovidiana come metafora narrativa, in Retorica e
Poetica, Atti del III Convegno italo-tedesco (Bressanone, 1975), Quaderni del Circolo filologico-linguistico padovano 10, Padova, pp. 79-91 [rist. in pianezzola E. 1999, Ovi-dio. Modelli retorici e forma narrativa, Bologna, pp. 29-42].
pirzio biroli stefanelli l. 1991, L’argento dei romani, Roma.robert C. 1919, Die antiken Sarkophag-reliefs, IV.3.3, Berlin.romizzi l. 2002, Note su due mosaici figurati dalla Casa di Dioniso e Ulisse a Thugga, in Ante-
nor. Miscellanea di studi di archeologia, Padova, 3, pp. 47-60.salvo G. 2009, Ovidio e la cultura figurativa di età augustea: il mito di Niobe tra arte e lettera-
tura, in Eidola. International Journal of Classical Art History, 6, pp. 89-112.segal Ch. 2005, Il corpo e l’io nelle «Metamorfosi» di Ovidio, in barChiesi 2005, pp. XVII-CI.tomei D. 2010, Il sacrifio di Ifigenia in Aulide. Gli esempi di Pompei, in Eidola. International
Journal of Classical Art History, 7, pp. 71-93.toso s. 2007, Fabulae graecae. Miti greci nelle gemme romane del I secolo a.C., Le Rovine Cir-
colari 9, Roma. tronChet G. 1998, La métamorphose à l’œuvre: recherches sur la poétique d’Ovide dans les
Métamorphoses, Bibliothèque d’études classiques 13, Louvain, Paris.Yalouris N. 1986, Le mythe d’Io: les transformations d’Io dans l’iconographie et la litterature
grecque, in BCH, Suppl. XIV, pp. 3-23vial H. 2010, La métamorphose dans les Métamorphoses d’Ovide. Étude sur l’art de la varia-
tion, Paris.zanker p., ewalD b. C. 2008, Vivere coi miti. L’iconografia dei sarcofagi romani, Torino.