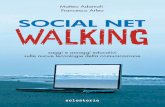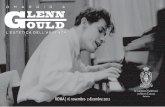Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive
CaPItolo 3 Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive
F. Corradi, M.J. Scherer, A. Lo Presti
In questo capitolo viene presentato il modello di valutazione delle tecnologie assistive (ATA process). Il modello dell’ATA process delinea un processo ideale che fornisce le li-nee guida di riferimento sia per i centri ausili pubblici sia privati, permettendo loro di confrontare, valutare e migliorare il proprio modello di abbinamento. Le azioni richieste dal modello dell’ATA process ai centri ausili possono essere suddivise in quattro fasi fon-damentali: i) l’accesso alla struttura e l’attivazione del processo; ii) la valutazione e la sele-zione delle TA; iii) la consegna e iv) il follow-up. L’ATA è un processo condotto dall’utente (user-driven) attraverso il quale la selezione di una o più TA è facilitata dall’utilizzo di ade-guate misure cliniche, dall’analisi funzionale e dalla valutazione psico-socio-ambientale che riguardano, in uno specifico contesto d’uso, il benessere personale dell’utente attraverso il miglior abbinamento di utente/cliente e soluzione assistiva (Scherer et al., 2012). Poiché l’ATA process e il modello MPT condividono sia una metodologia di lavoro condotta dall’utente (user-driven) sia il modello biopsicosociale dell’ICF, possono essere integrati all’interno di un percorso volto al migliore abbinamento della TA affinché questa possa promuovere il benessere personale dell’utente/cliente.
3.1 IntroduzioneLa World Health Organization (WHO), nel Disability and Rehabilitation Action Plan 2006-2011 (2006), riferisce che circa il 10% della popolazione mondiale vive l’espe-rienza di una qualche forma di disabilità temporanea o permanente. Il documento mette in evidenza come le tecnologie assistive (TA) possano essere un valido aiuto per le persone con disabilità “per aumentare il loro livello di indipendenza nella vita quotidiana e per esercitare i loro diritti” (WHO, 2006, p. 5, corsivo nell’originale). Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari lo sviluppo, la produzione, la distri-buzione e il supporto nell’uso delle TA.
In particolare, tra gli obiettivi del WHO in quest’area sono presenti:
• il supporto agli Stati membri nello sviluppo di politiche nazionali sulle TA;
• il supporto agli Stati membri nella formazione del personale, a tutti i livelli, nelcampo delle TA, soprattutto nell’area delle protesi e delle ortesi;
• la promozione e la divulgazione della ricerca sulle TA.
Tali impegni sono inseriti all’interno del World Report on Disability (WHO, 2011).
50 Capitolo 3
Accanto però a questi indirizzi di intenti, diversi studi evidenziano un tasso medio di abbandono delle TA, da parte di chi ne ha ricevuta almeno una, di circa il 30% entro il primo anno di utilizzo, con una variabilità a seconda della loro tipologia (Phi-lips e Zhao, 1993; Scherer, 1998; Kittel et al., 2002; Scherer et al., 2004, 2005; Dijcks et al., 2006). Uno studio recente (Federici e Borsci, 2011) ha evidenziato un tasso di abbandono di TA di circa il 25% all’interno di un percorso pubblico di prescrizione di TA, e un tasso di abbandono del 12% all’interno di un progetto riabilitativo. Quale causa dell’alto tasso di abbandono/non uso di TA all’interno del percorso pubblico di prescrizione, gli autori individuano l’assenza di un processo centrato sull’utente e/o l’assenza dei servizi di post fornitura di TA, quali il supporto e il training all’uso come già evidenziato in studi precedenti (Philips e Zhao, 1993; Judge, 2002; Scherer e Craddock, 2002; Lauer et al., 2006).
Tuttavia, sempre la WHO evidenzia che solo il 5-15% della popolazione che potrebbe trarre beneficio dall’uso delle TA ha poi realmente la possibilità di acceder-vi e conseguentemente utilizzarle (WHO, 2006). La WHO si augura che un numero sempre maggiore di persone possa trarre beneficio da tali tipologie di ausilio, in modo da ottenere la partecipazione desiderata all’interno del proprio contesto di vita (WHO, 2002).
Le evidenze sull’abbandono delle TA e il numero di persone che potrebbero trarne un vantaggio, e invece non lo ottengono, mostrano quindi che l’abbinamento auspi-cato dalla WHO (WHO, 2011) di fatto non sta avvenendo. È necessario individuare percorsi di abbinamento che permettano ai centri ausili di effettuare verifiche siste-matiche del processo in atto in ogni sua fase, compresi l’assistenza e il supporto post fornitura.
La necessità di individuare un modello di abbinamento ottimale è collegata ad almeno due obiettivi principali.
1. Minimizzare la dispersione finanziaria, che consentirebbe a più persone di sfrut-tare le TA appropriate.
2. Formulare soluzioni assistive che meglio rispondano alle esigenze degli utenti, raggiungendo in questo modo l’obiettivo della partecipazione.
Tuttavia, sebbene nel campo delle TA sia stato sviluppato un vasto numero di stru-menti di misura, essi tendono a concentrarsi sugli esiti dell’abbinamento, sofferman-dosi per esempio sulla misurazione della soddisfazione degli utenti e/o sulle presta-zioni della TA fornita [p.e.: PIADS (Jutai e Day, 2002); COPM (Law et al., 2005); QUEST (Demers et al., 1996); IPPA (Wessels et al., 2002); FIATS (Ryan et al., 2006); ATOM (Lauer et al., 2006)]. Quindi, procedure e misure standardizzate per l’abbinamento e l’assegnazione di TA nel momento della loro selezione sono ancora necessarie. Sebbene alcuni si riferiscano all’ICF come a uno strumento che può assi-stere il professionista durante il processo di abbinamento (Karlsson, 2010), Bernd e colleghi (2009) considerano che anche l’ICF Checklist sia una misura generica non sviluppata per lo scopo di valutare e rispondere alle esigenze di TA degli utenti. Le stesse ricerche (Bernd et al., 2009) riportano una mancanza di modelli affidabili e di
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 51
strumenti che possano essere utilizzati durante il processo di abbinamento delle TA. In realtà, la maggior parte degli studi in questo campo sono recensioni di letteratura o tentativi di sviluppare un efficace modello di valutazione ma senza validi presuppo-sti scientifici. L’unico strumento validato citato in letteratura è il modello del Matching Person & Technology (MPT; Scherer, 1998).
Il processo di valutazione di tecnologie assistive (ATA process) è stato sviluppato con lo scopo di identificare il processo ottimale che possa permettere sia di aumenta-re la qualità delle TA fornite, sia di promuovere il massimo beneficio dal loro uso. In tale prospettiva il modello dell’ATA process è in grado di identificare i passi necessa-ri per raggiungere il miglior abbinamento, coinvolgendo diverse competenze profes-sionali e tipologie di strumenti per le seguenti attività: analisi cliniche, processo di abbinamento della TA, analisi ambientali, valutazione dell’outcome e valutazione nel tempo della corrispondenza della TA individuata (Scherer et al., 2012).
Il modello dell’ATA process condivide con il modello MPT l’obiettivo di promuo-vere il benessere personale degli utenti/clienti garantendo che la TA sia adatta ai loro bisogni. Tuttavia le prospettive adottate dai due modelli sono diverse: il processo MPT descrive ciò che deve essere misurato, mentre l’ATA process mostra come un centro ausili debba essere strutturato per consentire il miglior abbinamento tra utente/cliente e TA.
3.2 Misurare l’abbinamento delle taIl modello MPT per quanto concerne la misura dell’abbinamento si inserisce comple-tamente all’interno dell’ATA process. Il modello MPT (Scherer, 1998) sostiene che le caratteristiche della persona, dell’ambiente in cui essa vive e della tecnologia da individuare devono essere considerate come interagenti quando si seleziona la TA più idonea ai bisogni della persona.
3.2.1 L’ICF e altre misure dell’outcomeLa Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) offre un modello che guida e integra gli aspetti complessi di una valutazione di TA: si tratta del modello biopsicosociale, sul quale si basa il modello MPT. L’ICF concepisce la “disabilità” come il prodotto dell’interazione tra le caratteristiche indi-viduali e quelle dell’ambiente fisico e sociale. La disabilità è definita come una “variante” del funzionamento umano lungo tre dimensioni: (i) menomazioni (il defi-cit organico e/o psicologico); (ii) limitazioni nelle attività e/o (iii) restrizioni nella partecipazione. In particolare, l’ICF non classifica le persone, ma descrive la vita di ogni persona in termini di “componenti della salute e alcune componenti a essa cor-relate (come l’istruzione e il lavoro)” (OMS, 2002, p. 11). Per la prima volta, il modello della WHO della disabilità tiene conto dei fattori ambientali e li classifica sistematicamente, consentendo la correlazione tra salute e ambiente e arrivando alla definizione di disabilità come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. Le informazioni che si ottengono dall’ICF sono utili non solo per studiare la disabilità,
52 Capitolo 3
ma anche per identificare gli interventi appropriati. Per esempio, se il problema è una lesione, l’assistenza si concentrerà sull’individuo; se il problema è correlato a una restrizione della partecipazione a causa di discriminazione, l’intervento sarà diretto all’eliminazione delle barriere sociali e/o ambientali, modificando le barriere presen-ti nell’ambiente e fornendo facilitatori, così da migliorare le performance nella vita quotidiana.
Benché l’ICF non sia stato specificamente sviluppato per guidare l’ATA process, la letteratura evidenzia come esso si presti a essere un modello descrittivo per l’ATA process. L’ICF cattura i complessi aspetti relativi all’impatto che la TA può avere sulla persona e sul suo ambiente, riuscendo in tal modo ad assistere il professionista nel processo decisionale (Bernd et al., 2009). Il processo di valutazione basato sull’ICF assisterà i professionisti nella comprensione dei bisogni dell’individuo, agevolerà la collaborazione tra i servizi a ogni livello del processo e darà le giuste priorità agli obiettivi dell’intervento. La WHO definisce come TA qualsiasi dispositivo o sistema con due caratteristiche: che consenta a una persona di effettuare un’attività che altri-menti sarebbe troppo difficile da eseguire, oppure che ne faciliti l’esecuzione (WHO, 2003). La TA include sia i dispositivi sia i servizi correlati. I servizi supportano l’ATA process, l’acquisizione e l’uso del dispositivo fornito (Bausch e Ault, 2008).
Le componenti dell’ICF sono ben integrate in combinazione con numerosi stru-menti di valutazione, come nell’ICF Checklist ricordata in precedenza. L’ICF è com-patibile con la Canadian Occupational Performance Measure (COPM), con l’Indivi-dually Prioritised Problem Assessment (IPPA) e con la Goal Attainment Scale (GAS) (Karlsson, 2010). L’ICF Checklist è uno strumento pratico, utile a far emergere e registrare le informazioni sul funzionamento e la disabilità di un individuo: mette in evidenza quali sono le capacità e le limitazioni dell’utente in attività e domini relativi alla partecipazione. È dotata di un elenco delle funzioni mentali, tra cui la funzione sensoriale e la funzione del dolore, della voce e della parola, del sistema respiratorio e così via. La Checklist aiuta il professionista del servizio a decidere se sia o meno necessaria una specifica valutazione funzionale. La COPM è stata sviluppata per catturare le prestazioni professionali individuali del cliente; non è specifica per la TA, ma riguarda le esigenze dell’utente di TA partendo da una prospettiva user-centered. Utilizzata insieme ad altri strumenti, è utile durante l’ATA process (Bernd et al., 2009). La GAS è stata introdotta per valutare i servizi di salute mentale; oggi è usata in pediatria, nella riabilitazione e nei servizi di salute mentale. È una misura del cam-biamento raggiunto dall’individuo nel corso di un intervento rispetto agli obiettivi individuali. L’IPPA è uno strumento generico per misurare l’efficacia di qualsiasi TA utilizzata. In sintesi, la COPM, la GAS e l’IPPA sono sensibili a misurare il cambia-mento; una combinazione di questi strumenti, insieme con l’ICF Checklist, offre ai fornitori di servizi ulteriori soluzioni basate su prove di misura dell’outcome di TA come alternativa o a complemento del MPT (Karlsson, 2010).
L’unico strumento di misura per l’abbinamento di TA sviluppato entro il modello dell’ICF e della sua Checklist, così come evidenziato in letteratura, è il MPT (Scherer e Craddock, 2002; Bernd et al., 2009); in particolare, l’Assistive Technology Device Predisposition Assessment (ATD-PA), in cui ogni elemento è stato mappato secondo
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 53
l’ICF Checklist. Nel modello MPT è stata infatti colmata una lacuna poiché, rispetto ad altri strumenti, considera le interazioni tra le caratteristiche del dispositivo, quelle dell’utente e quelle dell’ambiente entro lo spettro del modello biopsicosociale. Oltre al COPM, al GAS e all’IPPA, la letteratura suggerisce l’uso del Quebec User Evalua-tion of Satisfaction with Assistive Technology 2.0 (QUEST) e della Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale (PIADS) durante la valutazione dei fattori conte-stuali, delle caratteristiche dei dispositivi e della soddisfazione dell’utente della pro-pria qualità della vita, ma nessuno di questi ha i propri elementi mappati nell’ICF.
3.2.2 Il modello Matching Person & technologyIl modello MPT è collaborativo e condotto dall’utente (user-driven): si basa cioè sulla scelta della tecnologia più appropriata per soddisfare i bisogni della persona con disabilità attraverso il coinvolgimento della persona stessa e supportando il professio-nista, o il team di professionisti, nel rendere manifesti i suoi bisogni reali. Con l’MPT per la prima volta la persona con disabilità è esplicitamente coinvolta nella selezione della tecnologia. Il tradizionale processo unidirezionale dal fornitore al consumatore (modello medico) viene sostituito con un nuovo approccio, il quale riconosce che il fornitore è un elemento fondamentale all’interno delle influenze ambientali nella selezione della tecnologia e nella soddisfazione dei bisogni (modello sociale). Secon-do l’MPT, i fattori fondamentali all’interno del processo di selezione della TA più appropriata per ogni persona per raggiungere il miglior abbinamento sono tra loro interdipendenti e interattivi (vedi Figura 3.1).
• Ambiente: le caratteristiche architettoniche, degli edifici, dei contesti fisici e di quelli sociali, culturali e attitudinali in cui viene utilizzata la TA.
• Persona: caratteristiche relative al temperamento, alla personalità e alle preferen-ze dell’utente.
• Tecnologia: le caratteristiche salienti della TA stessa.
Il modello MPT contribuisce inoltre alla promozione della buona pratica professiona-le enfatizzando l’importanza di alcuni passaggi durante il processo di valutazione.
• Ottenere le informazioni pertinenti.
• Organizzare tali informazioni.
• Operazionalizzare e implementare i passaggi nel processo di corrispondenza tra la persona e la TA desiderata.
• Documentare, rivedere e aggiornare l’impatto della TA.
Il processo dell’MPT e le misure che valutano la predisposizione individuale per l’utilizzo della TA (o di altre forme di tecnologia) cercano di valutare la misura in cui la TA potrà essere accettata e utilizzata.
54 Capitolo 3
Figura 3.1 (Vedi inserto a colori.) Il Matching Person & Technology Model (Scherer, 2005). L’“abbinamento persona-TA” (tecnologia assistiva) – il cerchio più piccolo – è uguale alla soluzione assistiva quando aumentano la qualità della vita e il benessere.
Il professionista, utilizzando una serie di fogli di lavoro completati anche dall’utente (che identificano i fattori rilevanti relativi alla persona, alla tecnologia e all’ambien-te), ottiene informazioni per accertare gli elementi critici che potrebbero influenzare l’accettazione e l’uso della TA. L’obiettivo è di impedire l’abbandono e l’uso impro-prio della TA nonché quello di preparare al meglio, attraverso la raccolta di informa-zioni, il momento della scelta della TA più appropriata, che medi tra le esigenze espresse dall’utente e quelle relative all’ambiente di utilizzo. Per esempio, tali fogli di lavoro possono facilitare una previsione d’uso parziale o di riluttanza all’uso a causa di fattori ambientali, ma allo stesso tempo possono far emergere una buona previsione d’uso rispetto alle caratteristiche della tecnologia e della persona; così, l’ambiente in cui verrà utilizzata la TA può aver bisogno di modifiche in modo che la persona possa ottenere maggior soddisfazione e aumento di performance con la TA. Le caratteristiche ambientali si estendono oltre l’accesso fisico (spesso comprese le risorse economiche e il sostegno sociale), così che risulta essenziale, nel processo di selezione, coinvolgere fin dall’inizio tutte le persone che saranno interessate dall’uso della TA (utente, operatori sanitari, membri della famiglia, datori di lavoro, compagni di classe e così via).
La prospettiva del modello MPT ha le sue fondamenta nella problematica relativa all’abbandono di TA. Negli anni Ottanta, gli studiosi iniziarono ad analizzare i pro-
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 55
blemi concernenti l’abbandono di TA nell’ambito della riabilitazione, osservando in particolare quali fossero i motivi per cui le TA non venivano impiegate oppure veni-vano abbandonate. Da allora, la maggior parte delle ricerche sull’uso e l’abbandono di TA ha preso in considerazione diversi fattori, quali il costo delle apparecchiature, le abilità fisiche necessarie per l’uso, la demografia, la sicurezza dei prodotti e l’affi-dabilità. In particolare si individuano tre aree di studio: (1) le caratteristiche persona-li degli utenti e l’accettazione della tecnologia; (2) le caratteristiche del prodotto preferito dai consumatori; (3) le richieste di informazioni circa l’uso della TA. Zola (1982) ha evidenziato come i consumatori preferiscano i dispositivi che promuovono l’indipendenza connessa con la libertà psicologica e sociale, non solo fisica di funzio-namento. Inoltre, è stata evidenziata una serie di fattori personali che possono influen-zare l’accettazione e l’uso di TA, come la motivazione, la consapevolezza della disabilità, gli obiettivi di vita e il rapporto sforzo-ricompensa (effort-reward). Pertan-to, dispositivi che consentono agli utenti di completare compiti importanti hanno maggiori probabilità di essere utilizzati. Nella maggior parte degli studi è risultato che il costo di acquisto, la durata, l’affidabilità, la facilità d’uso, le caratteristiche di sicu-rezza, l’estetica, la facilità di riparazione, la gestione/portabilità e le buone istruzioni sono le caratteristiche più importanti per una buona TA.
Di solito i fattori associati alla persona sono combinati con quelli legati alla tec-nologia e alle caratteristiche ambientali. Philips e Zhao (1993) hanno riportato un abbandono pari al 29,3% per le TA, individuando quattro fattori che sono significati-vamente correlati al non uso e all’abbandono della TA da parte di utilizzatori con differenti disabilità.
1. Cambiamento nei bisogni dell’utilizzatore.
2. Facile ottenimento dell’ausilio.
3. Bassa prestazione dell’ausilio.
4. Mancanza di considerazione dell’opinione dell’utilizzatore durante l’assegnazio-ne dell’ausilio.
Il più alto tasso di abbandono si è verificato con gli ausili per la mobilità, soprattutto nel primo anno o dopo cinque anni di utilizzo. Ciò implica un duplice impatto, a livello individuale in termini di frustrazione e di depressione e a livello dell’intero sistema coinvolto, in termini di perdita di fondi e finanziamenti (Verza et al., 2006).
Zimmer e Chappell (1999) hanno esaminato 1400 persone anziane nella provincia canadese di Manitoba in relazione all’uso di specifiche tecnologie, al fine di svilup-pare un modello appropriato che evidenziasse le eventuali criticità nell’uso delle TA. Gli autori hanno rilevato che l’uso è influenzato dai seguenti fattori: predisposizione, necessità, sostegno sociale e livello di preoccupazione individuale relativamente ai problemi che potrebbero essere attenuati attraverso l’uso della tecnologia. Tuttavia, a una più stretta analisi, i risultati hanno mostrato che la principale preoccupazione è la sicurezza. Le persone anziane devono spesso affrontare problemi funzionali che limi-tano le loro attività e la loro indipendenza. Pertanto, la tecnologia che agisce sulle
56 Capitolo 3
difficoltà pratiche dell’anziano può essere un’occasione per migliorare la sua qualità di vita e un mezzo per fare fronte alla disabilità.
Pochi studi hanno indagato l’uso di TA nei bambini (la popolazione pediatrica). Tuttavia, nella maggior parte dei bambini con disabilità, l’utilizzo e l’abbandono delle TA spesso sono influenzati da altre persone vicine a loro, come genitori, insegnanti e terapisti (Caudrey e Seeger, 1983).
Nonostante in letteratura siano presenti molti modelli sulle TA, nessuno di questi si è dimostrato in grado di predirne l’uso. Lenker e Paquet (2004) hanno proposto un modello olistico-concettuale user-centered che spiega l’uso di TA in termini di bene-fici percepiti; tale modello mette in risalto come il processo decisionale non si verifi-chi immediatamente, ma si costruisca nel tempo. L’uso della TA ha un impatto sull’u-tente, sull’ambiente e sull’uso della tecnologia stessa; allo stesso tempo, l’impatto della TA sui tre domini predice il suo utilizzo futuro.
Simili risultati sono stati ottenuti da Verza et al., (2006): queste indagini hanno evidenziato come un approccio multidisciplinare, per la valutazione dei pazienti con sclerosi multipla che richiedono TA, possa ridurre il tasso di abbandono delle TA stesse. Gli autori identificano quattro fattori di abbandono: deterioramento dello stato fisico, non accettazione degli aiuti, insufficienza/mancanza di informazione e forma-zione e inadeguatezza della TA individuata. L’abbandono della maggior parte delle apparecchiature che subivano questa sorte avveniva o immediatamente o entro il primo anno di utilizzo.
La predisposizione all’uso della tecnologia è multiforme e comprende i bisogni, le abilità, le preferenze, le esperienze precedenti con la tecnologia, i fattori di perso-nalità, le aspettative e molte altre variabili. Un’analisi fra culture (Federici et al., 2003) ha confermato l’ipotesi di una relazione tra l’autorappresentazione della disa-bilità (valutata con il WHODAS II), le strategie di coping (misurato tramite il Coping Inventory for Stressful Situation, CISS; Endler e Parker, 1999) e la predisposizione individuale per l’uso delle TA (valutata con il Survey of Technology Use, SOTU).
In tutti gli studi si evidenzia il ruolo centrale dell’utente durante l’intero processo di selezione (assegnazione degli ausili), a partire da una scelta consapevole, dalla prova d’uso, fino all’uso della tecnologia, al fine di permettere un vantaggio in termi-ni di efficienza, soddisfazione, acquisizione di una maggiore autonomia e migliora-mento della qualità e dello stile di vita (Lenker e Paquet, 2004). La complessità dell’abbinamento tra utente e tecnologia richiede un approccio centrato sulla persona e, quindi, una più completa valutazione dell’utente prima della selezione/assegnazio-ne della TA. Inoltre, una migliore formazione dei professionisti e dei fornitori dei servizi di selezione/assegnazione delle TA e degli utenti sulle TA faciliteranno le decisioni riguardanti l’assegnazione delle TA stesse, riducendo così la probabilità che queste vengano abbandonate. Infatti, la necessità di assegnare una TA che aumenti le capacità personali e la qualità della vita si scontra spesso con il non uso o l’abbando-no delle TA o con un loro utilizzo non ottimale. L’MPT è il primo modello teorico che si è concentrato sul coinvolgimento della persona con disabilità nel processo di assegnazione dell’ausilio. Poiché l’esperienza di disabilità è unica e soggettiva, è necessaria una valutazione completamente centrata sull’utente, che gli dia la possibi-
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 57
lità di esprimere le proprie preferenze e che metta in primo piano le caratteristiche individuali e psicosociali (Scherer, 2005).
Secondo la Scherer (2002), solo attraverso un’approfondita valutazione possono essere identificati:
• i bisogni di adattamento dell’ambiente o di quelli di supporto che permettano l’utilizzo della TA;
• l’impatto delle limitazioni correlate;
• l’equilibrio tra le capacità funzionali e le limitazioni;
• le necessità di formazione e l’individuazione di contesti di prova d’uso (casa, scuola e lavoro);
• le TA migliori per l’utente in termini di usabilità ed estetica;
• la misura in cui la TA soddisfa le esigenze dell’utente, da verificare durante un follow-up, e l’esistenza di eventuali effetti collaterali indesiderati e imprevisti derivanti dall’uso della TA.
L’obiettivo finale del processo di selezione/assegnazione è quello di migliorare le performance e la qualità della vita dell’individuo, in cui qualità e benessere significa-no “tutto l’universo dei domini della vita umana, inclusi aspetti fisici, mentali e socia-li, che costituiscono quella che può essere chiamata una ‘buona vita’” (OMS, 2002, p. 167). Se gli ausili non raggiungono questo obiettivo, non saranno, o meglio non dovrebbero essere, utilizzati.
3.2.3 Il processo dell’MPt e le sue misureIl Box 3.1 illustra il processo dell’MPT e le misure correlate. Tale processo si sforza di seguire i cosiddetti “buoni principi” (GOOD principles).
Fase uno: il foglio di lavoro iniziale del processo Matching Person & Technology (MPT – Foglio di lavoro) è organizzato in aree in cui le persone possono descrivere/raccontare la perdita di una funzione (per esempio linguaggio/comunicazione, mobilità, udito e vista) e i propri punti di forza più importanti (area Limitazioni). Grazie a esso si possono verificare gli obiettivi iniziali e le aree da rafforzare attraverso l’utilizzo di una tecnologia (o altro supporto/strategia) o le modifiche ambientali necessarie. Eventuali interventi a sostegno degli obiettivi possono essere descritti sul modulo in uno spazio apposito (area Obiettivi ed interventi progettati). Quando una nuova tecnologia viene fornita a una persona è auspicabile lavorare a partire da un punto di forza. Ogni ele-mento deve essere discusso, a prescindere se un professionista lo ritenga rilevante o meno per quella specifica persona. Non è infatti possibile prevedere a priori quali elementi potranno influenzare il processo decisionale.
BOX 3.1 PrOCeSSO DI VaLUtazIONe e FOGLI DI LaVOrO MPt
58 Capitolo 3
Fase due: l’analisi della storia personale nell’uso delle tecnologie (Utilizzo delle tecno-logie) viene impiegata per identificare i supporti tecnologici attualmente utilizzati e quelli utilizzati in passato e la soddisfazione nel loro uso. Inoltre il modulo permette di analizzare perché un nuovo tipo di supporto può essere migliore rispetto ad altri. È organizzato secondo le stesse aree di funzionamento del foglio di lavoro iniziale de-scritto alla Fase uno. Anche se le Fasi uno e due si concentrano su “parti singole” del funzionamento dell’in-dividuo, si ritiene che solo se tutte le aree interessate all’abbinamento sono state analizzate allora nessuna barriera all’uso ottimale della tecnologia sarà omessa. Per esempio, quando ci si concentra sulla comunicazione e si sta per consigliare un dispo-sitivo che richiede una visione molto buona, e che non è stata valutata, ci possono essere problemi se la persona ha una significativa perdita della vista. L’obiettivo è quello di analizzare la persona nella sua interezza e farne una valutazione globale te-nendo conto di tutta la persona, degli ambienti di utilizzo della tecnologia e così via, e per raggiungere questo obiettivo bisogna considerare le varie parti che compongono il tutto e il rapporto dell’una con l’altra.
Fase tre: valutazione della predisposizione agli ausili. Il cliente/utente compila la versio-ne del modulo appropriata a seconda del tipo di tecnologia in esame. La natura modu-lare delle valutazioni consente l’uso di uno, due o più moduli nonché di sezioni di essi. Nella versione inglese i moduli per l’utente per la Valutazione della predisposizione alle tecnologie assistive e i moduli per la Valutazione della predisposizione alle tecnologie di supporto per problematiche cognitive (non presenti nella versione italiana) possono esse-re compilati al computer con la possibilità di avere il punteggio finale computerizzato con le relative linee guida interpretative.
Generale
– Analisi dell’utilizzo della tecnologia (SOTU) – per il cliente/utente
– Analisi dell’utilizzo della tecnologia (SOTU) – per l’operatore
Lo strumento SOTU contiene 29 item che indagano le esperienze attuali e i sentimen-ti verso le tecnologie del cliente/utente. La checklist richiede alle persone di elencare tutte le diverse tecnologie che utilizzano e in cui si sentono a proprio agio, con l’idea che l’introduzione di una nuova tecnologia deve capitalizzare il comfort e le abilità esistenti. Le persone sono inoltre invitate a fornire informazioni sulle aree relative al loro stato d’animo generale e al loro coinvolgimento sociale che potrebbero incidere in modo favorevole nell’uso della tecnologia. La versione per gli operatori è identica a quella dei clienti/utenti.
assistive
– Valutazione della predisposizione agli ausili (ATD PA) – per il cliente/utente
– Valutazione della predisposizione agli ausili (ATD PA) – per l’operatore
La strumento ATD PA indaga la soddisfazione soggettiva delle persone rispetto ai ri-sultati conseguiti in una varietà di aree funzionali (9 item); esso chiede all’utente di mettere in ordine di priorità aspetti della propria vita ove sono attesi dei miglioramen-
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 59
ti (12 item); indaga il loro contesto psicosociale o l’ambiente d’uso (33 item); richiede il punto di vista dell’utente rispetto all’ausilio (12 item). Le scale hanno l’obiettivo di mettere in evidenza le capacità, la qualità percepita della vita, il supporto familiare, il supporto degli amici, l’umore e il temperamento, l’autonomia e l’autodeterminazione, l’autostima e la disponibilità verso l’uso di strumenti tecnologici. La sezione finale con-sente il confronto di dispositivi concorrenti rispetto all’abbinamento strumento-per-sona. L’ATD PA (modulo per l’operatore) consente al professionista di determinare e valutare incentivi e disincentivi all’uso del dispositivo da parte di una persona specifica.
Supporto cognitivo
– Valutazione della predisposizione alle tecnologie assistive per problematiche cognitive (CST PA) – per il cliente/utente
– Valutazione della predisposizione alle tecnologie assistive per problematiche cognitive (CST PA) – per l’operatore
Lo strumento CST PA è strutturato come lo strumento ATD PA descritto preceden-temente, ma ha altri 6 item riguardanti le funzioni corporee, centrati su Funzioni Men-tali Specifiche.
• Prestare attenzione, non distrarsi.
• Memorizzare le informazioni su persone o eventi.
educative
– Valutazione della predisposizione alle tecnologie educative (ET PA) – per lo studente
– Valutazione della predisposizione alle tecnologie educative (ET PA) – per l’insegnante
Lo strumento ET PA è composto da 50 item (43 nella versione inglese) ed è stato progettato per identificare le prospettive degli studenti e dell’insegnante in quattro aree principali.
1. Obiettivo educativo: caratteristiche degli obiettivi educativi e dei bisogni educativi cui l’inse-gnante cerca di rispondere attraverso l’uso di una specifica tecnologia.
2. Tecnologia didattica: caratteristiche della particolare tecnologia educativa considerata.
3. Ambiente educativo: caratteristiche dell’ambiente psicosociale nel quale la tecnologia sarà usata, per esempio il grado di collaborazione della famiglia, dei colleghi, degli insegnanti e così via.
4. Studente: caratteristiche dello studente che possono influenzare l’impatto sull’uso della tecnologia.
Lavorative
– Valutazione della predisposizione alla tecnologia per la postazione di lavoro (WT PA) – per il lavoratore
– Valutazione della predisposizione alla tecnologia per la postazione di lavoro (WT PA) – per il datore di lavoro
60 Capitolo 3
I 18 item (28 nella versione inglese) dello strumento WT PA aiutano i datori di lavoro nell’identificazione di quei fattori che possono ostacolare l’accettazione e l’uso di una nuova tecnologia sul posto di lavoro.
Sanitarie
– Valutazione alla predisposizione alle tecnologie biomediche (HCT PA) – per l’operatore sanitario
Lo strumento HCT PA è una checklist composta da 42 item con lo scopo di analizzare le caratteristiche del particolare problema sanitario, le conseguenze presumibili date dall’uso della tecnologia biomedica, le caratteristiche della tecnologia biomedica consi-derata, gli aspetti personali che hanno influenza sulle decisioni sull’uso di una tecnolo-gia biomedica e l’atteggiamento delle altre persone, significative per il paziente, riguar-do alle preoccupazioni per la salute.Ciascuno dei singoli moduli può servire come guida durante un colloquio se ritenuto appropriato alla situazione. Il professionista completa la versione del modulo per l’ope-ratore e identifica eventuali discrepanze tra la sua compilazione e le risposte del cliente/utente. Queste discrepanze diventano argomento di discussione e di consulenza.
Fase quattro: il professionista discute con il cliente/utente quei fattori che possono indicare criticità nella sua accettazione e/o nell’uso appropriato della tecnologia.
Fase cinque: dopo l’analisi delle aree critiche (barriere e limitazioni), il lavoro pro-fessionale e individuale prosegue per individuare strategie di intervento specifiche e mettere a punto un piano d’azione per affrontare i problemi emersi.
Fase sei: le strategie e i piani d’azione individuati per far fronte ai problemi emersi vengono riportati per iscritto; questo perché l’esperienza ha dimostrato che i pro-grammi solo verbalizzati non vengono attuati quanto quelli scritti. I piani scritti servo-no anche come documentazione e sono utili per giustificare le azioni successive, come le richieste di finanziamento o di tempo per la formazione.
Fase sette: un follow-up di valutazione viene condotto per determinare eventuali adeguamenti da effettuare o nuove soluzioni tecnologiche da introdurre e per verifica-re il raggiungimento del beneficio atteso, il raggiungimento degli obiettivi programmati e se la persona ha cambiato le proprie priorità. Le misure contenute nella terza fase, Valutazione della predisposizione agli ausili, vengono utilizzate come livello base per de-terminare nel follow-up il cambiamento nel corso del tempo per una persona specifica.
Le misure nel Box 3.1, in particolare l’ATD-PA, sono sempre affidabili e valide (Scherer e Cushman, 1995; Vincent e Morin, 1999; Goodman et al., 2002;. Gatti et al., 2004;. Scherer e Sax, 2010). Le misure si correlano significativamente con i seguenti fattori: qualità della vita, umore, sostegno dell’ambiente, motivazione all’u-so delle TA, fiducia nel programma/terapeuta, autodeterminazione/autostima (Scherer et al., 2005), fattori ambientali dell’ICF (Scherer e Glueckauf, 2005), Satisfaction
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 61
with Life Scale (SWLS), Brief Symptom Inventory (BSI, Scherer e Cushman, 1995), e aspetti psicosociali (Brown e Merbitz, 1995; Brown, 1997).
Inoltre un recente studio, volto ad analizzare l’uso di interfacce neurali (Brain Computer Interface, BCI) rispetto all’uso di sistemi di eye-tracking nei soggetti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha trovato correlazioni significative tra i diversi fattori valutati con l’ATD-PA (TA, ambiente, disabilità, carattere) e altre misure quali l’usabilità, l’umore, la motivazione e il carico cognitivo. Lo studio evidenzia il ruolo fondamentale dell’ambiente di vita nell’uso della TA assegnata per promuovere una soddisfacente esperienza con essa. Questa indagine conferma gli studi precedente-mente citati e sostiene l’uso dell’ATD-PA come strumento appropriato per la valuta-zione della predisposizione all’uso di TA.
3.2.4 Il modello MPt e l’ICFLe diverse misure presenti nel processo dell’MPT sono compatibili con l’ICF e con-sentono la valutazione dei domini più importanti nel processo di abbinamento per l’uso della tecnologia. La Tabella 3.1 elenca i domini principali dell’ICF, alcuni esempi di TA e altre forme di supporto nonché le misure più appropriate dell’MPT per la valutazione di ciascun dominio dell’ICF (basato su Scherer e Glueckauf, 2005).
3.2.5 Le differenti versioni dell’MPtPer fornire misure pertinenti ai diversi interessi e bisogni delle persone con disabilità lungo l’arco di vita, si possono utilizzare diverse versioni dell’MPT. Il processo di valutazione Matching Assistive Technology and Child (MATCH) è stato progettato dalla Scherer (1997) all’interno del modello MPT: esso fornisce un approccio centra-to sulla persona per la valutazione della predisposizione individuale all’uso di TA, per i neonati e per i bambini tra 0 e 5 anni di età, con una versione separata per i bambi-ni in età scolare.
Il processo del MATCH consiste in una serie di strumenti progettati per coloro che mirano a ottenere il migliore abbinamento tra il bambino e un supporto tecnologico: i produttori e i valutatori delle TA, i centri di assistenza sociale e familiare, i coordi-natori dei centri ausili, gli psicotecnologi, i terapeuti e i genitori. Altri adattamenti dell’MPT sono stati progettati per affrontare specifiche disabilità o specifiche aree di valutazione, per esempio, il Cognitive Support Technology Predisposition Assessment (Scherer et al., 2012).
3.3 Il processo di valutazione di ta (ata process)La TA gioca un ruolo cruciale nel sostenere l’integrazione sociale delle persone con disabilità. L’ATA process comporta una serie sequenziale e articolata di valutazioni, condotte da esperti con diverse professionalità: un processo di abbinamento di suc-cesso è determinato sia dal modello di valutazione del protocollo sia dalle competen-ze del team multidisciplinare.
62 Capitolo 3
tabella 3.1 Elenco dei principali domini dell’ICF, di alcuni esempi di TA e altre forme di supporto e delle più appropriate misure dell’MPT per la valutazione di ciascun dominio dell’ICF. Liberamente tratto da Scherer e Glueckauf (2005).
ICF: Attività e Partecipazione Esempi di AT e altri supporti Misure dell’MPT
APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE: apprendimento, applicazione delle conoscenze acquisite, pensare, risolvere problemi e prendere decisioni.
Prendere appunti, servizi di sottotitolatura in tempo reale, personal digital assistant (PDA) e computer portatili, dispositivi di registrazione audio, software, calcolatrici elettroniche.
SOTU, ET PA, CST PA, MST
COMPITI E RICHIESTE GENERALI: eseguire compiti singoli o articolati, organizzare la routine e affrontare lo stress.
Assistenza personale, animali da assistenza, temporizzatori, aiuti per la memoria.
ATD PA sezioni B e C
COMUNICAZIONE: comunicazione attraverso il linguaggio, i segni e i simboli, inclusi la ricezione e la produzione di messaggi, portare avanti una conversazione e usare strumenti e tecniche di comunicazione.
Interpreti del linguaggio dei segni, dispositivi di comunicazione elettronici e manuali, periferiche di input e output per il computer, telefoni adattati e dispositivi di messaggistica di testo, radio e televisori adattati e dispositivi di segnalazione e di allarme.
Foglio di lavoro iniziale, utilizzo delle tecnologie, ATD PA Sezione B, HT PA
MOBILITÀ: muoversi cambiando posizione del corpo o collocazione o spostandosi da un posto all’altro, portando, muovendo o manipolando oggetti, camminando, correndo o arrampicandosi e usando vari mezzi di trasporto.
Carrozzine manuali ed elettriche, bastoni e deambulatori, supporti per i trasferimenti, veicoli adattati, ascensori, mappe in rilievo, sistema di posizionamento globale (GPS).
ATD PA Sezioni A e B
CURA DELLA PROPRIA PERSONA: cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del proprio corpo e delle sue parti, mangiare e bere, e prendersi cura della propria salute.
Posate adattate, tappeti antiscivolo, dispositivi robotici, allaccia-bottoni, dosatori di sapone liquido, spazzolini da denti elettrici.
ATD PA Sezioni A e B
VITA DOMESTICA: procurarsi un posto in cui vivere, cibo, vestiario e altri beni di prima necessità, pulizie della casa e sistemare e aver cura degli oggetti personali e di altri oggetti casalinghi e assistere gli altri.
Apribottiglie e lattine, tavoli inclinati, illuminazione adattata, barre di sostegno e rotaie, sistemi di controllo ambientale a distanza o tramite voce.
ATD PA Sezioni A e B
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 63
INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI: esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti per le interazioni semplici e complesse con le persone (estranei, amici, parenti, membri della propria famiglia, partner e persone amate) in un modo contestualmente e socialmente adeguato.
Dispositivi di comunicazione manuali ed elettronici, coach di life skill, ausili sessuali.
ATD PA Sezioni B e C
AREE DI VITA PRINCIPALI: svolgimento dei compiti e delle azioni necessari per impegnarsi nell’educazione, nel lavoro e nell’impiego e per condurre transazioni economiche.
Dispositivi di controllo a distanza, postazioni di lavoro personalizzate, modifiche strutturali, accesso alternativo al computer.
ATD PA Sezioni A e B, altre misure dell’MPT
VITA SOCIALE CIVILE E DI COMUNITÀ: le azioni e i compiti richiesti per impegnarsi nella vita sociale fuori dalla famiglia, nella comunità, in aree della vita comunitaria, sociale e civile.
Dispositivi di segnalazione e di allarme, dispositivi di riduzione del rumore, dispositivi adattati per attività ricreative e di svago, mezzi di trasporto adattati.
ATD PA Sezioni A e B, altre misure dell’MPT
Il processo di abbinamento si svolge in centri specializzati in TA, in cui un team di esperti ha un ruolo di mediazione tra la TA e la persona con disabilità. Nei paesi occidentali questo processo è caratterizzato da due modelli apparentemente contrap-posti: nel primo, più diffuso in alcuni paesi europei (per esempio l’Italia), la persona che ha bisogno di una TA è considerata come un utente/paziente; nel secondo model-lo, più comune nei paesi anglosassoni, la persona è piuttosto un consumatore o clien-te. Questa discrepanza è legata a differenze nelle politiche verso i servizi di assisten-za. Infatti, nel primo caso il centro non vende prodotti, ma fornisce solo assistenza e servizi di valutazione; invece, nel secondo caso il centro ausili può anche produrre e vendere la TA che fornisce. Rispetto al secondo modello, che sottolinea la centralità della soddisfazione del cliente, il primo garantisce un approccio più neutro nella valu-tazione e nell’assegnazione della tecnologia. L’ATA process descrive sia le competen-ze sia le funzioni del team multidisciplinare coinvolto durante il processo di corri-spondenza, e la loro interazione reciproca. L’ATA process può essere letto sia dal punto di vista dell’utente/cliente sia quello del centro ausili (vedi il Paragrafo 3.1).
L’ATA è un processo condotto dall’utente (user-driven) attraverso il quale la sele-zione di uno o più ausili viene facilitata dalla raccolta completa delle misure cliniche, dell’analisi funzionale e dalle valutazioni psico-socio-ambientali che riguardano, in un contesto specifico d’uso, il benessere personale dell’utente, attraverso il miglior abbinamento tra utente/cliente e soluzione assistiva (Scherer et al., 2012).
L’ATA process sotto la lente del modello biopsicosociale dell’ICF (vedi il Para-grafo 3.1) è caratterizzato dai seguenti fattori:
64 Capitolo 3
• il modello biopsicosociale dell’ICF è il punto di riferimento dell’ATA process;
• l’utente (attraverso la sua richiesta) cerca una soluzione per uno o più componen-ti dell’ICF: le strutture e le funzioni corporee (condizioni di salute), le attività e la partecipazione, all’interno di un contesto costituito dai fattori personali e ambientali;
• la richiesta dell’utente attiva il processo condotto dall’utente (user-driven);
• il processo user-driven ha inizio con l’ATA per individuare una soluzione assistiva;
• l’individuazione di una soluzione assistiva è facilitata dall’utilizzo di misure cli-niche, da analisi funzionali e da valutazioni psico-socio-ambientali;
• la richiesta degli utenti è soddisfatta con il miglior abbinamento tra utente/cliente e soluzione assistiva (compreso il benessere degli utenti e il raggiungimento del beneficio d’uso della TA).
Il centro ausili, per verificare la soddisfazione dell’utente e il raggiungimento del beneficio, dovrà attivare il supporto e il follow-up. Il benessere dell’utente continua fino a quando la soluzione, con il supporto e il follow-up, rimane un buon abbinamen-to (Scherer et al., 2012).
3.3.1 L’ata process in un centro ausili e in un progetto di riabilitazione
L’ATA è il processo ideale consigliato per un centro ausili pubblico o privato. Tutta-via, alcuni studi evidenziano dati significativi riguardanti l’abbinamento di TA nel campo della riabilitazione (Verza et al., 2006; Federici e Borsci, 2011). Federici e Borsci (2011) hanno condotto uno studio su larga scala sulla soddisfazione e sull’uso di TA all’interno di specifici percorsi pubblici (centri ausili) e nell’ambito di progetti di riabilitazione. Tale indagine ha evidenziato una differenza molto netta tra i due processi, mostrando tassi di abbandono significativamente differenti: in caso di per-corsi specifici, il tasso di abbandono è stato di circa il 25% (al di sotto delle medie internazionali, che mostrano tassi di circa il 30%; tuttavia, se si considerano solo gli apparecchi acustici e i montascale, le percentuali di abbandono si allineano con quest’ultimo dato). D’altra parte, nel caso di progetti di riabilitazione, il tasso di abbandono scende al 12%. Inoltre, in percorsi specifici non all’interno di un servizio di riabilitazione dedicato, esiste una grande variabilità per quanto riguarda i processi di assegnazione; ciò evidenzia l’esistenza di molti processi possibili nell’assegnazio-ne di TA. L’ATA process consente una standardizzazione generale dei processi in grado di indicare gli elementi essenziali in un percorso di successo di abbinamento. In realtà, nell’analisi di Federici e Borsci, emerge chiaramente l’assenza di alcuni passaggi indispensabili a raggiungere una buona corrispondenza tra utente e TA nei processi analizzati. In particolare, tutti i processi registrati in questo ambito non con-siderano come parte del processo di valutazione un servizio di follow-up della valu-tazione stessa, in grado di gestire i problemi e le frustrazioni degli utenti. La mancan-
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 65
za di follow-up nei servizi è uno dei principali fattori che possono causare l’abbando-no di ausili/TA nei centri ausili.
Secondo un altro studio condotto nel campo della riabilitazione, emerge un altro fattore rilevante, relativo a un basso tasso di abbandono (Verza et al., 2006). Si veri-fica una riduzione del tasso di abbandono del 28% (dal 37,5% al 9,5%) quando nella valutazione per l’individuazione di TA interviene un team multidisciplinare (fisiote-rapista, terapista occupazionale, fisiatra e psicologo) e quando nel processo di abbi-namento delle TA vengono coinvolti direttamente l’utente e il suo ambiente di vita.
Nello stesso studio, la possibilità di utilizzare strumenti di misura per la predispo-sizione all’uso di TA, come l’MPT, viene considerata un ulteriore fattore di riduzione dell’abbandono. L’importanza del ruolo dell’ambiente domestico e personale nell’uso della tecnologia abbinata (ausilio/TA) e nel raggiungimento di un’esperienza soddi-sfacente con la TA è stata sottolineata anche da Pasqualotto e collaboratori (2011).
L’ATA process definisce le linee guida del processo di assegnazione di una TA e tiene conto sia dell’intervento di un team multidisciplinare (con il coinvolgimento dell’utente e del suo ambiente), sia dei servizi di supporto e di follow-up, strettamen-te correlati alla necessità di rivalutare l’uso della TA nel tempo.
3.4 Il processo dell’MPt e quello di valutazione delle ta
Il processo dell’MPT permette la misurazione e la valutazione dell’abbinamento tra utente e TA mediante diversi strumenti di misura contenuti all’interno del modello (SOTU, ATD-PA, CST-PA, ET-PA, WT-PA e HCT-PA). D’altra parte, l’ATA process è un sistema per l’organizzazione dell’abbinamento della TA all’interno di un centro ausili, che consente ai suoi professionisti di controllare e gestire passo dopo passo l’articolazione del percorso in cui è coinvolto l’utente, per ottenere l’abbinamento ottimale. In parte, il processo dell’MPT coincide o, meglio, opera all’interno dell’A-TA process, in quanto entrambi hanno come obiettivo l’abbinamento ottimale tra utente e TA: tuttavia, il processo MPT è un metodo di valutazione con misure speci-fiche, mentre l’ATA process è la descrizione del processo che guida l’assegnazione della TA. L’ATA process può quindi accompagnare l’effettivo sviluppo di un proces-so di abbinamento mediante l’MPT. Il modello alla base dell’MPT e dell’ATA pro-cess è lo stesso, cioè un modello user-centered, che si basa su un modello biopsico-sociale di disabilità (l’ICF). Quello che cambia sono le prospettive: il processo del-l’MPT descrive ciò che dovrebbe essere misurato, mentre l’ATA process indica come un centro ausili dovrebbe essere organizzato nella gestione della valutazione per l’abbinamento tra utente e TA. In particolare, l’ATA process fornisce le informazioni e le linee guida per quanto concerne il setting, i professionisti ai quali l’utente deve rivolgersi, le informazioni da raccogliere, la gestione del centro ausili, il team multi-disciplinare coinvolto nel processo di abbinamento e così via. All’interno di questa impostazione strutturata e multidimensionale, l’MPT si adatta come un modello, come uno strumento di valutazione e come una “misura dell’outcome” della corri-spondenza raggiunta. Il modello MPT alla base dell’ATA process consente l’utilizzo
66 Capitolo 3
di una serie di misure che assicurano un approccio centrato sulla persona in grado di individuare le migliori TA adatte alle esigenze dell’utente. Questo obiettivo può esse-re raggiunto attraverso un approccio in cui l’utente/cliente e il professionista del team multidisciplinare collaborano durante il processo di valutazione. Nell’ambito dell’A-TA process, i diversi elementi forniti dall’MPT possono essere efficacemente utiliz-zati dal team multidisciplinare per determinare le aspettative dell’utente/cliente e definirne gli obiettivi (Initial Worksheet and History of Support Use), per effettuare ricerche sulle tecnologie utilizzate e analizzarne la soddisfazione d’uso (Survey of Technology Use, SOTU) e infine per eseguire valutazioni sulla predisposizione all’u-so di TA da parte dell’utente/cliente (Assistive Technology Device Predisposition Assessment, ATD-PA).
In questo modo, l’ATA process è in grado di guidare il lavoro all’interno di un centro ausili, permettendo ai professionisti di monitorare regolarmente tutti i fattori che promuovono il benessere personale dell’utente/cliente, attraverso la migliore combinazione dei loro bisogni con le soluzioni assistive. Allo stesso tempo permette di identificare e superare gli ostacoli che potrebbero avere un impatto negativo sul processo di assegnazione, come per esempio:
• la mancanza di risorse finanziarie per l’acquisto, la valutazione, il test e la forma-zione sulle TA;
• la presenza di un team multidisciplinare composto da professionisti che non siano stati precedentemente preparati/formati a cooperare durante il processo di abbi-namento e ad assistere l’utente/cliente della TA;
• un processo di valutazione che non consideri le esigenze dell’utente/cliente, le sue priorità, le sue preferenze, e non lo coinvolga nella scelta della TA.
Il modello MPT si propone di aiutare i professionisti a ottenere il miglior abbinamen-to utilizzando diverse misure validate nel contesto biopsicosociale (Scherer e Sax, 2010). Sia il processo sia le misure contribuiscono alla promozione del benessere personale dell’utente/cliente, individuando le migliori TA all’interno di un sistema ben definito, con professionisti formati e in un ambiente completamente centrato su un modello condotto dall’utente (user-driven).
3.5 ConclusioniSecondo la Scherer (2002) solo attraverso una valutazione approfondita possono emergere:
• la necessità di modificare l’ambiente o di supportarlo per permettere l’uso degli ausili/delle TA;
• l’impatto delle limitazioni, quali barriere alle attività e alla partecipazione nella vita quotidiana e nello svolgere quanto desiderato;
Misurare l’abbinamento delle tecnologie assistive 67
• l’equilibrio tra le capacità funzionali e le limitazioni;
• la necessità di formazione e di contesti di prova all’uso (casa, scuola, lavoro);
• la TA più conveniente per l’utente in termini di usabilità ed estetica;
• la misura in cui, attraverso un follow-up, la TA soddisfi le esigenze del consuma-tore e l’esistenza di eventuali effetti collaterali indesiderati.
L’obiettivo finale del processo di assegnazione di una TA è quello di migliorare il funzionamento e la qualità della vita di una persona con disabilità e di molti altri individui; “qualità della vita” indica benessere e, in senso generale, “tutto l’universo dei domini della vita umana, inclusi aspetti fisici, mentali e sociali, che costituiscono quella che può essere chiamata una ‘buona vita’” (OMS, 2002, p. 167). Se la TA non esegue questa funzione, non sarà, o meglio non dovrebbe essere, utilizzata. Impiega-re il processo dell’MPT all’interno dell’ATA process può aiutare i professionisti a ottenere una migliore corrispondenza tra utente e TA, e quindi può portare a una riduzione dell’abbandono delle TA.