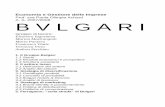L’acquedotto delle Fontane Secche a Bagnoregio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of L’acquedotto delle Fontane Secche a Bagnoregio
17ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
di Valerio Chiaraluce*
L’acquedotto delle Fontane Secchea Bagnoregio
Un sistema idraulico romano sotto la collina
SUMMARY. The “Fontane Secche”, aqueduct at Bagnoregio. This paper reports the results of investigations carried out in 2005 by the Cultural Association “Toward Sky” on the aqueduct “Fontane Secche” at Bagnoregio, Viterbo, Italy. The aqueduct consists of a system of galleries excavated at different levels in the tufa rock in order to feed a fountain located just outside the urban area. The aqueduct was in service for a very long time and five different stages can be recognized in its history, going from Roman times up until the 18th century. In the galleries of the lowest level, a series of numerals and lines incised on the walls are connected with the levelling of the tunnel that was carried out in 1556 by the Orvietan architect Ippolito Scalza.
La cittadina di Bagnoregio si sviluppa sulla som-mità di uno sperone tufaceo di forma allungata delimitato sui due versanti da pareti verticali in-cise dai torrenti Rio Chiaro (o Vecchio) e Rio Tor-
bido. Il luogo, grazie alla sua posizione facilmente di-fendibile, divenne sede di un insediamento già in età preromana; infatti fu sufficiente realizzare un fossato sull’unica via di facile accesso all’inizio del pianoro per
difendere una vasta area pianeggiante di circa 30 et-tari. Sull’estrema propaggine del masso tufaceo sor-ge Civita (Fig. 1), l’insediamento più antico, difeso da un ulteriore fossato e da una porta fortificata. Questa contrada un tempo era collegata al resto del pianoro da una lingua di terreno oggi completamente franata a causa del dissesto idrogeologico che colpisce tutta l’area. Il grande baratro che separa Civita da Bagnore-
Fig. 1. Veduta di Civita di Bagnoregio. In primo piano la contrada Mercatello.
*Archeologo. [email protected]
18 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
gio non fa parte quindi del paesaggio antico: proprio in quel luogo in epoca medioevale sorgevano alcuni importanti complessi quali la rocca di Castelgomizi, il convento di S. Francesco e la contrada di Mercatello, dove si trovava il palazzo comunale e dove si svolgeva il mercato cittadino. (Fig. 2) Al di là del baratro e di un’area oggi non edificata sotto la quale si sviluppa il complesso di gallerie oggetto di questo studio si tro-va la contrada Rota dove sorge l’abitato di Bagnore-gio vero e proprio. Gli abitanti delle diverse contrade hanno formato sempre un’unica comunità che, alme-no dal VI sec d.C., si riconosceva nel nome di Balneum Regis, attestato per la prima volta in un’epistola di S. Gregorio Magno.
Dopo la caduta dell’impero romano Bagnoregio subì il dominio dei Goti e quindi dei Longobardi; entrò infine a far parte del Patrimonio di S. Pietro nella Tuscia. Durante la fase feudale la cittadina vide una potente famiglia di conti esercitare la propria egemonia che ebbe fine soltan-to verso la metà del XII sec. quando Bagnorea, questa era la forma corrente in quei secoli, si costituì Libero Comu-ne. I secoli successivi furono caratterizzati da sanguinose lotte di potere, fra le famiglie Filippeschi e Monaldeschi che perdurarono sino al 1353, quando il cardinale Egidio Albornoz mise fine col suo intervento armato agli annosi conflitti che affliggevano lo Stato della Chiesa e la città in seguito divenne soggetta ad un luogotenente alle di-pendenze del Cardinale Governatore del Patrimonio di
S. Pietro. Negli anni 1695 e 1764 due disastrosi terremoti causarono gravissimi danni alla cittadina e aggravarono ulteriormente le frane che affliggevano la contrada Civita.
La città che muoreDal punto di vista geologico, lo strato più antico e più
profondo è quello delle argille azzurre di sedimentazione marina che sono emerse in superficie alla fine del Plioce-ne a causa dei sollevamenti tettonici. Sopra le argille, già in parte modellate dagli agenti atmosferici, all’inizio del Pleistocene si sono sedimentati, per uno spessore di parec-chie decine di metri, i prodotti delle emissioni piroclastiche dell’Apparato vulcanico Vulsino. Questi sedimenti fitta-mente stratificati e intercalati a colate laviche e sedimenti fluvio - lacustri formano la cosiddetta Serie dell’Albornoz. Sopra quest’ultima si è infine depositata un’imponente colata ignimbritica che ha colmato tutte le depressioni formando una vasta superficie pianeggiante: si tratta del tufo litoide rosso a scorie nere o, più semplicemente, Tufo di Orvieto. Queste tenere rocce vulcaniche hanno permes-so all’uomo di scavare facilmente degli ambienti ipogei per gli usi più disparati: tombe, abitazioni, stalle, acque-dotti, luoghi di culto, ecc. Questa stratificazione geologica ha dato vita ad un enorme fenomeno erosivo ancora oggi in corso, in parte imputabile anche ai disboscamenti effet-tuati dall’uomo. La naturale erosione del suolo, dopo aver demolito in più punti i sedimenti vulcanici ha raggiunto le sottostanti argille producendo un imponente fenome-
Fig.2. Il territorio di Bagnoregio. Il tracciato sommario dell’acquedotto delle Fontane Secche è stato sovrapposto all’imma-gine aerea, tra i versanti di Rio Vecchio e di Calleno.
19ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
no calanchivo. L’esito di questo processo è un paesaggio contraddistinto da plateaux, mesas e guglie i quali hanno come base una scarpata altamente instabile di argilla, al centro una parte molto più ripida corrispondente alla Se-rie dell’Albornoz ed alla sommità un masso tufaceo dalle pareti pressoché verticali (Fig. 3).
Le continue frane che demoliscono i plateaux a parti-re dai loro margini hanno spesso costituito un serio pro-blema: è il caso di Civita di Bagnoregio, definita con un azzeccato slogan turistico «la città che muore», isolata dal resto del pianoro da un grande fenomeno franoso e con-tinuamente sottoposta alla minaccia di nuovi cedimenti ai quali si è cercato di porre rimedio con moderne opere di consolidamento. Le acque meteoriche che precipitano sulle argille non vengono assorbite e ruscellando in super-ficie contribuiscono ad aumentare i fenomeni erosivi. Al contrario i tufi, vere e proprie spugne di roccia, assorbono velocemente l’acqua piovana che viene raccolta in una fal-da posta appena al di sopra delle argille. Ne consegue che le uniche sorgenti si formano dove affiora in superficie il punto di contatto tra tufi permeabili e argille impermea-bili.
L’approvvigionamento idrico di Bagno-regio
L’assenza di sorgenti naturali sul pianoro ha reso problematico l’approvvigionamento idrico dell’inse-diamento di Bagnoregio; per garantire quindi una costante disponibilità d’acqua si dovette ricorrere a di-
versi espedienti. Oltre alle cisterne per la raccolta delle acque piovane e ai pozzi che forano la rupe per decine di metri sino a raggiungere la profonda falda freatica, vennero anche realizzati tre acquedotti: l’acquedotto del Cannellone risalente al sec. IV che riforniva l’abita-to di Rota, l’acquedotto sottostante Civita che portava l’acqua di una piccola sorgente situata sotto la parete nord della rupe e l’acquedotto delle Fontane Secche, oggetto di questo studio (Fig. 2).
Quest’ultimo è costituito da un imponente com-plesso di cunicoli articolati su due livelli per uno svi-luppo complessivo di 992 m, che attraversa la rupe di Bagnoregio da parte a parte, costruito per alimentare una fonte extraurbana vicina alla città. L’acqua che si trovava sul lato settentrionale della rupe è stata con-dotta sul versante opposto, più facilmente raggiun-gibile e adatto alla coltivazione ad orticoltura. Non è facile dire se quest’acqua venisse captata da una sor-gente che si trovava alla base della rupe o provenisse direttamente dall’alveo del torrente; è probabile che le due soluzioni siano state adottate alternativamente nel corso dei secoli.
L’origine dell’acquedotto è di epoca romana; da al-lora, alternando fasi di abbandono a fasi di rinnovata funzionalità, è rimasto in uso almeno sino a tutto il XVIII sec. Il grave degrado idrogeologico che colpisce l’area ha provocato nel corso dei secoli l’approfondi-mento di alcune decine di metri dell’alveo del Rio Vec-chio e in parte anche l’abbassamento del livello della
Fig.3. Sezione della rupe di Bagnoregio con indicazione delle diverse facies geologiche. Le linee tratteggiate in nero indi-cano il progessivo abbassamento del suolo dovuto ai fenomeni erosivi. Le linee tratteggiate in blu indicano i livelli della falda.
20 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
falda freatica interna alla rupe, lasciando a più riprese le Fontane Secche all’asciutto.
Per ovviare a ciò in epoche diverse si resero neces-sari approfondimenti dello speco del cunicolo, la rea-lizzazione di nuove opere di presa e addirittura, nel XVI sec., lo scavo ex novo di un’altra galleria più pro-fonda. Caduto in disuso probabilmente nel corso del XIX sec., l’acquedotto venne ben presto dimenticato sino al 1970 quando lo studioso Eletto Ramacci assieme ad un gruppo di giovani appassionati di archeologia disostru-irono l’ingresso principale del complesso e ne percorse-ro il livello inferiore. Successivamente una piccola frana causata dal lavoro di scavo degli istrici ostruì nuovamen-te l’accesso all’ipogeo sino all’ottobre 2004 quando gli speleologi di Toward Sky, seguendo le indicazioni degli abitanti del luogo, riuscirono a penetrare di nuovo all’in-terno e a realizzare il rilievo delle gallerie.
L’acquedotto romanoL’ipotesi che i più antichi tratti di galleria dell’acque-
dotto risalgano ad epoca romana si basa essenzialmente sulla loro sezione di forma ogivale, comune a molti altri cunicoli romani e preromani scavati nei tufi dell’alto La-zio e dell’Etruria meridionale. La regolarità meccanica dei colpi di piccone e l’assenza assoluta di iscrizioni sulle pa-reti sono elementi ricorrenti in questo tipo di ipogei che lasciano immaginare l’utilizzo di manodopera altamente specializzata ma con un basso livello culturale. La preci-sione con cui gli orientamenti sono stati calcolati e seguiti anche per centinaia di metri denota invece un’elevata pa-dronanza di complesse tecniche di misurazione strumen-tale.
Lo scavo della galleria principale fu effettuato da due squadre di operai che lavoravano contemporaneamente partendo dai due opposti versanti. Mentre però la squa-
Fig. 4. Le fasi dell’acquedot-to. I tratti realizzati in cia-scuna fase sono disegnati in rosso e sono accompagnati dalle frecce che indicano la direzione di scavo.
21ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
dra che scavava da meridione affrontò perpendicolar-mente la rupe realizzando una galleria perfettamente rettilinea di circa 250 m, i loro colleghi che partivano da settentrione procedettero, sempre in linea retta, per cir-ca 60 m secondo un’angolazione ruotata di 59° rispetto all’altro scavo (Fig. 4A). In questo modo i due cunicoli non potevano non incontrarsi. Quando la distanza che sepa-rava le due gallerie fu di soli 1,5 m dovette avvenire un contatto acustico tra le due squadre di operai e, con un breve tratto di raccordo, si ottenne il congiungimento. La galleria nord risultava 13 m più lunga del necessario, per cui si creò un ramo morto.
A questo punto, per evitare all’acqua di compiere brusche curve che avrebbero potuto innescare pericolosi processi erosivi nel punto di incontro dei due scavi venne realizzato un altro raccordo con andamento più dolce del primo; inoltre si scavò un altro tratto di cunicolo rettilineo che permetteva un collegamento più diretto col versante nord. In questo modo gran parte dell’originaria galleria nord divenne superflua. I vari tratti di cunicolo erano stati scavati ad una quota leggermente differente: a questo in-conveniente si pose rimedio approfondendo e livellando il pavimento lungo tutto il percorso. Ciò naturalmente non avvenne nei tratti della galleria superflui, che sono per noi, assieme ai cambi di quota dei soffitti, utili testimoni per comprendere lo svolgersi dei lavori.
Un altro tratto di galleria di epoca romana è stato individuato sul versante meridionale. Esso si sviluppa per circa 30 m con andamento grossomodo parallelo alle cur-ve di livello, è interrotto alle due estremità da cumuli di detriti ed è raggiungibile oggi solo attraverso un cunicolo più recente che lo ha intercettato (Fig. 4A). È interessan-te notare come anche questa galleria, che probabilmen-te aveva la funzione di condurre l’acqua sino al luogo di utilizzo, formasse un angolo di 59° rispetto alla galleria sud. All’interno di questi cunicoli l’acqua scorreva lungo un’apposita canaletta scavata nel pavimento, oggi visibi-le soltanto in un punto. Non è stato possibile identificare l’opera di presa riferibile a questa fase, probabilmente perché completamente distrutta dalle frane del versante nord assieme alla parte terminale della galleria. Non è fa-cile comprendere per quale finalità fu realizzata una simi-le opera; è però ragionevole ipotizzare che il committente di un’impresa tanto grande e finanziariamente impegna-tiva vada riconosciuto nella comunità locale.
La seconda fase dell’acquedotto: un primo intervento di ripristino
Similmente a quanto riscontrato per i tratti d’epoca romana, anche quelli che risalgono al successivo interven-to sull’acquedotto non hanno restituito elementi utilizza-bili per una datazione precisa. Si può soltanto dire che al
momento in cui questi lavori vennero effettuati l’acque-dotto romano era già caduto in disuso da tempo, eviden-temente perché ormai secco a causa dell’abbassamento della falda freatica. La sezione della galleria che tende alla forma rettangolare è una caratteristica comune ad altri cunicoli di epoca medioevale della zona. Va anche notato come questi nuovi scavatori fossero meno abili di quelli che li avevano preceduti: le loro gallerie, infatti, sono un continuo susseguirsi di curve, significative di una costante incertezza riguardo alla direzione da seguire (Fig. 4B).
Prima di tutto fu necessario individuare il tracciato del cunicolo romano di cui non si conosceva più la posizione esatta. Fu scavata quindi una galleria che, dopo essere entrata perpendicolarmente nella rupe per una decina di metri, si divideva in due rami con direzione opposta a for-mare una pianta simile alla lettera «T», sperando in que-sto modo di intercettare l’antico acquedotto. Lo scopo fu raggiunto dal ramo diretto a ovest, anche se il cunicolo romano si rivelò essere ad una quota più bassa di 3 m ri-spetto allo scavo effettuato.
Penetrati nel cunicolo gli scavatori si resero conto che la sorgente del Rio Vecchio non alimentava più la galleria ma una certa quantità d’acqua percolava dalle pareti in un punto, a poca distanza dall’ingresso, laddove nel tufo era presente una faglia inclinata di 45° che metteva a con-tatto uno strato poroso con uno impermeabile. Per por-tare all’esterno quest’acqua venne realizzato un bypass che superava un tratto dell’acquedotto romano, in parte franato e in parte ostruito dai sedimenti accumulatisi in mancanza della regolare manutenzione. Lungo il percor-so venne realizzata una canaletta pensile scavata nella pa-rete del cunicolo che aveva la funzione di captare l’acqua di percolazione e di trasportarla all’esterno nello stesso luogo dove arrivava in epoca romana, probabilmente per alimentare una fontana.
L’acquedotto medioevaleLa soluzione adottata non risolveva il problema: l’ac-
qua di percolazione che veniva catturata con la canaletta pensile era infatti poca cosa rispetto a quella che sarebbe potuta arrivare dal Rio Vecchio se l’acquedotto fosse sta-to completamente riattivato. Una città in rapida crescita come la Bagnoregio del XIV sec. necessitava di acqua in abbondanza; perciò in questo periodo l’acquedotto fu oggetto di lavori che lo rimisero in funzione (Fig. 4C). La fonte realizzata in occasione di questi lavori può essere identificata con la Fons Rei citata nello statuto cittadino del 1373.
Dalla lettura dello statuto si possono ricavare interes-santi notizie riguardo all’utilizzo dell’acqua della fontana: sappiamo che una vasca fungeva da abbeveratoio; che era vietato lavare i panni nella fontana e di stenderli ad
22 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
asciugare a meno di quattro piedi da essa; che soltanto nel periodo della vendemmia vi si potevano lavare i tini desti-nati alla vinificazione e che l’acqua assieme a quella della vicina fonte di Calleno era utilizzata per l’irrigazione de-gli orti. Infine in un altro passo dello statuto si parla delle «case dei calzolai» situate in contrada Calleno: evidente-mente l’acqua delle due fonti veniva anche utilizzata per la concia delle pelli.
Per far fronte all’abbassamento della falda il fondo dell’originale cunicolo romano e di parte del bypass fu approfondito di circa 2,30 m. In questo modo lo speco approfondito assumeva una singolare sezione allungata molto irregolare (Fig. 5) che in alcuni punti (in quel trat-to del bypass che aveva già subito un approfondimento a causa dell’errore di quota di cui si è detto a proposito della seconda fase) presenta un’altezza di ben 8,60 m. L’abbas-samento di quota implicava necessariamente anche la re-alizzazione di una nuova fontana più in basso sul pendio, rifornita da una breve galleria che si innesta sul bypass.
Dove la galleria formava una doppia curva, nel punto corrispondente a quello in cui si erano incontrate le due squadre di scavatori, venne realizzata una canaletta scava-ta nel pavimento, coperta da lastroni di basalto o di tufo per evitare che l’acqua erodesse le pareti in coincidenza dei cambi di direzione. All’estremità della galleria verso il
Rio Vecchio venne anche realizzata una complessa opera di presa formata da due gallerie che si dipartono dal ramo principale formando una pianta a forma di tridente. L’ac-qua doveva arrivare dal ramo rivolto verso ovest oggi par-zialmente ostruito. Un sistema di canalette di lastre di ba-salto e blocchi di tufo situato all’incrocio dei tre rami, solo in parte visibile a causa dell’interro, permetteva mediante delle chiuse di scegliere se convogliare il flusso dell’acqua verso l’acquedotto o verso il ramo rivolto ad est che lo sca-ricava all’esterno, nel fosso. In questo modo era possibile interrompere l’erogazione dell’acqua quando si effettua-vano interventi di manutenzione dell’acquedotto.
Al contrario di chi li aveva preceduti, le persone che lavorarono nel cunicolo in questo periodo riempirono le pareti con decine di simboli, segni, immagini; mancano in-vece del tutto le iscrizioni (Fig. 6, nn. 1-13). Lungo la pare-te ovest sono state tracciate con uno stilo appuntito delle linee orizzontali servite per livellare il fondo della galleria secondo una corretta pendenza. All’altezza della linea di livellazione si concentrano gli altri simboli incisi sul tufo non profondamente e con tratto veloce. Si tratta essen-zialmente di stelle a cinque punte, a volte isolate, a volte raccolte in gruppi di quattro o cinque attorno alle nicchie delle lucerne e di alcune figure a forma di mandorla o di picche. Meritano attenzione un grande scudo diviso in quattro campi da una croce, tracciato con la calce sulla parete della galleria (Fig. 6, n. 2), e uno stemma scolpito a bassorilievo nel tufo (Fig. 6, n. 1; fig. 7). Quest’ultimo è formato da uno scudo di tipo torneriale (in alto a sinistra è presente l’incavo utilizzato per alloggiare la lancia duran-te i tornei) partito in due campi da una merlatura guelfa che l’attraversa orizzontalmente.
L’acquedotto rinascimentaleNel settembre del 1540 Papa Paolo III si recò in visita
alla comunità di Bagnoregio. Il Papa pranzò in campa-gna, assieme al suo seguito, in luogo detto «le Fontane Secche». In quell’epoca, infatti, aveva già avuto origine il toponimo ancora in uso con cui veniva indicata la vecchia Fons Rei caduta in disuso. La fontana è ancora in stato di abbandono nel 1550 quando il consiglio cittadino delibe-ra di condurre l’acqua del Rio Vecchio attraverso l’antico cunicolo delle Fontane Secche sino al nuovo mulino. Dun-que, almeno in questo periodo storico, l’acqua doveva es-sere attinta direttamente dall’alveo del torrente e non da una sorgente. In realtà il vecchio cunicolo non fu ristruttu-rato ma se ne scavò uno nuovo ad un livello più basso. Evi-dentemente ci si rese conto che un ulteriore approfondi-mento dello speco avrebbe provocato rovinosi crolli (Fig. 4D). Sei anni dopo la galleria era quasi completata perché veniva incaricato l’architetto orvietano Ippolito Scalza di effettuarne la livellazione. Nel 1563 Ioddo di Ildribando
Fig. 5. Un tratto della galleria superiore. In alto è visibile l’originario speco di epoca romana a sezione ogivale e al di sotto l’approfondimento del sec. XIV.
23ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
ricevette dal consiglio cittadino l’in-carico di fontaniere della Fonte di Ci-vita. Questo toponimo sostituì quel-lo vecchio, Fontane Secche, non più corrispondente alla realtà.
Anche il nuovo cunicolo fu inizia-to partendo contemporaneamente dai due opposti versanti. L’idea ori-ginale forse prevedeva due gallerie con orientamento leggermente dif-ferente che si sarebbero dovute con-giungere all’incirca a metà strada, ma vennero effettuati degli errori di misurazione e, nel tentativo di correggerli venne cambia-ta più volte la direzione dello scavo. Questo procedere per tentativi fece sì che sia la galleria sud che quella nord in-tercettassero ad un certo punto il vecchio cunicolo; è lecito immaginare che per mezzo di questo sia stata effettuata una precisa misurazione della distanza che separava i due scavi permettendo il completamento della galleria infe-riore mediante un grande raccordo a forma di «S». Nel punto di incontro si riscontra un dislivello di 1,89 m nel soffitto: la galleria nord era infatti più in alto dell’altra.
A questo punto il pavimento che, a causa dei vari errori in cui si era in-corsi doveva presentare due grandi dossi, venne livellato facendo ricorso al complesso sistema di linee, di cui si parlerà più avanti.
Gli operai realizzarono, a di-stanza regolare lungo tutto il tra-gitto, una serie di grandi nicchie che consentivano il passaggio delle carriole nei due sensi. Lungo tutto il percorso venne realizzata una cana-letta scavata nel pavimento, situata,
a seconda dei tratti, sul lato sinistro, sul destro o al cen-tro. Nel tratto del raccordo ad «S» la canaletta fu coperta con blocchi di tufo; ancora una volta simili apprestamenti sono limitati ai tratti non rettilinei del percorso. Da questa zona provengono anche quattro tubuli troncoconici, due dei quali ancora integri, che sono un interessante indizio della presenza di una tubatura oggi non più esistente. All’estremità verso il Rio Vecchio venne realizzata un’ope-ra di presa analoga a quella del ramo superiore, a cui fu collegata. Sullo stesso sito della precedente, ma ad una
Fig. 6. Graffiti, incisioni e raffigurazioni eseguite con malta di calce pre-senti sulle pareti dell’ac-quedotto (nn. 1-13, raffigurazioni risalenti al sec. XIV; n. 14, cifre della livellazione realizzate da Ippolito Scalza nel 1556; nn. 15-21 altre raffigura-zioni e iscrizioni risalenti probabilmente al sec. XVI; nn. 22-41 raffigura-zioni e iscrizioni dei secc. XVII-XX).
Fig. 7. Stemma inciso nella parete dell’approfondimento medievale della galleria superiore.
24 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
quota più bassa, venne edificata la fontana, visibile an-cora oggi, composta da tre grandi archi in blocchi di tufo (Fig. 8). Durante questa fase furono incisi sulle pareti mol-tissimi simboli e scritte: soprattutto croci e lettere legate, evidentemente iniziali di nomi propri. Alcune figurazioni meritano maggiore attenzione: presso una nicchia com-pare il simbolo del Monte di Pietà (Fig. 6, n. 19), istituzio-ne attestata a Bagnoregio già nel 1523; a poche decine di centimetri è presente una raffigurazione del Golgota (Fig. 6, n. 20).
La livellazione di Ippolito ScalzaLa livellazione effettuata da Ippolito Scalza merita
un’attenzione particolare per l’eccezionale abbondanza dei dati in nostro possesso. Una brevissima nota vergata su un registro della contabilità del Comune di Bagnoregio alla data 1 febbraio 1556 recita così: «2 scudi ad Ippoli-to Scalzo per olivellare il cunicchio della Fonte di Civita» Si tratta del noto architetto e scultore orvietano Ippolito Scalza, formatosi artisticamente a Roma, dove sembra sia stato in buoni rapporti con Michelangelo, e che tornò poi alla sua Orvieto dove per molti decenni operò al servizio
dell’Opera del Duomo. Alla notizia d’archivio corrispon-de il dato reale della presenza di un complesso sistema di linee e di numeri incisi nel tufo delle pareti del livello inferiore dell’acquedotto delle Fontane Secche, sistema evidentemente utilizzato per livellare il fondo del cunico-lo. Le linee sono state tracciate seguendo un filo teso tra due punti presi sulla parete alla stessa quota con l’ausi-lio di uno strumento che permetteva di battere dei livelli orizzontali.
Nel 1587 lo Scalza realizzò una statua di San Tommaso da collocarsi nel Duomo di Orvieto, statua che è universal-mente riconosciuta come il suo autoritratto. L’architetto poneva in mano alla statua una squadra, un regolo ed un compasso, mentre ai suoi piedi realizzava nel marmo la copia di due strumenti topografici: un teodolite e un quadrante d’altezza (Fig. 9). È del tutto lecito riconoscere in queste figure la riproduzione fedele degli attrezzi real-mente appartenuti allo Scalza, quelli che lui utilizzava an-che per le misurazioni ipogee. Il quadrante d’altezza (raf-figurato in verticale nella statua) è un semplice strumento affine al moderno clinometro, conosciuto già all’inizio del sec. XIII, che permette di misurare le pendenze e quindi
Fig. 8. Le Fontane Secche nello stato attuale.
25ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
anche di battere un piano orizzontale; è costituito da un quarto di circonferenza, in legno o in metallo, sul quale è riportata una scala goniometrica che va da 0 a 90 gradi. Su uno dei suoi lati sono applicate due pinnule con dei forellini che fungono da traguardo ottico. L’inclinazione della retta che corrisponde all’asse di osservazione viene letta sulla scala graduata per mezzo di un filo a piombo che funge da indice: quando il lato con le pinnule viene tenuto perfettamente orizzontale il filo a piombo indica il valore 0°.
Il fatto che le linee di livellazione si trovino nella pare-te est nel tratto meridionale della galleria e in quella ovest in quello settentrionale e che il passaggio tra le due pareti avvenga proprio nel punto di congiungimento degli scavi provenienti dagli opposti versanti è per noi un utilissimo indizio a favore dell’avvenuto utilizzo di un simile stru-mento nell’acquedotto delle Fontane Secche. Con il qua-drante d’altezza, infatti, ad un cambio della direzione del puntamento corrispondeva necessariamente un cambio
della parete d’appoggio, poiché era necessario accosta-re sempre lo strumento alla propria destra, per impedire che il lato con il filo a piombo venisse a trovarsi contro la parete stessa rendendo impossibile la lettura. Il cambio di direzione è spiegabile se si immagina che le operazioni di livellazione si siano svolte a scavo ultimato, iniziando dal punto di incontro dei due tratti di galleria, dove l’errore di quota tra l’una e l’altra era evidente sotto forma di scalino sul pavimento e sul soffitto ed era facilmente misurabile. Da questo punto centrale, dopo aver scelto due quote sul-la parete in modo tale che i piani orizzontali passanti per esse fossero utilizzabili ciascuna in uno dei tratti di galle-ria, si procedette alla livellazione nelle opposte direzioni.
Nel tratto di galleria scavata da sud, lungo la linea, si è riscontrata la presenza di una serie di numeri graffiti nel tufo che, ad un’attenta analisi, si sono rivelati essere dei valori di distanza espressi in canne orvietane (1 canna orvietana = 2,68 m). All’ingresso sud era stato fatto cor-rispondere il valore «60» (non conservato); dopo 26,80
Fig. 9. Particolare degli attrezzi raffigurati ai piedi del S. Tommaso di Ippolito Scalza. Le pinnule del quadrante d’altezza (non visibili nella foto) si trovano dalla parte opposta dello strumento.
26 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
m lungo il cunicolo si incontra il valore «50»; sempre alla stessa distanza erano posti il «40» (Fig. 10), il «30» (non conservato), il «20» ecc. Nell’ultima parte di questo conto alla rovescia la numerazione è segnata non più di dieci in dieci ma ad ogni canna. Si ha quindi una serie numerica continua dal «23» allo «0» («0», «1» e «2» non conservati, «22», «20» e «6» ripetuti due volte in verticale). Lo «0», doveva cadere precisamente nel punto in cui la galleria definitiva si distacca dal primitivo percorso con direzione e quota errati. Da qui la numerazione ricomincia in positivo: troviamo di nuovo il «10» e poi il «20»; il punto di con-giunzione tra i due scavi corrispondeva circa al numero «30» che non si è conservato. Poiché il cunicolo aveva, se pur minima, una sua pendenza, mentre la linea era per-fettamente orizzontale, nel tratto sud si rese necessario ogni tanto abbassare la linea di un po’ sulla parete secon-do il metodo della coltellazione. In due casi si è riscontrata la presenza di numeri indicanti la quota a cui si trovava la linea, espressa forse in doppie once, sopra il livello ini-ziale dell’ingresso sud (1 oncia = 1/144 di canna orvietana = 1,86 cm, 1 doppia oncia = 3.72 cm): si tratta delle cifre «25» e «50». Questo complesso sistema di segni servì da
riferimento quando fu data al fondo della galleria la giu-sta pendenza per un buono scorrimento dell’acqua. Era precetto diffuso tra gli architetti di quell’epoca controllare tali pendenze proprio a distanze di 10 canne. Biringuccio da Siena nel suo «De la Pirotechnia», data alle stampe per la prima volta nel 1540, raccomanda: «et per facilitar l’u-scita dell’acque et il portar delli operai, ogni dieci canne andar con la cava sagliendo dolce dolce un mezzo braz-zo».
Nel tratto del cunicolo scavato da nord non è pre-sente una serie di numeri analoga a quella presente nel tratto sud. Il motivo della loro assenza risulta chiaro ad una attenta analisi della linea tracciata sulla parete, infatti questa non è perfettamente orizzontale come le altre, ma leggermente inclinata secondo valori di pendenza mol-to vicini a quelli indicati da Biringuccio. La linea è stata tracciata già con l’inclinazione che si voleva dare al fondo della galleria e per questo motivo non sono state indicate le distanze e le quote, necessarie soltanto se si effettua un calcolo indiretto della pendenza. In pratica lo Scalza scelse in questa parte del lavoro di saltare un passaggio. D’altra parte il quadrante d’altezza permetteva di misurare diret-
Fig. 10. Una delle cifre incise nella parete del cunicolo inferiore da Ippolito Scalza nel 1556.
27ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
tamente qualsiasi pendenza. Tale metodo era forse meno preciso, ma sicuramente di più semplice e veloce applica-zione.
Si ritiene che il lavoro di Scalza sia stato eseguito quando lo scavo della galleria era ormai completato, pro-babilmente in un tempo molto breve. La cifra di due scudi versata come compenso è indicativa al riguardo, essa può essere confrontata con altre parcelle pagate all’architetto per prestazioni a noi note. Nel 1597 l’architetto ricevette 10 scudi per 6 giornate di lavoro presso il cantiere della chiesa del Crocefisso a Todi; due scudi corrispondeva-no quindi a una, massimo due, giornate lavorative. Non sappiamo se il suo operato si limitò alla sola livellazione o se esso ebbe un qualche ruolo anche nello scavo della galleria; i numerosi errori in cui si incorse in quella fase dei lavori tenderebbero ad escludere questa eventualità. Più probabilmente lo scavo fu condotto in maniera piut-tosto empirica da qualche maestranza locale. È comunque interessante notare come il teodolite munito di bussola scolpito ai piedi del San Tommaso rappresenti quanto di meglio la tecnologia di allora potesse fornire per le misure di topografia sotterranea.
Ultimi interventi sull’acquedottoL’ultimo statuto del Comune di Bagnoregio, rimasto
in vigore dal 1786 al 1856, testimonia come la Fonte di Civita fosse ancora in funzione in quel periodo. In questi secoli venne effetuata tutta una serie di interventi minori sull’acquedotto. Lungo parte della galleria inferiore una canaletta realizzata con dei coppi murati sostituì quella originale scavata nel pavimento. I muretti a secco, utilizza-ti per contenere all’interno delle grandi nicchie del livello inferiore il deposito terroso asportato dalle canalette, te-stimoniano il lavoro assiduo dei fontanieri di cui parla lo statuto. La loro attività risulta evidente anche in tutti quei punti della galleria inferiore dove, pur essendosi verificati dei distacchi sulle pareti e sul soffitto, non si riscontra a terra nessuna traccia di materiale di crollo. Numerose iscri-
zioni, sigle, disegni, non sempre chiari nel significato, fu-rono tracciati dagli addetti ai lavori nella galleria inferiore; meritano particolare interesse una firma «IOVINCQUIAZO VOLCHI 1701» (Fig. 6, n. 23) e la raffigurazione di una co-lomba con un rametto d’olivo nel becco vicina ad un altro uccello, probabilmente un falco (Fig. 6, n. 22).
Non sappiamo quando, forse dopo che il livello infe-riore cessò di funzionare, la parte terminale del cunicolo superiore venne riattivata in modo da sfruttare l’acqua che percolava dalle sue pareti, soluzione questa già adot-tata al tempo della seconda fase. Venne realizzata una grande nicchia a metà della parete est nel punto in cui il flusso d’acqua era maggiore; da questa nicchia l’acqua ve-niva raccolta in una vasca monolitica di tufo e incanalata sino all’esterno mediante una conduttura in tubi di terra-cotta incassata nel pavimento. In questa zona sono stati raccolti numerosi frammenti di tubuli abbandonati sul pa-vimento del cunicolo. Dall’esame delle linee secondo cui è avvenuta la rottura e dalla presenza su di essi di tracce di calce risulta evidente che essi erano un tempo parte inte-grante della conduttura e che furono in seguito sfondati dal di fuori, probabilmente per rimuovere otturazioni presenti al loro interno.
Quando l’acqua venne nuovamente a mancare tor-nò in uso di nuovo l’antico toponimo «Fontane Sec-che» che evidentemente non era andato mai del tutto dimenticato. La galleria abbandonata divenne allora meta di gruppi di curiosi che penetravano all’interno lasciando i loro nomi incisi sulle pareti e forse proprio per evitare queste visite l’ingresso sul versante meri-dionale venne murato. Il progresso tecnologico stava cambiando rapidamente l’ordine delle cose provocan-do la fine di consuetudini rimaste pressoché immuta-te per migliaia di anni. Nel 1927 venne inaugurato il nuovo acquedotto dotato di pompe meccaniche che riforniva tutte e tre le contrade di Civita, Mercatello e Rota; dopo questa data le vecchie fontane erano anco-ra utili, ma non più indispensabili.
28 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
Bibliografia
AA. VV., 1970. Carta geologica d’Italia nel-la scala di 1:100.000, foglio 137 (Viterbo).
Baciarello G, 1997. Risorse economiche e attività produttive di una comunità me-dievale. Bagnoregio e lo Statuto del 1373. Rivista Storica del Lazio 6.
Bestini M, D’Amico C, Deriu M, Girotti O, Tagliavini S, Vernia L, 1971. Note illustrati-ve della carta geologica d’Italia nella scala di 1:100.000, foglio 137 (Viterbo), Roma.
Biringuccio V, 1540. De la Pirotechnia Libri X. Venezia (ristampa anastatica, Milano 1977).
Cagiano de Azevedo M, Schmiedt G, 1974. Tra Bagnoregio e Ferento. CNR, Roma.
Capocaccia G, Macchioni F, 1922. Statuto della città di Bagnoregio del 1373. Bagno-regio.
Diviziani A, 1955. Artisti orvietani a Ba-gnoregio nei secoli XVI e XVII. Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano 11: 31.
Lattanzi F, Polci S, 1988. L’ambiente, la me-moria, il progetto: Testimonianze su Civita di Bagnoregio. SugarCo, Milano.
Macchioni F, 1956. Storia civile e religiosa della città di Bagnoregio dai tempi antichi al 1503. Agnesotti, Viterbo.
Margottini C, Serafini S, 1989. Civita di Bagnoregio. Osservazioni geologiche e monitoraggio storico dell’ambiente. Una ricerca ENEA, Roma.
Margottini C, Polci S (ed.), 1993. Studio monitoraggio e bonifica dei centri abitati instabili. ENEA, Roma.
Passeri L (a cura di), 2004. Guide Geologi-che Regionali. Appennino Umbro – Mar-chigiano, vol. I. BE-MA, Milano.
Petrangeli Papini F, 1972. Bagnoregio. Cronologia storica. Agnesotti, Viterbo.
Ramacci E, 1984. Ultimo statuto della città di Bagnoregio 1786 - 1856. Comune di Ba-gnoregio.
Ramacci E, 1986. Cento anni di Bagnore-gio. Toscografica, Empoli.
Romani PM, 1622. Pentalitologia ouero prose di cinque stili diversi, cioè dispute, dialoghi, lettere, istorie, & orazioni. Fei & Ruuli, Orvieto.
Satolli A, 1993. Per Ippolito Scalza. Gattei, Rimini.