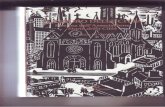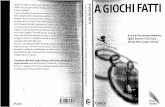Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati, in Linea II: Giochi,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati, in Linea II: Giochi,...
LINEA II GIOCHI, METAMORFOSI, SEDUZIONI DELLA LINEA
A cura di Marzia Faietti e Gerhard Wolf
LINEA
IIG
IOC
HI, M
ETA
MO
RFO
SI, SEDU
ZIO
NI D
ELLA LIN
EA
57596C € 38,00
,6%1������������������
� � � � � � � � � � � � �
LINEA IIGIOCHI, METAMORFOSI, SEDUZIONI DELLA LINEA
Il volume è stato realizzato a seguito del convegno LINEA II - Tangents, interlaces, knots, labyrinths. Structureand meaning of lines from antiquity to the contemporary period tenutosi dal 3 al 5 novembre 2010 a Firenze, pressoil Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, e pubblicato con i fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di FirenzeCristina Acidini, Soprintendente
A CURA DI
Marzia Faietti, Gerhard Wolf
TESTI DI
Alessandra Acocella, Joanne Allen, Markus Dauss, Marzia Faietti, Hana Gründler, Toni Hildebrandt,Eva Kernbauer, Sabine Mainberger, Susanne Meurer, Jenifer Ní Ghrádaigh, Wolfram Pichler, Maria Ludovica Rosati, Ilaria Rossi, Raimondo Sassi, Julia Saviello, Gerhard Wolf
RESPONSABILE EDITORIALE
Claudio Pescio
REDAZIONE
Sara Draghi
COLLABORAZIONE REDAZIONALE
Ilaria Rossi
TRADUZIONI
Cara Rachele, con la collaborazione di Theresa Holler
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Grafi ca Punto Print srl, Roma
RESPONSABILE COORDINAMENTO TECNICO
Alessio Conticini
SUPERVISIONE TECNICA DELLE IMMAGINI
Stefano Regi
RINGRAZIAMENTI
Elena Bonato, Ester Fasino, Eva Mußotter
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
12 Preludio. Limiti della prospettiva “albertiana” e divagazioni di linee tra Quattrocento e Cinquecento
14 Il sogno di Raff aello e la fi nestra di Leon Battista Alberti Marzia Faietti
30 Ring und Verschlingung: Gedanken über einen «corpo nato della prospettiva di Leonardo Vinci»Wolfram Pichler
52 Haarkunst als Linienspiel im 15. und 16. JahrhundertJulia Saviello
74 Intersecazioni tra percorsi lineari, metamorfosi materiche e variabilità delle tecniche
76 Otherworldly gesturing? Understanding linear complexity in medieval Insular artJenifer Ní Ghrádaigh
98 Percorsi lineari e peregrinatio archeologica: i Quaedam antiquitatum fragmenta di Giovanni MarcanovaRaimondo Sassi
116 Wood knots: interlacing intarsia patterns in the Renaissance choir stalls of San Zaccaria in VeniceJoanne Allen
134 Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operatiMaria Ludovica Rosati
154 Loops and Doodles – Interplays between printed and drawn lines in German art of the early sixteenth centurySusanne Meurer
Sommario
178 ‹The undulating line› versus ‹line and compass›Mediale und semiotische Aspekte der Linienästhetik in der Theorie des LandschaftsgartensMarkus Dauss
192 Disegno, Linea e linee nel Novecento tra rifl essioni teoriche ed esperienze artistiche
194 On Lines: Around 1900Sabine Mainberger
206 Strutture lineari tra spiritualità e geometria. Alcuni esempi fra gli astrattisti italiani degli anni Trenta e QuarantaIlaria Rossi
223 «A labyrinth of paths». Ludwig Wittgenstein on seeing, drawing and thinkingHana Gründler
236 John Cage und William Anastasi – Ästhetik und Ideologie der aleatorischen LinieToni Hildebrandt
256 Robert Morris: LabyrinthsAlessandra Acocella
272 Die formlose Linie: Eva Hesses «Miles of String»Eva Kernbauer
296 English abstracts of papers in Italian or German
300 Bibliografi a
L’azione di intrecciare materiali fl essibili per ottenere manualmente o con l’ausilio di uno strumento utensili e oggetti di diversa natura ap-partiene al patrimonio tecnologico dell’umanità fi n dalle epoche più arcaiche1. Questo gesto creativo, declinato nelle varianti dell’intreccio di fi bre vegetali, del nodo o della tessitura, è talmente radicato nella storia culturale umana da essere entrato nel linguaggio corrente con tutta una serie di espressioni metaforiche quali l’intreccio di una vicenda o la trama di una storia, seguire il fi lo degli eventi, tessere le lodi, dipanare una questione, tramare un intrigo e numerosi altri modi di dire così abi-tuali che l’originario contesto pratico, da cui le immagini sono tratte, è spesso dimenticato.
Nella lingua quotidiana il richiamo all’attività manuale dell’intrec-cio compare spesso in riferimento al tema della narrazione o dell’in-venzione. Alla tessitura – intesa per ora come modus operandi generale piuttosto che come tecnica specifi ca – vengono paragonati quei gesti che, combinando più elementi eterogenei secondo ritmi e formule pre-stabiliti, generano una struttura unitaria e inedita, dove la somma delle singole componenti non risulta solo un insieme di giustapposizioni e accostamenti, quanto piuttosto la produzione di una nuova realtà or-ganica, che non esisteva in precedenza. La suggestione della metafora tessile risiede proprio nel riconoscere alla pratica dell’intreccio il potere di creare la varietà, a dispetto del numero più o meno circoscritto di strumenti a sua disposizione. Si tratta di una varietà vivifi cata e, una volta portata a termine, profondamente coesa al suo interno, al punto da nascondere i meccanismi di realizzazione e di renderli visibili solo nel caso – e non sempre è possibile – in cui venga compiuto l’atto con-trario di disfare uno per uno i fi li e i nodi che la compongono.
In questo senso l’intreccio diventa narrazione e assume quasi il valore di creazione originaria o di gesto demiurgico. Non è un caso se la letteratura, le leggende e la cultura popolare abbondino di manufatti tessili magici e che in molte civiltà sia riscontrabile una sorta di mi-tologia archetipica del tessere, connessa al più complesso e articolato sistema simbolico del nodo e della legatura2. Per rimanere nel mondo classico, è la stessa esistenza umana ad essere rappresentata nel noto mito delle Moire-Parche come il frutto di un’opera di fi latura e tes-situra3. L’ugualmente rinomata abilità di Penelope nel tessere la tela
135Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
Maria Ludovica Rosati
136 Maria Ludovica Rosati
e nel ripercorrere di notte i suoi gesti per sciogliere l’intreccio, incarna non solo l’attesa e la fedeltà coniugale, ma soprattutto la capacità di creare il tempo e, dunque, nuovamente la vita4.
Anche il cosmo nelle sue relazioni interne, nel legame tra il sin-golo e il tutto e nelle leggi celate-svelate della sua realizzazione è spesso concepito come un intreccio tessile, prodotto da una forza superiore. In un frammento della Teogonia del poeta Ferecide di Siro (VI sec. a.C.), Zas [Zeus] regala come dono nuziale a Ctonie, uno dei nomi della Grande Dea mediterranea, «un manto grande e bello, e su di esso intesse in vari colori, Terra e Ogeno [Oceano] e il palazzo di Ogeno [Oceano]»5; a sua volta la stessa Core, un altro nome della medesima divinità femminile arcaica, è rappresentata in alcuni frammenti orfi ci come tessitrice che realizza il peplo del cielo6. Nel Corpus hermeticum di Ermete Trismegisto si dice inoltre che l’universo sensibile e tutto ciò che vi è contenuto sono avvolti dal cosmo intelligibile superiore come da una veste intessuta («quasi vestitum contexta»)7. Infi ne il gesto creatore del genere umano dell’Afrodite di Empedocle viene descritto nel Poema Fisico come l’azione di avviluppare «con morbidi lini» e di fi ssare «con amorose borchie» le membra dei corpi, quasi si trattasse di una ricama-trice, la cui opera è paragonata dal poeta anche a quella dei pittori, che mescolano le tinte per foggiare fi gure somiglianti all’esistente8.
In epoca contemporanea per chi è in grado di comprendere e se-guire il percorso intricato dei fi li, un tessuto può diventare mappa e rappresentazione: ne Le città invisibili di Calvino, Marco Polo racconta al Khan della città di Eudossia che custodisce un tappeto di misteriosa fattura, in cui si può contemplare la vera forma della città. E prosegue:
«A prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del tappeto, ordinato in fi gure simmetriche che ripetono i loro motivi lungo linee rette e circolari, intessuto di gugliate dai co-lori splendenti, l’alternarsi delle cui trame puoi seguire lungo tutto l’ordito. Ma se ti fermi ad osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno, disposte secondo i loro veri rapporti, quali sfuggono al tuo occhio distratto dell’andirivieni dal brulichio dal pigia-pigia. Tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofumo, l’odore di pesce, è quanto appare nella prospettiva parziale che tu cogli; ma il tap-peto prova che c’è un punto dal quale la città mostra le sue vere proporzioni, lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio. Perdersi a Eudossia è facile: ma quando ti concentri a fi ssare il tappeto riconosci la strada che cercavi in un fi lo cremisi o indaco o amaranto che attraverso un lungo giro ti fa entrare in
137Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
un recinto color porpora che è il tuo vero punto di arrivo. Ogni abitante di Eudossia confronta all’ordine immobile del tappeto una sua immagine della città, una sua angoscia, e ognuno può trovare nascosta tra gli arabeschi una risposta, il racconto della sua vita, le svolte del destino»9.
Proprio il racconto di Calvino introduce un altro elemento de-terminante per comprendere l’estetica del medium tessile. Il tappeto di Eudossia non può in apparenza essere lo specchio del mondo sensibile, perché sembra impossibile ridurre l’estrema e mutevole varietà di una città animata, con i suoi colori, odori e sapori («tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofumo, l’odore di pesce») a una forma geometrica, bidimensionale, meccanicamente ritmica e in sostanza lineare, come risulta essere quella di un qualsiasi manufatto tessile. Se prendiamo in considerazione la struttura decorativa di un tappeto, nei suoi motivi simmetrici o nei suoi avviluppamenti concen-trici possiamo tutt’al più riconoscere l’immagine di un inestricabile labirinto di nodi costretto su una superfi cie piana, una trasposizione simbolica e trascendente della realtà più che un illusorio trompe-l’oeil. Una lettura che pare trovar conferma nel fatto che nella cultura mu-sulmana, produttrice storica di tali manufatti, il disegno aniconico del tappeto, chiuso entro il perimetro delimitato della cornice, rappre-senta spesso lo schema mitico del paradiso, mentre il gioco dell’orna-mentazione a intreccio, in generale, allude a un superamento dei limiti della ragione umana per entrare in una dimensione di conoscenza mi-stica del divino10.
È dunque evidente che nella valutazione di ogni oggetto intessuto giochi un ruolo imprescindibile l’aspetto tecnico-materico della sua rea-lizzazione. Pur nella molteplicità di soluzioni tecnologiche esistenti (i nodi di un tappeto o di un arazzo, i punti di un ricamo, il lancio di fi li continui), ciò che caratterizza e accomuna questa classe è la fondamen-tale componente lineare della struttura, dal momento che alla base di un qualsiasi manufatto tessile esiste un intreccio. L’operazione fi sica di incrociare tra loro le fi bre infatti coincide sempre con un’azione di manipolazione della linea. Questa ultima può venir trattata alla stre-gua di segmento spezzato, come nel caso dei tappeti, dove ai fi li verti-cali, montati in tensione da un’estremità all’altra di un telaio quadro, vengono annodati uno a uno brevi fi li di trama per riempire lo spazio vuoto tra ordito e ordito, o, viceversa, la linea può essere lavorata come retta infi nita, grazie all’azione meccanica del telaio al tiro che permette di realizzare incroci tra fi lati continui, come avviene per i tessuti uniti e operati. L’esistenza di una vera e propria linearità esecutiva ed estetica appare immediatamente percepibile nella seconda tipologia di opere a
138 Maria Ludovica Rosati
intreccio, dal momento che nei tessuti operati i fi li, come linee, corrono paralleli o si intersecano perpendicolarmente tra di loro, potenzial-mente senza soluzione di continuità e a partire da un intreccio minimo di due fi li verticali (ordito) e di due fi li orizzontali (trama).
La linearità intrinseca dei tessuti operati risiede in primo luogo nella dimensione meccanica della loro esecuzione. Nel telaio al tiro (fi g. 1) i fi li di ordito sono montati in tensione tra due subbi (rulli) all’estre-mità della struttura e si presentano come un insieme di linee parallele poste su un piano orizzontale11. Nel montaggio del telaio ciascun fi lo viene passato attraverso una serie di lacci o maglie, posti perpendicolar-mente al piano della tessitura e riuniti in corpi (corpi di licci per il fondo tecnico e corpi di lacci per il disegno). Questi corpi sono collegati agli organi di comando del telaio, i pedali per i licci e il ramo del tiratoio per i lacci. L’azione di tali comandi permette la selezione dei fi li di ordito a gruppi, che vengono alternativamente abbassati o sollevati. Si viene così a creare il passo, ossia uno spazio vuoto dove viene fatta passare la navetta con la trama. Il fi lo della trama lavora sul medesimo piano orizzontale dell’ordito e viene lanciato da un lato all’altro del telaio, come una linea continua che interseca perpendicolarmente tutte le rette dell’ordito, passando sopra e sotto la sequenza dei fi li e producendo così l’intreccio12.
L’aspetto fi sico di ogni manufatto è dunque determinato dalla ri-petizione della soluzione d’intreccio minima, ossia dell’armatura, che corrisponde alle modalità di incrocio degli orditi e delle trame, presta-bilite in fase di montaggio13. La formula più semplice della tela-taff etas (fi g. 2a) si basa sull’azione di due soli pedali che sollevano l’uno tutti i fi li di ordito dispari, inseriti nel primo liccio, e l’altro tutti quelli pari, inseriti nel secondo liccio. Al primo passaggio della navetta il tessitore aziona il primo pedale, cosicché il fi lo della prima trama passerà sopra i fi li dispari e sotto quelli pari. Al passaggio successivo, viceversa, pre-mendo il secondo pedale si creerà il passo opposto e la seconda trama incrocerà i fi li pari e resterà sotto i fi li dispari.
Da questa struttura elementare derivano le altre armature tessili unite attraverso variazioni e complicazioni che riguardano sia la tipo-logia di intreccio che l’apparato meccanico del telaio. Mantenendo lo stesso numero di pedali, ma variando la sequenza dei comandi si ottiene il Gros de Tour (fi g. 2b), in cui due o più trame consecutive vengono lanciate nello stesso passo, ottenendo un eff etto di piccole coste oriz-zontali (il tessitore premerà il primo pedale per far passare le trame I e II, il secondo pedale per le trame III e IV, nuovamente il primo pedale per le trame V e VI etc.). Viceversa, nella luisina (fi g. 2c) i fi li di ordito consecutivi saranno appaiati nei licci in fase di montaggio, cosicché ogni trama incrocerà non più il singolo fi lo, ma gruppi di due o più orditi
139Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
(azionando il primo pedale la trama I passerà sopra i fi li 1 e 2 e sotto i fi li 3 e 4, premendo il secondo pedale la trama II passerà sotto i fi li 1 e 2 e sopra i fi li 3 e 4 e così via).
Se in questi due casi cambia solo il rapporto d’armatura, aumen-tando il numero dei licci e dei pedali e quello dei fi li verticali e orizzon-tali coinvolti nell’intreccio minimo, è possibile variare la sequenza dei punti di legatura e generare altre due classi di armature unite, quella della saia e quella del raso. Nella saia (fi g. 2d) la struttura tessile si caratterizza per un eff etto di coste diagonali, ottenuto dallo sposta-mento verso destra o verso sinistra del punto di legatura sui singoli fi li di ordito al passaggio di ciascuna trama. Nella sua forma più semplice (saia da 2 lega 1) la trama I legherà i fi li 1, 4, 7 etc. azionati dal primo pedale, la trama II legherà i fi li 2, 5, 8 etc. azionati dal secondo e la trama III legherà i fi li 3, 6, 9 etc. collegati al terzo pedale. Nuovamente
1 • Telaio al tiro del XVIII secolo, dettaglio del corpo dei licci e dei lacci. Lyon, Maison de Canuts
140 Maria Ludovica Rosati
la trama IV si comporterà come la I, la V come II, la VI come la III etc.. L’armatura raso (fi g. 2e), per la cui realizzazione sono necessari almeno cinque licci e cinque pedali, quindi cinque fi li di ordito e cinque colpi di trama, si contraddistingue invece per un ulteriore slittamento (defi nito tecnicamente scoccamento) dei punti di legatura, i quali ad ogni passag-gio di trama saltano come minimo il fi lo immediatamente successivo e vengono così nascosti dalle slegature adiacenti, producendo un eff etto di compattezza e lucidità su una delle due facce del tessuto.
Queste strutture basiche, che la stessa convenzione rappresenta-tiva del CIETA (Centre International d’Etude des Textiles Anciens) e dei tessitori mostra come grafi ci lineari, possono creare un gran numero di soluzioni decorative diff erenziate attraverso la giustapposizione di ma-teriali diff erenti negli orditi e nelle trame (si pensi all’eff etto ottico del pied de puole, ottenuto variando i colori dei fi lati in una tela) e, ancora, possono venir piegate per creare delle armature derivate (p.e. Gros e Luisina dal taff etas, Chevron dalla saia). Inoltre con il solo impiego del corpo dei licci si possono inserire anche orditi e trame supplementari, che lavorano autonomamente con una parte preselezionata della strut-tura tessile, formando semplici e reiterati motivi decorativi (i cosiddetti piccoli operati con disegno prodotto da slegature).
2
141Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
Tuttavia è evidente che in questa classe esiste un vincolo condizio-nante della linea e dell’intreccio: così come c’è bisogno di un rapporto d’armatura minimo, d’altro canto lo slittamento del punto di legatura può avvenire solo entro un ben preciso numero di fi li, pena la perdita della sostanza stessa di un tessuto, ossia l’incrocio ripetuto di ordito e trama, e dunque il numero di armature possibili è limitato. Inoltre il fatto che il disegno o eff etto decorativo coincida con la tecnica stessa di esecuzione e che questa si realizzi agendo su più parti del manufatto simultaneamente, implica una necessaria modularità della struttura or-namentale, ripetuta su tutta la superfi cie dell’oggetto secondo il ritmo della sequenza fi ssa di intreccio.
Si può aff ermare che tutta la storia dell’evoluzione tecnologica della tessitura a telaio, se da una parte sembra tendere alla velocizza-zione, mediante la meccanizzazione del procedimento tessile, dall’altra ha ricercato un continuo superamento del vincolo lineare della materia, introducendo espedienti che aggirassero la struttura fi sica, pur mante-nendone le regole di composizione.
Lo sforzo di implementazione tecnologica per ovviare al problema della linea è ben evidente nel passaggio tra XI-XII secolo e XIII-XIV secolo dalla tipologia degli sciamiti a quella dei lampassi, un’evoluzione
3
2 • Tracciato tecnico e sezione trasversale delle armature unite: taffetas (A), Grosde Tour (B), luisina (C), saia da 2 lega 1 faccia trama (D), raso da 5 scoccamento 2, faccia trama (E)
3 • Tracciato tecnico delle armature operate: sciamito (A) e lampasso (B)
142 Maria Ludovica Rosati
4 • Frammento di tessuto a ruote e leoni, manifattura della Sogdiana o dell’Asia centrale del VIII secolo, sciamito operato, seta, mm 620 x 310. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 633 F
5 • Particolare della scalinatura. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 633 F
143Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
resa possibile e stimolata dal perfezionamento dello strumento mecca-nico, il telaio al tiro presentato precedentemente14.
Negli sciamiti (fi g. 3a), tipica produzione alto medievale di origine medio orientale, la struttura è caratterizzata da un doppio corpo di fi li di ordito che lavorano indipendentemente15. Il primo corpo (ordito di fondo, F), nascosto all’interno del tessuto, ha la funzione di separare le due facce, dove corrono orizzontalmente un numero minimo di due trame, distinte per colore, mentre il secondo (ordito di legatura, L) lega le trame sulle due superfi ci in una delle armature basiche (generalmente una saia da 2 lega 1). Ciascuna faccia del manufatto si presenta dunque con una dominante trama (orizzontale), dal momento che sia il fondo che il disegno sono defi niti dai fi li orizzontali e le trame, quando non sono impiegate sul dritto, passano attraverso il primo corpo di ordito e si distendono sul rovescio, dove compare un eff etto a negativo.
Nonostante nel corso dei secoli, soprattutto in ambito sasanide e bizantino, siano stati raggiunti vertici di raffi natezza e preziosità tec-nica e formale con la moltiplicazione del numero delle trame per la defi nizione del decoro, la tipologia degli sciamiti mostra appieno cosa si intende per vincolo strutturale della linea. Poiché la separazione tra fondo e disegno avviene per lo scambio tecnico delle trame tra il dritto e il rovescio e questo passaggio è determinato dall’incrocio dei fi li, ossia di rette ortogonali su un piano bidimensionale, i motivi decorativi si presentano come appiattiti su un fondo omogeneo e recano contorni molto marcati, defi niti da una vera e propria scalinatura (fi gg. 4, 5). Os-servando da vicino in un tessuto il gioco dell’intreccio, appare evidente l’insormontabile limite della sua dinamica: per quante variazioni pos-sano essere applicate alla struttura, nell’unità minima la possibilità della linea curva è negata a causa del funzionamento stesso dei meccanismi di esecuzione tessile e tale eff etto può essere solo simulato con appositi escamotages nella totalità dell’insieme.
Con il perfezionamento del telaio al tiro tra XI e XIII secolo le possibilità espressive dei tessuti operati si ampliano e viene elaborata una nuova soluzione tecnica, il lampasso, dove anche il repertorio de-corativo della tradizione tessile precedente, in virtù del cambiamento tecnologico, viene rinnovato e arricchito. Nei lampassi (fi g. 3b) la strut-tura base è caratterizzata, come già negli sciamiti, da due corpi di ordito e da almeno due trame. Tuttavia, a diff erenza della precedente tipolo-gia, dove tutti gli elementi tessili lavoravano insieme per realizzare un unico intreccio, nel lampasso è riscontrabile un fondo tecnico, prodotto dal primo gruppo di orditi e di trame, e una seconda armatura (ma anche nei casi più complessi una terza e una quarta), in cui si intrec-ciano l’altro ordito (di legatura) e le trame supplementari per formare il disegno. Viene così a crearsi una moltiplicazione dei piani di tessitura,
144 Maria Ludovica Rosati
resa possibile dal fatto che ciascuna armatura è prodotta impiegando organi di comando distinti nel telaio, poiché i due gruppi di ordito sono inseriti in due distinti corpi di licci, azionati da serie diverse di pedali, mentre l’eff etto del disegno, indipendente dalla realizzazione del fondo, è creato con il comando laterale del ramo.
Con lo sdoppiamento delle armature i motivi decorativi non si di-stinguono più dal fondo solo in funzione del diverso colore delle trame ed eventualmente dei diff erenti fi lati impiegati, ma anche, e soprattutto, grazie alla giustapposizione tra l’intreccio del fondo e quello dell’opera. Sul dritto del tessuto il disegno acquista una tridimensionalità prima assente ed emerge dallo sfondo, perché le trame che defi niscono i motivi poggiano letteralmente sull’armatura di base, producendo una sorta di stratifi cazione tessile16. Inoltre l’autonomia tecnica della struttura tessile del decoro permette l’inserzione di ulteriori trame supplementari, libere di lavorare solo in alcune parti dei motivi decorativi, p.e. le trame broc-cate metalliche, dal momento che non concorrono a formare il fondo.
Se si guarda ad una messa in carta di un lampasso, ossia lo stru-mento pittorico con cui venivano date le indicazioni per il montaggio del telaio, è possibile osservare come la moltiplicazione delle trame e dei piani di tessitura riesca a simulare l’eff etto di un disegno vero e proprio. Certo, la necessità dell’incrocio rimane ed è grafi camente rappresentata dalla quadrettatura, dove ogni quadratino minore corrisponde al fi lo di ordito da azionare al passaggio di ciascuna navetta, eppure la possibilità di impiegare più spoline, ognuna con una trama di colore diverso, e per porzioni limitate del telaio, permette di raggiungere quasi l’impressione dello sfumato e cela la struttura lineare della tessitura17.
Abbiamo considerato fi nora il condizionamento dell’intreccio delle linee dal punto di vista della realizzazione materiale di un tessuto ope-rato, evidenziando come esista un repertorio di soluzioni e di regole di composizione a cui ogni manufatto deve necessariamente attenersi. La dinamica e la struttura lineare dell’aspetto tecnico, tuttavia, si rifl ettono anche sul versante ornamentale, generando un lessico di forme visive, caratterizzante questa classe di opere e in grado di migrare in altri media artistici come un vero e proprio eff etto tessile.
Il vincolo fattivo dell’intreccio si manifesta ad un primo livello nella stretta interdipendenza e totale coincidenza tra componente esecutiva e componente decorativa di un tessuto. L’ornamento o la fi gurazione in una stoff a operata vengono prodotti simultaneamente all’azione stessa di combinare i fi lati in armature tessili mediante il telaio: trattando il caso degli sciamiti, ad esempio, è già emerso come la defi nizione mar-cata e, per così dire, a gradini dei profi li rispetto al fondo venga imposta, senza possibilità di alternative, dalla peculiare modalità con cui le trame incrociano gli orditi.
145Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
6 • Frammento di tessuto a ruote e animali, manifattura bizantina o siriana del X-XI secolo, sciamito operato, seta, mm 640 x 160. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 634 F
146 Maria Ludovica Rosati
La tecnica, intesa come pratica di manipolazione della materia, genera formule decorative che le sono proprie e condiziona le scelte ar-tistiche dei tessitori. In una situazione produttiva nella quale il pattern ornamentale dipende dalla sequenza ripetuta dell’intreccio, la modula-rità della composizione diventa il primo requisito per la progettazione del disegno tessile e suggerisce quali siano le forme più adatte alla de-corazione e quali siano gli strumenti per una loro combinazione variata sulla totalità della superfi cie intessuta. Se la presenza di una ripetizione modulare è un vincolo ineludibile, tuttavia l’artista può creare eff etti diversi nello scegliere le dimensioni del modulo e la sua disposizione spaziale (a scacchiera regolare o sfalsata, con una traslazione della fi gura
7 • Frammento di tessuto a fenici e leoni, manifattura lucchese, prima metà del XIV secolo, lampasso lanciato e broccato, seta e fi lato metallico, mm 190 x 370. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 2298 C
147Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
8 • Frammento di tessuto a pappagalli e tralci, manifattura lucchese, prima metà del XIV secolo, lampasso lanciato e broccato, seta e fi lato metallico, mm 790 x 230.Köln, Kunstgewerbe Museum, inv. n. D 1042. In basso: particolare e ricostruzione del modulo decorativo (da DonataDevoti, L’arte del tessuto in Europa, Milano 1974)
148 Maria Ludovica Rosati
o con un suo ribaltamento speculare etc.), e, traducendo l’immagine nel montaggio fi sico del telaio, agisce nuovamente sulla struttura che lo ha condizionato in partenza.
Negli sciamiti alto medievali dominano composizioni auliche e geometrizzanti, basate prevalentemente sul modulo dell’orbicolo, una circonferenza recante al suo interno animali, motivi vegetali stilizzati, scene di caccia e personaggi regali o eroici, spesso ripetuti in fi gura-zioni simmetriche attorno ad un’asse centrale18. Il trattamento rigido e statico con cui sono raffi gurati i motivi – si pensi a tutta la serie di ani-mali araldici visti di profi lo di lontana ascendenza sasanide (fi g. 6) – è determinato, come si è detto, dalla natura piatta dell’intreccio tessile in questa tipologia. Tuttavia la stessa matericità della struttura non im-pone solo la scalinatura marcata delle linee, ma può essere stata stimolo anche per la creazione dello stesso pattern della ruota di dimensioni notevoli19, così diff uso in queste stoff e, dal momento che lo sciamito per la presenza del corpo di orditi interno e per il numero delle trame impiegate risulta essere un tessuto pesante, a sua volta rigido, che ben si presta a contenere una grande raffi gurazione da leggere distesa in piano, come quella degli orbicoli.
In un certo senso la teoria di Semper sullo stile e sulle forme come prodotto della lavorazione della materia e come rifl esso delle funzioni proprie di ciascun materiale troverebbe conferma in questo meccani-smo generatore dell’ornato dalla struttura tessile20. Proprio Semper che, come è noto, riteneva la tessitura la forma d’arte primaria dalla quale tutte le altre arti-tecniche hanno desunto «simboli e tipologie»21, in una conferenza sul disegno dei tessuti consigliava «di porre più pos-sibile di profi lo [le fi gure], poiché il profi lo rende assai meglio di una veduta frontale l’impressione di una superfi cie piana [propria del ma-teriale tessile]»22. Un espediente tecnico, adottato nella maggior parte degli sciamiti medievali.
Tuttavia, la complessità del rapporto tra arte e tecnica nelle opere tessili non può essere ad una visione eccessivamente meccanicista e de-terminista, dal momento che, se non si può negare il vincolo della ma-teria, ciascun manufatto è d’altronde riconducibile all’ambito più vasto della storia culturale e artistica dell’epoca che lo ha prodotto e il suo aspetto formale deriva anche di numerose componenti extra-materiali.
9 • Frammento di tessuto a uccelli, draghi e tralci ogivali, manifattura italiana, XIV secolo, stoffa usata come rivestimento interno di una pianta del XV secolo, lampasso lanciato e broccato, seta e fi lato metallico, mm 1350 x 1040. Zürich, Schweizerisches Landesmuseum inv. 11776
149Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
La statica fi ssità della decorazione negli sciamiti è frutto dell’esecuzione tecnica, ma al contempo vi è una piena consonanza con gli intenti arti-stici e con la destinazione d’uso delle opere, prodotte negli ateliers im-periali e riservate nelle varianti più preziose alla vestizione del basileus, come ricordano le immagini di Giustiniano e Teodora nei mosaici della basilica di Santa Apollinare in Classe a Ravenna. Nel cerimoniale bizan-tino l’apparizione del sovrano è una manifestazione epifanica dell’im-magine del potere e dei suoi simboli, concepita per una visione ieratica e frontale, in cui ogni elemento concorre a sottolineare la natura divina della fi gura. I vincoli tecnici della tessitura sono dunque sfruttati per realizzare una scelta stilistica dalle forti valenze simboliche, cosicché l’a-spetto di questa tipologia pare determinato, più che dal limite imposto dalla materia, dalla consapevole preferenza accordata ad una struttura tessile in grado di concretizzare particolari esigenze di contenuto.
In ambito tessile, inoltre, una armatura già esistente può essere impiegata perché soddisfa uno specifi co bisogno espressivo, ma, allo stesso tempo, la tecnica e la materia possono essere piegate per rag-giungere risultati inediti, meglio corrispondenti agli orientamenti del gusto. Il rapporto di dipendenza tra struttura e ornato è in questo
150 Maria Ludovica Rosati
caso ambivalente, come dimostrano l’evoluzione dell’intreccio dagli sciamiti ai lampassi e il perfezionamento del telaio al tiro. Si può ipotizzare che una tecnologia più avanzata abbia stimolato la cre-azione di nuovi moduli disegnativi, eppure lo stesso cambiamento tecnologico può anche essere il risultato e non la causa della ricerca di nuove armature, più consone agli eff etti decorativi che si volevano conseguire.
In Occidente la prima produzione di lampassi tra XIII e XIV secolo ad opera delle industrie lucchesi e veneziane si colloca in una fase artistica di generale interesse per il mondo sensibile, di sperimen-tazioni nella defi nizione spaziale e di duplice attenzione verso il quoti-diano da una parte e la preziosità, la drôlerie e il divertissement dall’altra. Anche il tradizionale repertorio fi gurativo dei tessuti suntuari viene investito dal rinnovamento, un cambiamento reso possibile non solo da un nuovo modo di concepire l’ornamentazione tessile, ma anche dall’impiego di una nuova struttura tecnica, che concretamente po-tesse tradurre gli eff etti ricercati23. Nei lampassi trecenteschi (fi gg. 7-9) le composizioni si fanno di più ampio respiro attraverso la com-binazione sfalsata e ribaltata del modulo decorativo o, viceversa, l’unità
10 • Tessuto ad aquile e motivi vegetali, particolare dell’effetto del pelo, manifattura veneziana, fi ne del XIV - inizio del XV secolo, velluto operato broccato, seta e fi lato metallico, mm 480 x 680. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 620 F
151Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
minima del disegno si riduce nelle dimensioni fi no a generare un ef-fetto di tappeto continuo, che maschera la struttura geometrica della sequenza di montaggio. Si diff ondono ornati organizzati per direttrici curvilinee e con andamento asimmetrico, composti da motivi animali e vegetali resi con varietà di dettagli e vivacità rappresentativa (fi g. 7), grazie alla presenza di armature autonome che permettono con la moltiplicazione delle trame una defi nizione dei profi li più morbida, in grado di eludere la rigida dimensione dell’intreccio ortogonale dei fi li. Attraverso gli espedienti tecnici i tessitori trasfi gurano la superfi cie piana delle stoff e in uno spazio abitato, percorso dai patterns decora-tivi e dotato quasi di una profondità tridimensionale, come nel caso del lampasso di Colonia (fi g. 8), dove gli uccelli volano letteralmente nel delicato intrico di tralci fi oriti, sovrapponendosi con i corpi e il lungo piumaggio caudale ai racemi retrostanti. Con l’introduzione delle trame supplementari metalliche con eff etti di broccature i mo-tivi ornamentali acquistano mobilità, cangiantismo e una vibrazione luministica in cui non manca una componente tattile (fi g. 9), come nel volgere di pochi decenni avverrà anche in un’altra e nuova tipologia di tessuti operati, i velluti, caratterizzati proprio dal gioco a rilievo del pelo (fi g. 10). Nella varietà e nella diversità tutte queste soluzioni cor-rispondono pienamente al gusto gotico tardo-medievale, e, tuttavia, sono ugualmente tipiche e determinate dalla tecnica del lampasso con cui sono materialmente realizzate.
La casistica descritta, non certo esaustiva, mostra come dall’in-treccio tessile con le sue regole di realizzazione, vincoli e limitazioni possa tuttavia generarsi una condizione di libertà creativa, in cui la dinamica del mezzo lineare è in grado di produrre un vocabolario di motivi potenzialmente illimitato, nonostante il numero circoscritto di strutture materiali esistenti. Gli strumenti di realizzazione di un manufatto, sia dal punto di vista della tessitura fi sica che da quello dell’ornamentazione, sono riconducibili ai principi dell’intreccio e della sovrapposizione delle linee, della stratifi cazione dei piani, che si pro-ducono dall’accostamento e dalla traslazione dell’elemento lineare, e, infi ne, al principio della ripetizione modulare, intesa come sequenza ritmica dell’armatura e, contemporaneamente, come principio di dispo-sizione dell’ornato. Queste componenti di tipo squisitamente geome-trico e matematico, come ben aveva evidenziato Calvino nel racconto del tappeto di Eudossia («lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio»), formano l’essenza stessa di un oggetto tessile, della sua tecnica e della sua estetica, e rappresentano un vero e proprio codice espressivo, strettamente imparentato con il linguaggio della decora-zione in generale. La natura del medium tessile sembrerebbe coincidere con le forme e i signifi cati della decorazione in tutti i suoi tratti pecu-
152 Maria Ludovica Rosati
liari, a partire dalla stessa operazione basilare-creativa dell’intreccio di fi bre che è, di per sé, un modus ornamentale universale, sia che si realizzi concretamente nell’accostamento di elementi fl essibili diversi, sia che venga solo evocato in altri contesti materici (mosaici pavimentali, bordi miniati etc.). A un livello superiore le soluzioni ornamentali caratteri-stiche di un tessuto possono migrare in altre tecniche, mantenendo la loro peculiarità e generando un immediato eff etto percettivo tessile, tanto perché viene riprodotto un pattern specifi co delle stoff e, come la formula a orbicoli degli sciamiti, riproposta nei plutei e nelle tran-senne scolpite del Medioevo campano, quanto perché, ed è il caso dei rivestimenti ceramici delle architetture islamiche, si ripropongono con diversi materiali i meccanismi fondanti della ripetizione modulare ad infi nitum e della stratifi cazione lineare tessile. È il tessuto stesso, come oggetto nella sua interezza, ad incarnare infi ne la funzione decorativa, dal momento che ogni manufatto è concepito per essere indossato da persone o cose, per sottolineare ed esaltare le qualità del soggetto rive-stito, per indirizzare l’attenzione verso il centro visivo e simbolico di ogni immagine, rappresentazione e messa in scena.
Il gioco dell’intreccio, azione meccanica di realizzazione del manu-fatto tessile, si trasforma quindi in una modalità decorativa peculiare e l’oggetto creato diventa a sua volta una soluzione ornamentale mutua-bile in altri contesti artistici. Con un procedimento analogo alla metafora linguistica, anche nell’ambito fi gurativo la tessitura dei fi li-linee assume dunque il valore di paradigma per la creazione della varietà decorativa.
1 Per una lettura etnologica della tecnica dell’intreccio non solo di fi bre tessili, ma di tutti i materiali fl essibili cfr. Leroi-Gourhan 1971, pp. 161-311, in particolare pp. 245-296.2 Il nodo, come segno ambivalente che sintetizza l’azione di forze opposte (il legare e lo sciogliere), è attributo caratterizzante di molte divinità di ambito indo-europeo ed è investito di molteplici signifi cati magico-rituali. Cfr. Eliade 1980; Tagliapietra 1996, pp. 216-235.3 Omero, Iliade, XX, 128 e XXIV, 210; Omero, Odissea, VII, 197.4 Omero, Odissea, II, 94-106; XIX, 137-151; XXIV, 128-141.5 Colli 1977-1979, II, 1978, vv. 14-18, pp. 78-81.
153Vincolo e libertà nell’intreccio delle linee: il caso dei tessuti operati
6 Porfi rio, De antro Nympharum e Damascio, De principiis, entrambi in Colli 1977-1979, I, 1977, pp. 252sg.7 Trismegistos ed. 2001 III, 34, p. 364sg. Il cosmo come tessuto compare anche nella speculazione indiana vedica. Eliade 1980, p. 104.8 Empedocles ed. 1975, IX, p. 26sg. e XXI, p. 34sg.9 Calvino 1992, p. 440sg.10 Brusatin 1993, p. 8sg. Ad esempio, il gruppo dei tappeti safavidi con scene di caccia della metà del XVI secolo (due testimonianze si trovano rispettivamente al Museum of Fine Art di Boston e al Museo Poldi Pezzoli di Mi-lano), sono stati tradizionalmente interpretati come immagini del Paradiso, appoggiandosi alla presenza di motivi tipici descritti anche nelle fonti scritte, sebbene più recentemente Oleg Grabar abbia sottolineato come tale lettura debba rimanere sul piano dell’allusione simbolica piuttosto che della visione naturale. Cfr. Cammann 1972; Idem 1974; Grabar 1989, pp. 210-217. Secondo Herman Vahramian «il pattern di un tappeto chiama in causa al tempo stesso una ripetizione della cosmogonia», dal momento che un motivo geometrico reiterato all’infi nito è un simbolo che consiste in migliaia di centri (nodi), «i quali rappresentano ogni volta una rivelazione primordiale in forma ar-chetipica». Cfr. Vahramian 1996, p. 82. A conferma del simbolismo trascendente della decorazione islamica Ernst Diez ricorda inoltre «la defi nizione persiana di un motivo di tappeto come zeman (tempo) e dello sfondo come zemin (spazio)». Cfr. Diez 1938, p. 45.11 Per la rappresentazione di un telaio al tiro cfr. Torino 1981, fi gg. 18-20, p. 22sg., dove sono riprodotte due tavole dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alambert, relative alla voce Soierie (vol. XI, tavv. LX, LXIV), e la ricostruzione del telaio di Philippe Lasalle (1723-1804), conservata presso il Musée des Tissus di Lione.12 Per una comprensione più approfondita del funzionamento del telaio restano sempre validi i tradizionali manuali tecnici, destinati in primo luogo ai tessitori. Cfr. Alzati 1892; Algoud 1912; Villard 1923. Gli aspetti tecnici della tessitura sono illustrati anche in Pariset 1890, in particolare pp. 240-290.13 Per la defi nizione tecnica delle singole armature e per la loro rappresentazione grafi ca cfr. Vocabulaire technique 1959-1976; Vial 1979.14 Per il passaggio dalla struttura degli sciamiti a quella dei lampassi e per l’evoluzione del telaio al tiro cfr. Cuoghi Costantini 1981; Guelton, Vial 1998; Desrosier 2004, pp. 14-28 con relativa bibliografi a.15 Per quanto riguarda il montaggio del telaio, i fi li di legatura sono inseriti nei licci e, dunque, sono alzati e abbassati dai pedali, mentre i fi li di fondo passano attraverso i maglioni e lavorano al tiro, venendo selezionati a seconda del disegno.16 L’eff etto tridimensionale dei lampassi è ben visibile osservando una macrofoto. Cfr. Riboud 1998, cat. 3, tav. 12, pp. 93-95.17 Esempi di messa in carta del XVIII secolo, conservati presso il Musée des Tissus di Lione, sono pubblicati in Devoti 1974, cat. 152 e in Arizzoli-Clémentel 1990, p. 66. 18 Numerosi esemplari di sciamiti alto medievali sono conservati presso il Musée des Tissus di Lione. Cfr. Marti-niani-Reber 1986. Si segnala inoltre il recente ritrovamento nella Cattedrale di Ascoli di un grande telo di sciamito dell’VIII-IX sec., nel quale è possibile leggere la struttura decorativa ad orbicoli nella sua interezza. Cfr. Digilio in Lucca 2010-2011, scheda 78, pp. 164-166.19 Nei più preziosi esemplari bizantini il diametro degli orbicoli può superare i 50 cm, come nel caso del telo di Mozac del Musée Historique des Tissus di Lione (inv. n. 27.386), uno sciamito operato dell’VIII-IX secolo con scene di caccia imperiale entro ruote. Cfr. Martiniani-Reber 1986, pp. 109-111.20 Semper 1992. Per una recente sintesi del pensiero semperiano cfr. Rykwert 1996, con relativa bibliografi a.21 «L’arte tessile e la ceramica sono quelle [branche della tecnica] in cui si manifesta per la prima volta, accanto al perseguimento dell’obiettivo, l’aspirazione all’abbellimento, in virtù della scelta formale e della volontà di ornamen-tazione. Tuttavia [...] quella tessile mantiene un predominio incondizionato, perché in essa si può riconoscere l’arte primigenia, in quanto tutte le altre arti, non esclusa la ceramica, hanno derivato dall’arte tessile tipologia e simboli, mentre quest’ultima appare autonoma, sotto tale aspetto, avendo creato da sé le sue tipologie o avendole desunte dalla natura. È indubbio che i primi principi dello stile si siano consolidati all’interno di questa tecnica artistica primigenia». Cfr. Semper 1992, terza sezione, paragrafo 4, p. 51.22 La citazione è tratta da Gombrich 1984, p. 86sg.23 Per un repertorio iconografi co delle soluzioni decorative nei lampassi trecenteschi cfr. Devoti 1974, cat. 33-55 e Rosati 2010, fi gg. 1-4, 6, 10-13.