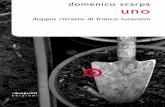riserva naturale orientata bosco pantano di policoro - Regione ...
L’effetto di vincolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel diritto interno:...
Transcript of L’effetto di vincolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel diritto interno:...
GIORGIO REPETTO
L’EFFETTO DI VINCOLO DELLE SENTENZEDELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
NEL DIRITTO INTERNO:DALLA RISERVA DI BILANCIAMENTO
AL ‘DOPPIO BINARIO’ (*)
Sommario: 1. Premessa. I due significati dell’‘effetto di vincolo’. – 2. Nascitaed evoluzione della riserva di bilanciamento: concrete cases o general propositions?– 3. Il fondamento delle sentenze della Corte di Strasburgo che richiedono l’ado-zione di misure generali. – 4. … la loro (incerta) tipologia … – 5. … e i loro effettinell’ordinamento italiano nell’esperienza più recente. – 6. Un tentativo di siste -mazione del ‘doppio binario’: a ciascuno (giudici comuni e Corte costituzionale)il suo. – 7. Uno stress test: il caso Varvara. – 8. L’effetto di vincolo e la ricomposi-zione pluralistica del rapporto tra sistemi e tra giurisdizioni: la via italiana ad unweak review.
1. Premessa. I due significati dell’‘effetto di vincolo’. – Nella giuri-sprudenza costituzionale in tema di efficacia della CEDU nel diritto in-terno successiva alle sentenze gemelle (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), ilproblema del grado di vincolo esercitato dalle sentenze della Corte euro-pea dei diritti dell’uomo nel diritto interno (e sul giudizio di costituzio-nalità in particolare) si è andato progressivamente scindendo in dueaspetti diversi. Uno, più generale, attiene alla possibilità per il giudice dicostituzionalità di sindacare l’interpretazione delle regole convenzionalioperata dalla Corte europea o comunque di modularne in linea di prin-cipio la portata. L’altro, più specificamente riguardante il profilo del-l’esecuzione delle decisioni, riguarda invece l’efficacia da attribuirsi alleforme di restitutio in integrum individuate, con maggiore o minore det-taglio, dalla stessa Corte europea in tutti quei casi in cui venga accertata
––––––––––(*) Il presente lavoro trae spunto da una lezione svolta nel dicembre 2014 presso il
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentalidell’Università degli Studi di Pisa: ringrazio gli organizzatori, in particolare Elena Malfatti,e i partecipanti all’incontro per le stimolanti osservazioni. Una versione notevolmente ab-breviata di questo scritto è destinata agli Scritti in onore di Gaetano Silvestri.
DIRITTO PUBBLICO, 3/2014
1076 DIRITTO PUBBLICO
una violazione della Convenzione che richieda l’adozione di misure ge-nerali (c.d. violazione sistemica o strutturale).
I due profili sono strettamente intrecciati, ma è necessario tenerlidistinti perché riflettono due diversi gradi di intensità del vincolo opera-to dalle sentenze europee. Il primo, infatti, investe direttamente i termi-ni dell’esistenza o meno della violazione ravvisata dalla Corte europea,cioè, al di là degli strumenti (normativi, amministrativi, organizzativi)necessari per porvi rimedio, se all’accertamento di quella violazione e alprincipio che ne consegue debba darsi ingresso nel diritto interno o me-no.
Il secondo, invece, si appunta specificamente sulle forme e suglistrumenti specifici che devono essere messi in atto in tutti quei casi incui ci si trovi davanti all’accertamento di violazioni ripetute, che chiama-no in causa una disfunzione non occasionale del diritto interno (a partiredall’eventualità che la violazione sia dovuta ad una norma di legge). Nelprimo caso, in altre parole, il supposto vincolo chiama in causa l’accerta-mento in sé effettuato dalla Corte europea (se cioè una violazione debbaritenersi esistente o meno), mentre nel secondo caso, data per assodata laviolazione, il vincolo investe gli strumenti di natura generale atti a dareesecuzione, nei termini il più delle volte di una restitutio in integrum, al-la pronuncia europea nell’ordinamento interno.
Nel presente articolo, il tema verrà analizzato a partire dall’itinera-rio seguito dalla Corte costituzionale per limitare la portata dei prece-denti europei nell’ambito della c.d. riserva di bilanciamento (§ 2), perpoi passare ad esaminare il fondamento, la tipologia e gli effetti nel dirit-to interno delle sentenze europee che accertano violazioni sistemiche ostrutturali (§§ 3-5). Successivamente, si proporrà un’ipotesi di lettura delmeccanismo del ‘doppio binario’ (§ 6), imperniato su una limitazionedei casi di disapplicazione del diritto interno e su un rafforzamento deldovere del giudice di rivolgersi alla Corte costituzionale, prendendo an-che spunto dal caso Varvara (§ 7), prospettando infine un inquadramen-to del problema alla luce delle trasformazioni che investono sia il rap-porto tra CEDU e diritti nazionali, sia quello tra giudice comune e Cor-te costituzionale (§ 8).
NOTE E COMMENTI 1077
2. Nascita ed evoluzione della riserva di bilanciamento: concretecases o general propositions? – All’indomani delle sentenze gemelle, laquestione del vincolo interpretativo esercitato dalle sentenze della Corteeuropea era considerato come uno dei punti maggiormente oscuri dellasistemazione offerta dalla Corte costituzionale. Le due sentenze, come siricorderà, desumevano dal tenore dell’art. 32 CEDU l’attribuzione allaCorte europea di una ‘funzione interpretativa eminente’ in grado di im-porsi senz’altro sull’ordinaria attività interpretativa dei giudici, mentremaggiori dubbi circondavano l’intensità di quel vincolo proprio sul-l’attività del giudice costituzionale.
Se la sent. n. 349/2007, da un lato, riteneva infatti che, sull’interpre-tazione della CEDU, la Corte europea avesse una ‘parola ultima’, taleper cui in caso di contrasto tra Costituzione e norme convenzionali laverifica andasse comunque condotta sulle norme della Convenzione«nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo»(1), nella sent. n.348/2007, dall’altro lato, il riconoscimento che «le norme della CEDUvivono nell’interpretazione che di esse viene data dalla Corte europea»era accompagnato dalla rilevante precisazione per cui «si deve peraltroescludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondiziona-tamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi na-zionali»(2).
La contraddizione si è rivelata tuttavia ben presto solamente appa-rente, tenuto conto innanzi tutto che in entrambe le pronunce la riservaalla Corte costituzionale di una competenza a verificare il rispetto dellaCostituzione da parte della norma convenzionale assorbiva chiaramenteanche il risultato dell’interpretazione fornito dalla Corte europea e lo at-traeva, fermo restando il suo significato, nell’orbita di quella funzione dibilanciamento che la Corte riservava a se stessa.
Oltre a ciò, a togliere peso ai rischi di un vincolo troppo intenso acarico della Corte costituzionale, e in certa misura anche dei giudici co-muni, al rispetto delle sentenze europee sta anche il fatto che tutto l’im-pianto delle sentenze del 2007 è imperniato sull’individuazione del legi-––––––––––
(1) Punto 6.2. Cons. in dir., in fine.(2) Punto 4.7. Cons. in dir.
1078 DIRITTO PUBBLICO
slatore come unico organo interno tributario del vincolo esercitato dallaCEDU e dalle sentenze del suo giudice(3). Ciò nonostante, la configura-zione del vincolo al rispetto delle sentenze della Corte europea non hamancato di sollevare critiche, sia con riferimento agli effetti che questoproduce sui giudici comuni, sia in relazione all’attività interpretativa del-la Corte costituzionale. Dal primo punto di vista, infatti, è stato osserva-to come postulare un vincolo interpretativo fondato sulla giurispruden-za della Corte europea si ponga in contrasto con l’orientamento secondocui la CEDU stessa non è ritenuta in grado di determinare limitazioni (ocessioni) di sovranità ai sensi dell’art. 11 Cost., perché nei termini fattipropri dalla Corte costituzionale i giudici restano soggetti, nell’interpre-tazione di quella che è e resta una legge dello Stato (appunto, la Conven-zione per come resa esecutiva nel diritto interno con la legge n.848/1955), alle decisioni prese da un organo esterno; il che determinereb-be la «sovrapposizione di una competenza giurisdizionale esterna a quel-la dei giudici nazionali, che perdono l’usbergo del libero convincimentoe si trovano assoggettati ad un vincolo del tutto anomalo»(4). Da qui l’ul-teriore interrogativo intorno ai limiti fino ai quali si può estendere que-sto effetto di vincolo, tenuto conto che esso vale, ferma restando la riser-va di bilanciamento, anche per la Corte costituzionale, di modo che que-sto effetto, tutt’al più, non dovrebbe dispiegare i suoi effetti erga omnesma restare limitato alle circostanze del caso concreto, con l’ulteriore enecessaria conseguenza che l’ordinamento resta vincolato in senso strettosolamente al contenuto delle decisioni prese nei suoi riguardi, mentre sidovrebbe parlare di una modulazione degli effetti quando la sentenzadella Corte europea riguardi un altro paese(5).––––––––––
(3) «[A]llo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDUovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica deisingoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal tra-dizionale diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da con-sentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente» (sent. n. 349/2007,punto 6.1. del Cons. in dir.).
(4) M. LUCIANI, Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzio-nale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale, in Corr. giur.,2008, p. 203, che ritiene non chiaro anche il modo in cui la Corte costituzionale si è ritenu-ta, nei termini anzidetti, vincolata al rispetto dei precedenti europei.
(5) M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 204.
NOTE E COMMENTI 1079
Con riferimento all’attività interpretativa della Corte costituziona-le, si è osservato come dalle sentenze non possa essere fatto discendere unobbligo al rispetto dell’interpretazione fatta propria dalla Corte europea,tenuto conto che questa può semmai rilevare al fine di individuare le di-sposizioni normative interne la cui applicazione comporta una violazio-ne della CEDU, che spetta allo Stato nel suo complesso (ed in primis aisuoi organi legislativi) rimuovere, ma che non è in grado di vincolare igiudici, pur rivestendo per questi ultimi una indubbia rilevanza(6). Suquesta premessa, e sulla più generale conclusione per cui la fisionomiaistituzionale della Corte europea è di per sé incompatibile con la creazio-ne di un vincolo interpretativo a carico delle autorità nazionali(7), l’in-tensità di esso viene ulteriormente attenuata quando a venire in discus-sione è l’attività della Corte costituzionale, considerato che ad essa nonpuò non essere riservato il compito di interpretare le disposizioni con-venzionali in difformità dai precedenti europei, quando e nella misura incui ciò si riveli necessario per adeguare il portato derivante dalla Con-venzione al rispetto di disposizioni costituzionali interne, evitando cosìuna situazione di conflitto(8).
Questa ricostruzione più moderata è quella che si è imposta nellasuccessiva giurisprudenza costituzionale e che è valsa a scongiurare il ri-schio di un eccessivo timore reverenziale nei confronti della Corte euro-pea, sia da parte dei giudici comuni, sia, soprattutto, della Corte costitu-
––––––––––(6) E. CANNIZZARO , Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e ordinamen -
to italiano in due recenti decisioni della Corte costituzionale, in Riv. dir. int., 2008, p. 141.(7) Su cui v. E. CANNIZZARO , The Effect of the ECHR on the Italian Legal Order: Di -
rect Effect and Supremacy, in Italian Yearbook of International Law, 2009, p. 183, che giu-stamente rimarca l’assenza di un sistema di vincolo del precedente interno alla stessa giuri-sprudenza della Corte EDU. In argomento v. anche V. ZAGREBELSKY, La giurisprudenzacasistica della Corte europea dei diritti dell’uomo: fatto e diritto alla luce dei precedenti, inB. BISCOTTI - P. BORSELLINO - V. POCAR - D. PULITANÒ (a cura di), La fabbrica delle inter -pretazioni, Milano, 2012, p. 69.
(8) E. CANNIZZARO , Sentenze della Corte europea , cit., p. 142, secondo il quale ci sitroverebbe davanti, in casi del genere, ad «una sorta di verfassungskonforme Auslegung dellaConvenzione europea», da esercitare tuttavia con «notevole cautela» poiché uno strumentocon cui la Corte costituzionale si riserva uno spazio di manovra interpretativo al fine di«garantire la sopravvivenza di disposizioni legislative pur difformi rispetto ad obblighiinternazionali» costituisce pur sempre un prezzo molto alto da pagare poiché «allontane-rebbe l’ordinamento italiano dagli indirizzi affermati sul piano internazionale, in nettocontrasto con l’obiettivo di fondare uno ius commune in materia di diritti dell’uomo».
1080 DIRITTO PUBBLICO
zionale. La fase giurisprudenziale inaugurata dalle ‘seconde’ sentenze ge-melle (nn. 311 e 317 del 2009), che con il principio della ‘massima espan-sione della tutela’ ha offerto una copertura ulteriore a quella riserva dibilanciamento che la Corte si era ritagliata già nel 2007, risulta infattichiaramente incentrata sulla relativizzazione dell’effetto di vincolo ope-rato dalle sentenze europee nel diritto interno e sulla maggiore conside-razione per uno spazio di ‘adattamento’ dei precedenti europei affidatonon più al solo legislatore. In questo spazio, la tecnica interpretativa delbilanciamento, usata dalla Corte come strumento in grado di consentireo vietare l’immissione di un contenuto di tutela sulla base del principiodella ‘massima espansione delle tutele’, non mette in discussione la titola-rità del ruolo di interprete eminente della Convenzione, che resta riser-vato alla Corte europea, valorizzando piuttosto il giudizio sul «come edin qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si in-serisca nell’ordinamento costituzionale italiano»(9). L’attenzione posta alrisultato concreto dell’interazione tra garanzie interne e convenzionali,unitamente alla considerazione per cui il richiamo al margine di apprez-zamento nazionale richiede di tenere conto del complesso dei diritti fon-damentali, ha spinto la Corte da quel momento in poi a sdrammatizzareil problema del vincolo interpretativo delle sentenze europee ricondu-cendolo più congruamente ai termini del rispetto della ‘sostanza’ delledecisioni europee(10). Proprio il criterio del rispetto della sostanza dellesentenze europee ha assunto, nelle parole dei due relatori delle sentenzedel 2007 e del 2009, il valore di un temperamento rispetto alla rigida os-servanza del contenuto delle pronunce europee, fondato sulla considera-zione della maggiore o minore riferibilità del decisum europeo all’ordi-namento italiano o al grado di radicamento nei precedenti europei(11).
In un quadro simile, l’esito inaugurato da questa giurisprudenza,che costituisce a sua volta lo sfondo teorico – non sempre adeguatamente
––––––––––(9) Sent. n. 317/2009, punto 7. del Cons. in dir.(10) Sent. n. 311/2009, punto 6. del Cons. in dir. Nella giurisprudenza successiva v.
in part. sentt. nn. 236 e 303 del 2011, 15/2012 e ord. n. 150/2012.(11) V. sul punto G. SILVESTRI, Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti
fondamentali , in Studi in onore di Franco Modugno, vol. IV, Napoli, 2011, p. 3416, e G.TESAURO, Costituzione e norme esterne, in Dir. U.E., 2009, pp. 219 s.
NOTE E COMMENTI 1081
rispettato, come si vedrà tra poco – di tutta la giurisprudenza successiva,costituisce il punto di fuga di una sistemazione dei rapporti tra corti etra ordinamenti che lascia ferma la prerogativa della Corte europea co-me giudice unico della Convenzione e che riserva alla Corte costituzio-nale l’infungibile ruolo di custode delle modalità secondo le quali il pro-dotto di quella interpretazione viene immesso nel diritto interno, sullabase delle diverse competenze degli organi dello Stato e dei rimedi inter-ni volti ad evitare i relativi conflitti(12).
Se questo appare l’indubbio corollario della complessa opera di ag-giustamento dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte europea deidiritti dell’uomo(13), non pare discutibile come a livello interno lo scopocostantemente perseguito dalla giurisprudenza costituzionale sia di evi-tare un’applicazione diretta della Convenzione da parte dei giudici co-muni, col connesso rischio di disapplicazione del diritto interno con essacontrastante(14). Il richiamo al rilievo ‘mediato’ della giurisprudenza eu-ropea è servito alla Corte costituzionale per compiere una doppia opera-zione. Da un lato, essa si sottrae al rischio di un vincolo diretto al rispet-to della giurisprudenza europea considerata in quanto tale (a prescinderecioè dalle ulteriori valutazioni riferite ai caratteri del caso di specie) per-ché ribadisce che la natura non autoapplicativa della CEDU non dipendeda una qualità intrinseca della stessa (delle norme della Convenzione edella giurisprudenza del suo giudice) bensì da una autonoma determina-zione del diritto interno, secondo la quale da essa non possono discende-re posizioni soggettive immediatamente esigibili di fronte al giudice na-––––––––––
(12) G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, cit., p. 217.(13) Senza tacere il fatto che la persistente qualificazione del vincolo interpretativo co-
me legato al ruolo di «interprete eminente» della Corte EDU e non ad un più modesto «do-vere di presa in considerazione» da parte delle autorità nazionali (sul modello del duty to ta-ke into account fatto proprio dallo Human Rights Act inglese, o della Berücksichtigungsp-flicht richiamata nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco) si lega ad unaoperazione di politica giudiziaria con cui la Corte costituzionale valorizza il ruolo dellaCorte europea come giudice unico mentre attenua la portata della Convenzione nel dirittointerno, sia per il tramite del divieto di applicazione diretta, sia in ragione del limite del ri-spetto dell’intera Costituzione (così E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte diStrasburgo secondo la Costituzione italiana, in Corr. giur., 2010, p. 959).
(14) Una perdita di potere discrezionale che verrebbe compensata dal potere/doveredei giudici di procedere ad una interpretazione adeguatrice ogni volta che ciò si riveli possi-bile (così E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo , cit., p. 957).
1082 DIRITTO PUBBLICO
zionale, quando a ciò sia di ostacolo una norma interna incompatibi-le(15). Dall’altro lato, ha identificato in se stessa il soggetto in grado dipresiedere a questa determinazione(16), posto che il ruolo che si è riser-vata in tal senso è stato più volte qualificato nelle proprie pronunce co-me «infungibile»(17), nel senso che ove manchi l’intervento del Legislato-re non può che spettare alla Corte il compito di dettare le linee dell’im-missione del diritto convenzionale nel diritto interno, nel rispetto diquanto prescrive il canone interpretativo del rispetto sistematico dellaCostituzione.
È noto, e non merita di essere qui ripercorso nel dettaglio, l’itinera-rio che ha seguito la Corte costituzionale dopo il 2009 nel modulare l’ef-fetto delle sentenze europee ricorrendo frequentemente a tecniche di di-stinguishing(18) che hanno attirato l’attenzione della dottrina, spesso criti-ca per via dell’assenza di una unitaria e coerente teoria del precedente edi un uso della giurisprudenza europea mirante talvolta a dare confermaalla decisione interna già assunta sulla base di altri parametri e di altre ra-gioni(19).
Di questo indirizzo interpretativo, di cui vi è traccia più o menoesplicita nella gran parte delle sentenze costituzionali che negli ultimi an-ni hanno affrontato il tema dell’immissione della CEDU nel diritto in-terno, quello che vale piuttosto la pena porre in evidenza è il mutare del-l’approccio seguito in ordine ai criteri di composizione dei conflitti tra
––––––––––(15) E. CANNIZZARO , The Effect of the ECHR, cit., p. 177.(16) G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, cit., p. 216, dove si nota che «fino a
quando il conflitto tra norma interna e norma internazionale convenzionale è costruitocome questione di costituzionalità, lo strumento della non applicazione da parte del giudicecomune equivarrebbe nella sostanza all’introduzione di un meccanismo di controllo diffusodi costituzionalità, scelta opposta a quella operata nel nostro attuale ordinamento giuridi-co».
(17) Sentt. nn. 170 e 202 del 2013.(18) Basti pensare, senza alcuna pretesa di esaustività, alle ordd. nn. 43 e 143 del 2009
e alle sentt. nn. 56 e 239 del 2009, 236, 257 e 303 del 2011, 15/2012.(19) V. per tutti, oltre a quanto rilevato da E. LAMARQUE in Gli effetti delle sentenze,
cit., p. 960, A. GUAZZAROTTI, Strasbourg Jurisprudence as an ‘Input’ for Cultural Evolu-tion in Italian Judicial Practice, in G. REPETTO (ed.), The Constitutional Relevance of theECHR in Domestic and European Law. An Italian Perspective, Antwerp/Portland/Ore-gon, 2013, pp. 55 ss., nonché, dello stesso autore, amplius in Precedente CEDU e mutamen-ti culturali nella prassi giurisprudenziale italiana, in Giur. cost., 2011, pp. 3779 ss.
NOTE E COMMENTI 1083
norme della Convenzione e, soprattutto, precedenti del suo giudice enorme costituzionali con essi confliggenti.
In particolare, tenuto conto che la riserva di bilanciamento fondatasu un ‘margine di apprezzamento interno’, per quanto si è detto, costi-tuisce ormai un dato acquisito nella giurisprudenza costituzionale e cheproprio ad essa la Corte si è richiamata per ‘sagomare’ i contorni dellesentenze europee, quando non espressamente per impedirne la piena effi-cacia, il punto dirimente diventa comprendere con quali modalità essa sisia avvalsa di un simile apprezzamento. Nella già richiamata sent. n.317/2009, infatti, il canone della ‘massima espansione delle tutele’ si do-veva ritenere l’equivalente di una valutazione sistematica dei rapporti tradiritto convenzionale e diritto costituzionale considerata però nell’otticadi un processo di aggiustamento e di mutui apprendimenti, nel senso cheil risultato dell’integrazione tra tutele era da ritenersi, come ben è statodetto, bidirezionale(20), perché di per sé non escludeva che da Strasburgopotessero provenire input in grado di produrre una riconfigurazione dialcuni bilanciamenti che dovrebbero ritenersi imposti guardando al pia-no solamente interno (basti pensare al filone giurisprudenziale sulla ria-pertura del giudicato, su cui infra). Più avanti, e segnatamente nella sent.n. 264/2012, il criterio in questione lascia il campo ad un’impostazionedei rapporti centrata sulla diversa fisionomia istituzionale delle due Cor-ti: mentre la Corte EDU, infatti, «è tenuta a tutelare in modo parcelliz-zato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in gioco», la Cortecostituzionale «opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valoricoinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta aquel bilanciamento, solo ad essa spettante, che, nella specie, dà appuntoluogo alla soluzione indicata»(21). Dietro questa formula, come è statonotato, si nasconde non solo un possibile fraintendimento intorno aicaratteri ‘costituzionali’ della giurisdizione affidata alla Corte EDU, maanche e soprattutto il tentativo di confinare l’azione di questa al solo pia-
––––––––––(20) O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, art 10, c. 1, Cost. e bilanciamento ‘bi-
direzionale’: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionalenelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?, in Forum Quad. cost.,16 dicembre2009.
(21) Punto 5.4. del Cons. in dir.
1084 DIRITTO PUBBLICO
no internazionale, senza considerare adeguatamente che sempre maggiorie più frequenti sono le occasioni in cui questa manifesta un’attitudine re-sponsiva nei confronti di soluzioni anche divergenti elaborate dalle Cor-ti nazionali, facendo così intravedere «uno spazio per una composizionecooperativa dei conflitti»(22).
Questo orientamento(23) produce l’indubbio effetto di sostituire adun criterio dinamico di integrazione, quello affidato alla ‘massima espan-sione delle tutele’, un meccanismo più rigido perché fa leva piuttostosulla cristallizzazione istituzionale del ruolo delle due Corti, raffiguratecome poste a guardia di due ordini normativi e istituzionali separati,quando non contrapposti. Un esito, quest’ultimo, che rafforza le per-plessità di chi ritiene che qualsivoglia adeguamento del portato delle de-cisioni europee, a maggior ragione quando si traduce – come nel caso dispecie – in un impedimento all’immissione nel diritto interno di un pre-cedente CEDU, costituisca un inadempimento dell’obbligo derivantedall’art. 46 CEDU e determini un allontanamento inammissibile dell’or-dinamento italiano dagli indirizzi affermatisi a livello europeo, circo-stanza tanto più grave quanto più quegli indirizzi siano consolidati neltempo(24).
Piuttosto che mettere in dubbio qualsiasi spazio di autonoma valu-tazione dei precedenti europei, che costituisce semmai un orientamentospeculare a quello fatto proprio dalla Corte costituzionale nella sent. n.
––––––––––(22) C. PINELLI, ‘Valutazione sistematica’ versus ‘valutazione parcellizzata’: un para-
gone con la Corte di Strasburgo , in Giur. cost., 2012, p. 4232.(23) Che si è tradotto in una faglia di conflitto con la Corte EDU, che dopo il caso
Maggio v. Italy (n. ric. 46286/09, sent. del 31 maggio 2011) è tornata di recente nel casoStefanetti (n. ric. 21838/10, sent. del 15 aprile 2014) ad occuparsi della legislazione internarelativa ai criteri di riliquidazione delle pensioni maturate in Svizzera, ribadendone la con-trarietà alla Convenzione. Da ultimo, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi in li-nea col suo precedente del 2012 nella sent. n. 10/2014. Vale la pena sottolineare come que-sta saga giurisprudenziale sia stata presa ad esempio dalla stessa Corte europea, in un docu-mento preparatorio di un seminario interno sul seguito delle proprie sentenze, comeun’ipotesi di reluctance da parte delle corti interne nell’adeguare il proprio diritto interno:Seminar background paper su Implementation of the judgments of the European Court ofHuman Rights: a shared judicial responsibility?, in www.echr.coe.int.
(24) G. STROZZI, La tutela (s)bilanciata dei diritti fondamentali dell’uomo, in Dir.U.E., 2014, pp. 193 ss., e F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenzenazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra ‘guerra’ e ‘dialogo’,in Dir. pen. contemp., 14 luglio 2014, pp. 13 ss.
NOTE E COMMENTI 1085
264/2012, vale invece la pena riaffermare come quella riserva di bilancia-mento che la Corte si è ritagliata (e non può che spettarle) richiede disvolgersi sul terreno dei casi concreti e dell’integrazione delle relativetutele più che sul piano delle general propositions(25), secondo il modellodella ‘massima espansione delle tutele’(26). Diversamente, oltre a quantogià detto, si finirebbe anche per sovrastimare un inquadramento dell’ef-fetto di vincolo delle sentenze europee affidato alle tradizionali coppieoppositive civil law/common law e, soprattutto, giurisdizione legata alcaso/giurisdizione con effetto erga omnes(27), che se pure non hanno laloro perso validità, richiedono di essere profondamente ripensate alla lu-ce della sempre più evidente connotazione ‘oggettiva’ della giurispruden-za europea.
3. Il fondamento delle sentenze della Corte di Strasburgo che richie-dono l’adozione di misure generali. – Ad un simile modo di operare del-l’effetto di vincolo si è andata infatti affiancando, nel periodo più recen-te, un’ulteriore modalità di integrazione, imperniata sulle sentenze dellaCorte di Strasburgo che accertano una violazione c.d. sistemica dellaConvenzione. Parallelamente al consolidamento del ruolo della Corteeuropea (consacrata con gli ultimi Protocolli aggiuntivi, in particolare inn. 14 e 16), si assiste sempre più spesso a casi in cui questa non si limitaa ravvisare un contrasto ‘isolato’ tra un atto interno e una clausola dellaCEDU, bensì accerta situazioni di conflitto che, per il fatto di ripetersinel tempo e dare luogo a una mole notevole di contenzioso, ovvero per-ché sono dovute a scelte di sistema fatte dall’ordinamento interno, nonpossono essere risolte solamente tramite la condanna all’equa riparazione
––––––––––(25) Così C. PINELLI, op. e loc. ult. cit.(26) V. sul punto il riassestamento cui si è giunti da ultimo con la sent. n. 191/2014,
secondo la quale l’impiego congiunto del parametro interno e di quello convenzionale con-sentono alla Corte «di effettuare una valutazione sistematica e non frazionata dei diritti co-involti dalla norma di volta in volta scrutinata, in modo da assicurare la massima espansionedi tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali [...] che sempre si trova-no in integrazione e reciproco bilanciamento».
(27) Su cui richiamano l’attenzione D. TEGA, I diritti in crisi, Milano, 2012, pp. 43ss., e F. BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesidi un confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessitàdel sistema dei reciproci rapporti, in Giur. cost., 2012, p. 4240.
1086 DIRITTO PUBBLICO
di cui all’art. 41 CEDU(28), richiedendo l’adozione di specifiche misure acarattere generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 CEDU(29). Sipensi solamente, per stare alle classificazioni che ha effettuato la dottrinasulla scorta della giurisprudenza, a quei casi in cui la violazione è deter-minata, in assenza di uno specifico provvedimento applicativo, dalla solaesistenza (oppure dall’assenza) di una norma di legge; ovvero a quei casiin cui un provvedimento (amministrativo o giurisdizionale) esiste macostituisce l’applicazione corretta di una norma di legge; ovvero, infine,a quei casi in cui l’applicazione della legge operata da un certo provvedi-mento non è la sola possibile, ma rappresenta nondimeno una prassi dif-fusa e consolidata(30).
In tutti questi casi, l’esperienza degli ultimi anni insegna che la Cor-te europea, nel decidere la controversia ad essa sottoposta, ha spessoprovveduto in un primo momento a rilevare l’esistenza del problema ela perdurante assenza di rimedi a livello nazionale, provvedendo in unsecondo momento a fornire indicazioni generali, rivolte a mettere in lu-ce il carattere non isolato della violazione e spesso a prefigurare, in ma-niera più o meno specifica, gli strumenti attuativi che lo Stato dovrebbemettere in campo per porre rimedio alla violazione accertata(31).
––––––––––(28) «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Proto-
colli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imper-fetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equasoddisfazione alla parte lesa».
(29) Il cui § 1 recita: «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle senten-ze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti».
(30) P. PIRRONE, Art. 46, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY (a cura di),Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali , Padova, 2012, p. 748, con richiami di giurisprudenza.
(31) Emblematico il filone giurisprudenziale riguardante la durata irragionevole deiprocessi nel sistema italiano. In un primo momento, come noto, la Corte europea prendeatto (Bottazzi v. Italy, n. ric. 34884/97) che «the frequency with which violations arefound shows that there is an accumulation of identical breaches which are sufficientlynumerous to amount not merely to isolated incidents. Such breaches reflect a continungsituation that has not yet been remedied and in respect of which litigants have no domesticremedy» (§ 22). Successivamente (Scordino (1) v. Italy, n. ric. 36813/97) la Corte, rilevatatra l’altro l’inadeguatezza dei rimedi compensativi introdotti dalla legge n. 89/2001 (c.d.Legge Pinto), giunge (§§ 238 ss.) a indicare specifici strumenti volti a rendere effettivo il di-ritto consacrato dall’art. 6 CEDU, così come elaborati dal Comitato dei Ministri e dalle Ri-soluzioni ivi citate. Per ulteriori richiami giurisprudenziali e per un’analisi dettagliata dellagiurisprudenza in argomento v. D. HAIDER, The Pilot-Judgment Procedure of the European
NOTE E COMMENTI 1087
Con l’andar del tempo, il diffondersi di questa prassi ha spinto laCorte europea ad addossare sugli Stati contraenti non solo l’obbligo diequa riparazione derivante dall’art. 41 della Convenzione, e che tradizio-nalmente ha rappresentato lo strumento principe di soddisfazione dellepretese dei soggetti vincitori a Strasburgo, ma anche un obbligo di risul-tato volto a porre fine, secondo modalità vagliate dal Comitato dei Mi-nistri, alla prassi di portata generale ritenuta in contrasto con la Con-venzione(32).
L’evoluzione di questa prassi giurisprudenziale risulta fortementelegata ad un mutamento nel modo tradizionale di intendere l’efficaciadelle sentenze della Corte europea, proprio perché rispetto allo strumen-to dell’equa riparazione, che ha costituito il pilastro sul quale si è andatacostruendo la natura solamente dichiarativa delle sentenze della Corteeuropea, si è andato valorizzando il ruolo dell’obbligo di conformazionedi cui all’art. 46 CEDU(33).
Quest’ultimo articolo, infatti, ha progressivamente ampliato la suasfera d’azione perché l’obbligo che da esso nasce non è più stato letto inconnessione con i profili individuali dell’accertamento operato dallaCorte (la misura individuale di restitutio in integrum), ma anche a queiprofili generali che la sentenza di condanna ravvisa come fonti più o me-no dirette della violazione subita dal ricorrente. Man mano, infatti, chela Corte e il Comitato dei Ministri si sono confrontati con ricorsi che in-direttamente richiedevano, per la loro soluzione, di accertare l’esistenzadi violazioni strutturali a livello interno, il contenuto rilevante delle sen-tenze in questione è andato oltre i confini tracciati dall’oggetto formale––––––––––Court of Human Rights, Leiden-Boston, 2013.
(32) Come affermato già nella decisione Scozzari and Giunta v. Italy (nn. ricc.39221/98 e 41963/98, § 249), «a judgment in which the Court finds a breach imposes onthe respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awardedby way of just satisfaction, but also to choose, subject to supervision by the Committee ofMinisters, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in theirdomestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so faras possible the effects».
(33) P. LEACH, No longer offering fine mantras to a parched child? The European Co -urt’s developing approach to remedies , in A. FØLLESDAL - B. PETERS - G. ULFSTEIN (eds.),Constituting Europe. The European Court of Human Rights in a National, European andGlobal Context, Cambridge, 2013, pp. 142 ss., B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale so-vranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012, p. 116.
1088 DIRITTO PUBBLICO
della causa, per abbracciare le valutazioni adottate dalla Corte europea inmerito all’esistenza e ai possibili rimedi da attuare per far fronte a taliviolazioni(34).
Questo orientamento è stato oggetto di valutazioni assai diversifica-te nella dottrina internazionalistica, che si è divisa tra chi ritiene che allesentenze europee debba ancora riconoscersi solamente una natura dichia-rativa e chi, al contrario, ritiene che rientri ormai pianamente nell’ambi-to della giurisdizione della Corte europea, come scaturente dall’art. 3della Convenzione, il potere di dettare misure di ordine generale(35). Dalprimo punto di vista, le sentenze della Corte europea non sarebbero ingrado di fondare un obbligo giuridico in capo agli Stati al di là della sin-gola misura individuale oggetto del giudizio, ferma restando la facoltàper questi ultimi di un adempimento spontaneo a eventuali indicazionidi ordine generale, dettato però da una mera esigenza pratica, consistentenell’evitare future sentenze di condanna. Dal secondo punto di vista, in-vece, preso atto di un obbligo di adeguamento del diritto interno aquanto stabilito dal testo della Convenzione, alle sentenze della Corteviene riconosciuta la funzione di chiarire la portata di quanto in essa sta-bilito, con tutto quel che ne consegue in termini di effetto vincolantedelle decisioni anche al di là del caso da cui ha tratto origine la contro-versia.
Come è stato giustamente osservato, se il primo indirizzo non tro-va più alcun riscontro né nella giurisprudenza né nella prassi degli organieuropei, il secondo trascura che dalla CEDU non deriva alcun obbligo diadeguamento del diritto interno a quanto stabilito nelle decisioni dellaCorte, perché gli Stati restano liberi di predisporre i mezzi che ritengo-no più appropriati per realizzare l’obbligo di risultato derivante dagli
––––––––––(34) P. PIRRONE, Art. 46, cit., p. 479. Di una «vigorosa tendenza a portarsi oltre il ca-
so» scrive A. RUGGERI, L’‘intensità’ del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali,con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affer -mazione della Costituzione come ‘sistema’, in ID., ‘Itinerari’ di una ricerca sul sistema dellefonti, vol. XVII (Studi dell’anno 2013), Torino, 2014, p. 46.
(35) V. l’attenta ricostruzione di S. VEZZANI, L’attuazione delle sentenze della Corteeuropea dei diritti dell’uomo che richiedono l’adozione di misure a portata generale, in L.CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo ,Napoli, 2012, pp. 50 ss.
NOTE E COMMENTI 1089
obblighi internazionali assunti con la sottoscrizione della Convenzio-ne(36).
Quanto all’individuazione del fondamento del potere in questione,più appropriata pare quindi la ricostruzione fornita da chi ha ritenutoche all’ombra dell’art. 46 CEDU sia maturata una prassi infra legem, cheha spinto lo spettro delle sue possibili letture verso la consacrazione del-l’esercizio di una giurisdizione di natura sempre più oggettiva, in questoavvalorata da un ampliamento dei poteri e del ruolo riconosciuto allaCorte europea. La costante emancipazione di quest’organo, infatti, dalmodello della giurisdizione internazionale, l’attribuzione di un potere diricorso agli individui oltre che agli Stati e, non ultimo, il consolidamen-to del suo ruolo nei termini di un rispetto sempre più radicato delle suepronunce sono tutti elementi che hanno spinto ad allargare il legame trala funzione da esso esercitata e l’ampiezza del suo giudicato, perché ad es-so non si richiede più solamente di dirimere controversie, ma anche di«assicurare il rispetto del diritto oggettivo, in quanto tale, tutelando l’in-teresse generale ed evitando, quindi, il ripetersi di violazioni analoghe aquella accertata» così che «il giudicato tenderà ad estendersi oltre i limitidelineati dall’oggetto formale della controversia»(37).
Seppure, pertanto, sembra indubbio che il fondamento delle deci-sioni che accertano violazioni sistemiche e impongono agli Stati obblighidi adeguamento di natura generale, per quanto variamente intesi, vadarinvenuto nell’evoluzione del ruolo della Corte europea e nella sua affer-mazione come attore costituzionale europeo, resta fermo che questaevoluzione non deve essere sovrastimata. Ancora oggi, infatti, le raffigu-razioni più consapevoli del suo ruolo costituzionale sono attente a tenerein equilibrio la dimensione individuale della sua azione, caratterizzata––––––––––
(36) S. VEZZANI, op. ult. cit., p. 51. La discrezionalità degli Stati nell’individuare le mi-sure in grado di porre rimedio all’inadempimento dichiarato a Strasburgo è una costantedella giurisprudenza europea, a partire da Marckx v. Belgium, n. ric. 6833/74. Questa di-screzionalità è a ragione ritenuta un’applicazione del più generale principio di sussidiarietàda M. VILLIGER, The Principle of Subsidiarity in the European Convention on Human Ri -ghts, in M.G. KOHEN (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict ResolutionThrough International Law. Liber amicorum Lucius Caflisch , Leiden/Boston, 2007, p.632.
(37) P. PIRRONE, op. ult. cit., pp. 749, 757, nonché ID., L’obbligo di conformarsi allesentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2004, pp. 19 ss.
1090 DIRITTO PUBBLICO
dal suo porsi come giudice di ricorsi individuali che ad essi deve dareuna risposta ed in ciò trova un tratto imprescindibile della sua fisiono-mia, e la dimensione costituzionale(38), che si incarna nel suo ruolo di ga-rante oggettivo dell’ordine pubblico europeo dei diritti fondamentali,con tutto quel che ne consegue in termini di ultrattività dell’efficacia del-le sentenze e, in prospettiva, di un potere di selezionare i casi da decide-re(39).
Proprio per questo, il ricorso agli strumenti in questione va valuta-to in concreto, nella consapevolezza che la diffusione di una simile giuri-sdizione oggettiva rischia di incrinare quel fragile equilibrio che finora,tra alterne fortune, ha fatto dell’esperienza della Corte europea una suc-cess story. Un equilibrio che, tuttavia, oggi pare incrinato soprattuttodalla difficoltà di identificare con ragionevole accuratezza le caratteristi-che delle sentenze in questione, dietro la quale si nasconde il problema didelimitare i confini del potere della Corte di imporre agli Stati misure diportata generale.
––––––––––(38) In argomento v. C. PINELLI, The Constitutional Relevance of the ECHR in Do -
mestic and European Law. General Assessments, in G. REPETTO (ed.), The ConstitutionalRelevance, cit., pp. 239 ss. e L. HELFER, Redesigning the European Court of Human Rights:Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime, in Eu-ropean Journal of International Law, 2008, p. 134, dove si auspica il consolidamento diuna diffuse embeddedness della Convenzione negli ordinamenti nazionali, che prescinde darigide gerarchie ma richiede «the skilful use of persuasion to realign the interests and in -centives of decision-makers in favour of compliance with the tribunals’ judgments». A so-stenere un a ricomposizione del dibattito tra individual e constitutional justice nei terminidi un pluralismo costituzionale sono da ultimo L. WILDHABER - S. GREER, Revisiting theDebate about ‘constitutionalising’ the European Court of Human Rights, in Human RightsLaw Review, 2012, pp. 684 ss., secondo i quali «the fact that national courts may not shareStrasbourg’s interpretation of what are essentially the same fundamental rights found indifferent documents, does not mean that each court, and each document, are not compo-nents of a common, though pluralistic, ‘multi-verse’ of constitutional systems. As othercommentators have pointed out, the unevenness of a constitutional process does not neces-sarily deprive it of its constitutional character».
(39) Sui termini dell’evoluzione in chiave costituzionale riveste oggi un peso centraleil nuovo potere attribuito alla Corte dal Protocollo n. 16 di rendere parere in chiave pre-ventiva alle giurisdizioni superiori degli Stati membri: sui rischi connessi a tale evoluzionev. ora O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una ‘alta giurisdizione nazionale’ ai finidella richiesta di parere alla Corte EDU ex Protocollo 16?, in forumcostituzionale.it (2aprile 2014), e, più in generale, A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapportitra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione allaCEDU e all’entrata in vigore del Prot. 16), in rivistaaic.it (7 febbraio 2014).
NOTE E COMMENTI 1091
4. … la loro (incerta) tipologia … – Come si diceva poc’anzi, le deci-sioni della Corte europea che determinano un vincolo particolarmentepenetrante sono quelle che richiedono allo Stato misure di carattere ge-nerale, il che avviene quando oggetto dell’accertamento non è un contra-sto isolato tra un atto interno (una prassi amministrativa, un provvedi-mento amministrativo, una sentenza) e una clausola della Convenzione,bensì quando un contrasto, per il fatto di ripetersi nel tempo e dare luo-go ad una mole notevole di contenzioso, ovvero perché è dovuto ad unascelta di sistema fatta dall’ordinamento, non può essere risolto solamentetramite una condanna al pagamento di un’equa riparazione.
Nell’analizzare questa categoria di decisioni, la prima difficoltà stanel fatto che esse non rientrano in una precisa categoria, perché alla man-canza di precise regole di procedura (fatta eccezione per l’art. 61 del re-golamento di procedura della Corte in tema di sentenze pilota, di cui siparlerà oltre) si affianca la sovrapposizione tra due dimensioni in cui sipuò esplicare l’accertamento di una violazione strutturale. C’è, infatti,una prima dimensione fattuale, che ricorre quando una sentenza di con-danna si presta a produrre effetti di sistema per il solo fatto che la viola-zione riscontrata si ripete nel tempo, indipendentemente dalla fonte dellaviolazione contestata, se cioè essa sia legislativa, regolamentare, ammini-strativa o giurisdizionale. Si pensi, ad esempio, al filone già menzionatosulla durata ragionevole dei processi ovvero alla sentenza pilota resa con-tro l’Italia nel caso Torreggiani sul sovraffollamento carcerario(40): inquesto caso oggetto della condanna è, ancora prima delle regole che gui-dano i processi nel diritto italiano o le condizioni della reclusione, il fat-to, rispettivamente, della durata dei giudizi o della ristrettezza dei luoghidi detenzione, così come appurato nella sua oggettività e per come deter-minato da una serie indistinta di fattori (amministrativi, organizzativi,normativi, ecc.) che hanno portato la Corte europea a pronunciarsi ripe-tutamente sull’argomento. C’è poi una seconda dimensione, che si po-trebbe definire invece istituzionale, che ricorre quando la natura siste-matica della violazione dipende dalla particolare fonte giuridica di essa,indipendentemente – questa volta – dalla consistenza numerica o dalla––––––––––
(40) Torreggiani and Others v. Italy, n. ric. 43517/09, sent. dell’8 gennaio 2013.
1092 DIRITTO PUBBLICO
frequenza statistica delle violazioni riscontrate e portate all’attenzionedel giudice europeo. Si pensi, qui, alle vicende dei noti casi Scoppola(41)(relativo alla necessaria retroattività della legge penale più favorevole) oCosta e Pavan(42) (sull’accesso alla diagnosi preimpianto per le coppie fer-tili ma soggette al rischio di trasmissione di una malattia genetica): inquesti casi, la natura strutturale della violazione accertata è legata nonpiù ad un fatto ripetuto nel tempo, bensì alla fonte da cui trae origine laviolazione, che in virtù della sua natura generale (in questi casi una legge)si pone come ostacolo al soddisfacimento della pretesa del ricorrente e al-la sua restitutio in integrum. Nulla esclude, peraltro, che le due dimen-sioni possano ricorrere congiuntamente, come è avvenuto nella sentenzapilota resa nel caso M.C. v. Italy(43) relativa alle limitazioni al risarcimen-to per i danni subiti da emotrasfusioni. Questa ambiguità si è riversatasulle formule decisionali cui la Corte europea ha fatto ricorso per con-dannare gli Stati in presenza di violazioni sistemiche, che a seguito dellaformalizzazione della procedura per l’adozione delle sentenze pilota(44),risultano oggi articolate in tre grandi categorie(45):
i) le sentenze pilota in senso stretto (full-pilot judgments): sono le de-cisioni verso cui la Corte, a partire dal celebre caso Broniowski v. Po-land, ha con sempre maggiore frequenza instradato le controversiecaratterizzate dall’allargamento degli effetti ad una schiera non determi-nabile a priori di soggetti e di situazioni(46). In queste, come noto, allaidentificazione di una violazione strutturale la Corte fa seguire l’indica-
––––––––––(41) Scoppola (2) v. Italy, n. ric. 10249/03, sent. del 17 settembre 2009.(42) Costa et Pavan v. Italie, n. ric. 54270/10, sent. del 28 agosto 2012.(43) M.C. and Others v. Italy, n. ric. 5376/11, sent. del 3 settembre 2013.(44) Con la modifica, già ricordata, dell’art. 61 del regolamento di procedura della
Corte, avvenuta nel 2011.(45) Riprendo, modificandola leggermente, la classificazione operata da P. LEACH - H.
HARDMAN - S. STEPHENSON - B.K. BLITZ (eds.), Responding to Systemic Human RightsViolations. An Analysis of ‘Pilot Judgments’ of the European Court of Human Rights andtheir Impact at National Level, Antwerp/Oxford/Portland, 2010, pp. 13 ss.
(46) La natura sistemica della violazione è stata così definita dalla Corte europea a par-tire da Burdov v. Russia (2), n. ric. 33509/04, sent. del 15 gennaio 2009, § 131: «the viola-tions found […] were neither prompted by an isolated incident, nor attributable to a parti-cular turn of events in this case, but were rather the consequence of regulatory shortco-mings and/or administrative conduct of the authorities».
NOTE E COMMENTI 1093
zione di misure generali che lo Stato condannato è tenuto a prendere alfine di porre rimedio alla violazione in tutta la sua portata. A questi ele-menti può accompagnarsi una ulteriore proceduralizzazione (introdottadal ricordato art. 61 del Regol. proc.), costituita dall’assegnazione di unmargine temporale entro cui lo Stato è tenuto a conformarsi e dal tem-poraneo ‘congelamento’ dei ricorsi aventi le medesime caratteristiche diquello pilota. Va notato che la natura sistemica della violazione è stataalternativamente qualificata come widespread(47) o structural(48), ripro-ponendo così la doppia dimensione fattuale e istituzionale che caratteriz-za l’intera materia(49);
ii) le sentenze pilota in senso lato (quasi-pilot judgments, Art. 46 jud-gments): alla base di queste pronunce vi è sempre una medesima disfun-zione sistemica da parte degli Stati, cui segue una invocazione diretta del-l’art. 46 cit. da parte della Corte come fonte di un obbligo all’introdu-zione di misure generali o individuali necessarie per porre fine alla viola-zione. A differenza delle sentenze pilota in senso stretto, tuttavia, in que-sta categoria di sentenze non c’è l’indicazione nel testo della sentenza dispecifici rimedi imposti agli Stati, né è possibile avvalersi degli strumentiprocedurali contenuti nel citato art. 61(50). Anche in questo caso, nonmancano pronunce che ravvisano la natura sistemica della violazionenon tanto nel carattere diffuso del problema esaminato (e quindi nel ri-schio di ricorsi ripetitivi), quanto nella natura della disfunzione conside-rata in sé e per sé(51).
––––––––––(47) Broniowski v. Poland, n. ric. 31443/96, sent. del 22 giugno 2004.(48) Olaru and Others v. Moldova , n. ric. 476/07, sent. del 12 ottobre 2010.(49) Per un’analisi dettagliata di questa tipologia di sentenze, oltre all’analisi offerta da
D. HAIDER, The Pilot-Judgment Procedure, cit., passim, v. anche P. LEACH, No longer offer-ing fine mantras, cit., pp. 161 ss.
(50) Quali esempi di queste pronunce, limitandosi a quelle concernenti l’Italia, basti ri-chiamare quelle relative al filone sul giudizio celebrato in absentia (Sejdovic v. Italy, n. ric.56581/00 e RR v. Italy¸ n. ric. 42191/02) o a quelle in tema di espropriazione (Scordino 1v. Italy, n. ric. 36813/97, Scordino 3 v. Italy, n. ric. 43662/98 e Guiso-Gallisay v. Italy,58858/00).
(51) Come nei casi (riportati da P. LEACH, No longer offering fine mantras, cit., p.168) relativi al congedo parentale per i soggetti di sesso maschile appartenenti alle forze ar-mate, alle limitazioni dei diritti di difesa per i detenuti condannati per ragioni disciplinari,ovvero alle norme che regolano i conflitti all’interno delle comunità religiose.
1094 DIRITTO PUBBLICO
iii) Le sentenze che accertano ma non dichiarano una violazione siste-mica (other judgments addressing systemic issues): in questi casi, oltre al-l’assenza degli elementi procedurali previsti per le sentenze pilota, non èesplicitamente richiamato nel corpo delle decisioni un obbligo di esecu-zione ex art. 46 CEDU che vada al di là dei contorni del caso di specie,ma ciò nonostante la Corte provvede ugualmente a identificare un pro-blema sistemico e intima conseguentemente allo Stato di farsene carico.È accaduto in passato che la Corte europea si sia servita di queste pro-nunce per ‘instradare’ una sentenza pilota o quasi-pilota(52), ma frequentisono anche i casi in cui la Corte si limita ad accertare violazioni che pre-sentano elementi di maggiore ‘qualificazione’ in termini sistematici ostrutturali rispetto a ipotesi di contrasto solamente puntuale o isolato(53).Quest’ultima categoria, dai contorni sicuramente più incerti perché prividi qualsiasi contrassegno formale (primo fra tutti il richiamo esplicito adun obbligo di conformazione derivante dall’art. 46 cit.), è quella che ne-gli ultimi tempi ha creato i maggiori interrogativi, perché sempre piùspesso gli Stati condannati (tra cui l’Italia) trattano queste pronunce comese fossero pronunce rientranti nei casi i) e ii)(54), predisponendo a livellointerno strumenti di adeguamento (legislativi o giurisprudenziali) similia quelli richiesti nelle altre tipologie decisorie.
Da questa classificazione, e dall’evidente sovrapposizione tra i requi-siti che spingono la Corte europea ad adottare l’uno o l’altro moduloprocessuale, deriva che gli effetti che si producono per le autorità nazio-nali sono in larga misura coincidenti, perché la natura sistemica o co-munque non occasionale della violazione è il presupposto comune a tut-te e tre le tipologie di pronunce e spesso non si differenzia al loro inter-no se non per ragioni quantitative (la numerosità dei casi di violazione) enon qualitative (cioè legate, in ipotesi, alla natura o al rilievo della viola-zione accertata).
––––––––––(52) Come avvenuto nel passaggio dalla decisione Bottazzi a Scordino (1) sulla durata
irragionevole dei processi.(53) È il caso, sempre con riferimento all’Italia, della decisione resa nel caso Saadi (n.
ric. 37201/06) e delle altre che si richiameranno più diffusamente nel prossimo §.(54) P. LEACH - H. HARDMAN - S. STEPHENSON - B.K. BLITZ (eds.), Responding to Sy-
stemic Human Rights Violations, cit., p. 27.
NOTE E COMMENTI 1095
Da un lato, infatti, non sussiste una correlazione sostanziale tra il ti-po di fattispecie esaminate e il modulo decisionale impiegato dalla Corte,sia perché questa ha dimostrato, come si è visto, di alternare indici diver-si e non sovrapponibili quanto ai casi che richiedono soluzioni generali(widespread e/o structural), sia ancora prima perché a spingere per l’ado-zione di una sentenza pilota non è una caratteristica oggettiva del caso,bensì il più delle volte solo un’esigenza organizzativa interna al lavorodella Corte, consistente nel numero di ricorsi pendenti di cui questa sipuò momentaneamente liberare avviando questa procedura.
Dall’altro lato, il presupposto comune a tutte queste pronunce è laloro capacità di dispiegare effetti, più o meno vincolanti, anche al di làdella specifica controversia da cui ha tratto origine la pronuncia, ma nel-la consapevolezza che il grado di intensità e di penetrazione dei rimediprefigurati nelle sentenze europee dipende prevalentemente dalle specifi-cità del caso e dalla natura più o meno obbligata del rimedio richiesto al-lo Stato. Quest’ultimo può variare tra un minimo, coincidente con l’in-vito più o meno esplicito allo Stato di dotarsi di un certo tipo di rime-dio(55) (ad esempio la modifica di una certa norma legislativa o l’introdu-zione di un meccanismo compensativo) sino all’ipotesi massima in cui lasoluzione imposta allo Stato resistente è una e una soltanto: ad esempio,la riapertura del processo in tutti quei casi in cui questo sia stato celebra-to in violazione dei requisiti stabiliti dall’art. 6 CEDU(56), la restituzionedella proprietà ingiustamente sottratta(57) o la richiesta specifica di libera-zione del soggetto ingiustamente detenuto(58).
Le difficoltà nell’identificazione di una tipologia di decisioni caratte-rizzata da un’ultrattività del giudicato ex art. 46 CEDU trova le sue ra-gioni, oltre che in quanto già detto, anche nel fatto che con l’arsenaledecisionale di cui si è dotata la Corte essa ha inteso rispondere ad una––––––––––
(55) D. HAIDER, The Pilot-Judgment Procedure, cit., pp. 150 ss.(56) Somogyi v. Italy, n. ric. 67972/01, sent. del 18 maggio 2004.(57) Papamichalopoulos and Others v. Greece, n. ric. 14556/89, sent. del 31 ottobre
1995.(58) Assanidzé v. Georgia, n. ric. 71503/01, sent. dell’8 aprile 2004. Per ulteriori rife-
rimenti v. E. MALFATTI, I ‘livelli’di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione euro-pea, Torino, 2013, p. 158; D. HAIDER, The Pilot-Judgment Procedure, cit., pp. 134 ss.; P.LEACH, No longer offering fine mantras, pp. 149 ss., P. PIRRONE, Art. 46, cit., pp. 752 s.
1096 DIRITTO PUBBLICO
carenza della propria azione, derivante dall’assenza strutturale di un ef-fetto diretto e prevalente delle proprie decisioni a livello interno. In que-sta chiave, c’è chi ha visto nell’espansione dei suoi poteri (e soprattuttonel diffondersi delle sentenze pilota) l’istituzionalizzazione di un obbligodi lawmaking a carico degli Stati, particolarmente evidente quando la ca-renza strutturale a livello interno coincide con una norma legislativa (siaessa contraria alla Convenzione o del tutto assente)(59). Se una simile let-tura accentua eccessivamente alcuni aspetti del problema(60), resta veroche l’innesto di una robusta componente oggettiva in una giurisdizionetradizionalmente vincolata al caso concreto e priva di un potere decisio-nale valido erga omnes rischia di dilatare oltre il dovuto l’effetto ultrapartes delle decisioni europee(61): se non secondo la classica accezione in-ternazionalistica dell’authorité de chose interpretée, almeno nei terminidi una portata espansiva all’interno del singolo ordinamento nazionale,in tutti i casi che con quello deciso a Strasburgo presentano un certo gra-do di affinità(62).
5. … e i loro effetti nell’ordinamento italiano nell’esperienza più re-cente. – Pur se i contorni dell’obbligo gravante sugli Stati di introdurremisure generali può variare sensibilmente a seconda dei caratteri del casoda cui ha tratto origine la controversia e dai contenuti dell’accertamentoeffettuato a Strasburgo, resta vero il fatto che tutte le pronunce in que-stione recano in sé un grado variabile di autoapplicabilità. La Corte eu-ropea, infatti, non lascia lo Stato del tutto libero di individuare gli stru-menti per porre rimedio alla violazione (come tradizionalmente si rite-neva dovesse avvenire), ma predispone degli indirizzi, delle linee di in-––––––––––
(59) M. FYRNYS, Expanding Competences by Judicial Lawmaking: the Pilot JudgmentProcedure of the European Court of Human Rights, in A. V. BOGDANDY - I. VENZKE (eds.),International Judicial Lawmaking. On Public Authority and Democratic Legitimation inGlbal Governance, Berlin/New York, 2012, pp. 332, 346.
(60) Primo fra tutti la natura legislativa della violazione che, al centro dell’attenzionedell’autore, non rappresenta né l’unico caso, come visto, in cui la Corte europea impiega imoduli decisionali prima previsti, né quello statisticamente più frequente.
(61) Sulla connotazione casistica della giurisprudenza europea v. per tutti V. ZAGRE-BELSKY, La giurisprudenza casistica della Corte europea , cit., pp. 61 ss.
(62) Sul punto, per notazioni critiche, v. S. VEZZANI, L’attuazione delle sentenze dellaCorte europea , cit., pp. 58 s.
NOTE E COMMENTI 1097
tervento, più o meno stringenti e più o meno vincolanti a seconda delcaso, di cui le autorità nazionali (in prima battuta il legislatore(63), ma an-che il giudice ordinario e quello costituzionale) devono tenere conto nelmomento in cui vengono chiamate a darvi esecuzione. Non infrequente,del resto, è l’accostamento di questo tipo di pronunce alla tipologie dellesentenze additive di principio, in ragione del fatto che quelle, come que-ste, attribuiscono al giudice la possibilità di elaborare regole immediata-mente operative desumendole dai principi somministrati dal giudice co-stituzionale (o da quello europeo)(64).
Limitando ora il discorso alla dinamica interna al circuito tra giudicicomuni e Corte costituzionale, queste sono le sentenze che rischiano dimettere più a dura prova quello che tradizionalmente è stato ritenuto unpunto fermissimo dell’impianto giurisprudenziale aperto dalle sentenzegemelle del 2007, vale a dire il divieto di applicazione diretta della CE-DU da parte del giudice, con la connessa disapplicazione del diritto in-terno con essa contrastante(65). Un divieto che, come si ricorderà, costi-tuiva il corollario logico del riconoscimento di un’efficacia diretta allaConvenzione (come ad ogni trattato per il solo fatto di essere stato resoesecutivo) senza tuttavia il conseguente riconoscimento di una qualcheprimauté in grado di condurre alla disapplicazione del diritto internocontrastante, ma solo – al ricorrere dei necessari presupposti – ad unainterpretazione conforme pur sempre subordinata al criterio del rispettodella Costituzione nel suo insieme(66).
––––––––––(63) Per un esame del recepimento in sede legislativa di alcuni precedenti europei v. D.
TEGA, I diritti, cit., pp. 107 ss., e B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale, cit., pp. 201 ss.(64) B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., p. 125, e A. RUGGE-
RI, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti, cit., p. 3, dove opportunamente si richia-ma a riprova quanto stabilito dalla Corte cost. nella sent. n. 210/2013 (punto 7.2. del Cons.in dir.) per cui «le modalità attraverso le quali lo Stato membro si adegua con misure strut-turali alle sentenze della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente determinatenel loro contenuto da tali pronunce, ma ben possono essere individuate con un ragionevolemargine di apprezzamento». L’accostamento in parola è notato anche da L. HELFER, Rede-signing the European Court of Human Rights, cit., p. 140.
(65) In questi termini v. G. FRIGO, Costituzione della Repubblica Italiana e applica-zione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nell’ordinamento giuridi-co nazionale, in Temi romana, 2012, p. 62. Di ‘primo caposaldo’ della giurisprudenza costi-tuzionale scrive E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo , p. 957.
(66) E. CANNIZZARO , The Effect of the ECHR, cit., pp. 177, 179.
1098 DIRITTO PUBBLICO
Le ragioni di questo potenziale contrasto sono evidenti: mentre in-fatti il più delle volte il giudice interno si trova davanti un dictum, unaccertamento di violazione in concreto, che richiede di essere tradotto inprecetto operativo da soggetti diversi (in primis il legislatore o, in sua as-senza e se possibile, la Corte costituzionale), in questo caso è la stessa sen-tenza europea a fornire al giudice, sempre più di frequente, gli strumentiin grado di recepire quell’esigenza volta all’introduzione di misure gene-rali in concreta regola di giudizio. Una eventualità, quest’ultima, ulte-riormente rafforzata dalla circostanza che a rivolgersi al giudice internonon sia un qualsiasi soggetto che si trovi in condizioni simili a quelle delsoggetto ricorrente e vittorioso a Strasburgo, ma sia proprio quest’ulti-mo, che al giudice chiede quindi non l’esecuzione di una sentenza qual-siasi, ma della sua sentenza.
Per queste sentenze, di conseguenza, l’espansione del significato del-l’art. 46 CEDU si presta a produrre effetti non solo sul piano dei rap-porti tra Corte EDU e giudici nazionali, ma anche all’interno dei singoliordinamenti nazionali e di quello italiano in particolare, perché favoriscel’attenuazione del vincolo che lega il giudice interno a convertire in que-stione di costituzionalità ogni ipotesi di contrasto tra diritto interno eCEDU che non sia risolubile per il tramite dell’interpretazione confor-me, intesa come unico strumento in grado di integrare l’efficacia direttadella Convenzione nel diritto interno. Un’attenuazione che crea le pre-messe per configurare in capo al giudice un obbligo di disapplicazionedel diritto interno imposto dal combinato disposto del citato art. 46CEDU, nella sua versione ‘forte’, e dei contenuti più o meno immedia-tamente precettivi delle sentenze europee che accertano la violazione si-stemica della Convenzione e sanciscono la necessità che lo Stato adottimisure di natura generale.
Questo potenziale conflitto richiede tuttavia di essere attentamentecoordinato con lo spazio che, sulla scia di quanto si è detto supra nel § 2,resta riservato alla Corte costituzionale intesa quale organo cui è deman-dato in ogni caso di presidiare la compatibilità ‘di sistema’ dei contenuticonvenzionali immessi nel diritto interno. A ben vedere, tuttavia, laprassi sperimentata negli ultimi anni ha già delineato alcune forme di
NOTE E COMMENTI 1099
composizione di questo conflitto, facendo emergere con chiarezza i di-versi ruoli che, in relazione a questo tipo di sentenze, sono stati svoltidai diversi attori giurisdizionali coinvolti. A tal fine, può essere suffi-ciente ricordare quanto avvenuto in tre casi in cui si è posto un pro-blema del genere, molto noti e quindi richiamati nei loro termini essen-ziali e nella sola prospettiva dell’adeguamento del diritto interno allaviolazione sistemica accertata a Strasburgo.
A) Il caso Dorigo: il ricorrente, un soggetto detenuto a seguito dicondanna in via definitiva, ottiene dalla Commissione europea dei dirittidell’uomo un riconoscimento della natura non equa ex art. 6 CEDU delprocesso cui era stato sottoposto in sede nazionale. Il rapporto dellaCommissione, recepito in diverse occasioni dal Comitato dei Ministri eavallato più volte dalla Corte europea(67), intimava all’Italia di dotarsi diun rimedio di natura generale consistente nella riapertura del processo, alfine di consentire un nuovo svolgimento del giudizio nel rispetto deldictum europeo. Quello che merita di essere evidenziato è che in conse-guenza del persistente inadempimento delle autorità italiane, il Comitatodei Ministri nell’esercizio della sua funzione di sorveglianza esercitata aisensi del precedente art. 32, § 4, della CEDU, ha non solo intimatoall’Italia di ottemperare alla pronuncia(68), ma ha anche fornito indica-zioni operative sui ‘requisiti minimi’ che la procedura di riapertura delgiudizio avrebbe dovuto avere(69). Requisiti di cui il Comitato dei Mini-stri ha ribadito il necessario rispetto da parte delle autorità nazionali purdopo che la procedura di controllo sulla situazione di Dorigo era statachiusa a seguito del provvedimento con cui la Corte di cassazione(70) neaveva sospeso l’esecuzione della pena(71). Nell’inerzia del legislatore, a
––––––––––(67) V. per tutte Lucà v. Italy, n. ric. 33354/96, sent. del 27 febbraio 2001.(68) V. le risoluzioni interinali ResDH(2000)30 del 19 febbraio 2002, ResDH(2004)-
13 del 10 febbraio 2004 e ResDH(2005)85 del 12 ottobre 2005.(69) V. in part. la Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri del 19 gen-
naio 2000 e le relative note esplicative, nelle quali vengono fornite istruzioni operative sul-l’ambito di applicazione del rimedio invocato e sulle condizioni necessarie affinché le vitti-me possano beneficiarne.
(70) Con sent. del 1° dicembre 2006, n. 2800.(71) Risoluzione finale ResDH(2007)83 del 19 febbraio 2007, dove si legge che le au-
torità italiane sono chiamate «to draw all the necessary consequences from the decision of
1100 DIRITTO PUBBLICO
farsi carico del compito di recepire queste indicazioni è stata la Corte co-stituzionale che, dopo un primo tentativo andato a vuoto (sent. n.129/2008), adita proprio dal giudice chiamato a decidere delle sorti diDorigo, è giunta a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. nellaparte in cui non prevede che tra i casi di revisione del processo possa es-servi anche quello di un giudizio ritenuto dalla Corte di Strasburgo nonequo ai sensi dell’art. 6 CEDU (sent. n. 113/2011). Tra gli elementi signi-ficativi di questa pronuncia, del resto ben nota, due in particolare meri-tano di essere messi in luce ai nostri fini. Il primo è che la Corte prendeatto che le misure estremamente dettagliate e di per sé potenzialmenteautoapplicative richiamate nelle pronunce della Corte europea e nelle ri-soluzioni del Comitato dei Ministri non erano in grado di venire recepi-te a livello interno dal giudice penale chiamato a dare esecuzione allasentenza ex art. 46 CEDU, considerata l’assenza di un istituto processua-le in grado di assimilare direttamente, senza cioè alcuna intermediazione,una pronuncia di condanna della Corte europea ad una ipotesi di riaper-tura del processo. Un’assenza della sedes materiae dovuta sia all’impossi-bilità di percorrere l’interpretazione analogica delle fattispecie previstenel citato art. 630 c.p.p., sia di applicare il ricorso straordinario in cassa-zione di cui all’art. 625-bis c.p.p. o l’incidente di esecuzione di cui all’art.670 c.p.p. A ciò consegue che è spettato alla Corte costituzionale suppli-re a questa carenza strutturale, in primo luogo avvalendosi proprio delparametro interposto di cui all’art. 46 CEDU, ed in secondo luogo ope-rando un’addizione normativa che, priva di referenti normativi sul pia-no solamente interno, ha trovato espressamente il suo verso nei prece-denti europei che hanno quindi ‘guidato’ l’opera di immissione dispostadalla Corte costituzionale(72).
––––––––––the court of Cassation and the requirements of the Convention, both generally and in thepresent case, particularly with regard to the erasure of the negative effects for the appli-cant of mentioning the conviction in his criminal record, as well as any other redress whi-ch may be due to him». Oltre a ciò, ad esse si richiede «to complete, as rapidly as possible,the legislative action needed to make it possible, in Italian law, to reopen proceedings fol-lowing judgments given by the Court».
(72) Ho approfondito questi aspetti dell’iter decisionale della Corte costituzionale inCorte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici , in Giur. cost. 2011, pp. 1552ss.
NOTE E COMMENTI 1101
B) Il caso Scoppola: in questione era qui una norma di interpretazio-ne autentica (contenuta nell’art. 7, co. 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341)che incideva in senso peggiorativo su una normativa processuale che perun periodo limitato di tempo ha consentito agli imputati di un reato pu-nibile con l’ergastolo l’accesso al rito abbreviato e la conseguente sostitu-zione della pena a vita con trenta anni di reclusione. La sentenza di con-danna per violazione dell’art. 7 della CEDU (Nulla poena sine lege) vienepronunciata dalla Grande Camera nel 2009. In essa si ravvisa una viola-zione sistemica consistente nel mancato rispetto del principio che impo-ne la necessaria retroattività della norma penale più favorevole e, benchévenga espressamente richiamato un obbligo di esecuzione a carico delloStato fondato sull’art. 46 CEDU e la possibilità per la Corte di indicare«the type of measure that might be taken in order to put an end to a situa-tion it has found to exist», la sentenza si limita a fornire solamente pre-scrizioni riguardanti la condizione specifica del ricorrente(73). In partico-lare, la sentenza specifica il contenuto dell’obbligo ex art. 46 cit. a caricodello Stato nel fatto che questi è ritenuto «responsible for ensuring thatthe applicant’s sentence of life imprisonment is replaced by a penalty consi-stent with the principles set out in the present judgment» (§ 154). Senon-ché, tenuto conto della natura ben delimitata e specifica della violazionecontestata (l’attribuzione di portata retroattiva all’art. 7, d.l. n.341/2000) e del rimedio invocato (il ricalcolo della pena), nella misuraindividuale era da ritenersi incorporata una naturale vocazione espansi-va, non essendo immaginabili alternative valide e considerando la posi-zione del tutto simile nella quale si trovavano i soggetti condannati al-l’ergastolo in virtù del medesimo articolo. Anche in questo caso, le tap-pe del processo di adeguamento interno al pronunciamento venuto dallaCorte europea sono state più di una. In un primo momento, infatti, laCorte di cassazione adita dallo stesso Scoppola ai sensi dell’art. 625-bisc.p.p. (Ricorso straordinario in cassazione), con sent. 28 aprile 2010, n.16507, ha provveduto a rideterminare direttamente la pena accogliendocosì in via diretta il principio stabilito dalla Corte europea, sulla base diun’evidente disapplicazione ‘mascherata’ del diritto interno. In seguito,––––––––––
(73) Scoppola (2) v. Italy, cit., §§ 148 ss.
1102 DIRITTO PUBBLICO
alcuni soggetti che si trovavano nella stessa situazione di Scoppola mache non avevano presentato ricorso a Strasburgo si sono visti estenderela portata della sentenza europea direttamente ad opera della Cassazioneche, almeno in un’occasione (sez. I pen., 10 gennaio 2012, n. 25227) hadisapplicato anch’essa il diritto interno, provocando in questo modo lareazione delle Sezioni Unite, che con un’ordinanza dello stesso anno (10settembre 2012, n. 34472, Ercolano) hanno rimesso la questione alla Cor-te costituzionale. Quest’ultima, dopo che nel 2011 aveva fatto uso di undistinguishing per evitare di dare attuazione alla pronuncia europea in uncaso simile ma non riguardante la medesima fattispecie(74), decide in que-sto caso di dichiarare l’incostituzionalità della normativa impugnata, sen-za minimamente intervenire per censurare lo strappo derivante dallaprecedente disapplicazione operata dalla Corte di cassazione nel 2010 nel-la sentenza riguardante Scoppola. Anzi, motivando in modo assai signifi-cativo in punto di rilevanza della questione, la Corte costituzionale sta-bilisce che proprio la precedente decisione della Corte di cassazione sulricorso di Scoppola, per il fatto di aver assolto all’obbligo di esecuzionedella sentenza europea, produce l’effetto di radicare il giudizio innanziad essa, perché in questa circostanza l’assenza di un precedente diretto dicondanna a favore dei ricorrenti nel giudizio a quo «impedisce di defini-re la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo costituzionale di ade-guamento alla sentenza della Corte EDU, che di quella norma ha rilevatoil contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della CEDU. Si tratta – aggiunge laCorte – di una conclusione che riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui sidebba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale,relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la ria-pertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sedeesecutiva»(75).
––––––––––(74) Sent. n. 236/2011, su cui v. C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favo-
revole tra CEDU e diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, pp. 3047 ss.(75) Sent. n. 210/2013, punto 8. Cons. in dir. L’esito cui è giunta la Corte è da rite-
nersi ulteriormente significativo per il fatto che, facendo leva sul precedente europeo «intermini» e sulla sua prima applicazione ad opera della Cassazione, viene aggirato l’ostacoloconcernente l’applicazione, in sede esecutiva, di una norma applicata in sde di giudizio dicognizione: sul punto v. A. PUGIOTTO, Scoppola e i suoi fratelli (L’ergastolo all’incrocio tragiudizio abbreviato, CEDU e Costituzione) , in Giur. cost., 2013, p. 2945.
NOTE E COMMENTI 1103
C) Il caso Costa e Pavan: con una decisione del 28 agosto 2012, laCorte europea ha condannato l’Italia perché la legge che disciplina l’ac-cesso alle tecniche di fecondazione assistita (la legge n. 40/2004) proibisceil ricorso alla diagnosi preimpianto alle coppie non sterili che siano por-tatrici sane di malattie geneticamente trasmissibili. A differenza degli al-tri due casi esaminati in precedenza, qui la Corte europea non ha né pre-figurato rimedi restitutori di portata individuale o generale, né ancoraprima ha chiamato espressamente in causa obblighi a carico dello Statoderivanti dall’art. 46 CEDU, tenuto probabilmente conto che la viola-zione accertata viene fatta semplicemente coincidere con l’esistenza deldivieto legislativo il quale quindi, una volta rimosso, avrebbe comporta-to la riespansione di un diritto ad accedere alle tecniche in questione. I ri-correnti vittoriosi a Strasburgo, infatti, si sono in un secondo momentorivolti al Tribunale di Roma che, con provvedimento d’urgenza adotta-to nel settembre 2013, ha riconosciuto alla coppia il diritto di accederealle procedure richieste e, per l’effetto, ha disapplicato la norma internacontenente il divieto contestato, muovendo dal presupposto che la sen-tenza ottenuta dai ricorrenti in sede europea ha, nei confronti delle parti,‘valore assimilabile al giudicato formale’. Nella discussa ordinanza, infat-ti, si legge che quest’ultima dispiega effetti nel diritto interno in forzadell’art. 46 CEDU e che tali effetti possono essere resi operativi dal giu-dice anche provvedendo alla disapplicazione del diritto interno «ogniqualvolta la regola ricavabile dalla sentenza CEDU sia sufficientementeprecisa e incondizionata da sostituirsi, senza margini di ambiguità, aquella interna riconosciuta contraria alla Convenzione, laddove la rimes-sione alla Corte costituzionale dovrà essere limitata alle sole questioniche, pur in presenza di una regola CEDU autoapplicativa, evidenzino unpossibile contrasto tra quest’ultima e i principi supremi dell’ordinamen-to costituzionale»(76). Parallelamente a questo caso, che ha suscitato unvivo dibattito in dottrina(77), la questione è stata nuovamente sottoposta
––––––––––(76) Trib. Roma, sez. I civ., ord. 23 settembre 2013 (Giud. D. Galterio), con richiamo
sul punto alla già citata Corte cost. n. 210/2013.(77) V. per tutti i commenti, speculari nel giudizio dell’iter argomentativo seguito dal
giudice, di A. RUGGERI, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU edi efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo , in diritticomparati.it (8 ottobre 2013),
1104 DIRITTO PUBBLICO
all’attenzione di altri giudici ad opera di coppie che, pur non avendo fat-to ricorso a Strasburgo, erano intenzionate ad avvalersi dei principi con-tenuti nella pronuncia europea. Per queste ipotesi, coerentemente conl’approccio scelto dal Tribunale di Roma, i giudici hanno ritenuto dinon potersi pronunciare anch’essi nel senso della disapplicazione, prov-vedendo a sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti allaCorte(78).
Le tre vicende giurisprudenziali velocemente passate in rassegna mo-strano a quale livello di compenetrazione siano ormai arrivate le relazio-ni tra le sentenze della Corte europea e i giudici nazionali quando si po-ne un’esigenza di adeguamento del diritto interno ad un accertamentoeuropeo che implica, in termini più o meno espliciti, la predisposizionedi misure restitutorie di natura generale.
Sulla scia di quanto detto in precedenza, va in particolare sottolinea-to come le diverse soluzioni cui sono giunte le autorità giurisdizionaliinterne sono andate tutte nella direzione di un adeguamento alle indica-zioni formulate in sede europea(79), benché – e questo è il punto – il fon-damento degli obblighi di esecuzione a carico dello Stato fosse assai di-verso nelle tre ipotesi.
Mentre nel caso Dorigo, infatti, la pervasività e il dettaglio delle mi-sure richieste fanno pensare quasi ad una procedura di sentenza-pilotaante litteram, in Scoppola il modulo decisionale è quello dei quasi-pilotjudgments, mentre in Costa e Pavan manca qualsiasi riferimento all’art.46 CEDU, pur incorporando la pronuncia un accertamento, benché‘non dichiarato’, di violazione sistemica.
––––––––––e di A. IANNUZZI - V. ZAMBRANO, Sentenza Costa e Pavan: il giorno dopo. L’emersione del‘desiderio’ di concepire un figlio sano come paradigma delle interazione tra diritto interna-zionale e diritto interno, in costituzionalismo.it, 2/2014.
(78) Ordinanze del Trib. Roma del 15 gennaio 2014 e del 28 febbraio 2014 (attual-mente iscritte al Reg. ord. della Corte cost. rispett. ai nn. 2014/69 e 2014/86).
(79) Questo ovviamente non toglie che non siano mancate occasioni nelle quali, perragioni anche diverse, un simile adeguamento non si è realizzato: è appena il caso di ricor -dare quanto avvenuto a seguito della sentenza pilota resa nel caso Torreggiani c. Italia e del-la presa d’atto contenuta nella sentenza della Corte cost. n. 279/2013, che ha rinviato al le-gislatore il compito di predisporre i necessari rimedi preventivi e compensativi (intervenutida ultimo con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92).
NOTE E COMMENTI 1105
6. Un tentativo di sistemazione del ‘doppio binario’: a ciascuno (giu-dici comuni e Corte costituzionale) il suo. – Questi casi, sommariamenteesposti, e quelli che verranno richiamati nelle prossime pagine dimostra-no come la tipologia di sentenze europee presa in esame in questa sedeabbia incrinato l’assolutezza di quel divieto di disapplicazione del dirittointerno che costituiva, come visto, il caposaldo dell’approccio seguitodalla Corte a partire dal 2007. Lungi dal considerare quest’ultimo un esi-to privo di punti interrogativi, ciò che pare necessario è individuare lechiavi di composizione di un sistema che vede espandersi la capacità delledecisioni della Corte europea di dettare le regole del caso concreto e lapossibilità, avallata anche dalla Corte costituzionale, che queste regoleproducano un vincolo diretto nei confronti del giudice nazionale in as-senza di una mediazione costituita dal vaglio della Corte costituzionale odalla interposizione del legislatore.
Quando la legge non interviene, infatti, si aprono gli spazi affinchédella questione sia investito il giudice comune, cui può ben venir affidatala richiesta di dare attuazione alla decisione europeo provvedendo a di-sapplicare il diritto interno contrastante. Questa eventualità, tuttavia, de-ve essere limitata ad ipotesi eccezionali, nelle quali ricorrano i seguentipresupposti:
i) Il primo è costituito dall’esigenza che a rivolgersi al giudice perchiedere l’esecuzione della decisione europea sia solo e soltanto il medesi-mo soggetto vittorioso a Strasburgo, per il quale unicamente si può confi-guare un obbligo di esecuzione ex art. 46 CEDU in grado di condurrealla non applicazione del diritto interno contrastante;
ii) Il secondo presupposto è dato dall’esistenza di un rimedio proces-suale che consenta al ricorrente vittorioso di portare la ‘sua’ controversiadavanti ad un giudice(80). Come è noto, le sentenze della Corte europeaintervengono di norma quando una certa controversia è stata definitacon sentenza definitiva e in relazione alla quale potrebbero quindi valere(in modo più o meno penetrante a seconda della natura del giudizio) pre-
––––––––––(80) Questo è presupposto è da ritenersi coincidente con l’ipotesi in cui la sentenza eu-
ropea abbia accertato la violazione di una norma sostanziale della CEDU (e non una suaregola processuale), come osservato da A. PUGIOTTO, Scoppola e i suoi fratelli , cit., p. 2944.
1106 DIRITTO PUBBLICO
clusioni a riproporre davanti ad un giudice una richiesta volta a revocarein dubbio un accertamento definitivo. L’esperienza degli ultimi anni, re-lativa soprattutto al campo del processo penale, ha dimostrato tuttaviasino a che punto l’assolutezza del giudicato abbia trovato un limite inpronunce di condanna promananti dalla Corte europea. Basti pensare aicasi in cui l’oggetto della condanna si appuntava proprio sulla mancanzadi un rimedio processuale volto a rimettere in discussione un provvedi-mento giurisdizionale lesivo di un diritto garantito dalla Convenzio-ne(81), ovvero alle ipotesi in cui il ricorrente si serve di un rimedio esi-stente, ma utilizzato in forme eccentriche o extra ordinem rispetto allasua funzione ordinaria(82).
iii) Il terzo presupposto è poi costituito dalla necessità che la pretesadella parte ottenga soddisfazione, e la pronuncia europea trovi quindiapplicazione nel caso concreto, per il solo tramite della disapplicazione diuna norma interna che di fatto impedisce di realizzare l’interesse del pri-vato e la cui non applicazione realizza, in tutto o in parte, l’interesse del-la parte senza che a ciò siano di ostacolo altri elementi, primi fra tutti –secondo la teorica tradizionale dell’autoapplicabilità – l’esigenza di unanormazione di dettaglio o la pluralità di soluzioni astrattamente ammis-sibili. Questo presupposto, tra tutti, è quello che investe maggiormente idelicati problemi relativi al potere interpretativo del giudice e che piùdegli altri si espone al rischio di un aggiramento ogni qualvolta il giudicefaccia ricorso a strategie finzionistiche(83).
iv) Il quarto e ultimo presupposto è rappresentato dall’assenza di unprofilo di contrasto tra la regola convenzionale cui si dà attuazione neldiritto interno e una o più norme o principi costituzionali. In caso di––––––––––
(81) Oltre al già richiamato precedente del caso Dorigo (Cass., n. 2800/2006), valga ilrichiamo a Cass., 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi .
(82) Come avvenuto in relazione al ricorso straordinario in cassazione di cui all’art.625bis c.p.p. nel ricordato caso Scoppola, nonché nel caso Drassich , Cass., sez. IV pen., 12novembre 2008, n. 45807.
(83) Se si pone mente all’ordinanza del Tribunale di Roma nel caso Costa e Pavan, adesempio, appare evidente come all’assenza di una specifica misura operativa nel testo dellapronuncia europea, che di per sé solo con molta difficoltà può portare a qualificarla comeautoapplicativa (v. A. IANNUZZI - V. ZAMBRANO, Sentenza Costa e Pavan: il giorno dopo,cit., p. 15) ha fatto seguito un provvedimento giurisdizionale che non risolve il problemadei limiti dell’applicazione della normativa interna ai ricorrenti.
NOTE E COMMENTI 1107
conflitto, il giudice è obbligato a posticipare la risoluzione del caso ri-spetto all’accertamento da devolvere alla Corte costituzionale, poichéper il rilievo dei valori in gioco l’individuazione della portata e dei limitidel dictum europeo dovrebbe essere ‘delegata’ alla Corte costituzionale,titolare di un potere, come ricordato, infungibile in merito alla selezionedei contenuti convenzionali che comportano una possibile violazionedella Costituzione.
Se tutte queste condizioni sussistono, l’intervento del giudice cheprovvede alla disapplicazione del diritto interno contrastante con la pro-nuncia della Corte europea non pare essere in contraddizione con il con-tenuto essenziale dell’orientamento seguito dalla Corte costituzionale,considerato che una misura del genere opera quale atto interno di esecu-zione dell’obbligo di cui all’art. 46 CEDU, senza con questo necessaria-mente compromettere la funzione del Giudice delle leggi di presidio al-l’unità sistematica del tessuto costituzionale.
Il problema principale, con tutta evidenza, risiede tuttavia nel ri-schio che il giudice ometta di effettuare le necessarie verifiche intorno airischi di contrasto con la Costituzione e dia così attuazione ad un obbli-go convenzionale senza il necessario passaggio attraverso il vaglio dellaCorte costituzionale.
Un rischio che non può essere né sottovalutato richiamando la natu-ra comunque necessariamente inter partes del provvedimento, né forsegiustificato alla luce del fatto che una simile disapplicazione è comunquedovuta per evitare il rischio che l’attuazione del precedente europeo si‘incagli’ nel giudizio di costituzionalità, i cui incerti esiti minerebbero ilquando e l’an dell’esecuzione(84).
L’eventualità che il giudice ometta, nei casi in cui ciò sia necessario,di rivolgersi alla Corte costituzionale va sicuramente contestata ed, anzi,ben ferma dovrebbe restare la sua soggezione all’obbligo di rimessioneogni qualvolta, nonostante un precedente diretto della Corte europea,questo sollevi profili di contrasto col dettato costituzionale non emenda-
––––––––––(84) È la tesi sostenuta in E. LAMARQUE - F. VIGANÒ, Sulle ricadute interne della sen-
tenza Scoppola (ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’ade-guamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo), in Giur. it., 2014, p. 405.
1108 DIRITTO PUBBLICO
bili per il tramite dell’interpretazione conforme(85). Il rischio, tuttavia,che ciò in singoli casi non avvenga non pare ragione sufficiente per impe-dire al giudice qualsiasi spazio nell’attuazione delle decisioni europee.
Ad uno sguardo attento, infatti, che un tale rischio si avveri non pa-re solamente la risposta sbagliata ad un’anomala espansione della portatadel giudicato europeo, perché riflette anche, più in profondità, il diversoruolo che, nell’evoluzione del sistema, sono venuti progressivamente ad
––––––––––(85) Un caso del genere è quello verificatosi (o meglio: che si sarebbe potuto verifica-
re) con la sentenza della Cass., sez. III civ., 30 settembre 2011, n. 19985, chiamata a decide-re della domanda di risarcimento del danno promossa da Filippo De Jorio a seguito della de-cisione della Corte di Strasburgo che aveva accolto il suo ricorso e sancito che l’insindacabi-lità parlamentare, che a livello interno aveva garantito la non punibilità dell’autore delle af-fermazioni ingiuriose dirette nei suoi confronti, era nel caso di specie contraria all’art. 6CEDU perché, tra l’altro, tali affermazioni andavano assimilate ad una ‹querelle entre par-ticuliers»(De Jorio c. Italie, n. ric. 73936/01, sent. del 3 giugno 2004). La Corte di cassazio-ne, chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello intervenuta il 16 maggio2005 che aveva anch’essa respinto le doglianze di De Jorio, prende spunto dalla sentenzaeuropea per affermare che «l’effetto di giudicato» che da essa discende determinerebbe «lamancata operatività anche nel giudizio civile dell’art. 68 Cost., non essendo stato rinvenutodai Giudici di Strasburgo il rispetto del giusto equilibrio che deve esistere nella materia trale esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei dirit-ti fondamentali dell’individuo. Se ne deve dedurre – prosegue la sentenza – che la sentenzadella CEDU ha definitivamente statuito, seppure nel corso dello svolgimento del giudizio[…] circa la non operatività dell’art. 68 Cost., con l’effetto che questa Corte non può igno-rare la statuizione, essendo chiamata a decidere proprio sulla stessa questione». Malgrado,nel prosieguo della pronuncia, la Corte di cassazione abbia ritenuto che le opinioni in que-stione risultassero comunque coperte dal diritto di critica politica, resta il fatto che una elu-sione dell’operatività dell’art. 68 Cost., per quanto giustificata dall’esigenza di dare attuazio-ne ad un precedente europeo, appaia fortemente criticabile, tenuto conto, sulla base diquanto detto, che l’equilibrio su cui è fondata l’operatività dell’insindacabilità parlamentareriflette un bilanciamento tra beni di rilevanza costituzionale che può spettare solo alla Cor -te costituzionale (o eventualmente al legislatore) rimettere in discussione. Sulla vicenda v.anche E. MALFATTI, Immunità parlamentari e diritti processuali dei terzi offesi: l’‘accer-chiamento’ del modello di giudizio della Corte italiana è davvero completo?, in Quad. cost.,2009, pp. 966 ss., C. PADULA, Insindacabilità parlamentare e ricorsi alla Corte europeasenza previo esaurimento dei rimedi interni, in ConsultaOnLine (25 ottobre 2012), pp. 15ss., e, da ultimo, A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU:la dottrina del ‘doppio binario’ alla prova dei casi (e dei conflitti) concreti, in Giur. cost.,2014, pp. 3033 ss., dove condivisibilmente si prende spunto da questa e da altre pronunce(come l’ordinanza del Tribunale di Roma nel caso Costa e Pavan) per lamentare come sem-pre più spesso la pressione ‘esterna’ proveniente da Strasburgo finisca per far assimilare lesue pronunce a quelle di un giudice di ultima istanza, erodendo così le barriere erette dallaCorte costituzionale e determinando «il conseguente abbandono della separazione formaletra ordinamento interno e sistema CEDU a suo tempo tentata dalla Consulta» (p. 3034).Se questa conclusione appare condivisibile per i casi appena ricordati, non sembra tuttaviamettere in discussione le ragioni poste a fondamento del modello di doppio binario di cuinel testo. Sul punto, in ogni caso, si tornerà infra.
NOTE E COMMENTI 1109
assumere il giudice comune e la Corte costituzionale nei loro rapporticon le decisioni europee.
Mentre il primo, infatti, ha visto indubbiamente rafforzarsi il suoruolo di esecutore delle sentenze europee e la sua veste di ‘terminale’ pri-vilegiato dell’obbligo scaturente dall’art. 46 CEDU quando a rivolgersiad esso è il ricorrente vittorioso a Strasburgo, la seconda ha visto consoli-dare il suo ruolo di garante interno dell’equilibrio del sistema, costitu-zionalmente presidiato, tra diritti interni e diritti convenzionali. Ciò,inevitabilmente, non può che temperare il monopolio della Corte costi-tuzionale nel modulare l’ingresso dei contenuti convenzionali quando ilprofilo prevalente dell’accertamento è quello del giudice del caso, men-tre ad essa deve restare saldamente riservata la funzione vitale di occu-parsi dei bilanciamenti che chiamano in causa la portata erga omnes diuna clausola della Convenzione o di un precedente europeo.
Del resto, l’esperienza degli ultimi anni dimostra come la salvaguar-dia della centrale funzione della Corte non abbia impedito ad essa, in re-lazione alle pronunce europee che accertano violazioni sistemiche e im-pongono rimedi di natura generale, di riconoscere a queste ultime un ef-fetto di vincolo, ferma restando la valutazione intorno alle modalità e ailimiti che guidano l’immissione dei contenuti convenzionali nel dirittointerno. Ciò detto, anche la Corte costituzionale può essere chiamata adare seguito ad un accertamento di violazione sistemica quando manchi-no i presupposti perché di ciò si occupi il giudice del caso e, in particola-re, quando ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
a) chi si rivolge ad essa sia un soggetto che si trovi nell’identica si-tuazione di un soggetto ricorrente e vittorioso a Strasburgo ma che siaprivo di una pronuncia resa in suo favore. Di conseguenza, questi nonpuò beneficiare di alcun riconoscimento diretto da parte del giudice(proprio per l’assenza di uno specifico obbligo di esecuzione ex art. 46CEDU) e l’unica strada a sua disposizione consiste nella possibilità che lasua questione venga portata all’attenzione della Corte costituzionale,l’unica in grado (in assenza del legislatore) di dettare modalità e limitidell’adeguamento richiesto alla luce del quadro costituzionale, disponen-do di margini di manovra sicuramente più ampi rispetto al giudice co-
1110 DIRITTO PUBBLICO
mune per valutare la pertinenza del giudicato (sia quando il termine diraffronto è contenuto in una decisione comunque riguardante l’Italia(86),sia quando invece – più problematicamente – riguarda altri paesi)(87);
b) non esista un rimedio che consenta di rivolgersi al giudice, maga-ri perché oggetto della doglianza è proprio l’assenza stessa del rimedio,circostanza che richiederebbe un passaggio sempre necessario presso laCorte quando la violazione accertata a Strasburgo non investe i profilisostanziali, ma processuali, il che richiede di intervenire con strumentiche abbiano per necessità una portata generale(88);
––––––––––(86) È il caso, già discusso, della sent. n. 210/2013, in relazione alla quale v. anche
l’ord. n. 235/2013 (nonché l’ord. n. 247/2014).(87) Cfr. ad es. sentt. nn. 187 e 196 del 2010, nonché, nonostante la particolarità del
caso, l’ord. n. 150/2012. Da ultimo, un caso virtuoso di impiego (o … non impiego) di pre-cedenti europei concernenti paesi diversi dall’Italia è quello riguardante i limiti posti alla ca-pacità di una sentenza pilota che accerta una violazione dell’art. 6 CEDU di determinare larevisione del processo a livello interno in applicazione di quanto statuito dalla Corte cost.con la sent. n. 113/2011. I fatti, sommariamente esposti, sono questi: alcuni detenuti in re-gime di custodia cautelare sottoposti al regime del 41-bis o.p. si lamentano del fatto di nonaver potuto interloquire adeguatamente col proprio difensore durante lo svolgimento delprocesso. In particolare, essi chiedono che la loro sentenza di condanna, ormai definitiva,venga soggetta a revisione in base al nuovo art. 630 c.p.p. perché: i) la Corte cost., consent. n. 143/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto in questione e, an-che se lo ha fatto sulla base di soli parametri interni, nella motivazione ha richiamato unasentenza della Corte europea, Öcalan v. Turkey (n. ric. 46221/99, sent. del 12 marzo2003), rispetto alla quale ha predicato «significative assonanze» con la propria pronuncia; ii)la sentenza Öcalan avrebbe le caratteristiche di una sentenza pilota, il che abiliterebbe i ri-correnti a giovarsene invocandone l’applicazione diretta davanti al giudice. La Corte di cas-sazione (sez. VI pen., 26 settembre 2014, n. 39925, e 6 novembre 2014, n. 46067) rigetta iricorsi adducendo alcune significative motivazioni. In primo luogo, per potersi giovare del-la nuova revisione europea è necessario che la decisione di condanna resa dalla Corte euro-pea «sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con la sentenza pas-sata in giudicato». In secondo luogo, molta cautela è espressa relativamente alla circostanzache il processo venga riaperto a seguito di una condanna resa non nello stesso caso (come inrealtà era ovvio), ma in una procedura di sentenza pilota: tutt’al più, una simile eventualitàpresupporrebbe che i soggetti potenzialmente beneficiari si trovino in «un’identica condi-zione sostanziale» e, in ogni caso, che questa identica situazione abbia ad oggetto i profilisostanziali e non anche quelli processuali, tenuto conto (e qui il rinvio è alla più volte citatasentenza della Corte cost. n. 210/2013) che qui l’efficacia ultra partes della sentenza euro-pea può dispiegarsi solamente quando il rimedio investe la sede esecutiva e non richiede lariapertura del processo: «in questa ipotesi, l’apprezzamento, ve[rt]endo su eventuali erroresin procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, nonpuò che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudicato interno può essere po-sto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sullamedesima fattispecie» (sent. n. 210/2013, punto 8. del Cons. in dir.).
(88) Paradigmaticamente, la sent. n. 113/2011 e, in essa, il già richiamato ruolo gioca-to dal parametro interposto di cui all’art. 46 CEDU.
NOTE E COMMENTI 1111
c) la sola disapplicazione non sia sufficiente a dare applicazione aldictum europeo e a soddisfare l’interesse della parte, rivelandosi a tal finenecessari interventi comunque manipolativi, ovviamente sempre che lacaducazione disposta dalla Corte sia possibile e non vada al di là dei suoilegittimi spazi di intervento, richiedendo invece l’intervento del legisla-tore(89).
In definitiva, il tentativo di sistemazione che si è avanzato in questepagine dovrebbe dimostrare come solo un’adeguata presa in carico, a li-vello nazionale, delle trasformazioni che stanno investendo il sistema ditutela imperniato sulla Corte europea può consentire di trovare un giu-sto contemperamento tra un’esigenza sempre più pressante di un prontoadeguamento alle decisioni europee che accertino la violazione di dirittidei singoli e la predisposizione di garanzie per cui questo adeguamento, amaggior ragione quando porti con sé la necessità di introdurre misuregenerali, resti compatibile col quadro dei valori costituzionali e, in esso,con la ripartizione di funzioni tra giudici e Corte costituzionale. Solol’individuazione di limiti all’ingresso diretto di contenuti promanantidalla Corte di Strasburgo, infatti, si rivela capace di salvaguardare questodelicato equilibrio, senza per questo compromettere un grado ragione-vole di resilienza della risposta giurisdizionale interna rispetto alla riven-dicazione di spazi decisionali sempre più ampi e penetranti avanzata daigiudici di Strasburgo(90). La combinazione di un ampio potere di inter-vento della Corte costituzionale nello svolgere la sua ‘riserva di bilancia-mento’ (uso dell’argomento sistematico in funzione della ‘maggioreespansione delle tutele’, rispetto della ‘sostanza’ delle decisioni europee) el’attribuzione al giudice del caso, allorché ne ricorrano i presupposti, diun potere ‘sorvegliato’ di disapplicazione(91) sembrerebbe essere la rispo-sta meglio in grado di tenere unite esigenze apparentemente divergenti.––––––––––
(89) È il caso, tra tutti, della già citata sent. n. 279/2013.(90) Una simile esigenza è fatta valere, anche se in termini non del tutto coincidenti,
anche da R. CONTI, Costituzione e diritti fondamentali: una partita da giocare alla pari,in Il diritto europeo nel dialogo tra le Corti, Milano, 2013, pp. 250 ss.
(91) Che non farebbe venire meno quell’esigenza di legal certainty posta a fondamen-to della riserva alle Corti costituzionali del potere di giudicare degli atti interni in violazio-ne della CEDU (come ad esempio in V. FERRERES COMELLA, Constitutional Courts andDemocratic Values. A European Perspective, New Haven/London, 2009, p. 143.
1112 DIRITTO PUBBLICO
7. Uno stress test: il caso Varvara. – Il modello di interazione giuri-sdizionale che si è tentato di delineare nelle pagine precedenti sarà proba-bilmente messo alla prova nel caso Varvara, un vicenda giurisdizionaleriguardante le ipotesi di confisca in caso di lottizzazione abusiva, che tor-na alla Corte costituzionale dopo un precedente del 2009 (sent. n. 239) ea seguito di una pronuncia della Corte europea che è tornata a condanna-re l’Italia per l’interpretazione che i giudici interni danno all’art. 44, co.2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia)(92). Secondo questo articolo, la confiscadei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente co-struite è disposta dalla sentenza del giudice penale «che accerta che vi èstata lottizzazione abusiva».
Secondo la giurisprudenza prevalente, tuttavia, questa sanzione hanatura meramente amministrativa e pertanto può essere adottata dal giu-dice penale anche quando non vi sia stata una sentenza che abbia accerta-to la responsabilità penale dell’imputato, essendo sufficiente che dal di-spositivo della sentenza emerga comunque un profilo di responsabilitàdi quest’ultimo, come nel caso di un proscioglimento che implichi unaccertamento implicito di responsabilità (ad esempio per intervenutaprescrizione).
La Corte europea, pronunciandosi sul punto dopo il noto preceden-te reso nel caso Sud Fondi c. Italia(93), ha ritenuto che una simile inter-pretazione sia contraria alla Convenzione, e segnatamente all’art. 7 e al-l’art. 1, prot. 1, poiché, tra l’altro, alla sanzione in questione deve esserericonosciuta natura penale e ogni spossessamento della proprietà che pre-scinda da un accertamento espresso di responsabilità penale deve ritenersicontrario alla Convenzione. Senza entrare ora nel merito dei complessiproblemi relativi alle diverse interpretazioni fornite dalla Corte europeae dai giudici italiani(94) (in ciò avallati anche dalla richiamata sent. n.
––––––––––(92) Varvara v. Italy, n. ric. 17475/09, sent. del 29 ottobre 2013.(93) N. ric. 75909/01, sent. del 20 gennaio 2009.(94) Sul punto v. D. RUSSO, La ‘confisca in assenza di condanna’ tra principio di lega-
lità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le corti, in osserva-toriosullefonti.it, 2/2014, C. LIVERANI, La confisca urbanistica tra legalità penale e princi-pio di colpevolezza ex art. 7 CEDU, in Cass. pen., 2014, ppp. 3383 ss.
NOTE E COMMENTI 1113
239/2009 della Corte costituzionale)(95), resta il fatto che nel caso di spe-cie la Corte europea pare aver adottato una decisione che ‘accerta manon dichiara’ una violazione sistemica (l’interpretazione prevalente ac-cordata all’art. 44 cit.) e per l’effetto rchiede alle autorità nazionali l’ado-zione di ‘misure generali’ (consistenti in una interpretazione adeguatricedi segno opposto rispetto a quella vivente ed in linea con il dictum euro-peo)(96).
Il perno del dissidio tra le due diverse prospettive (quella interna,supportata dalla giurisprudenza prevalente e avallata dalla Corte costitu-zionale, e quella esterna, patrocinata dalla Corte europea) verte quindi inprima battuta su due diverse interpretazioni adeguatrici, che muovono aloro volta da un inquadramento formale (natura amministrativa o pena-le della sanzione) e da un fondamento sostanziale (prevalenza della tuteladel paesaggio, da un lato, protezione della proprietà, dall’altro) divergen-ti, se non contrapposti. Muovendo proprio da un simile impianto con-trappositivo(97), la Corte di cassazione ha sollevato nel maggio del 2014una questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, co. 2, del d.P.R.n. 380/2001 ‘come interpretato dalla Corte EDU (sentenza Varvara) nelsenso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiara-zione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale siastata accertata in tutti i suoi elementi’: una questione di costituzionalità,quindi, che ha come oggetto non la norma che discende dall’art. 44 cit.nel suo significato proprio o come interpretato nel diritto vivente, mapiuttosto nel senso fatto proprio dalla Corte europea(98).
Dei tanti profili di interesse della vicenda, quello che investe le ri-flessioni svolte in queste pagine riguarda i termini e gli effetti dell’impo-stazione prescelta dalla Corte rimettente, soprattutto alla luce della alter-nativa tra la possibilità di utilizzare il ricorso all’interpretazione del di-ritto interno conforme alla CEDU e la sollevazione dell’incidente di co-––––––––––
(95) V. in part. punto 3. del Cons. in dir., in fine.(96) In tal senso, puntualmente, A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici
nazionali , cit., p. 3026.(97) Messo in luce, criticamente, da F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a
Strasburgo il Re è nudo, in Dir. pen. contemp., 9 giugno 2014, pp. 7 ss.(98) Corte cass., sez. III pen., ord. 20 maggio 2014, n. 20636.
1114 DIRITTO PUBBLICO
stituzionalità. Un’attenta dottrina, infatti, non ha mancato di rilevarecome la scelta della Cassazione di sollevare la questione dinnanzi allaConsulta sembri in contrasto con il principio consolidato, fatto peraltroproprio nel precedente del 2009, per cui tale rimedio è percorribile sololaddove ‘l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti im-possibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sor-gere dubbi sulla sua legittimità costituzionale’. Nel caso di specie, quin-di, il giudice comune si troverebbe di fronte alla paralizzante alternativadi adeguarsi alla decisione europea (in quanto adeguamento ‘necessitato’)ovvero di dover attendere la formazione di un diritto vivente incostitu-zionale per rivolgersi alla Corte costituzionale(99). Da questa peculiare (eparadossale) situazione ne uscirebbero rafforzati i dubbi sulla tenuta delsistema del ‘doppio binario’, perché esso finirebbe per consacrare (e qua-si ‘istituzionalizzare’) la possibilità per il ricorrente vittorioso a Strasbur-go di ottenere immediata soddisfazione presso il giudice comune, il qua-le non sarebbe tenuto a rivolgersi alla Corte costituzionale per far valereun’eventuale illegittimità del precedente europeo, né in ogni caso potreb-be farlo, dovendo semmai attendere che su quel punto si sia consolidato– se del caso – un diritto vivente e ben potendo, nel frattempo, dare libe-ro corso alla decisione europea.
Tenuto anche conto dell’effetto paradossale che si verrebbe a creare,è legittimo dubitare che questa costituisca l’unica soluzione possibile al-l’impasse in cui si trova il giudice che dubiti, al di là del caso di specie,della conformità a costituzione di un’interpretazione adeguatrice dellanormativa nazionale imposta da Strasburgo.
A rileggere infatti il precedente del 2009, l’impressione è che quellaalternativa (adeguamento impossibile o attesa che si formi un diritto vi-vente incostituzionale) si riferisca unicamente all’ipotesi che l’incostitu-zionalità derivi da un mancato adeguamento del significato dell’art. 44cit. a quanto specificamente richiesto dalla Corte europea e non, invece,a qualsiasi altro profilo di incostituzionalità, ivi compreso quello derivan-te da un contrasto tra il significato di esso imposto a Strasburgo e una opiù norme costituzionali.––––––––––
(99) A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici nazionali , cit., p. 3030.
NOTE E COMMENTI 1115
La Corte costituzionale, in altre parole, si ritaglia uno spazio di in-tervento del tutto residuale solo nel caso in cui l’adeguamento interpre-tativo imposto da Strasburgo sia impossibile, ovvero sia possibile ma neldiritto vivente, una volta che si è formato, questo non venga accolto: sen-za precludere, quindi, la possibilità che in linea di principio venga coin-volta anche in un momento precedente, quando cioè la norma che deri-va dalla Corte di Strasburgo ponga in sé problemi di costituzionalità, fi-nendo così per coinvolgere la legittimità della medesima disposizio-ne(100).
Un esito, quest’ultimo, che seppure non dovrebbe trovare applica-zione nel caso di specie (tenuto conto del dovere per il giudice di sondarele possibilità interpretative alla luce del diritto vivente), dovrebbe restarefermo proprio nell’ipotesi che ci interessa, quella cioè in cui il dubbio in-terpretativo riguardi il giudice chiamato a dare concreta applicazione allasentenza europea, per il quale questo onere di adeguamento interpretati-vo si assottiglia fino a scomparire.
Da un lato, ciò dimostrerebbe come l’eventuale conflitto tra inter-pretazione conforme a CEDU e Costituzione non possa essere ricostrui-to in termini perfettamente simmetrici, perché all’esigenza di garantirela supremazia delle norme costituzionali deve comunque essere garantitoun accesso prioritario alla Corte costituzionale, così che l’adeguamentoad una interpretazione imposta da Strasburgo non potrebbe mai prevale-re rispetto ad un dubbio sulla sua stessa costituzionalità, al punto di im-pedire al Giudice delle leggi di pronunciarsi sul punto.
Dall’altro lato, per quanto più ci interessa in questa sede, ciò rivelaanche che al giudice comune che sia chiamato a dare soddisfazione, in ap-plicazione dell’art. 46 CEDU, al ricorrente vittorioso a Strasburgo è nonsolo consentito, ma, nei termini anzidetti, imposto di verificare che il ‘re-cepimento’ della decisione europea, anche e soprattutto quando compor-ti una limitata disapplicazione del diritto interno, non presenti profili diincostituzionalità, dovendo in caso contrario demandare la relativa veri-––––––––––
(100) Secondo il tenore della medesima sent. n. 239/2009 e coerentemente, del resto,con l’impianto complessivo che sorregge, nel periodo più recente, il rapporto tra interpre-tazione conforme e sentenze interpretative di accoglimento, su cui v. E. MALFATTI - S. PA-NIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, p. 135.
1116 DIRITTO PUBBLICO
fica alla Corte costituzionale, nel rispetto dell’infungibilità del suo ruo-lo(101).
8. L’effetto di vincolo e la ricomposizione pluralistica del rapporto trasistemi e tra giurisdizioni: la via italiana ad un weak review. – L’evolu-zione che negli ultimi anni ha caratterizzato, nell’ordinamento italiano,il recepimento delle pronunce della Corte europee che accertano viola-zioni sistemiche e ne ha rafforzato l’effetto di vincolo presenta, nel com-plesso, luci ed ombre.
Se da un lato, infatti, non pare discutibile che in alcuni casi il ‘giocodi squadra’ tra giudici comuni e Corte costituzionale ha condotto ad esi-ti tutto sommato positivi su alcuni dei fronti più delicati aperti con Stra-sburgo (si pensi per tutti alle varie ipotesi di riapertura del processo), nel-l’insieme, dall’altro lato, sembra innegabile che le profonde trasforma-zioni indotte dalla diffusione del meccanismo del ‘doppio binario’ rischi-no di alterare gli equilibri consolidati dei rapporti tra Corte, giudici e le-gislatore nella tutela dei diritti fondamentali, soprattutto in presenza diuna diffusione sempre maggiore delle ipotesi di disapplicazione, più omeno mascherata, del diritto interno.––––––––––
(101) Per queste ragioni, pur condividendone le diagnosi e le proposte volte a «sdram-matizzare i conflitti senza abdicare ai bilanciamenti», non riesco del tutto a condividerequanto espresso da A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici nazionali e CorteEDU, cit., p. 3036, secondo il quale, al contrario, la dottrina «del doppio binario […] sem-bra proprio costituita per permettere al giudice comune di non coinvolgere la Corte costi-tuzionale nel dubbio che un contrasto di standard di tutela vi sia», nel presupposto che conessa sia consentito ai giudici comuni di far prevalere lo standard di tutela CEDU su quellocostituzionale, al punto che ricorrendo ad essa il soggetto vittorioso a Strasburgo potrebbeaddirittura, secondo l’ipotesi dell’autore, «far riaprire le porte del giudizio interno per otte-nere il bene della vita imposto da Strasburgo ma negato dalla Consulta». Senza negare i de-licati problemi che ognuna delle soluzioni in gioco sottende, resta vero, da un lato, che il ri-schio evocato resta limitato alla sola ipotesi del giudizio promosso dal soggetto ricorrente evittorioso a Strasburgo (senza, quindi, alcuna possibilità di «generalizzarne» gli effetti), dal-l’altro lato che questo giudizio trova pur sempre un limite nella riserva di accertamento co-munque demandata alla Corte costituzionale; se il rispetto di tale riserva, per quanto detto,potrebbe essere difficilmente imposto al giudice che trascuri il dubbio di costituzionalità cheemerge dal caso che è chiamato a decidere, non dovrebbe dubitarsi che una simile eventuali-tà sia e debba essere scongiurata quando la Corte costituzionale si sia già pronunciata nelsenso di una prevalenza, rispetto allo standard derivante da una sentenza europea, di quellocostituzionale. Anche per questa ragione, pertanto, sembra provare troppo l’affermazioneper cui il sistema del doppio binario «non sembra una strada percorribile senza attenuare, oaddirittura contraddire la dottrina della stessa Corte sull’esigenza di accentrare il sindacatodi legittimità sulle leggi contrastanti con la CEDU» (op. ult. cit., pp. 3036 s.).
NOTE E COMMENTI 1117
A dispetto di ciò, se si colloca il quadro che si è cercato di riassume-re in queste pagine in una prospettiva più ampia, l’impressione è chel’evoluzione in corso chiami in causa variabili più profonde rispetto allasola estensione della natura rimediale delle pronunce europee, investendoi termini essenziali del rapporto tra Corte europea e sistemi nazionali, daun lato, e tra Corte costituzionale e giudici comuni, dall’altro lato.
Basti pensare, dal primo punto di vista, alla difficoltà di determina-re con criteri sufficientemente precisi la nozione di ‘violazione sistemica’e, di conseguenza, di identificare l’effetto delle ‘misure di portata genera-le’ di cui la Corte europea chiede l’introduzione alle autorità nazionali.Questa difficoltà, infatti, sembra dovuta all’emergere di un modello digiudizio che, pur non imponendo un obbligo di disapplicazione a caricodelle autorità nazionali(102), ha visto variamente rafforzarsi obblighi con-formativi sempre più penetranti, che hanno con sempre maggiore evi-denza attratto in seno alla Corte europea funzioni tradizionalmente at-tribuite al Comitato dei Ministri e alle autorità nazionali, in primis quel-le parlamentari(103).
Questo indirizzo è ritenuto compatibile con le premesse istituziona-li del sistema convenzionale fino a quando gli obblighi veri e propri re-stano confinati ad un numero limitato di pronunce, che li menzionanoespressamente in riferimento al meccanismo di cui all’art. 46 CEDU,mentre in tutti gli altri casi in cui la Corte europea ravvisa una disfun-zione sistemica che non chiama in causa l’art. 46 cit., l’onere di adegua-mento ricade sul circuito collaborativo imperniato su Comitato dei Mi-nistri e autorità (in primo luogo legislative) nazionali(104). L’esperienzadegli ultimi anni dimostra tuttavia come ad una simile limitazione la
––––––––––(102) Un obbligo, peraltro, talvolta riaffiorante nella giurisprudenza europea, cfr. ad
esempio, Dumitru Popescu c. Roumanie (N. 2), n. ric. 71525/01, sent. del 26 aprile 2007,§§ 103-104.
(103) Sui problemi che ne scaturiscono v. E. MALFATTI, I ‘livelli’ di tutela, cit., p. 161.(104) V. COLANDREA, On the Power of the European Court of Human Rights to Or-
der Specific Non-monetary Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze, Broniowskiand Sejdovic Cases , in Human Rights Law Review , 2007, pp. 397 ss., e E. LAMBERT ABDEL-GAWAD, The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: Towardsa Non-coercive and Participatory Model of Accountability, in Zeitschrift für ausländischesÖffentliches Recht und Völkerrecht, 2009, pp. 483 ss.
1118 DIRITTO PUBBLICO
Corte europea non sempre si sia attenuta. Ciò, innanzi tutto, ha portatoad una emarginazione del ruolo del Comitato dei Ministri, che ha vistoattenuarsi il suo potere di interlocuzione con le autorità nazionali(105),cui solo in parte ha posto rimedio il Protocollo n. 14 e il sistema di rac-cordo con la Corte da esso predisposto. Al tempo stesso, questa limita-zione è apparsa incompatibile con un modello di giudizio che ancora og-gi mette al centro il ricorso individuale, senza che la Corte possa avvaler-si di strumenti di selezione dei casi più rilevanti(106).
Nonostante ciò, questa estensione di campo può pur sempre vederlimitati i suoi effetti in sistemi in cui il processo di adeguamento ai dictaeuropei è affidato in prima battuta al legislatore, al di là del fatto che ilsuo intervento sia fondato o meno su una specifica ed espressa preferen-za istituzionale rispetto all’attuazione giurisdizionale(107).
È evidente, invece, che laddove non solo manchino meccanismi effi-caci di monitoraggio e di attuazione a livello parlamentare delle decisionidella Corte europea, ma dove, come in Italia(108), l’inerzia del legislatorefaccia da sfondo alla gran parte dei casi discussi in queste pagine, gli effet-ti, già di per sé non di poco conto, dei nuovi indirizzi interpretativi del-la Corte europea si fanno dirompenti, perché finiscono per scaricare tut-to e solo sul circuito giurisdizionale il peso di un’attuazione che esso non
––––––––––(105) Come era stato previsto da V. ZAGREBELSKY, Violazioni strutturali e Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo: interrogativi a proposito di Broniowski, in Dir. uma-ni e dir. inter., 2008, pp. 5 ss.
(106) Sul dibattito più recente v. almeno S. GREER - L. WILDHABER, Revisiting the De-bate about ‘constitutionalising’, cit., p. 667, e R. BELLAMY, The Democratic Legitimacy ofInternational Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the EuropeanCourt of Human Rights, in European Jour. Inter. Law, 2014, pp. 1029, secondo il quale inun simile modello, «contestation ought to be limited to cases where domestic political andjudicial avenues have been exhausted and only involve those rights that might be conside-red basic to each citizen within a given polity being able publicly to advance their interestson equal terms to others, though controversy exists as to whether these involve only corecivil and political rights or also certain minimum social and economic rights too».
(107) Come avviene nello Human Rights Act , in part. Sect. 3 e 10, su cui richiamo leosservazioni di R. BELLAMY, The Democratic Legitimacy, cit., p. 1028, che vede in ciò unacaratteristica del political constitutionalism rispetto al legal constitutionalism proprio deimodelli, come quello tedesco e italiano, incentrati prevalentemente sull’attuazione ad operadel giudice.
(108) C. FASONE, Il ruolo del Parlamento nell’applicazione della CEDU, in diritticom-parati.it (5 febbraio 2015).
NOTE E COMMENTI 1119
è in grado di sopportare, ma per il quale deve nondimeno trovare rispo-ste(109).
Muovendo ora alle trasformazioni che investono il fronte interno,pare evidente che queste difficoltà richiedano al circuito giudice comune– Corte costituzionale di dotarsi di strumenti decisionali in grado di ar-ginare, o comunque di modulare, l’incidenza sempre più penetrante del-le sentenze europee e di renderla compatibile col quadro costituzionale.Per il primo, innanzi tutto, sembra necessaria una maggiore cautela neltrarre indicazioni operative dalle sentenze della Corte europea, in parti-colar modo quando esse non siano espressamente indicate in riferimentoall’art. 46 CEDU e, soprattutto, quando esse non siano direttamente ese-guibili senza un intervento del legislatore (come, in larga parte, nel casoCosta et Pavan). In secondo luogo, il modello del ‘doppio binario’ ri-chiede di tener fermo l’obbligo del giudice di rivolgersi alla Corte costi-tuzionale in ogni caso in cui l’adeguamento al principio elaborato a Stra-sburgo (anche quando riguarda i limitati casi di disapplicazione) sollevaun dubbio di legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda la Corte costituzionale, sembra indubbio che ilmodello in questione pone il rischio di un’incrinatura del monopolioche essa si era ritagliata dopo il 2007, se non altro perché, dietro la disap-plicazione, ad essere messa in dubbio è una premessa teorica di fondodelle sentenze gemelle, costituita dal fatto che gli effetti degli obblighi in-ternazionali devono essere determinati autonomamente dal diritto inter-no e, in questo, il ruolo della Corte costituzionale è da ritenersi infungi-bile. Ciò nonostante, l’impressione è che negli ultimi anni il Giudice del-le leggi abbia saputo rispondere assai efficacemente ai rischi insiti in que-sto processo, in un primo momento ritagliandosi un margine di valuta-zione legato alle esigenze di tutela derivanti dal sistema costituzionale nelsuo insieme per poi, in un secondo momento, affiancare sempre piùspesso il parametro costituzionale a quello convenzionale(110), sino al-l’esito ultimo di un assorbimento dei profili di illegittimità riferibili alla
––––––––––(109) In linea con queste le affermazioni di F. BILANCIA, Leggi retroattive e interferen-
za nei processi in corso, cit., p. 4241.(110) Come avvenuto, ad esempio, nelle sentt. nn. 170 e 202 del 2013.
1120 DIRITTO PUBBLICO
Convenzione in quelli propriamente costituzionali(111). Ciò dimostra,sul fronte interno, come la ricombinazione indotta dalla diffusione dellaportata precettiva delle sentenze europee non abbia in fondo posto lepremesse per un’alterazione del sistema di controllo di convenzionalità,perché nelle mani del giudice comune esso rimane, per riprendere unaclassificazione proposta da Jeremy Waldron, un prototipo di weak re-view(112), in cui l’assenza di un diffuso potere di disapplicazione non ècontraddetta da un limitato e circoscritto potere per il giudice comunedi dare esecuzione alle singole sentenze europee, perché esso controbilan-cia (seppur solo in linea di fatto) la mancanza di protocolli legislativi diattuazione delle sentenze europee e la sostanziale estromissione del cir-cuito governo-parlamento dal fronte in questione.
In questo quadro, il doppio binario che si è andato profilando negliultimi anni e l’espansione del potere dei giudici comuni di dare attuazio-ne alle sentenze europee può costituire un ragionevole contemperamen-to rispetto ai rischi di un sovraccarico interpretativo che può venire allaCorte Costituzionale da pronunce europee che richiedono immediataesecuzione, ferme restando quelle esigenze di separazione funzionale cheprima si invocavano, e che in sostanza vedrebbero ristabiliti i ruoli deigiudici comuni come primi garanti dell’applicazione della Convenzionee della Corte costituzionale come garante dell’unità sistemica dell’ordina-mento costituzionale e del rispetto, da parte della CEDU e delle senten-ze del suo giudice, del testo e del tessuto costituzionale considerato nelsuo insieme.
––––––––––(111) Sentt. nn. 278 del 2013 e 162 del 2014.(112) J. WALDRON, The Core of the Case Against Judicial Review , 115 Yale Law Jour.
(2006), pp. 1354 s., secondo il quale «In a system of strong judicial review, courts have theauthority to decline to apply a statute in a particular case (even though the statute on itsown terms plainly applies in that case) or to modify the effect of a statute to make its appli-cation conform with individual rights (in ways that the statute itself does not envisage).Moreover, courts in this system have the authority to establish as a matter of law that a gi-ven statute or legislative provision will not be applied, so that as a result of stare decisis andissue preclusion a law that they have refused to apply becomes in effect a dead letter»; alcontrario, «in a system of weak judicial review, […] courts may scrutinize legislation for itsconformity to individual rights but they may not decline to apply it (or moderate its appli-cation) simply because rights would otherwise be violated». La distinzione in parola è stataripresa da R. BELLAMY, op. ult. cit., p. 1023 ss., e condivisibilmente valorizzata rispetto airischi che la CEDU finisca per generare, nell’area europea, un legal cosmopolitanism.