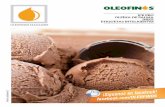“La linea della palma”. La risalita delle mafie dal Mezzogiorno al Nord Italia
Transcript of “La linea della palma”. La risalita delle mafie dal Mezzogiorno al Nord Italia
CANTIERI DI STORIA SISSCO – 2013
Dal nuovo meridionalismo alla “questione settentrionale”.
I dualismi territoriali in età repubblicana (1945-2012)
Coordinatore: Francesco Dandolo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Pierluigi Basile
(Università degli Studi Roma Tre)
“La linea della palma”. La risalita delle mafie dal Mezzogiorno al Nord Italia
Salerno, 12 settembre 2013
Premessa
Era il 1970 quando l’intellettuale siciliano Leonardo Sciascia coniò il paradigma della “linea
della palma” che sale sempre più verso nord per spiegare lo spostamento della frontiera del costume
e del sentire mafiosi ben oltre i confini dove erano germogliati e s’erano alimentati. Lo sguardo
deformato dalla lente “culturalista”, non consentiva allora allo scrittore di Racalmuto di osservare
come non tanto una mentalità, quanto organizzazioni criminali – le mafie appunto (e qui si fa
riferimento ai tre ceppi “storici”, sorti nel XIX secolo e denominate Cosa nostra, ‘ndrangheta e
camorra) - già da tempo erano presenti, con le loro ramificazioni, fatte di uomini e affari, nelle
regioni dell’Italia centro-settentrionale.
Nell’arco di alcuni decenni la “linea della palma” si è spostata ben oltre i confini nazionali e
le mafie italiane oggi rappresentano un modello di riferimento per altri gruppi criminali sparsi nel
mondo (da ciò anche la fortuna internazionale del termine e la sua diffusione).
Un avanzata lenta ma costante, ha risalito la Penisola. L’attenzione sul problema ha tuttavia seguito
un andamento discontinuo provocata ogni volta dall’allarme sociale, così come discontinuo ed
episodico è stato l’impegno repressivo dello Stato1. Di conseguenza anche un processo vecchio di
circa 60 anni, come la penetrazione delle mafie al di fuori delle cosiddette “aree tradizionali”, è
“apparso” solo negli ultimi decenni in concomitanza con le prime pubblicazioni dedicate a questo
argomento, in precedenza solo sfiorato dalla cronaca dei giornali e confinato nelle aule dei tribunali
o nei documenti della Commissione parlamentare antimafia (d’ora in poi CPA).
L’obiettivo del presente intervento sarà proprio quello di osservare, nella sue linee generali,
le tendenze di fondo del fenomeno della risalita delle mafie verso nord, seguendo un percorso di
lettura che osserva queste dinamiche attraverso la pubblicistica di varia natura (inchieste e dossier
giornalistici, saggi di ricerca, atti di convegni) e in parallelo si confronta con le relazioni prodotte
dalla Commissione parlamentare antimafia o da altre istituzioni pubbliche.
L’aspetto più importante che infatti si vuol qui tentare di cogliere è come la percezione e i
paradigmi interpretativi sulla questione mafiosa siano mutati con l’evoluzione di un fenomeno che,
sopravvivendo ai cambiamenti temporali e superando i vecchi confini spaziali, ha saputo cambiar
pelle senza mutare sostanza. Nel contempo il percorso tra atti e pubblicazioni servirà ulteriormente
a dimostrare – a conferma di quanto già detto - come il corso degli eventi e la reazione della società
abbiano col tempo suscitato una crescente attenzione che si è tradotta poi in studi, ricerche,
iniziative di vario genere.
1 Si tratta di una costante rilevabile in generale nei confronti del fenomeno mafioso, come giustamente ha fatto in
passato rilevare Rosario Mangiameli (Mafia e storia, in Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e
storiografia, a cura di F. Benigno e C. Torrisi, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2005, p. 105) che a supporto
della sua tesi citava anche il giudice Giovanni Falcone.
La relazione verrà suddivisa in tre parti, dove la scansione temporale terrà presente questo
doppio binario (evoluzione del fenomeno e produzione scritta su di esso): nella prima parte, che
copre il ventennio 1960-80, affronterò rapidamente gli anni dell’incubazione del fenomeno, segnati
da silenzi e reticenze; nella seconda si passa agli anni Novanta, quando la stagione stragista di Cosa
Nostra e quella dei grandi processi, accenderà i riflettori sull’emergenza mafiosa, facendo emergere
con evidenza il radicamento e il potere delle mafie nel ricco e opulento nord; infine il racconto degli
anni 2000, segnati dal predominio ‘ndranghetista e dalla minaccia camorrista, vedrà ormai
affermarsi l’immagine mediatica della “mafia padana”, con lo sfondo di complicità e interessi che
hanno decretato il successo delle holding criminali in tutto il paese e altrove.
1. Una marcia silenziosa: il primo tempo delle «ramificazioni territoriali della mafia»
Sin dalle origini del Novecento non sono mancati alcuni isolati e sporadici spostamenti di
mafiosi “nel Continente”. Io stesso, nel corso di una ricerca su alcune cosche siciliane, mi sono
imbattuto in alcuni uomini d’onore che già negli anni Venti avevano messo le mani su vastissime
proprietà in Puglia (appartenute alla Regina di Spagna) e in Toscana, dove avviarono fiorenti
aziende agricole, investendo così i proventi illeciti accumulati nell’area d’origine. Ma si potrà
cominciare a parlare di una prima consistente e stabile presenza mafiosa al Nord solo a partire dagli
anni a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Fu Cosa Nostra a fare da apripista.
Allora, mentre a Palermo la mafia riusciva a sopravvivere al lento declino delle campagne e
avviava il “sacco” edilizio della città, smentendo così la tesi di chi ne vedeva solo l’espressione di
una società povera ed arretrata, a Milano si potevano incontrare boss del rilievo di Joe Adonis
(all’anagrafe Giuseppe Doto), mafioso americano che nel capoluogo lombardo gestiva night club e
bische, ma con un occhio spostato verso estorsioni, commercio di preziosi e iniziale traffico di
droga. Accanto a lui altri membri di importanti famiglie criminali, giunti per diverse vie e motivi
nel profondo Nord: c’era Angelo La Barbera, uno dei protagonisti del sacco di Palermo, che si era
spinto a Roma e poi a Milano per cercare nuove occasioni di investimento (ma vi trovò invece la
morte nel 1963); poi c’erano coloro (furono migliaia) che – in applicazione ad una legge del 1965 -
vennero inviati ad espiare lontano da casa un periodo di «soggiorno obbligato».
Alla base di questa misura di prevenzione c’era allora la convinzione – espressa ad esempio
nel 1969 dal presidente del Tribunale di Palermo di fronte alla CPA - che «il mafioso siciliano,
trasportato fuori dall’isola, perde[sse] il proprio prestigio, la propria iattanza e diventa[sse] un
fantoccio». Questa idea appariva ancora figlia dell’interpretazione della mafia come sottoprodotto
di una mentalità e una cultura tipica del Mezzogiorno, che si sarebbe quindi dissolta nel civile e
progredito settentrione. Ma col tempo si sarebbe rivelata una fallace illusione. Al contrario il
soggiorno – come oggi quasi unanimemente accettato – fu uno dei più potenti fattori di diffusione
delle mafie, come aveva presto intuito il giudice Cesare Terranova, il quale sin dal 1974
denunciava: «Lanciare per l’Italia questi delinquenti ha significato fecondare zone ancora estranee
al fenomeno mafioso».
A differenza dei soggiornanti molti affiliati alle mafie giunsero al Nord allora
volontariamente, per sopravvivere agli scontri tra clan o per sfuggire alla cattura. Uno dei più noti
latitanti di allora, la “primula rossa” Luciano Liggio, giungerà a Milano nel 1972, dopo l’omicidio
del procuratore Pietro Scaglione, e qui esportò l’idea dei sequestri di persona, che venne praticata
con grandi risultati per le mafie fino ai primi anni Novanta.
Nel 1970 Milano era già una base operativa per la mafia siciliana, che in questa prima fase
dettava legge sul lucroso traffico di stupefacenti, sempre mantenendo stretti contatti con l’isola.
Le attività di questi primi nuclei finirono sotto le lenti della Commissione parlamentare antimafia
sin dai suoi primi lavori. Così ad esempio nella Relazione Cattanei del 1972, il presidente «alla
luce di numerosi episodi» – tra cui una operazione di polizia che l’anno precedente aveva portato
all’arresto di 114 persone – poteva trarre le conclusioni che «la mafia, muovendo dalla sua base
tradizionale, si sia insediata in altre zone e in particolare nei grossi centri urbani come Milano,
Roma, Genova e Napoli o nelle zone limitrofe»2.
Passarono altri quattro anni e la Relazione conclusiva di minoranza presentata dai deputati
del Pci e di Sinistra indipendente (1976) alla stessa CPA avrebbe segnato uno spartiacque,
costituendo la prima forte e chiara presa di coscienza rispetto ad un fenomeno che era già entrato
nella sua fase di piena maturazione. La Relazione avrebbe infatti squarciato un velo di silenzio –
reso ancora più spesso dall’atteggiamento di indifferenza e distacco mostrato sino ad allora dagli
organi di informazione e delle autorità locali – denunciando «l’esplodere della mafia a Milano e in
altri centri del Nord», l’assurdità della scelta delle località di soggiorno obbligato per i mafiosi («ha
favorito il loro inserimento al Nord»), il loro enorme potere economico («incrementato
particolarmente negli ultimi anni, col traffico di droga e con i sequestri, e quindi di grandi
possibilità di spostamenti e di collegamenti»); ma Pio La Torre, Cesare Terranova e gli altri
estensori del documento non avrebbero neppure omesso un dato fondamentale come lo «sviluppo
impetuoso» della «mafia calabrese» che avveniva silenziosamente a dimostrazione di «una
insufficiente vigilanza e mobilitazione della opinione pubblica e di tutti gli organi dello Stato».
Milano si sarebbe sempre più affermata da una parte come l’architrave nello scacchiere
internazionale che portava l’eroina asiatica, la cocaina sudamericana e l’hashish da Marocco e
2 La Relazione Cattanei, accompagnata da una selezione di documenti ed elenchi allegati agli atti della Commissione
parlamentare antimafia, sono raccolti nel volume Dossier Mafia, a cura di Alberto Consiglio, «Il libro nero», n. 3,
Roma, 1972.
Albania nell’Europa occidentale, e dall’altra come la “capitale del riciclaggio”, non soltanto grazie
alla rete di rapporti stretta dai siciliani o grazie alla complicità di Michele Sindona e Roberto Calvi,
gli spregiudicati banchieri al servizio degli uomini d’onore dell’isola.
Infatti alla fine dei Settanta al Nord si erano già insediate sia la camorra – come dimostra il
progetto espansionista di Raffaele Cutolo con la sua Nuova Camorra Organizzata che si spinse fino
in Lombardia - che la ‘ndrangheta calabrese, richiamate dall’odore del grande mercato della droga o
spinte dalla necessità per trovare rifugio dai nemici o dalla polizia.
Il caso del Piemonte – insieme alla Lombardia uno dei territori d’arrivo preferiti dalle mafie
- era emblematico di come la ‘ndrangheta potesse dispiegare il suo potere in un territorio nuovo,
riuscendo a scalzare progressivamente i siciliani: a Torino infatti dall’iniziale collaborazione tra
calabresi e “cursoti” (gruppo catanese affiliato a Cosa Nostra), si passò – complice la repressione
dei secondi da parte di polizia e magistratura – al monopolio degli uomini della ‘ndrangheta, che in
breve gestiranno tutti gli illeciti (droga, usura, estorsioni, gioco d’azzardo). Il potere dei calabresi
però si spinse anche nella provincia, come dimostra il noto caso della piccola comunità di
Bardonecchia, ben rappresentato dalla figura di Rocco Lo Presti che incontreremo più avanti.
Nonostante l’avanzata nel territorio sia stata piuttosto “rumorosa” (tra 1970 e 1983 a Torino
si verificarono ben 66 omicidi) per rompere il muro di gomma e riflettere sulle dinamiche in atto si
dovette attendere l’omicidio eccellente. Nel 1983 infatti, fu l’uccisione del procuratore della
Repubblica di Torino Bruno Caccia da parte di membri della ‘ndrangheta a smuovere le acque e
spingere le istituzioni locali a dedicare un primo vero momento di riflessione sul problema mafie,
diventato ormai «una questione nazionale», come si volle affermare traendo il concetto dai titoli
usati il 5 settembre 1982 dal «Corriere della Sera» e de «la Repubblica» dopo l’omicidio Dalla
Chiesa. Nel novembre 1983 così nel capoluogo venne promosso dal Consiglio regionale del
Piemonte un convegno su “Mafia e grande criminalità” ( le relazioni saranno pubblicate in Atti del
convegno: Mafia e grande criminalità. Una questione nazionale, Torino, 25-26 novembre 1983),
al quale intervennero diverse figure del mondo universitario e operatori della giustizia: tra questi il
sociologo calabrese Pino Arlacchi, abbozzando una prima ipotesi interpretativa sulla penetrazione e
lo sviluppo della grande criminalità nell’Italia settentrionale, individuava i due fattori decisivi
nell’enorme domanda di eroina e la formidabile disponibilità di capitale di marca mafiosa; il giudice
Sebastiano Sorbello, invece, seguendo i binari della lettura culturalista, la attribuiva alla grande
ondata migratoria dal Sud, che avrebbe - a suo avviso - riprodotto l’habitat entro cui il “pesce-
mafia” si muove e nutre.
Queste iniziative però – una volta raffreddata l’ondata emotiva suscitata dal delitto – si
sarebbero spente senza lasciare rilevanti tracce. Qualcosa si muoveva anche sul fronte milanese, in
conseguenza di un altro omicidio importante come quello dell’eroe borghese, Giorgio Ambrosoli
(11 luglio 1979), chiamato a fare luce sulla matassa della Banca Privata. Nel medesimo anno infatti
il Consiglio regionale avrebbe organizzato alcune giornate di studio, replicate nel 1981-82. A
dimostrazione invece della reattività di alcune ristretti ambienti culturali va citata, era il 1982,
l’iniziativa del primo “Coordinamento degli insegnanti e presidi in lotta con la mafia” e ancora nel
1985 la nascita, su iniziativa di Nando Dalla Chiesa, del “Circolo Società civile”, da cui sarebbe
presto nata l’omonima rivista («Società civile») impegnata a raccontare storie e uomini della
malavita milanese.
L’impegno di queste sparute avanguardie e gli episodici momenti di riflessione accesi più
dal clamore del momento che dal bisogno di conoscenza mostravano ancora come il nodo
dell’espansione delle mafie restasse un argomento marginale. Gli anni Ottanta così si chiudevano
con le parole sconsolate di Giovanni Falcone che nel 1989, in una intervista affermava: «manca la
consapevolezza che si tratti di un fenomeno nazionale e ciò non solo per l’accresciuta entità del
fenomeno, ma perché realmente sta infiltrandosi in tutto il territorio dello Stato»3.
2. La rivelazione e la fine delle “isole felici”
Dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio che nel 1992 squarciarono Palermo e la Sicilia,
«L’Italia in trincea» («la Repubblica», 21 luglio) era chiamata ad affrontare l’emergenza mafia e
come il 1993 avrebbe dimostrato – con gli attentati di Roma, Firenze e Milano – la sfida si giocava
adesso a tutto campo. Nel pieno di un momento molto delicato di transizione alla nuova fase della
storia repubblicana, mentre un intero sistema politico crollava sotto i colpi delle inchieste di
Tangentopoli, nel marzo del 1993 giungeva l’incriminazione di Giulio Andreotti, accusato di
concorso esterno in associazione mafiosa. Il caso Andreotti e Tangentopoli erano però solo le punte
avanzate di un energico attacco sferrato su tutto il territorio nazionale contro corruzione e
criminalità in risposta alla violenza mafiosa. Tra 1992-93 le forze dell’ordine e la DDA di Milano,
grazie anche a collaboratori di giustizia come Antonio Zagari e Saverio Morabito, ricostruirono le
ramificazioni dei clan mafiosi sul suolo lombardo; dai filoni di indagini si svilupparono una
quarantina di inchieste (“Duomo Connection”, “Wall Street”, “Nord-sud”, “Count down” etc.) che
sgominarono le organizzazioni che ruotavano attorno a uomini di Cosa Nostra e i calabresi.
Intanto si assisteva ad un fiorire di interesse e passione civile tra l’opinione pubblica, che
contagiò l’intera Penisola, dove sorsero a catena una serie di osservatori sulla legalità, centri studi,
3 G. Falcone, La mafia tra criminalità e cultura, intervista di G. Fiume, in «Meridiana», n. 5, p. 208.
associazioni e riviste specializzate4. Sull’onda di questa spinta che veniva dal basso e insieme
dall’alto, e anche grazie alla massa imponente di documentazione resa disponibile agli studiosi, la
produzione scientifica dedicata alla storia delle mafie sarebbe sensibilmente cresciuta5.
I tempi erano adesso maturi perché il problema delle mafie al nord venisse affrontato in
modo diretto. Come abbiamo visto infatti l’andamento delle ricerche su questo tema era stato sino
ad allora episodico e l’argomento era stato affrontato in modo non sistematico. Un fondamentale
contributo in questo senso venne ancora una volta grazie all’impegno della CPA, che nel corso
dell’XI legislatura costituì un apposito gruppo di lavoro e ne approvò all’unanimità, poco prima
della fine della legislatura, il rapporto conclusivo, redatto a seguito di numerosi sopralluoghi, di
moltissime audizioni, di acquisizione di una notevolissima quantità di documenti. II lavoro, che si
svolse nell’arco di alcuni mesi e venne coordinato dal sen. Carlo Smuraglia, aveva alla fine prodotto
una relazione molto ampia che si componeva di una relazione di sintesi (114 pp.) e 9 schede relative
a ciascuna delle regioni visitate. Le conclusioni della relazione (pubblicata nel volume O. Barrese
(a cura di), La mafia al nord: la relazione di Carlo Smuraglia su insediamenti ed infiltrazioni di
soggetti e organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali, 1994) sancivano di fatto la fine
del sogno delle “isole felici”: nessuna infatti delle aree considerate – nonostante le differenze
interne e le varie intensità della penetrazione – poteva ritenersi esente da fenomeni di tipo mafioso o
da infiltrazioni nel tessuto economico e nel mondo degli affari. Interessanti le considerazioni sulle
attività delle mafie, che accanto agli ambiti tradizionali (controllo di appalti, estorsioni, usura,
truffe) e al traffico degli stupefacenti, si occupavano sempre più del traffico di armi, e mostravano
la spiccata propensione ad inserirsi nel tessuto economico attraverso l’acquisizione di aziende in
4 Per un primo bilancio si può consultare l’appendice del volume di U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla
lotta di classe all’impegno civile, Editori Riuniti, Roma, 2009 (pp. 449-473): qui apprendiamo ad esempio che in Puglia
nel 1993, si è formato l’Osservatorio pugliese contro la criminalità, per la legalità e la nonviolenza, a cui aderivano 45
associazioni; nel dicembre 1994 la Regione Toscana invece inaugurava il Centro di documentazione Cultura della
legalità democratica, che si occupa ancora oggi di raccogliere, produrre e mettere a disposizione di scuole, associazioni,
ricercatori, semplici cittadini materiali sui fenomeni di criminalità e di illegalità; in Emilia Romagna, presso la Regione,
operava invece un Osservatorio regionale sulla criminalità che, nell’ambito del progetto “Città sicure”, si è occupato in
particolare delle infiltrazioni mafiose nella regione; in Piemonte, dall’esperienza del Gruppo Abele, fondato nel 1965 da
don Luigi Ciotti, è nata nel 1995 Libera, associazione nazionale impegnata sui temi dell’antimafia sociale; già nel 1992
era nata comunque la rivista mensile «Narcomafie», che da anni ormai conduce diverse inchieste sulla penetrazione
delle mafie al nord; in Lombardia, dove era già attivo sin dal 1985 il Circolo Società civile, nel 1990 nasceva un
Laboratorio antimafia milanese, mentre nel 1997 si è costituito Omicron (Osservatorio milanese sulla criminalità
organizzata al Nord) che ha pubblicato un bollettino, e insieme all’associazione Saveria Antiochia, ha dato vita ad un
centro studi e documentazione sulla legalità democratica; infine in Veneto nel maggio 1993 si è costituito
l’Osservatorio veneto sul fenomeno mafioso, con lo scopo di «contribuire all’elevazione del livello culturale e
dell’impegno civico dei cittadini in ordine alla dimensione nazionale del fenomeno mafioso». 5 A titolo di esempio si possono citare solo alcuni dei volumi usciti negli anni Novanta: P. Pezzino, Una certa
reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria, Franco Angeli, Milano, 1990; N.
Tranfaglia, Mafia, politica e affari. 1943-91, Laterza, Roma-Bari, 1992; E. Ciconte, ‘Ndrangheta, dall’Unità ad oggi,
Laterza, Roma-Bari, 1992; D. Gambetta, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Einaudi, Torino,
1992; I. Sales, La camorra, le camorre, Editori Riuniti, Roma, 1993; S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni
nostri, Donzelli, Roma, 1996; G.C. Marino, Storia della mafia, Newton, Roma, 1997; F. Barbagallo, Il potere della
camorra, Einaudi, Torino, 1999.
difficoltà, l’acquisto di immobili, la speculazione finanziaria. L’analisi poi si spingeva fino a
considerare anche diverse cause della diffusione delle mafie: tra le principali l’uso incauto del
soggiorno obbligato, la fuga volontaria di soggetti mafiosi, i movimenti migratori dal Sud al
Centro-Nord, l’appetibilità delle zone di destinazione. Tra le ricostruzioni contenute nelle schede
monografiche, invece spiccava il caso di Milano: come le inchieste avevano mostrato, nella città e il
suo hinterland erano radicate e operavano ben 51 famiglie mafiose e circa 2.000 affiliati. Nel tempo
si era assistiti ad un cambiamento, con la massiccia presenza delle famiglie calabresi, che avevano
riempito i vuoti lasciati dalla scomparsa dei siciliani. Una funzione di secondo piano era assunta
dalla camorra, insediata in un territorio specifico e impegnata solo in settori specifici (rapine e furti
di Tir). La supremazia della ‘ndrangheta, che come nei luoghi d’origine aveva ottenuto il controllo
del territorio in alcuni comuni della provincia, interessò anche le altre forme di criminalità (i gruppi
italiani, come la Sacra Corona Unita pugliese, e quelli stranieri turchi, slavi, marocchini e
sudamericani), con le quali esisteva da tempo un patto di coesistenza sulla base in particolare della
divisione dei rispettivi settori di interesse. Infine la relazione si concentrava sulle misure di
contrasto e sui processi di sensibilizzazione rispetto al tema, per rimuovere la «lunga
sottovalutazione e rimozione» del problema.
La relazione Smuraglia, così come altre pubblicazioni promosse da istituzioni regionali o da
alcuni istituti di ricerca, dimostravano finalmente una maggiore attenzione rispetto al fenomeno del
radicamento delle mafie nelle regioni del centro-Nord. Un'altra dimostrazione in questo senso si
poteva trovare nei volumi dedicati agli stessi argomenti, e pubblicati nei medesimi anni. Si parte
dalla storia di “Duomo Connection” (P. Colaprico, L. Fazzo, Duomo Connection. Indagine sulla
fine della Capitale morale, 1991): lo scandalo, raccontato dai due cronisti che lo avevano fatto
scoprire al grande pubblico, dimostrava come un giovane incensurato (Toni Carollo), figlio di un
siciliano emigrato in seguito diventato uomo d’onore negli anni Settanta, possa diventare dopo
l’uccisione del padre un boss emergente di Cosa Nostra, coinvolto nell’attività di traffico di
stupefacenti e quelle connesse al riciclaggio del denaro sporco, al centro di un sistema di poteri
(massoneria e politica) e uomini forti. La presenza di amministratori cittadini (vennero toccati nomi
forti come il sindaco Paolo Pillitteri, cognato di Craxi, e un altro socialista assessore comunale) e
costruttori lombardi disegnava un quadro inquietante che faceva affermare agli autori che la
“capitale dell’economia” fosse ormai «diventata terra di scorribanda per l’homo novus della
malavita organizzata.»
A dispetto delle sempre più chiare risultanze giudiziarie anche allora comunque capitava di
riscontrare una tendenza a minimizzare da parte delle istituzioni la presenza delle mafie nei nuovi
contesti (si pensi al sindaco di Milano che riduceva la mafia a una questione di fiction). Oppure ci si
ostinava a coniugare in un tempo indefinito il problema mafioso come un verbo dell’irredimibile
situazione meridionale, come con uno sfrontato piglio quasi razzista (erano gli anni delle simpatie
leghiste) avrebbe fatto Giorgio Bocca nel suo libro L’inferno. Profondo Sud, male oscuro (1992).
Di fronte allo spettacolo desolante di intere regioni abbandonate a famelici politici e a un sistema
clientelare fatto di sprechi e assistenzialismo malato, l’unico auspicio era questo: «Bisogna che gli
italiani dell’Italia ricca diano appoggio ai fratelli meridionali che hanno iniziato la loro resistenza
civile».
Di ben altro tenore le parole dell’allora presidente della CPA, Luciano Violante, impegnato
anche con i suoi scritti a spiegare la forza e il potere raggiunto dalle tre organizzazioni criminali
storiche, cui si era aggiunta anche la SCU. In particolare Violante sottolineava la capacità di
penetrazione nelle economie ed estensione territoriale raggiunta dalla ‘ndrangheta, la quale – come
scrive in uno dei primi testi (Non è la piovra. Dodici tesi sulle mafie italiane, 1994) - «ha assunto
[…] connotati preoccupanti anche in relazione agli insediamenti, nelle regioni del Nord e Centro
Italia, in particolare Piemonte e Lombardia, in Germania, in Francia e in alcuni paesi dell’Est
europeo» in virtù alla presa esercitata sul traffico internazionale degli stupefacenti, all’abilità
mostrata nel riciclaggio di denaro sporco e negli investimenti all’estero o con imprese formalmente
pulite.
In quel frangente un gruppo molto attivo era quello del Circolo Società civile di Milano,
che nel 1994 promosse un convegno dal titolo “Metropoli e criminalità organizzata. Il ruolo della
cultura e delle scuole”, pubblicando poi gli atti nel volume Mafia/mafie. Che fare? (1994). Una
grossa responsabilità nella “resistibile ascesa” delle mafie e nella loro diffusione veniva attribuita
dalla presidente del circolo (Jole Garuti), a uomini e partiti che avevano malgovernato l’Italia.
Dall’analisi si passava così direttamente alla risposta e qui, nella volontà di avviare una
rigenerazione morale e politica nel paese facendo appello alla società civile (come il nome del
circolo suggeriva), contrapposta o comunque estranea al sistema dei partiti, si riproducevano e si
riflettevano alcuni degli umori più diffusi in quello scorcio storico. Dallo stesso ambiente culturale
– essendo giornalisti del mensile «Società civile» - provenivano pure M. Portanuova, G. Rossi e F.
Stefanoni gli autori di una delle varie inchieste (Mafia a Milano. Quarant’anni di affari e delitti,
1996) dedicate in quegli anni a ricostruire i molti volti della criminalità milanese, i suoi rapporti con
la vita cittadina e i tanti intrecci che avevano coinvolto la città lombarda.
Per arrivare ai primi lavori condotti col metodo scientifico e un approccio rigoroso bisognerà
attendere fino al 1998. In quell’anno vennero pubblicati due saggi di ricerca che qui separatamente
analizzeremo. Enzo Ciconte, già autore di una storia della ‘ndrangheta e consulente presso la
commissione antimafia, portava a termine una ricerca per conto della presidenza della regione
Emilia-Romagna che ebbe come titolo Mafia, camorra e ‘ndrangheta in Emilia Romagna (1998).
Sulla base della documentazione redatta dagli organi di polizia e dalla magistratura, veniva qui
ricostruita una storia lunga 25 anni, attraverso la parabola criminale di singoli personaggi e gruppi
di mafiosi operanti nella zona emiliana. I dati empirici consentono all’a. di formulare alcune ipotesi
e approntare un quadro interpretativo generale, che però tiene conto delle differenze esistenti tra
regioni diverse. Intanto Ciconte afferma che il fenomeno della espansione delle mafie ha smentito i
diffusi e rozzi luoghi comuni sulle mafie. L’insorgenza e l’operatività delle mafie in zone nuove
infatti avviene solo a determinate condizioni, che sono riassumibili così: la presenza di soggetti
criminali (giunti al soggiorno o per una scelta precisa, frutto di una strategia predeterminata) e
l’esistenza dei fattori locali che hanno consentito e favorito il fenomeno (scarsa attenzione,
tolleranza e bassa preoccupazione, debole reazione delle istituzioni locali e nazionali e degli organi
di controllo). La riproduzione delle condizioni di partenza, con una piena “occupazione del
territorio” e gli effetti connessi (meccanismo estorsione/protezione, omertà diffusa,
condizionamento delle istituzioni locali), è riscontrabile solo in alcune aree (come la Lombardia e il
Piemonte), per effetto della maggiore concentrazione di criminali e loro associati, e per la differente
importanza nello scacchiere internazionale degli stupefacenti (Milano è un centro nevralgico mentre
l’Emilia è solo un mercato). Se dunque per alcuni versi l’Emilia presenta sostanziali differenze
rispetto ad altre aree del Nord rispetto al fenomeno mafioso (tipo lo scarso controllo del territorio,
se si escludono isolati casi dove l’alta concentrazione di famiglie meridionali e soggiornanti ha
creato delle enclaves come il comune di Budrio e il quartiere Pilastro di Bologna), per altri aspetti
invece le dinamiche sono le medesime in atto altrove: l’importanza della funzione degli “uomini-
cerniera” per mettere in contatto il mondo mafioso con quello economico-finanziario ad esempio,
cosa che dimostra la disponibilità di elementi autoctoni a collaborare strettamente con i mafiosi; o
ancora la gestione dei traffici illegali e dei canali di riciclaggio dei proventi illeciti.
Il secondo saggio di ricerca (Mafie vecchie mafie nuove. Radicamento ed espansione) uscito
nel 1998 è invece opera di Rocco Sciarrone, sociologo di origini calabresi che lavora a Torino. Il
proposito da cui muove la ricerca – condotta consultando un ampia mole di documenti (CPA,
Direzione investigativa antimafia, organi di polizia) e dialogando serratamente con gli studi sino ad
allora dedicati alle mafie – è quello di tentare di individuare i meccanismi sociali di riproduzione
della mafia. La tesi di fondo è chiaramente esposta in apertura del libro, ovvero «la mafia si
riproduce nel tempo e nello spazio grazie alla sua capacità di accumulare ed impiegare capitale
sociale», per questo la rete di rapporti esterni risultano decisivi nel suo successo in ogni contesto.
Per dimostrare la capacità di radicamento ed espansione delle mafie in contesti differenti, ma anche
per verificare le ipotesi formulate circa i meccanismi di diffusione in aree non tradizionali, l’analisi
empirica segue due percorsi e analizza 3 differenti casi studio: nella prima parte il focus è tutto
centrato su Gioia Tauro, in Calabria, che rappresenta un area di radicamento tradizionale; la
seconda parte invece, centrata sull’espansione di gruppi mafiosi in aree non tradizionali, esamina un
area contigua a quella di genesi storica della mafia (Puglia) e un area distante (Piemonte). Prima di
approfondire l’analisi dei casi, però l’a. passa in rassegna le tesi e i paradigmi più diffusi sul
fenomeno della diffusione delle mafie in aree non tradizionali, raffrontandole e talvolta
confutandole: comincia con la tesi della “non esportabilità”, sostenuta da Diego Gambetta6, secondo
cui «la mafia è un marchio difficile da esportare [essendo] fortemente dipendente dalle risorse e
dall’ambiente locale», dove per risorse e ambiente locale si vuol fare riferimento al network di
parentela e amicizia necessario ai mafiosi per impiantare la loro industria della protezione privata7;
la “metafora del contagio”, rivalutando la vecchia tesi culturalista-etnica, attribuisce la diffusione
dell’infezione mafiosa alle dinamiche migratorie, responsabili di aver trasportato gli agenti patogeni
dalle zone di tradizione mafiosa ad aree prima immuni8; le “strategie di espansione” fanno
riferimento al comportamento strategico perseguito dagli attori mafiosi attraverso due forme di
diffusione (colonizzazione e imitazione), che talvolta si trovano combinate o attivate in tempi
diversi; la “tesi del complotto” richiama una strategia centralizzata di diffusione premeditata da un
inafferrabile “terzo livello”; infine ci sono le “forme di adattamento”. Le diverse interpretazioni –
sostiene l’a. – non riescono a cogliere la complessità del fenomeno. Le migliori risposte vengono
solo dal raffronto con la specificità dei contesti, dove appare manifesto il mescolarsi dei fattori,
quindi anche l’insufficienza di ipotesi monocausali. Così ad esempio nel caso della Puglia, area in
passato risparmiata dalle mafie, l’insorgenza della criminalità organizzata, sempre più chiara a
partire dagli anni Ottanta ma già irresistibile e preoccupante nel decennio successivo9, si spiega con
una serie di cause: la presenza di opportunità favorevoli per lo sviluppo di settori illegali (traffico di
6 D. Gambetta, La mafia siciliana. Un industria della protezione privata, cit., p. 353.
7 Come precisa anche Sciarrone il problema posto da Gambetta potrebbe essere risolto se – come fa Raimondo
Catanzaro (Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Liviana, Padova, 1988) - la prospettiva venisse
rovesciata: dove è invece l’offerta di protezione a creare la propria domanda, la mafia potrebbe diffondersi nei contesti
in cui i mafiosi riescono a trovare le condizioni favorevoli per imporre il meccanismo della estorsione-protezione. 8 Tale ipotesi, che non spiega la disomogenea diffusione delle mafie, non tiene conto dei “fattori interni” che – come
ricordava Arlacchi – avevano favorito negli anni Settanta l’emersione del fenomeno mafioso al Nord. Tra questi il
sociologo citava la centralità del traffico di stupefacenti – con l’importanza assunta da Milano in questa rete
internazionale e la crescente richiesta nelle città del nord – e l’espansione della sezione finanziaria e speculativa del
capitalismo settentrionale, che si lega alla crescente disponibilità di risorse delle famiglie mafiose (grazie al traffico di
stupefacenti) e crea le cosiddette “lobbies politico-finanziarie-mafiose” (cfr. Lo sviluppo della grande criminalità
nell’Italia settentrionale negli anni ’70 e ’80: un’ipotesi interpretativa, in Consiglio regionale del Piemonte, Atti del
convegno: Mafia e grande criminalità. Una questione nazionale, Torino, 25-26 novembre 1983). 9 Nella relazione conclusiva presentata nel luglio 1999 dal presidente della Commissione parlamentare antimafia (nella
XIII legislatura fu Ottaviano Del Turco) si poteva infatti leggere: «La centralità della Puglia e il suo ruolo come nodo
strategico del crimine organizzato dovevano subito dopo consolidarsi definitivamente, a seguito della crisi istituzionale
ed economica dei vari paesi dell’Est, l’Albania innanzitutto, del disfacimento della Jugoslavia e della conseguente
chiusura della via dei Balcani ai traffici verso l’Europa occidentale: la criminalità pugliese aveva così modo di
internazionalizzarsi venendo a contatto con tutta l’infinita varietà delle mafie orientali, comprese quella turca, russa e
cinese» (citata in N. Tranfaglia, Mafia, politica e affari 1943-2008, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 254).
stupefacenti e tabacchi), la strategia espansiva messa in atto dalle mafie tradizionali (in particolare
dalla Nuova Camorra Organizzata di Cutolo), la presenza in Puglia di soggiornanti obbligati e
camorristi nelle carceri pugliesi; l’imitazione da parte della criminalità locale dei modelli di azione
e organizzazione delle mafie tradizionali (da cui la nascita nel 1981 della “Sacra Corona Unita”10
), e
infine il deterioramento e la bassa reattività del tessuto istituzionale e sociale locale. Il caso
piemontese invece dimostra la capacità degli esponenti mafiosi di adattarsi anche in contesti diversi,
come Torino e piccoli centri come Bardonecchia, sfruttando le opportunità offerte dai mercati legali
e illeciti: l’origine della storia della comunità di montagna – altamente significativa da quando nel
1995 è diventato il primo comune del nord dove venne sciolto il consiglio comunale – appare ad
esempio legata all’invio al soggiorno di membri della ‘ndrangheta che in breve ottennero il
controllano del mercato del lavoro, attivando catene di richiamo nei paesi di origine e offrendo un
servizio ben accetto agli imprenditori locali. Diversa la parabola criminale nel capoluogo, dove il
traffico di stupefacenti funse da calamita per diversi gruppi (uomini della Stidda, “cursoti” catanesi
e calabresi) entrati in seguito in competizione tra essi.
Gli anni Novanta – con la relazione di Smuraglia e i saggi di Ciconte e Sciarrone – avrebbero
aperto il sentiero delle analisi sulle penetrazioni mafiose. Dopo la rivelazione cominciava il tempo
del risveglio.
3. Il risveglio: le mafie padane nel crimine globale
Nella cronologia mafiosa agli anni delle stragi – i primi Novanta – è seguita la stagione
definita da Nicola Tranfaglia «la lunga bonaccia», per spiegare come alla strategia dell’attacco
frontale è seguita quella dell’inabissamento. Questo è vero soprattutto per Cosa Nostra, la mafia più
colpita da arresti e defezioni nell’ultimo scorcio del XX secolo. Sia la camorra e ancor di più la
‘ndrangheta in questo inizio millennio hanno infatti mostrato segni di forza e resistenza e insieme
una capacità di rigenerarsi e rinnovarsi che testimoniano la loro intatta vitalità. Le cifre contenute in
un rapporto presentato nel 2006 dalla Confesercenti parlano di organizzazioni mafiose (alle tre
storiche aggiunge la SCU pugliese) composte da circa 20.000 affiliati e con un fatturato
10
Sempre negli anni Novanta vennero pubblicati i primi libri dedicato alla “quarta mafia”: G. Ruotolo, La quarta mafia.
Storie di mafia in Puglia, Pironti, Napoli, 1994; M. Massari, La Sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, Roma-
Bari, 1998. Dopo la SCU si è registrata, nella vicina Basilicata, la formazione di una organizzazione di stampo mafioso
denominata “I Basilischi”: questa si sviluppò nei primi anni ’90 a Potenza, per diffondersi successivamente nel resto
della regione, e nacque originariamente come una filiazione della ‘ndrangheta resasi in seguito autonoma dal punto di
vista organizzativo e operativo (si veda in proposito S. Pantaleone, Gli anni dei Basilischi. Mafia, istituzioni e società in
Basilicata, Franco Angeli, Milano, 2003).
complessivo di 130 miliardi di euro. Proprio in virtù delle enormi disponibilità economiche e della
sempre più frequente infiltrazione dei capitali illeciti nei settori finanziari e nei circuiti
internazionali si è ricorsi con sempre più frequenza a termini quali “mafia finanziaria”, mentre con
“globalizzazione delle mafie”, si è voluta definire la proliferazione nel mondo di fenomeni criminali
di tipo mafioso e il ruolo dei processi di globalizzazione nel favorire e diffondere tali fenomeni11
.
Negli ultimi anni l’attenzione dei media, come pure delle istituzioni, si è spostata da Cosa
Nostra e l’interesse è parso concentrarsi sulla criminalità calabrese (sulla scia di delitti eclatanti,
come quello nel 2005 del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno e quello di
Duisburg in Germania nel 2007); e sulla camorra, anche qui sull’onda del successo di Gomorra, il
racconto di Roberto Saviano pubblicato nell’aprile 2006. Intanto non calava la pressione degli
organi inquirenti sulle ramificazioni al Nord, come dimostrano importanti maxi-operazioni come
“Crimine-Infinito”, coordinata dalle procure di Reggio Calabria e Milano con 164 arresti solo in
Lombardia, o “Minotauro”, che portò all’arresto di oltre 150 appartenenti alla ‘ndrangheta in
Piemonte.
Ulteriori elementi conoscitivi sul radicamento delle mafie al Nord venivano raccolti dalla
CPA, nel corso della XV legislatura. Il presidente, Francesco Forgione, infatti sin dalla sua
relazione programmatica, sottolineava la necessità di affrontare il problema della mafie («delle
vere holding economiche e finanziarie del crimine») contrastando ogni «riduzione della questione
Meridionale a questione criminale», quindi allargando lo sguardo oltre la loro aree d’origine per
comprendere i nodi posti dagli «insediamenti mafiosi al Nord e il ruolo centrale che la cittadella
finanziaria del paese ha nel riciclaggio e nel reinvestimento dei capitali criminali, in un’osmosi
territoriale che pone un problema più generale di trasparenza dell’economia»12
. Per farlo veniva
così creato un apposito comitato (“Presenza e natura della criminalità organizzata in aree e settori
diversi da quelli tradizionali”). Le conclusioni del lavoro della commissione a distanza di due anni
avrebbero confermato le tendenze evolutive mostrate ad esempio dalla camorra: si registrava così la
capacità di «muoversi con estrema efficienza sul piano transnazionale, stringendo alleanze con
gruppi stranieri per la cogestione di traffici di sostanze stupefacenti e armi, per il contrabbando di
merci contraffatte, per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere (spesso tossici e nocivi),
per il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti». Il contestuale controllo esercitato sulle zone
d’origine induceva ad «esprimere il vero volto della camorra moderna» come un «intreccio tra
11
A tale riguardo si vedano i volumi di S. Becucci, M. Massari, Globalizzazione e criminalità, Laterza, Roma-Bari,
2003, quello di Umberto Santino, Mafie e globalizzazione, Di Girolamo, Trapani, 2007, e infine G.C. Marino,
Globalmafia, Bompiani, Milano, 2011. 12
La relazione programmatica, svolta da Forgione il 6 dicembre 2006, è ora riportata in N. Tranfaglia, Mafia, politica e
affari 1943-2008 cit., pp. 369-370.
“globale” e “locale”»13
. Per la prima volta nella storia della CPA una relazione specifica veniva poi
dedicata alla ‘Ndrangheta, l’«organizzazione mafiosa meno studiata, meno conosciuta anche perché
più impenetrabile, più ramificata territorialmente in Italia e all’estero». Nel testo firmato dal
medesimo presidente Francesco Forgione (si veda pure il testo pubblicato 'Ndrangheta. Boss
luoghi e affari della mafia più potente al mondo. La relazione della Commissione Parlamentare
Antimafia, 2008) è presente una prima organica mappa della conquista silenziosa del Nord, dove
spicca il ruolo di Milano e la Lombardia, che – secondo l’a. - rappresentano la metafora della
ramificazione molecolare della ‘ndrangheta in tutto il Nord».
L’interesse suscitato su questi temi presso il grande pubblico negli ultimi tempi si è riflesso
nella produzione editoriale, come possono testimoniare anche i numerosi libri – perlopiù opere di
giornalisti basati sulle più recenti inchieste giudiziarie – che raccontano la storia delle mafie (ormai)
padane con il corollario di collusioni politiche e complicità economiche: in questa categoria
rientrano libri come quello di Davide Carlucci e Giuseppe Caruso (A Milano comanda la
ndrangheta, 2009), con la capitale lombarda descritta nei termini di una Reggio Calabria o Palermo
d’altri tempi, preda di fameliche cosche lanciate alla conquista di ogni sorta di affare mentre la
politica non sembra intenzionata a prendere le dovute contromisure; poi è la volta di Giovanni
Tizian (Gotica. ‘ndranghera, mafia e camorra oltrepassano la linea, 2012), che osservando il
fluire di uomini e soldi che si spostano da Gela, Casal di Principe, Platì ed armati di violenza e
finanza, afferma: «I capitali mafiosi nel loro fluire da sud a nord formano una sorta di ossatura del
Paese, la sua spina dorsale». È l’Unità d’Italia realizzata dalle mafie, come pure è stato
provocatoriamente affermato dall’associazione antimafia da cui l’a. proviene (daSud) per
festeggiare i 150 anni del nostro paese. A chiudere la sezione delle inchieste giornalistiche Marta
Chiavari (La quinta mafia. Come e perché la mafia al Nord è fatta anche da uomini del Nord,
2011): le storie degli imprenditori del nord (Maurizio Luraghi, Ivan Perego etc.) soci dei mafiosi,
mostrano uno spaccato esemplare del potere economico delle ‘ndrine e i loro collegamenti col
mondo imprenditoriale lombardo, dove d’altra parte l’atteggiamento più diffuso accanto ai casi di
collusione sembra l’omertà, da sempre imputata come tara etnica ai meridionali.
Un contributo notevole in termini di proposte, analisi e confronto in quest’ultimo decennio è
giunto anche dall’associazione nazionale Libera, costituita nel 1995 e radicata in tutto il territorio
nazionale. Saltando ovviamente i tanti incontri formativi/informativi organizzati a livello locale,
bisogna segnalare ad esempio che al tema delle mafie al Nord sono stati dedicate due importanti
convegni che hanno coinvolto giudici, procuratori, operatori sociali ed economici, amministratori
pubblici: il primo si svolse a Padova il 25 ottobre 2004, a cui seguì anche un incontro a Roma
13
CPA, XV legislatura, Relazione conclusiva del presidente on. Francesco Forgione, 19 febbraio 2008, p. 68.
dedicato ad un tema poco conosciuto, quello delle mafie nell’Italia centrale (gli atti sono stati
raccolti in Mafie d’Italia nel nuovo millennio: analisi e proposte, 2005); più recentemente a
Torino (7-8 ottobre 2011) si è svolto poi il seminario di studio Mafie al Nord. Dall’infiltrazione al
radicamento. Limiti analisi prospettive nella lotta alla criminalità economica (le relazioni sono
raccolte nel numero monografico di «Narcomafie» n. 12, 2011), che ha visto tra gli altri la presenza
di due sociologi da tempo impegnati su questo fronte di ricerca come Nando Dalla Chiesa, e il già
citato Rocco Sciarrone, che in aperta polemica con i tanti libri usciti di recente riaffermava
«l’esigenza di affiancare un quadro analitico in grado di spiegare e comprendere dinamiche e
processi che caratterizzano il fenomeno mafioso nelle aree non tradizionali».
La rivista «Narcomafie», spesso in collaborazione con i presidi di Libera sparsi nelle regioni
del nord, ha registrato sin dagli anni Novanta i segnali dell’infiltrazione mafiosa e della sua
evoluzione. Per questo è importante citare almeno alcuni dei lavori di raccolta di questo materiale:
Ombre nella nebbia. Dossier mafie in Lombardia (marzo 2010) ad esempio è uno dei più ricchi,
con una selezione di articoli che registrano ad esempio la lunga sottovalutazione del fenomeno
mafioso e la crescente “predisposizione” delle amministrazioni locali a stringere rapporti con gli
ambienti criminali. La prova che gli interessi della ‘ndrangheta hanno ormai raggiunto dimensioni
prima impensabili viene invece da L’altra Valle d’Aosta. ‘Ndrangheta, negazionismo e casi
irrisolti ai piedi delle Alpi (2012), quaderno interamente dedicato a ricostruire la trama della mafia
calabrese ripercorrendo le tracce dei documenti della CPA, degli organi istituzionali, e le carte
dell’operazione “Tempus Venit”, che nel 2007 dimostrava a tutti come nemmeno la piccola regione
di confine potesse ancora considerarsi un isola felice, viste le mani criminali strette attorno al
Casino di Saint Vincent e nei settori vecchi (edilizia e costruzioni) e nuovi (stupefacenti, truffe).
L’attrazione del tema delle mafie al Nord ha – come abbiamo visto – portato ad un crescente
impegno delle istituzioni pubbliche, enti di ricerca, associazioni. Sono state promosse, così come
nel caso di Libera, giornate di incontro invitando gli “addetti ai lavori”: il 9-10 novembre 2007
l’Associazione Saveria Antiochia Omicron di Milano (che ha attivato il sito tematico
www.omicronweb.it) invitava il senatore Smuraglia e diversi giudici, a fare un punto su La mafia
invisibile. Criminalità organizzata al Nord. Controllo del territorio e potenza economica. Alla
base del workshop organizzato dall’Università di Firenze nel 2001 (i saggi raccolti verranno raccolti
nel volume a cura di S. Beccucci e M. Massari, Mafie nostre, mafie loro. Criminalità organizzata
italiana e straniera nel Centro-Nord, 2001) vi erano invece gli interessi di ricerca di due studiosi,
che aprivano un confronto sulle organizzazioni criminali tradizionali italiane attive nel centro-nord
e l’emergere dei gruppi criminali stranieri nel nostro paese (albanesi, cinesi, kosovari), due temi
sempre più intrecciati vista la sempre più stretta collaborazione attivata tra essi.
Partendo proprio da uno studio comparativo di sociologia empirica, che guarda nell’insieme
alle mafie italiane ed a quelle straniere (in particolare quella russa e le triadi cinesi) e alla loro
penetrazione in territori nuovi, il criminologo italiano Federico Varese, più di recente ha offerto
una sua interpretazione delle regole fondamentali del “trapianto” delle mafie (Mafie in movimento.
Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, 2011). La sua “tesi anticulturalista” mira
chiaramente a respingere fin dalla radice il paradigma culturale, che vuole le mafie come elementi
(quintessenze) della cultura meridionale, e che ha – nella versione accademica – creduto come il
tasso elevato di “civismo” e di “capitale sociale” (i riferimenti sono agli studi di Robert Putnam)
fossero il migliore “immunizzatore” rispetto al trapianto mafioso. Per fermarci al territorio italiano
l’a. attraverso la storia dei casi di Bardonecchia e Verona – cui è dedicato un capitolo e che sono
scelti come esemplificativi di un processo di trapianto vincente e uno invece fallito – vuol
dimostrare come a parità di condizioni “culturali” (condizioni di fiducia generalizzata e capitale
sociale) una medesima organizzazione (‘ndrangheta) possa mettere a frutto la sua strategia di
radicamento solo in presenza di alcune condizioni ambientali. Come infatti viene esplicitato meglio
nel capitolo Il trapianto delle mafie le due categorie che possono spiegare il trapianto sono:
l’offerta, ovvero l’afflusso di mafiosi nei nuovi territori, e le condizioni del nuovo territorio, che
possono contribuire alla nascita di una “domanda di mafia”. Solo in presenza di entrambi questi
fattori le mafie possono attecchire, prendere vigore e svilupparsi.
Una presenza stabile ormai su questo tema è quella dello storico Enzo Ciconte. Egli intanto
(in equipe con Raimondo Catanzaro e Marco Trentini), aggiornando la sua prima ricerca, tornava a
studiare - sempre su incarico della Regione Emilia Romagna – Criminalità organizzata e disordine
economico in Emilia Romagna (marzo-aprile 2004); a distanza di qualche anno offriva un primo
interessante spaccato sulla vicina Toscana, lontana dai clamori della cronaca ma anch’essa
interessata da decenni dal fenomeno delle presenze mafiose (La criminalità organizzata in
Toscana. Storia, caratteristiche ed evoluzione, Regione Toscana, ottobre 2009). Infine lo stesso –
questa volta su impulso del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – presentava una
sintesi e un quadro d’insieme (L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di
alcune regioni del Nord Italia, 23 febbraio 2010), con una cronologia di riferimento e alcuni focus
tematici e dedicati ai vari contesti interessati dal fenomeno. Dalla sua analisi, oltre a osservare
tendenze di fondo ed evoluzione storica dei processi, si può ricavare una differenziazione interna,
che vede da una parte le regioni del nord-ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria nell’ordine) come
aree di antico e profondo radicamento, seguite da aree intermedie (Toscana, Emilia, Veneto, Valle
d’Aosta) e infine da aree che non hanno ancora conosciuto la presenza di stabili e organizzati gruppi
attivi. Un ultimo aspetto che Ciconte invitava a considerare, svolgendo un intervento nel corso di un
convegno su Sviluppo capitalistico e Unità nazionale (Roma, 25-27 maggio 2011), erano i riflessi
della questione mafiosa – di solito considerata solo un problema di criminalità – sul sistema
capitalistico del paese. Se infatti le mafie sono state a lungo considerate una sorta di “palla al piede”
dello sviluppo economico del Mezzogiorno, osservando la realtà da un altro angolo visuale si
potrebbe osservare come esse siano state, specie negli ultimi tre-quattro decenni, «parte di un
moderno e distorto sviluppo economico», i cui caratteri salienti l’a. così sintetizza:
L’economia del Mezzogiorno, e in parte quella nazionale, ha inglobato finanza e capitali d’origine
criminale e mafiosa. In quest’ultimo periodo sono emersi con maggiore evidenza alcuni aspetti già
presenti sin dalle origini: per alcuni ceti l’esistenza delle mafie si è rivelata conveniente, per certi versi
un affare, perché da esse hanno ricavato vantaggi economici.
Al Sud come al Nord in diverse epoche s’è venuto formando un blocco sociale variegato che ha
inglobato ceti sociali di varia provenienza nella difesa di un modello di sviluppo e di un’economia con
una consistente quota mafiosa fatta di capitale mafioso e di metodo mafioso. Per queste ragioni è
possibile dire che non siamo in presenza di un fenomeno solo criminale, ma di un problema di ben
altra natura14
.
Si può per concludere concordare con Ciconte quando afferma che il fenomeno mafioso
rappresenta ormai «un dato strutturale e permanente che attraversa per intero la storia d’Italia
addirittura ancor prima che si formasse lo Stato italiano». La sua lunga parabola e la sua ultima
evoluzione hanno dimostrato sempre di più quanto sia errato tentare di ridurlo ad una mera
“questione criminale”. L’espansione e il radicamento in tutto il paese, dalla Sicilia alla Valle
d’Aosta, ci dimostrano quanto sia impossibile ricondurlo entro i confini della “questione
meridionale”. Siamo di fronte ad una «questione nazionale», di certo una delle sfide più importanti
e decisive per il futuro di tutto il Paese.
14
E. Ciconte, La criminalità organizzata nel Mezzogiorno e nel Nord Italia, Roma, 25-27 maggio 2011 (testo della
relazione), p. 5.