“Pisanus pinxit”? Le suggestive metamorfosi di un’anconetta del primo Quattrocento, in “Arte...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of “Pisanus pinxit”? Le suggestive metamorfosi di un’anconetta del primo Quattrocento, in “Arte...
Jostf italiani1 Spa - Spedi/ione in abbonamento postille - DL. 353/2003 (con). In I.. 27/02/2004 Alt. 1, DCB Milano)
s o<1 Ctì
sa cam ?3
o< > ARTE CRISTIANA
\RTE CRISTIANA4JOAGOSTO
VTJU.-ME
8422007XCV
RIVISTA INTERNAZIONALE DI STORIA DELL'ARTE E DI ARTI LITURGICHE
A\L REVIEW OF ART HISTORY AND LITURGICA!, ARTS
Liturgia e Arte
.&CMNBUT»- 19-20146Milano VINCENZO GATTI II luogo della custodia eucaristica (Parte li)12857 / M I i-- ,
Storia
FRANCESCA PASLT "Pisanus pinxit". Le suggestive metamorfosi diun'anconetta del primo Quattrocento (ili. 11)
DAVIDE FIGXON Sulle tracce di Stefano Scotto: un contributo alla storiaJ
della pittura lombarda tra '400 e '500 (Parte II) (ili. 12)
GEORGE T. NOSZI.OPYAND SUSANJ. MAY Rejledions onpatronage,fona, iconographf andpolitics in Pinturicchio's "Fossi altarpiece"
lesione Beni Culturali (Parte I) (Ìli. 21)i- Roma
Ii Beni Artistici e Storici, Firenze-
Arte Sacerdozioè de Geneve - Facultè des Lettres
PILON VALERIO La diaconia liturgica di Renato Valcavi (ili. 45)
V* .Umori- San Paolo - TorinoO&UI/ZZA
degli Studi - Verona MuS6Ì
dell'Italia Centrale ItEANA Tozzi Museo dei beni ecclesiastici della diocesi di Rieti.s DWUJ fecou Motivi iconografici e simbologia cristologìca in una pianeta tessuta
di-Pisa ad arazzo (sec. XV) (ili. 12)
(jBKnkà degli Studi. Pa\ia• MJtE
or Orsola Benincasa, Napoli NotÌZÌQNOGUCDNEK
II.EANA Tozzi Alla XXI conferenza dell'ICOMJ
«lenza Beni Artistici e Storici
Htóo Nazionale per i PubbliCOZÌOni
i Culturali Ecclesiali - Roma
321
333
343
371
393
398
399
399
j dei Musei Statali di BerlinoIM.LOTT
tà Nlsida - Malta
,' - I ì l f l l /CCOVINO \A1-ENZL\SO
v.."u Nazionale Beni Ecclesiali. Roma
C Tuoi i diritti risenati
Redazione impaginatoneScuota Beato .Angelico\ldcuiinpagiiiazion eCoair Tonello
npa: Brìantea - MBM Graphic, Milano
Periodico associato al (CALICentro d'.\zione Liturgicaal ISSN: 0004-;VKM) e all'Unione StampaPeriodka Italiana iL'SPI)
Toste italiane Spa - Spedizione inabbonamento postale - DL. 353/2003icom. I n L 2 7 02 2004An. l.DCB Milano)" Hanno collaborato a questo numero: Marta Candiani e John Young
"Pisanus pinxit"? Le suggestive metamorfosidi un'anconetta del primo Quattrocento*
Francesco, Pasut
Sono trascorsi quasi ottant'annida quando nel 1929 Georg MartinRichter pubblicò la cosiddetta Ma-donna della Pergola (fìg. 1), un dipin-to allora del l 'ant iquario romanoPaolo Paolini, facendosi forte dellapresenza nell'iscrizione sul cartiglioin basso della dicitura da lui inter-pretata come "antonius pisanus" persostenere un'attribuzione a Pisanel-lo; lo studioso, pur dichiarando dinon essere in grado di provare lagenuinità della sottoscrizione, affer-mava che "it did not seem to be que-stionable"1. Da allora la tavoletta,nel frattempo sparita dalla circola-zione e non più esaminabile diretta-mente, bensì solo con l'ausilio divecchie fotografie, è stata al centrodi un dibatt i to critico alimentatoproprio dalla presunta firma di Pisa-nello. In realtà questa, come si avràmodo di dire, non è assolutamenteautentica, ma del resto le stesse con-notazioni s t i l i s t iche del l 'operahanno poi indotto la maggior partedegli studiosi ad escluderla dal cata-logo pisanelliano e qualcuno è giun-to a metterne anche in dubbio l'an-tichità tout court. La possibilità offer-tami di studiarla da vicino è stataun'esperienza di grande interesse,di cui vorrei rendere conto nellasede attuale; ciò potrà essere di sti-molo ad una riconsiderazione delcontroverso dipinto, oggetto di unavicenda conservativa a dir poco infe-lice.
Protagonista della tavola è la Ver-gine Maria, assisa su un seggio cela-to dall'ingombro del corpo, con ilpiccolo Gesù completamente nudoe disteso su un panno di lino biancoposto sopra le sue ginocchia (fìg. 4).Il sottile velo trasparente che copre icapelli della Madonna scende deli-catamente lungo il collo; la veste èrossa, il manto blu con decorazionifloreali dorate e foderato di pellicciabianca. Ai lati di Maria si librano in
volo due angeli adoranti e immedia-tamente sopra di lei appare lo Spiri-to Santo in veste di una colombabianca, a significare il miracolosoconcepimento di Cristo nel suogrembo'. A sinistra è San GiovanniBattista, che in una mano mostra ilsimbolo dell'agnello mistico e nel-l'altra il rotolo con il versetto evan-gelico "Ecce agnus dei qui tollit pec-catum mundi" (Gv 1, 29), ripassatoperò in modo maldestro dal pennel-lo di un restauratore. Fa coppia conil precursore di Cristo una santa,sulla destra, vestita di una tunica blue di un manto rosso, ma priva diattributi utili alla sua identificazio-ne. La posizione della mano sinistrafa pensare che in origine sorregges-se qualcosa (forse la palma del mar-tirio?); la mano destra sembra tesa aindicare il Bambino.
Lo spazio che ospita la sacra con-versazione è un vero e proprio giar-dino nascosto, un luogo ameno eprivatissimo, posto al riparo dasguardi indiscreti grazie a due brevipareti in muratura erette in primopiano, per sorreggere sia il graticciocoperto dai serti di rose rampicantiesteso alle spalle delle figure, sia ilpergolato soprastante. Dall'arcataaperta nella parete sinistra si scorgo-no brani del paesaggio boschivo cir-costante. La volta della pergola,composta di rami intrecciati, è rive-stita dalle fronde di un albero di vitee da grappoli di uva matura, chericadono verso il basso risaltandocontro il cielo in lamina dorata; lefoglie d'uva si estendono anche sul-l'oro applicato ai due angoli in cimaalla tavola. L'iconografìa è dichiara-tamente mariana: Yhortus condusus èmetafora della purezza di Maria1 edè abbinato, come accade spessonella pittura settentrionale di fineTrecento-inizio Quattrocento, all'ar-busto di rose, fiore che al ludeall 'Immacolata Concezione4; altri
simboli mariani sarebbero la piantadi vite' e probabilmente i volatili, tracui si distinguono due piccoli pap-pagalli6.
La provenienza ant ica de l l aMadonna della pergola è sconosciuta ein tal senso spiace che non sia verifi-cabile il contenuto dell 'et ichettacartacea stracciata, la cui esistenzasul retro è registrata nella relazionedi restauro; il dipinto è stato infattiapplicato su un supporto di legnodifficilmente rimovibile, che impe-disce purtroppo di visionarne iltergo7. Il collegamento con un'ipo-tetica destinazione per Mantova, allabase del quale è semplicemente l'os-servazione di Shigetoshi Osano cheil fiore ornamentale dipinto sulmanto di Maria e sulla veste dellasanta sarebbe la calendula, notaimpresa araldica della famiglia Gon-
Among works attributed to Pisanello,thè so-called Madonna della Pergolahas enjoyed alternating criticai fortu-nes. The attribution to thè celebratedmaster was long upheld by Ihe presen-ce in thè picture afa scroll hearing thèpainter's name, but that signaturehas now been proved to be apo-cryphal. The complex conservationhìstory of thè work, restored at leastthree times in thè course of thè pastcentury, is a fascinating tale to teliThis article follows Ihe. main stages inthat history, based on thè informationgained now that thè picture, whosewhei'eabouts had been unknown since1929, has coinè to light again.Thepanel bears thè marks ofextensivedamage in its present state. Nonethe-less, direct sudy and observationallow us to conclude that thè Madon-na della Pergola is thè work of apointer active in Lombardy and thèVeneto in thè first quarter of thè 15"1
century.
321
1. Pittore lombardo-veneto, 1410-20circa, Madonna della Pergola, giàRoma, coli. Paolo Paolini (stato deldipinto nel 1929).
zaga, non può essere accolto pacifi-camente, trattandosi di un motivoornamentale troppo vistosamenter imaneggia to dai restauratori1*.Dopo la sua prima apparizione allafine degli anni dieci del Novecentopresso l'antiquario Paolo Paolini, lacui attività nel mercato artistico del-l'epoca meriterebbe di essere inda-gata a fondo", la storia più recentedella tavola includerebbe un passag-gio nella collezione Heimann diVenezia, probabilmente la stessa inparte pervenuta per lascito al MuseoCorrer nel 193710.
La fortuna critica della Madonnadella Pergola inizia nel 1927, quandoRaimond Van Marle ne segnala l'esi-stenza in una collezione privata,confermando l'autografia di Pisanel-lo sulla base della firma e delle sup-poste analogie stilistiche con le testi-mon ianze giovanil i dell 'artista:sarebbe questa, a suo avviso, l'opera
più antica - databile certamenteprima del 1430 - tra quelle eseguitedal maestro, che si rivela discepolo"extremely gifted and very indivi-duai [...] of Stefano da Verona"11.Una sintonia con i modi di Stefano(nella testa del Bambino e nel trat-tamento del panneggio) avverteanche Georg Martin Richter, nelcui contributo del 1929 è resa notaper la prima volta la fotografìa dellatavola12: elementi decorativi quali losfondo vegetale, animato in sensonaturalistico dagli uccellini , e leaureole in pastiglia dorata sono letticome chiari riflessi della pitturaveronese contemporanea". Lo stu-dioso confronta poi la figura dellaVergine con opere di Gentile daFabriano1"1 per ricondurre la Madon-na in collezione Paolini, considera-ta dal punto di vista stilistico "a mix-ture of thè art of Stefano and Genti-le", in seno alla prima attività di
Pisanello in Veneto, pressappoco trail 1408 e il 1414, in lieve anticiposulla Madonna della quaglia (Verona,Museo di Castelvecchio), che Rich-ter riteneva dipinta sempre dallostesso artista nel 1420 circa1"'.
Frat tanto, divenuto il dipintoirreperibile, la sua paternità pisanel-liana è accolta con qualche riservada A.H. Martinie, il quale nel 1930lo elenca tra quel l i di Pisanello,avvertendo in merito alla firma che"il serait [...] nécessaire d'identifiercette signature avant d'attribuer letableau lui-mème" al maestro, ed èinvece messa in dubbio da GeorgeFrancis Hill (1933), propenso arigettare la validità dell'iscrizione ead assegnare il quadro alla "scuola"di Stefano da Verona; anche JeanBabelon, nella sua monografia del1931, gli riserva una semplice men-zione tra le opere attribuite a Pisa-nello, sebbene non trascuri di attira-re l 'a t tenzione sulla presenza delcartiglio con la sottoscrizione "Anto-nius Pisanus"16.
Torna viceversa a metterne inrisalto la "qualità [...] notevole enon indegna di un Pisanello esor-diente", essendo "lo stile [...] quellodi un giovane esposto agli influssi diStefano da Verona e di Gentile daFabriano", Luigi Coletti nell'articolouscito nel 1947 su "Arte Veneta"17."Diff ici le impugnare di falso" lafirma, dice lo studioso, che notaquanto gli angeli e l 'immagine delBambino, ispirato a quello dipintoda Gentile nella Madonna dell'umiltàdi Pisa (Museo Nazionale di SanMatteo), possiedano un sapore gen-tile se o-maso lini ano e la formulazio-ne delle pieghe accuratamenterisvoltate del manto di Maria ricordila p isane l l ìana - a parere suo -Madonna col Bambino in trono delMuseo dì Palazzo Venezia a Roma"1.Fu Luigi Colett i a cogliere perprimo la somiglianzà tra la struttura
322
2. Pisanello (attr. a), Frammento di per-golato, Treviso, Chiesa di Santa Cateri-na.
3. Pittore lombardo-veneto, 1410-20circa, Madonna della Pergola, giàRoma, coli. Paolo Paolini (stato deldipinto nel 1917).
del pergolato, all'ombra del quale sidispongono le figure, e un lacertodi affresco riemerso alla metà deglianni quaranta del Novecento sullaparete sud della chiesa di SantaCaterina a Treviso (fig. 2), facenteparte di un ciclo qualitativamenteall 'altezza del giovane Pisanello,secondo un ' ipotesi a t tualmenteabbastanza condivisa1".
Ancora nel 1953 Coletti riconfer-ma per la Madonna ex-Paolini ilnome di Pisanello e la data verso il1420, con queste parole: "dubbisulla sua autenticità non mi sembra-no giustificati; e pertanto, pur nonconoscendola direttamente, la riten-go probabile opera autografa""".L'anno precedente Raffaello Bren-zoni aveva a sua volta ribadito ilvalore del dipinto "sicuro per auten-ticità di firma" nell'ottica del corret-to inquadramento della primissimaattività di Pisanello, viste le palesiderivazioni formali da Stefano daVerona e da Gentile da Fabriano,senza trascurare di avvertire chel'impossibilità di rintracciarne l'ubi-cazione ostacola però "un approfon-dimento [...] dal lato formale, cro-matico e materiale"-1.
Sullo sfondo di questo panorama
si leva nel 1953 la voce di BernardDegenhart", che parla esplicita-mente del quadro come di un falso,appellandosi all'opinione inedita diPietro Toesca, memore dell'origina-le visto a suo tempo e assolutamen-te scettico riguardo alla genuinitàdella scritta contemplante il nomedi Pisanello. Mentre qu ind i laMadonna della pergola trovava acco-glienza tra le opere certe del mae-stro nella riedizione postuma delleliste di Bernard Berenson curatanel 1968 da Luisa Verteva {fig, 3)as,nessuno sembrava essere ancoradisposto a dare credito all'attribu-zione illustre. Lo stesso Berenson, aonore del vero, doveva avere nutri-to qualche incertezza sull'attribu-zione, visto che le annotazioni sulverso della fotografìa in suo posses-so (Biblioteca Berenson, Firenze,Villa I Tatti) riflettono significativicambi di opinione: "with Pisanello","vvith Stefano da Zevio" e "with thèearlier Francesco Benaglio" (riferi-mento questo poi depennato). Daparte sua, Enio Sindona nel 1961aveva sottolineato la "mediocre fat-tura" della tavola, che anche RenzoChiarel l i sceglie di classificareprima (1972) tra i dipinti di asse-
4. Pittore lombardo-veneto, 1410-20circa, Madonna della Pergola, collezio-ne privata (stato attuale).
324
5. Michelino da Besozzo, Madonna delroseto, Verona, Museo di Castelvec-chio.
gnazione incerta e poi (1974) traquelli da respingere-4.
La tradizionale ascrizione a Pisa-nello è oggi concordemente rigetta-ta, ma tutt'altro che unanime è ilgiudizio della critica sull'opera, oraaccostata in forma dubbiosa a Gia-como di Nicola da Recanati, comeipotizzava Alessandro Conti, oppurea un anonimo della cerchia di Pisa-nello e di Gen t i l e da Fabriano,molto dotato nell'assimilare i modidei due maestri, secondo ShigetoshiOsano, mentre Enrica Cozzi escludeper il motivo del pergolato una rela-zione diretta con il citato frammen-to in Santa Caterina a Treviso e
—t-rva nel dipinto un livello di qua-lità modesta; un commento analogoesprime Tiziana Franco2"'. Infine, inuna comunicazione orale del 2005agli a t tual i proprietari , MiklósBoskovits ha pronunciato il parereche l'autore sia "un pittore dell'areaveneto-lombarda del 1410-20 circa",escludendone l'identificazione conPisanello, "che s t i l is t icamente emorfologicamente percorre stradediverse".
Lo stato di conservazione con ilquale la Madonna della pergola tornaoggi ad essere visibile non è certodei più incoraggianti, nonostante ilrestauro fatto eseguire nel 1992(figg. 2, 6). Lo spessore del suppor-to, ricavato da un 'unica asse dilegno di venatura longi tudinaleincurvatasi leggermente nella zonamediana, parrebbe essere integro.Nei margini superiore e inferiore -viceversa non sui lati verticali dellatavola, forse rifilati - avanza rispettoalla par te dipinta una striscia dilegno grezzo, segno che probabil-mente in antico la piccola anconadoveva essere ricoperta da una cor-nice a incasso2". Non vi è alcuna trac-cia, per quanto è dato capire, dellapresenza di scomparti laterali poidispersi e si può supporre che ledimensioni originali del dipintonon fossero troppo diverse da quelleattuali (cm 78x51x3,6).
La materia pittorica, verosimil-mente già di per sé alquanto dete-riorata, ha subito pesanti dannianche a seguito di vecchie e drasti-che puliture che hanno determinatoun forte impoverimento della pelli-cola cromatica, fittamente fratturatae appiatt i ta sull ' intera superficiedell'opera. Tra le parti maggior-m c - n t e compromesse è il gruppodella Madonna col Bambino (fig. 9);la figura di Gesù è interamente per-duta ed è stata integrata ex-novo in
sede di restauro al fine dì preserva-re la leggibilità dell'insieme. Nume-rose sono le cadute di colore nellazona superiore della tavola e i pig-menti risultano fortemente scuriti,mentre la consistenza della laminadorata, nello scorcio del ciclo e neidue angoli di risulta in alto è moltoassottigliata. In stato di conservazio-ne migliore si presenta la figura delBattista, che non dovrebbe diverge-re eccessivamente dall'aspetto origi-nale (fig. 10), così come per certiversi gli angeli e il volto della santa,dove con l'eliminazione degli stratipittorici sovrapposti l'immagine hariacquistato, almeno in parte, unsentore più genuino.
Come ha avuto il merito di accor-gersi Shigetoshi Osano*7, il dipintoha subito in passato almeno treinterventi di rifacimento condotti
in modo alquanto discutibile. Loattestano le vecchie fotografie, apartire da quella dell'Archivio dellaBiblioteca Berenson (fig. 3), cheriproduce il quadro nel 1917 quan-do già era dell'antiquario Paolo Pao-liniatl, seguita dalla fotografia pubbli-cata nel 1929 da Richter (fig. 1) e,in ultimo, da quella scattata primadel restauro del 1992 (fig. 6). Inte-grazioni del tutto arbitrarie hannointeressato le figure degli angeli involo, i) viso della Madonna e dettaglidello sfondo, come i sostegni che siprolungano lateralmente dall'altodella volta fino a terra per sostenereil peso del pergolato. Lo spessoreeccessivamente sovrabbondantedella materia pittorica nelle duesagome dei pappagalli, che appaio-no di una lucentezza ambiguarispetto al resto della raffigurazione,
325
gnazione incerta e poi (1974) traquelli da respingere24.
La tradizionale ascrizione a Pisa-elio è oggi concordemente rigetta-
la, ma tutt 'altro che unanime è ilgiudizio della critica sull'opera, oraaccostata in forma dubbiosa a Gia-como di Nicola da Recanati, comepotizzava Alessandro Conti, oppure
a un anonimo della cerchia di Pisa-nello e di Genti le da Fabriano,nolto dotato nell'assimilare i modi
ei due maestri, secondo ShigetoshiOsano, mentre Enrica Cozzi escludeper il motivo del pergolato una rela-zione diretta con il citato framrnen-o in Santa Caterina a Treviso e
osserva nel dipinto un livello di qua-lità modesta; un commento analogoesprime Tiziana Franco-'. Infine, inuna comunicazione orale del 2005agli a t tual i proprìetari , MiklósBoskovits ha pronunciato il parereche l'autore sia "un pittore dell'areaveneto-lombarda del 1410-20 circa",escludendone l'identificazione conPomello, "che stilisticamente emorfologicamente percorre stradediverse ".
Lo stato di conservazione con ilquale la Madonna della pergola tornaoggi ad essere visibile non è certodei più incoraggianti, nonostante ilrestauro fatto eseguire nel 1992ifigg. 2, 6). Lo spessore del suppor-to, ricavato da un'unica asse dilegno di venatura long i tud ina leincurvatasi leggermente nella zonamediana, parrebbe essere integro.Nei margini superiore e inferiore -viceversa non sui lati verticali dellatavola, forse rifilati - avanza rispettoalla parte dipinta una striscia dilegno grezzo, segno che probabil-mente in antico la piccola anconadoveva essere ricoperta da una cor-nice a incasso-*5. Non vi è alcuna trac-cia, per quanto è dato capire, dellapresenza di scomparti laterali poidispersi e si può supporre che ledimensioni originali del dipintonon fossero troppo diverse da quelleattuali (cm 78x51x3,6).
La materia pittorica, verosimil-mente già di per sé alquanto dete-riorata, ha subito pesanti d a n n ianche a seguito di vecchie e drasti-che puliture che hanno determinatoun forte impoverimento della pelli-cola cromatica, fittamente fratturatae appiattita sull ' intera superficie
ll'opera. Tra le parti maggior-mente compromesse è il gruppo
ella Madonna col Bambino (fig. 9);a figura di Gesù è interamente per-hita ed è stata integrata ex-novo in
«*
sede di restauro al fine di preserva-re la leggibilità dell'insieme. Nume-rose sono le cadute di colore nellazona superiore della tavola e i pig-menti risultano fortemente scuriti,mentre la consistenza della laminadorata, nello scorcio del ciclo e neidue angoli di risulta in alto è moltoassottigliata. In stato di conservazio-ne migliore si presenta la figura delBattista, che non dovrebbe diverge-re eccessivamente dall'aspetto origi-nale (fìg. 10), così come per certiversi gli angeli e il volto della santa,dove con l'eliminazione degli stratipittorici sovrapposti l'immagine hariacquistato, almeno in parte, unsentore più genuino.
Come ha avuto il merito di accor-gersi Shigetoshi Osano-'7, il dipintoha subito in passato almeno treinterventi di rifacimento condotti
in modo alquanto discutibile. Loattestano le vecchie fotografie, apartire da quella dell'Archivio dellaBiblioteca Berenson (fig. 3), cheriproduce il quadro nel 1917 quan-do già era dell'antiquario Paolo Pao-lini2", seguita dalla fotografia pubbli-cata nel 1929 da Richter (fig. 1) e,in ultimo, da quella scattata primadel restauro del 1992 (fìg. 6). Inte-grazioni del tutto arbitrarie hannointeressato le figure degli angeli involo, il viso della Madonna e dettaglidello sfondo, come i sostegni che siprolungano lateralmente dall 'altodella volta fino a terra per sostenereil peso del pergolato. Lo spessoreeccessivamente sovrabbondantedella materia pittorica nelle duesagome dei pappagalli, che appaio-no di una lucentezza ambiguarispetto al resto della raffigurazione,
325
6. Pittore lombardo-veneto, 1410-20circa, Madonna della Pergola, collezio-ne privata (stato del dipinto prima delrestauro, 1992).
induce a domandarsi se anche quinon giocò un ruolo fondamentale lasolerzia dei restauratori di inizioNovecento. A più riprese è statarifatta con Toro in conchiglia, adot-tando senza scrupoli lo stesso identi-co motivo floreale, la decora/ionesul manto di Maria e sulla tunicadella santa, la cui fisionomia purevariò marcatamente all'occorrenza.Nella foto risalente al 1929 (fig. 1)la figura è stata addirittura trasfor-mata in Santa Caterina, dipingendotra le sue mani un mezzo raggio diruota dentata, poi fat to sparire.Nella medesima fotografia è impres-sionante il cambiamento operatosulla figura del Bambino, copiatodalla Madonna dell'Umiltà di Gentileconservata al Museo Nazionale diSan Matteo a Pisa.
Nel contempo furono abbondan-temente rimaneggiate sia la scritta
di fonte evangelica sul rotolo delBattista, di autenticità molto dubbiae certo riadattata con palesi frain-tendimenti dal restauratore, sia lacelebre "firma" di Pisanello sul car-tiglio, previsto forse in origine peraccogliere un motto devozionale oqualche riferimento al committente(fig. 7). Quello che si può tranquil-lamente affermare è che sempre esolo la porzione centrale dellalunga iscrizione è decifrabile: leparole che in un primo tempo siriescono a leggere "[...] ctor pìsanus[...]" (interpretabili come "pictorpisanus" oppure come "victor pisa-nus")ffi, sono state corrette successi-vamente un po' alla meglio in"[antonjius pisanus" e, infine, inuno storicamente più verosimile"pisanus pi[nxit]". L'ultima formu-la è quella tuttora visibile sulla tavo-la (fig. 8), ma esigui cambiamenti
nel duftus e nella posizione delle let-tere rivelano che nel restauro piùrecente si è proceduto a saggiarequanto vi fosse eventualmente diantico nella scritta. In conclusione,l'ìncoerenza presentata fin dall'ini-zio dalla segnatura, sotto il profilopaleografico e linguistico, è tale daavvalorare l'idea che si tratti di unfalso appositamente confezionatoper esigenze mercantili e di collezio-nismo1".
Ma si tratta solo di un'iscrizionefalsificata oppure di un falso inte-grale":1 Non vi è dubbio che solo unacompiuta serie di indagini diagnosti-che offrirebbe le condizioni idealiper esprimersi con la serenità dovu-ta. Per quanto mi riguarda, sonoabbastanza convinta che la Madonnadella pergola sia un'opera della primametà del Quattrocento, benché lepesanti manomissioni e alterazionisubite durante l'ultimo secolo ren-dano davvero arduo allo stato attua-le percepire la qualità effettiva deldipinto e, di conseguenza, avventu-rarsi in rischiose proposte attributi-ve. Per il momento può essere suffi-ciente ribadire - alla luce anche deiriscontri emersi dalla vicenda critica- la sua contestualizzazione nell'orbi-ta della p i t tura tra Lombardia eVeneto nel primo quarto del Quat-trocento, tenendo conto dell'impor-tante presenza anche nella secondadelle due regioni di Michelino daBesozzo".
Merita innanzitutto attirare l'at-tenzione sulla originalità della com-posizione. L'insieme è stato bencongegnato dall'artista, puntandosu due mot ivi di forte appeal: laprofonda fuga prospettica del rosetoin secondo piano, che viene replica-ta ed enfatizzata nello scorcio dellapergola voltata. Perdute in massimaparte le fini ture pittoriche, l'effettodi ricchezza materica che doveva inorigine caratterizzare la tavoletta,
326
7. Firma apocrifa di Pisanello sul car-tiglio della Madonna della Pergolaistato dell'iscrizione nel 1917, nel1929 e nel 1992).
apparentandola alla "fulgida dina-stia di anconette" prodotte dallebotteghe lombardo-vene te in epocatardogotica : >-, r imane ancoraapprezzabile nella lavorazione pun-zonata e a rilievo delle aureole, diforma peraltro piuttosto inusuale41.L'idea stessa della figurazione unitaall'eleganza del disegno, che affioraancora nei particolari dove la stesu-ra originale è maggiormente inte-gra (come nell'effìgie del Battista),e alla raffinatezza descrittiva riserva-ta ad alcuni dettagli avranno sicura-mente accentuato un tempo il fasci-no dell'immagine.
C'è qualcosa nella figura aristo-cratica della Vergine, dal fisicoallungato, dal viso fanciullesco conl'alta fronte bombata, e nell 'insi-stenza decorativa dei risvolti delmanto di affine alla produzione gio-vanile di Stefano da Verona, senzaperò la predilezione per le curvelentissime e modulate che costitui-scono l'essenza del linguaggio pecu-liare del noto maestro (figg. 2, 9).Non sembra pertanto fuorviantepensare che la tavola già in collezio-ne Paolini sia nata negli stessi anni(1410-20 circa) che vedono Stefanoesprimersi in opere quali la Madon-na della quaglia del Museo di Castel-vecchio a Verona, spesso rapportata
alla nostra, e la Madonna col Bambinodella Galleria Colonna a Roma1"1.Non sposta nella sostanza il proble-ma della cronologia notare le tan-genze, nella figura di Maria, conalcune delle prime opere gentilianedi Zanino di Pietro, già rientrate neldibattito critico sulla tavoletta(Madonna col Bambino e Santi, NewYork, coli. Fioratti; Matrimonio misticodi Santa Caterina, Urbino, GalleriaNazionale delle Marche)'3. In terraveneta r i condur rebbe anche ilbrano della coppia di angeli, dovegli svolazzi dei panni accompagnatida una morbida linea di contornosono in linea con le ricerche con-dotte tra il pr imo e il secondodecennio del Quat t rocento daNicolo di Pietro"' o dal Maestrodegli affreschi della Cappella Ric-chieri nel Duomo di Pordenone;tr.
È invece probabi lmente allaMadonna del roseto di Michelino daBesozzo (Verona, Museo di Castel-vecchio), eseguita pare per la cittàdi Verona3*, che occorre guardareper rintracciare il precedente piùillustre di quella recinzione di rosein prospettiva innalzata oltre le figu-re (fìg. 5), anche se le capziose solu-zioni spaziali ideate dall'artista lom-bardo sono trasposte in formamolto semplificata1''. D'altra parte fu
327
forse in analogo ossequio alle speri-mentazioni di Michelino ed in uncontesto di riferimenti tutti lombar-di40 che anche Stefano da Veronadispiegò naturalistici fondali di rosedietro alle figure degli Evangelisti,nei perduti affreschi delle vele dellaCappella Rama in San Francesco aMantova"", prima che Pisanello dessevita nel 1426 alla illusionistica incor-niciatura di rose rampicanti finitaattorno alla Tomba Brmzoni, in SanFermo a Verona4-. Nel celebre dipin-to di Michelino compare anche ilmotivo del pergolato voltato, perchéassume questa forma il recinto fiori-to che delimita l'area del giardinosacro. Non si può dire se sia bastatoquesto spunto all'autore della tavolaqui in esame per arrivare a concepi-re la trovata, decisamente sorpren-dente, della volta a botte dominantesulla raffigurazione oppure se egliabbia avuto accesso ad altri modellialtrettanto autorevoli43. Il confrontopiù convincente è comunque quellogià individuato da Coletti con ilframmento in Santa Caterina a Tré-viso (fìg. 3), opera forse di poco pre-cedente ma approssimativamente
coeva, dove la struttura del pergola-to dipinto è arricchita con la tendadi vaio sovrastante che enfatizzaulteriormente la ricerca di profon-dità spaziale, ma dove l'effetto diinsieme doveva essere tangibilmentemeno prezioso, per quanto lo statoestremamente lacunoso dell'affre-sco conceda di valutare. Nel pergo-lato affrescato a Treviso (o in qual-che altra opera analoga oggi perdu-ta) si dovrà cercare la fonte di ispira-zione della soluzione compositivapart icolarmente singolare dellatavoletta qui discussa, dove la fre-schezza dell'invenzione è tale chesembra difficile attribuirla alla fanta-sia di un falsario moderno44.
L'equilibrio precario dell'immagi-ne del Battista, in bilico sul lembo delcartiglio posato a terra, può invecederivare dagli interventi dei restaura-tori che si sono ripetutamente eserci-tati sullo sfortunato dipinto. Di fronteall'estro che serpeggia nella rappre-sentazione, affiorando anche nel par-ticolare vivido delle foglie di vite libe-ramente distribuite sulle zone riserva-te alla lamina dorata, appaionocomunque alcuni cedimenti qualitati-
vi e inflessioni arcaizzanti, ad t•*•nella posa statica della santa. È •tagli come questi, awicìnabili a >zioni care al primo MichelinoBesozzo, come indica il confrontouna tavola recentemente ricondottiall'attività del maestro verso il 14-»1405 (figg. 10-1 l) r ' , che si misur^ .formazione solo in una certa misi.r.*aggiornata del nostro pittore. Un'ulte-riore modesta attenzione alla ricerca-rissima eleganza lineare così tipica •:•linguaggio di Michelino si scopremio avviso, nel tentativo di ingentilirela massa compatta del Battista, ritman-do dolcemente le cadenze del manto.ma soprattutto ponendo tra le suemani una minuta suppellettile, conun gesto che ricorda - ovviamente allalontana - brani delle miniature miche-liniane nel celeberrimo Libro d'Or*Bodmer (New York, Pierpont MorganLibrary, MS. 449, f. 6v, Adorazione deiMagi, f. 14v, San Bìagio, f. 73v, SanLuca)"'. Ancora un'indicazione utilequindi, almeno in linea di massima,per restringere al clima degli anni1410-20 i tempi spettanti alla notoriaquanto tuttora enigmatica Madonnadella pergola.
* Devo alla generosità del Prof. MiklósBoskovits la conoscenza dell'opera e l'occa-sione di affrontarne l'analisi diretta, confor-tata come sempre dalla sua consuetudine adialogare sui temi di studio. Solo la cortesiadegli attuali proprietari, cui va la mia grati-tudine, rende peraltro possibile pubblicarequeste brevi note. Per i problemi inerentialle iscrizioni presenti sul dipinto ho potutocontare sull'aiuto di Sandro Bertelli e diMarco Petoletti. Voglio infine ringraziareAndrea De Marchi, per avermi gentilmentemessa al corrente delle sue opinioni sullatavola, fornendomi anche copia delle foto-grafie a colori da lui possedute.
(1) G.M. RICHTER, Pisanello Studies-I, in"The Burlington Magazine", LV, 1929. pp.59-66, in pari. pp. 59-60, tav. I.
(2) II rimando biblico è a Le 1, 35 ("LoSpirito Santo scenderà su di te, su te sten-derà la sua ombra la potenza dell'Altissi-mo"): G.L. M Ù L L E R , Gottesmutter, inMarienlexikvn, a cura di R. BÀUMER-L.
SCHEFFCZYK, II, St. Ottilien 1989, pp. 684-92 (in pari. pp. 689-90); F. 2EIUXGER,Heiliger Geist. I. Exegese e K. PILTZ, HtdtigerGeist. III. Ihonogmphie, in Marienlexikon, III,1991, pp. 108,113,
(3) B.E. DALEY, The "Closed Gardesanathè "Sealed Fountain ": Song o/Songs 4:12 in thèLate Medieval ìconography of Mary, in Medie-val Gardens [Dumbarton Oaks Colloquiimion thè History of Landscape Architecture,IX], a cura di E. BLAIR MacDOUGALL,Washington 1986, pp. 253-78; M. AZZIVISENTIN'I, Dall'hortus conclusili al giardinodi villa aperto sul paesaggio: riflessioni in margi-ne ad alcuni dipinti e disegni di area veneta traQuattro e Cinquecento, in "Venezia Cinque-cento", XI, 2001, fase. 22, pp. 155-66.
(4) E.M. VETTER, Maria im Rosenhag,Dusseldorf 1956, pp. 17-21 (in part. p. 19);R. SCHUMACHER-WOLFGARTEN, Rose,in Lexikon der christlichen Ikonographie, III,Rorne-Freiburg-Basel-Wien 1971, p. 567; M.LEVI D'ANCONA, The Garden of thè Renais-sancf. Botanical Symbolism in Italia» Paintìng,
Firenze 1977, pp. 332-34 n. 4, 349-50; G.SCHILLER, Ikonographie der christlichenKunst, IV, 2, Gùtersloh 1980, pp. 206-10.
(5) Levi D'Ancona, 1977, pp. 393-94 n. 5.
(6) Sulla simbologia del pappagallo, dicui le fonti lodano l'abilità nel pronunciarela parola «Ave»: M. LEVI D'ANCONA, Lozoo del RmasàmtntQ. Il significato degli animalinella pittura italiana dal XIV al XVI secolo,Lucca2001,pp. 170-71.
(7) La presenza del presunto cartellinoinventariale non costituisce di per sé provadell'autenticità del dipinto, dato che l'usodi applicare tali etichette era espedientecorrente tra i falsificatori attivi tra Otto eNovecento, allo scopo di simulare la bontàdella provenienza delle opere [se ne vedaun significativo esempio nella produzionedi Icilio Federico Joni: G. MAZZONI, inFalsi d'autore: Irìlio Federico Joni e la cultura delfalso tra Otto e Novecento, catalogo dellamostra, (Siena, Complesso Museale di SantaMaria della Scala, 18 giugno-3 ottobre 2004),
8, Firma apocrifa di Pisanello sul car-tiglio della Madonna della Pergolastato attuale).
*. Pittore lombardo-veneto del 1410-20orca. Madonna della Pergola, collezioneprivala (stato attuale, particolare).
a cura di G. MAZZONI, Siena 2004, p. 174cai. 48].
(8) S. OSANO, Studi Pisanelliani riconsi-derati (I), in "Bijutsushi-Ronso" (Studies inArt History), 1985, pp. 59-66, 73-4. Con lacalendula è generalmente identificato ilfiore inserito nel festone decorativo checorre alla sommità della parete orientale,nella sala affrescata da Pisanello in PalazzoDucale a Mantova (T. FRANCO, in Pisanel-lo. Una poetica dell'inatteso, a cura di L.PUPPI, Cinisello Balsamo, Milano, 1996, p.61). Volendo, si possono riscontrare analo-gie anche con l'impresa gonzaghesca dellamargherita, u t i l izzata da GianfrancescoGonzaga (1407-1432) e da molte donnedella famiglia: M. PALVARIN1, A proposito dicalendule, anzi di margherite. I fregi floreali inantichi affreschi mantovani, in "Quadrantepadano", IV, 1983, num. 2. pp. 35-6; G.MALACARNE, / Gonzaga di Mantova, I, /Gonzaga Capitani. Ascesa di una dinastia daLuigi a Gianfrancesco (1328-1432), Modena2004, p. 193.
(9) Nel corso della sua carriera mercan-tile, che sembra essere cessata prima del1930 [R. BRENZONI, Pisanello, pittore (1395circa - ottobre 1455), Firenze 1952, p. 133],Paolini aprì una sede anche a Montepulcia-no ed ebbe modo di conoscere GiuseppeMazzoni, titolare della nota casa d'arte diSiena (G. MAZZONI, Quadri antichi del
Novecento, Vicenza 2001, p. 311), Dalle sche-de del catalogo della vendita organizzata aNew York nel 1924 (The Collection of ProfessarPaolo Paolini-Rome-Italy. Distinguished Pain-tings and Sculptures by Celebrateti ItalianMasters X-XVI Century, New York, AmericanArt Galleries, 10-1 Uh December 1924) siintuiscono i rapporti instaurati dall'antiqua-rio romano con Bernard Berenson, Giaco-mo De Nicola, Frederick Mason Perkins eRaimond Van Marle. Con Berenson, in par-ticolare, Paolini fu in contatto epistolaredal 1910 al 1937 {cfr. The Berenson Archive.An Inventory of Correspondence on thè Cente-nary of thè Birth of Bernard Berenson, 1865-1959, a tura di N. MARIANO, Florence1965, p. 73), periodo durame il quale eglifornì allo studioso numerose fotografie didipinti passati fra le sue mani. Sull'antiqua-rio, cfr. poi M.S. FRINTA, Drawing thè nel clo-ser; thè case of Ilicio federico foni, painter ofantiaue pictures, in "Pantheon", XL, 1982, p.222; M. TAMASSIA, Collezioni d'arte tra Otto-cento e Novecento. Jacquier fotografi a Firenze1870-1935, Napoli 1995, pp. 107-9.
(10) Così sembra dall'appunto di Anto-nio Morassi, sul verso della fotografia rima-sta nel suo archivio (Università Ca' Foscaridi Venezia, Dipartimento di Storia e Criticadelle Arti G. Mazzariol, un i t à n. 149, Inv.20096; la notizia mi è stata cortesementecomunicata dall'ing. Pier Maria Fossati, checolgo l'occasione per ringraziare). Riguar-
329
do alla collezione Heimann: G. MARIA-CHER, // Museo Correr di Venezia. Dipinti dalXIV al XVI secolo, Venezia 1957, p. 12; E.E.GARDNER, A Bibhogiapincal Repertory of Ita-lia» Private Collections, II, Vicenda 20(12, p.215.
( 11 ) R. VAN MARLE, The Development ofItalian Schooh of Paintings, Vili, The H agii e1927, p. 488.
(12) Copia della fotografia pubblicalanell'articolo di Richter era posseduta daAntonio Morassi (cfr. qui n. 10).
(13) In riferimento a Stefano da Verona,Richter (1929, p. 59 n. 3) rammenta laMadonna dell'umiltà affrescata nella sacrestiadella parrocchiale di Illasi (Verona) e quel-la su tavola del Worcester Museum of Art( M a s s . ) , che erano riferite al pittore.Entrambe le redazioni sono di assegnazionedubbia: la prima è stata accostata a Giovan-ni Badile (M. BOSKOV1TS, in Arte in Lom-bardia tra Gotico e Rinascimento, catalogodella mostra, Milano 1988, p. 268; C.VOLPE, Da Altichiero a Pi sanello-recensione, in"Arte Antica e Moderna", I, 1958, p. 412),ma da altri continua ad essere ritenuta delseguito di Stefano [E. MOEXCH, Stefano daVerona: la mori critiaue d'un peintre, in Hom-mage a Michel Ladotte. Etudes sur la pemturedu Moyen Age et de la Renaissance, a cura di P.Rosenberg et al., Paris 1994, pp. 81, 83; A.MAIAVOLTA, in Pisanello. I luoghi del goticointernazionale nel Veneto, catalogo della mostra(Verona, Museo di Castelvecchio, 8 settem-
bre-8 dicembre 1996), a cura di F.M. ALI-BERTI GAUDIOSO, Milano 1996, p. 129; E.KARET, The Drawings oj Stefano da Veronaand his Circi? and thè Orìgini of Collecting inItaly: A Catalogue Raisonné, Philadelphia-Verona 2003, p. 38 fig. 30, come "Maestrodi Illasi"]. La tavola di Worcester, secondoalcuni esperti, è forse più in linea con imodi di Bonifacio Bembo (Volpe, 1958, p.411; C. DA\TES, in European Paintings in thèCollf.ction oflhe Worcester Art Museum, Worce-ster, Mass., 1974, I, pp. 475-78).
(14) Pensando nello specìfico allaMadonna col Bambino, i Santi Francesco, Giro-lama e un santo guerriero (New York, coli.Fìoratti), eseguita in realtà da Zanino diPietro [su cui cfr. M. BOSKOVITS, in TheMartello Collection. Paintings, Drawings andMiniatures from thè XlVth to thè XVIIIth Centu-ria, a cura di M. BOSKOVITS, Florence1985, pp. 148-49 cai. 44; C. GUARNIERI,in (dentile da Fabriano e l'Altro Rinascimento,catalogo della mostra (Fabriano, Spedaledi Santa Maria del Buon Gesù, 21 Aprile-23luglio 2006), a cura di L. LAUREATI e L.MOGHI ONORI, Milano 2006, p. 166 Gat.III. 13].
(15) L'assegnazione della Madonna dellaquaglia a Pisanello è stata a lungo accredita-ta [cfr. E. MOKN'CH, in Pisanello: le peintreaux sept vertus, catalogo della mostra,(Paris, Musée National du Louvre, 1996), acura di D. CORDELLIER e P. MARINI,Paris 1996, pp. 78-80, cai. 35; M.MOLTENI, in Pisanello, Una poetica, 1996,pp. 45-8 cat. 1]. Sulla tavola, vedi oltre n.34. Oltre a discutere la Madonna della col-lezione Paolini, nello stesso contributo arti-colato in due parti (cfr. G.M. RICHTER,Pisanello Studies-II, in "The Burl ingtonMagatine", LV, 1929, pp. 128-39), GeorgMartin Richter tenta di estendere la pater-nità di Pisanello ad altre due tavole, ma lesue proposte non hanno avuto seguito. Idue dipinti sono il San Cimiamo nel deserto(già Teddington, Middlesex, H.M. ClarkCollection), da ultimo attribuito a France-sco dei Franceschi (D. GORDON, NationalGallerà Catalogues. The Fifteenth Century Ita-lian Paintings, I, London 2003, pp. 54, 55fìg. 6; l'attribuzione era già avanzata daMiklós Boskovits, secondo l'appunto segna-to sulla carpetta della fotografia consultabi-le nella fototeca del Kunsthistorisches Instì-tut di Firenze) oppure alla cerchia di Anto-nio Vivarini (B. DEGENHART-A. SCH-MITT, Corpus der italienischen Zeichnungen,1300-1450, voi. III. Verona-fanello un seineWerkstatt, I, Berlin 2004, p. 171, Abb. 160;per una bibl. esauriente; T. FRANCO, inPisanello. Una poetica, 1996, p. 117 cat. 10),e il Ratto di Dejanira (già Londra, Mr.Agnew), variamente avvicinato a JacopoBellini e a Pesellino (Franco, 1996, p. 131cat. 24).
(16) A.-H. MARTINIE, Pisanello, Paris1930, pp. 11-2; G.F. HILL, Pisanello, Antoniodi Pucdo Pisano, in U. THIEME-F. BEGKER,Allgetneines Lexikon der Bildenden Kunstler,XXVII, Leipzig 1933, p. 93; J. BABELON,Pisanello, Paris 1931, p. 29. Il nostro quadroè invece trascurato da Adolfo Venturi (A.VENTURI, Pisanello, Roma 1939) e da Ber-nard Degenhart (B. DEGENHART, AntonioPisanello, Wien 1940).
10. Pittore Ioni bardo- vene t o20 circa, Madonna dettazìone privata (stato attuale,re).
(17) L. COLETTI, Pittura venetaal Quattrocento-!!, m "Arte Veneta". I. '. — ~p. 259efig. 213.
(18) La tavola del Museo romano è >:^ja lungo dibattuta tra il giovane Pisane!.Stefano da Verona. Per il primo propc:. •-ancora oggi, con un margine di dubb:Esther Moench (E. MOENCH, Pisantlìo. ,peintre, 1996, pp. 73-8 cat. 34, con bibl. con*pietà); per Stefano da Verona, M i k .Boskovits (M. BOSKOVITS, Pisanello e gbaltri. Un bilancio delle ricerche sulla pillili'. ~Lombardia e Veneto all'inizio del Quattrocem-:in "Arte Cristiana", LXXXVII, 1999. p.336). Tiziana Franco (cfr. 1996, pp. 121-2?cat. 18, che riporta il parere di Andrea IVMarchi) interpreta il famoso dipinto in rap-porto alla bottega di Giovanni Badile, venti-lando un possibile coinvolgimento di Fran-cesco Badile nell'esecuzione.
(19) 1,'affresco in Santa Caterina a Tré-viso, che doveva raffigurare una Sacra con-versazione, è ampiamente frammentario: siconservano solo il dettaglio della pergola divite, posta al riparo di una tenda di vaio, ela parziale figura del donatore all'estremadestra. Su l l ' appar tenenza del ciclo almomento della formazione di Pisanello, altempo della sua frequentazione della botte-ga di Gentile da Fabriano (1415-20 ca.), sisono da ul t imo espressi in modo più omeno deciso: M. BOSKOVITS, Arte lombar-da del primo Quattrocento: un riesame, in Artein Lombardia, 1988, pp. 16-7, 46 n. 39; A. DEMARCHI, Gentile da Fabriano. Un viaggionella pittura italiana alla fine del gotico, Mila-no 1992, pp. 60-61, 92 n. 86; M. BOSKO-VITS, Le milieu de jeune Pisanello: quelques pro-blèmes d'attri/nitiim, in Pisanello. Actes du collo-que organisée au Museé du Louvre, 26-28 juin1996, a cura di D. CORDELLIER e B. PY,Paris 1998, pp. 86, 95 nn. 4-5; Boskovits,1999, pp. 331-32, 338 nn. 3-4; G. FOSSA-LUZZA, Episodi del tardogotico, in Gli affreschinelle chiese della Marra Trevigiana dal Duecentoal Quattrocento, 1.2, Tardogotiro e suepersistenze, Cornuda (Treviso), 2003, pp. 25-6; A. DE MARCHI, Gentile e la, sua bottega, inGentile da Fabriano. Studi e ricerche, a cura diA. DE MARCHI, L. LAUREATI e L. MO-CHI ONORI. Milano 2006, pp. 31-2 e 51 n.102. Come evidenzia lo studioso, gli epitaffidatati 1408, 1409 e 1411 presenti nel chio-stro, sono utili a puntualizzare il momentodella campagna decorativa. Maggiore caute-la riguardo all'attribuzione degli affreschi aPisanello dimostrano Enrica Cozzi (E.
330
COZZI, Treviso, in La Pittura nel Veneto. IlQuattrocento, a cura di M. LUCCO Milano,1989, pp. 102-6) e Tiziana Franco ( 1996, pp.125-28 cat. 20). Al problema dell'attività tre-vigiana del giovanissimo Pisanello, sempreagli inizi del secondo decennio del Quattro-cento, si collega anche l 'affresco dellaMadonna col Bambino (Museo Civico), prove-niente dalla locale Chiesa di S. Margherita{cfr. ora A. DE PICCOLI, in Gentile da Fabia-no, 2006, pp. 158-59 Cat. 111.10; A. DE PIC-COLI, Fragaumta pietà in Santa Margherita aTreviso: dagli stacchi dì Luigi Bailo alla ricompo-sizione dei contesti originali, in "Bollettinod'Arte", Ser. VI, XCI, 2006, Nri. 135-36, pp.135, 150-59, 170 n. 61. 185 cat. 63-4).
(20) L. COLETTI, Pisanello, Milano1953, p. 30 Cat. 3. Per il modo in cui lefalde del manto della Vergine sono risvolta-te è citata sempre la Madonna col Bambino inIrono del Museo di Palazzo Venezia a Roma;per i due angeli, la Madonna della quaglia diVerona. Entrambi i dipinti sono assegnati aPisanello da Coletti, che insiste sulle asso-nanze con la gentiliana Madonna dell'umiltàdì Pisa e cita infine lo Sposalizio Mistico diSanta Caterina (Urbino, Galleria Nazionaledelle Marche), attribuito in passato a Gemi-le, mentre spetta a Zanino di Pietro [A.VASTANO, in Fioritura tardogotica nelle Mar-che, catalogo della mostra (Urbino, PalazzoDucale, 25 luglio-25 ottobre 1998), a curadi P. DAL POGGETTO, Milano 1998, p.210 cat. 73].
(21) Brenzonì, 1952, pp. 117, 131-33 tav.X. Giudico indicativo di un cambiamentodi opinione il fatto che Brenzoni non inclu-desse la Madonna ex-Paolini nel successivovolume dedicato a Pisanello (R. BRENZO-NI, L'arte pittorica di Pisanello nelle sue opereautentichi, Firenze 1955).
(22) B. DEGENHART, Di una pubblica-zione su Pisanello e di altri fatti (I), in "ArteVeneta", VII, 1953, p. 183 n. 1.
(23) B. BERENSON, Italian Piclures oftheRenaissance. Central Italian and North ItaliotiSchools, London 1968,1, p. 349. II, tav. 543.
(24) E. SINDONA, Pisanello, Milano1961, p. 122; R. CHIARELLI, L'opera comple-ta del Pisanelki, presentazione a cura di G.A.Dell'Acqua, Milano 1972, pp. 85-6 cat. 2("benché le possibilità di giudizio restinolimitate [...] non appare nel dipinto alcun-ché al dì fuori di un generico riferimento aGentile da Fabriano"); R. CHIARELLI,Antonio Pisano detto il Pisanello, in Maestridella pittura veronese, a cura di P. BRUGNO-LI, Verona 1974, p. 72. Come "preleso Pisa-nello" Antonio Morassi archiviava la fotodel dipinto (cfr. qui n. 10).
(25) A. CONTI, Una miniatura e altre con-siderazioni sul Pisanello, in Itinerarì. Contributialla storia dell'arte in memoria di M.L. Ferrari,Firenze, I, 1979, p. 75 n. 17; Osano, 1985;Cozzi, 1989, pp. 104-5; Franco, 1996, pp.125, 131 cat. 23. Una semplice menzionedella tavola è nel catalogo già citato Pisanel-lo. I luoghi del gotico internazionale, 1996, p.236.
(26) All'inizio del Novecento (figg. 1, 4)la tavola era provvista di una cornice lignea
moderna, fatta a imitazione degli altarolidi devozione domestica rinascimentali,secondo il gusto col le / . ionis t ico delmomento.
(27) Osano, 1985. Lo studioso è tornatoad occuparsi della storia conservativa dellaMadonna della pergola con la comunicazione"Abuso del restauro o falsificazione? Persi-stenza dell 'intervento antiquariale", nel-l 'ambito del simposio "Le nuove tecnolo-gie sulle vie della cultura" (Tokyo, IstitutoItaliano di Cultura, 2-3 dicembre 2005).
(28) Lo sì ricava dall'appunto sul versodella fotografia.
(29) Cfr. anche Osano, 1985. Ne! primocaso saremmo di fronte a un ' imitazionepalese della dicitura adottata da Pisanelloper autografare alcune sue opere: "OpusPisani Pìctoris"; "Pisanus pictor"; "Pisanuspinsit" o "pi(nxit)". Nel secondo il nome diVittore coincide con quello tradizional-mente attribuito dalla critica al pittore,prima che Giuseppe Bìadego giungesse aprecisarne l'identità anagrafka in Antonio(G. BIADEGO, Pisanus Pictor, in "Atti delReale Istituto Veneto di Scienze, Lettere edArti", LXVII, 1907-08, P. II, pp. 837-51; cfr.Van Marle, 1927, p. 56; Martinie, 1930, pp.6-12; Venturi, 1939, p. 1; Chiarelli, 1972, p.85).
(30) Sul fenomeno delle firme apocrife,apposte sui dipinti per scopi non unica-mente commerciali, ma anche campanili-stici: O. KURZ, Fttlìì e falsati, edizione italia-na a cura di L. Collobi Ragghianti-C.L.Ragghianti, Venezia 1961, pp. 30-3; G. PRE-VITALI, La fortuna dei primitivi. Dal Vasariaineoclassici, Torino 1964, pp. 156-57 n. 4,161-63, 242-43; Conti, 1979, p. 74; M. FER-RETTI, Falii e tradizione artistica, in Storiadell'Arte Italiana, Parte III, Voi. Ili, a cura diE ZERI, Torino, 1981, pp. 154-55, 165, 167,170 e n. 21; A.G. DE MARCHI, Falsi Primiti-vi. Prospettive critiche e metodi di esecuzione,Torino-Londra-Venezia 2001, pp. 105-7.Particolarmente calzante al caso nostro èricordare la Madonna con il Bambino e Santidegli Staatliche Museen di Berlino (n.1471), sulla quale già nel 1718 era statodipinto un cartellino con la firma spuria di"Vittore" Pisanello (Franco, 1996, p. 110cat. 3).
(31) Per l'attività veneta di Michelino,posta in genere tra il 1404 e il 1417 circa,ma da certuni anche molto anticipata neitempi: G. ALGERI, Per {'attività di MicheUnnda Besozzo in Veneto, in "Arte Cristiana",LXXV, 1987, pp. 17-32; S. OSANO, Micheli-nò da Besozzo in San Vincenzo di Tiene, in"Paragone", XL, 1989, n. 467, pp. 63-67;M.E. AVAGNINA e C. RIGONI, in Pisanello.I luoghi del gotico internazionali-, 1996, pp.151-153, 167-170; Boskovits, 1999, pp. 334,341-42 nn. 21-22; M. BOLLATI, in Gentileda Fabriano, 2006, p. 172 cai. III. 16; DeMarchi, 2006, pp. 33, 51 n. 115.
(32) F. TODINI, Dipinti su tavola delprimo Quattrocento in Lombardia, in II Politticodegli Zavattari in Costei Sant'Angelo. Contribu-ti pir la pittura tardogotica lombarda, a cura diA. GHIDOLI TOMEI, Firenze 1984, pp. 53-56, 58 (da cui la citazione).
(33) Mi sembra inverosimile tuttavia chefossero inventate di sana pianta, ma forsenon sono esenti anch'esse da integrazionimoderne, poiché la loro tipologia non sem-bra trovare riscontri nella produzione sutavola del primo Quattrocento in Veneto eLombardia, come mi fa presente AndreaDe Marchi.
(34) Cfr. Boskovits, 1998, pp. 92-3;Boskovits, 1999, pp. 336-37. L'attribuzione aStefano da Verona della Madonna della qua-glia non è tuttavia pacifica e il tradizionalerifer imento a Pisanello è comparso inrecenti contributi (cfr. qui, n. 15). Sullaricostruzione della personalità artistica diStefano, che "rimane [...] il più grosso pro-blema aperto nello studio del gotico inter-nazionale nel Veneto" (E. CASTELNUOVO,L'autunno del medioevo nel Veneto, in Pisanello.I luoghi del gotico internazionale, 1996, p. 32),è importante ricordare gli studi di: Moench,1994, pp. 78-97; E. CASTELNUOVO, Vero-na: gli anni venti del Quattrocento, in Pisanello,catalogo della mostra (Verona, Museo diCastelvecchio, 8 settembre-8 dicembre1996), a cura di P. MARINI, Milano 1996,pp. 59-71; E. KARET, The Pavian Orìgins ofStefano da Verona, in "Arte Lombarda", C,1992, Nr. 1, pp. 8-19; E. KARET, Stefano daVerona's Stay in Manina: A Rtexamination, in"Arte lombarda", CXXXVI, 2002, Nr. 3, pp.10-20; Karet, 2003.
(35) Sulle opere di Zanino accostate allaMadonna delia pergola, vedi qui nn. 14, 20.Per un recente profilo biografico dell'arti-sta: M. MINARDI. Zanino di Pietro, in Gentileda Fabriano. Studi e ricerche, 2006, p. 181.
(36) Penso all'angelo nella Tentazione diSan Kenedetto (Milano, Museo Poldi Pezzolì,Inv. 1573), del 1415-20 circa, appartenentea un complesso più vasto. Sulla propostache l'abbia realizzato Niccolo di Pietro sudisegno di Gentile da Fabriano, per unadestinazione mantovana [De Marchi, 1992,pp. 101-5 e note relative; A. DE MARCHI,in II potere, le arti, la guerra: lo splendore deiMalatesta, catalogo della mostra (Rimini ,Caste 1 Sìsmondo, 3 marzo-15 giugno 2001),a cura di A. DONATI et al., Milano 2001, p.164 cat. 47], dissente Mìklós Boskovits(1999, pp. 332, 340 nn. 8-9), che esclude ilcoinvolgimento di Gentile nell'ideazionedelle scene. Per le diverse ipotesi di prove-nienza, si veda il riepilogo di A. DI LOREN-ZO, in Gentile da Fabriano, 2006, pp. 150-54cat. III.8)
(37) De Marchi, 2006, pp. 32-3.
(38) Per l'attribuzione a Michelino e unadatazione al 1410-15: Boskovits, 1988, pp. 11-12; Boskovits, 1999, pp. 334, 342 n. 24.
(39) La moderna sottolineatura dellaspazialità dell'hurtiiì ronc.lusus nella tavola diMichelino è stata letta da De Marchi (1992,p. 40 n. 28; De Marchi, 2006, pp. 51-2 n.115) in dipendenza dalla finta cornicedipinta da Pisanello nel Cenotafio, in SanFermo a Verona, ritardandone perciò l'ese-cuzione a dopo il 1426.
(40) A partire dalle due Damigelle affre-scate contro un fondale di rose distribuitesu un ideale retìcolo quadrato, nel Castello
331
11. Michelino da Besozzo (attr. a),Crocifissione e Madonna col Bambino esanti, collezione privata.
Visconteo di Pavia, alla fine del Trecento
(Boskovits, 1988, pp. 10, 45. n. 7; De Mar-chi, 1992, pp. 15-6, fig. 6).
(41) Gli affreschi, dìstrutti durante laseconda guerra mondiale, sono descritti daVasari: "i quattro Evangelisti a sedere; e die-tro alle spalle loro, per campo, fece alcunespalliere di rosai, con un intessuto di cannea mandorle, e variati alberi sopra, et altreverdure piene d'uccelli". Generalmentedatati al terzo decennio del Quattrocento(C. PIRINA. Pittura, in Maritava- Ij> Arti, acura di E. ARSlAN, II, Mantova 1961, pp.243-47; De Marchi , 1992, p. 107 n. 10;
Karet, 2002, pp. 12-16; Karet, 2003, p. 29),
sono ora ricondotti a] rnufflentU tufi pIHc1-de l'arrivo di Stefano a Verona, nel 1424-25(Moench, 1989, pp. 158-59; Moench, 1994,pp. 79, 81; Boskovits, 1999, p. 345 n. 32).
(42) Dal capolavoro pisanelliano dipen-deva sicuramente il "grande rosaio di colo-re verde azzurro", ora scomparso, ai lati delquale erano gli Angeli con cartigli, affrescatida Stefano in San Fermo Maggiore a Vero-na (F. PIETROPOLI, in Pisandlo. i luoghi delgotico internazionale, pp. 46-7).
(43) Non mi pare possa reggere il con-
fronto la modestissima raffigurazione delpergolato sullo sfondo di una delle scenedel ciclo di affreschi (post 1450), del cosid-detto Casino di caccia di Palazzo Borromeo aOreno (Vimercate, Milano), ricordato daOsano (1985; l'illustrazione in F. MAZZINI,Affreschi lombardi del Quattrocento, Milano1965, tav. 61).
(44) Merita ricordare che gli affreschi diTreviso, probabilmente già scialbati allafine del secolo XVI, furono riscoperti solonel 1944: G. MAZZOTTI, Una scoperta: gliaffreschi della Chiesa di Santa Caterina e dellaCappella degli Innocenti a Treviso, Treviso1947; M. BOTTER, Sante Caterina di Treviso,chiesa e convento dei Servi (1346-1772), in"Studi Storici del l 'Ordine dei Servi diMaria", X, 1960, pp. 177-206.
(45) Boskovits, 1999, pp. 334, 342 un.23, 25; ma anche D. PARENTI, in GALE-RIE ADRIANO RIBOLZI, Peintwes Italien-nes du XIV' au XVIH' siede, a cura di C.BEDDIXGTON, Monte-Carlo 1998, pp. 8-9,50-55; MINARDI, Michelino da tìesozzo, inGentile da Fabriano, Studi e ricerche, 2006, p.176. Per altri aggiornamenti sul percorsodi Michelino: L. CASTELFRANCHI VE-GAS, La formazione, e, gli esordi di Michelino daBesozzo miniatore, in "Prospettiva", 1996,num. 83-84, pp. 116-27; G. ALGERI, Un"Boccaccio" pavese del 1401 e gualche nota perMichelino da Besozzo, in "Arte Lombarda",1996, Nr. 116, pp. 42-50; M. BOSKOVTTS,Un epitaffio figurato per Federico Zeri, in"Gaiette des Beaux-Arts", CXXXV, 2000,pp. 77-82; F. LOLLINI, Michelino da Besozzo,in Dizionario Biografico dei miniatori italiani:
secoli IIXVL a c-iira rii M. BOLLATI, Mila-no 2004, pp. 764-66.
(46) L. CASTELFRANCHI VEGAS, //Libro d'Ore Budmer di Michelino da Besozzo e irapporti tra miniatura francese e miniatura lom-barda agli inizi del Quattrocento, in Études d'arifrancai^ offertes a Charles Sterling, a cura di A.CHÀTELET e N. REYNAUD, Paris 1975,pp. 91-103, con precoce datazione del codi-ce (1405 circa), ritardata alla metà delsecondo decennio del Quattrocento daBoskovits (1999, p. 342 n. 25; e Bollati.2006, p. 172; Minardi, 2006, p. 176).
332





















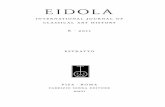


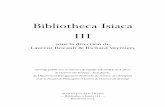








![MA [History] 321 23 - History of Europe 1789 to 1945 AD](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632806f4cedd78c2b50dde4b/ma-history-321-23-history-of-europe-1789-to-1945-ad.jpg)


