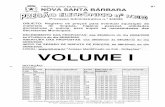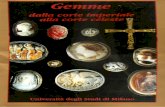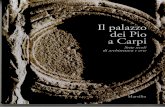Giulio Ciampoltrini, Paesaggi e insediamenti nel territorio di Santa Croce sull'Arno. Dagli Etruschi...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Giulio Ciampoltrini, Paesaggi e insediamenti nel territorio di Santa Croce sull'Arno. Dagli Etruschi...
La terra fra i due fiumi: paesaggi d’età etrusca e romana nel territorio di Santa Croce sull’ArnoGiulio Ciampoltrini
Inter Arnum et Arme: la definizione data nei documenti altomedievali di Lucca alla piccola ‘Mesopotamia’ valdar-nese, compresa tra gli attuali corsi dell’Arno e dell’Uscia-na, che va dal territorio oggi di Fucecchio fino alla lingua di terra formata ai piedi di Montecalvoli dalla confluenza dei due fiumi, ne esalta il carattere sostanzialmente uni-tario – oggi perduto nella divisione tra quattro comuni e due province – generato da una millenaria storia comune, che trenta anni di ricerche e recuperi permettono di riper-correre almeno dall’età etrusca.
Sono proprio i fiumi l’elemento portante del sistema di insediamento etrusco nelle pianure di quel tratto di Valdarno Inferiore che si è proposto di definire ‘La Terra dei Quattro Fiumi’1, generate e percorse dall’Arno, con il suo corso meandriforme che le immagini aerofotografiche sapientemente trattate da Marcello Cosci hanno permes-so di recuperare, in puntuale aderenza ai dati storici2; dall’Usciana, erede – canalizzato nel Cinquecento – del lento e meandriforme corso del fiume che raccoglie le acque della Valdinievole, il cui splendido nome etrusco, conservato fino al X secolo, Arme, ne sottolinea il ruolo3; dal ramo di sinistra dell’Auser, oggi perduto nei canali emissari della Bonifica del Bientina; dall’Era, potente via di terra e d’acqua da Volterra al settentrione.
Arno e Arme sono già nel VI secolo a.C. i catalizzatori di un sistema di insediamenti capace di coniugare lo sfrut-tamento delle risorse agricole del territorio e l’assistenza ai traffici che si intrecciano fra Etruria nord-occidentale tirrenica e Etruria padana.
I piccoli insediamenti che l’indagine di superficie e l’archeologia di emergenza hanno fatto individuare lungo l’Usciana e lo scavo di Sant’Ippolito di Anniano ha rivelato sull’Arno trovano ragion d’essere – come nelle altre contrade della ‘Terra dei Quattro Fiumi’ – sia nelle occasioni agricole dei dossi fluviali, che nei commerci transappenninici indiziati dai lingotti di aes signatum con una variante del ‘ramo secco’ ritrovati a Tricolle di Ponte a Cappiano ai primi del Novecento4, oggi al Museo Archeologco Nazionale di Firenze, e in maniera ancor più risolutiva dalle cinquecento libbre di «pani di metallo … rame con qualche apparenza d’oro» emersi nell’apertura dell’Antifosso di Usciana, nel 1752, nella pianura di Castel-franco, in Arsiccioli, sull’antico dosso dell’Usciana, se in
questi, come tutto lascia credere, si devono riconoscere lingotti del ‘rame ferroso’ distribuiti nel corso del V secolo a.C. di qua e di là degli Appennini5. Si è argomentato, in effetti, che l’Arme-Usciana svolgesse un ruolo non secon-dario nella rete itineraria che da Pisa e dall’Arno poteva raggiungere il distretto dell’Etruria padana che abbraccia Marzabotto e Bologna, per la Valdinievole (dove i relitti della frequentazione etrusca d’età arcaica e classica si infittiscono progressivamente)6 e il crinale appenninico, sino alla valle del Reno.
Il complesso di ceramiche restituite da un contesto che fu almeno in parte possibile esplorare nella sezione esposta dalle opere di bonifica in località Nacqueto di Castelfranco di Sotto, nel 1999, in coerenza con i mate-riali sporadici forniti da scavi in profondità nei territori di Castelfranco (Iserone 1984, Ascialla 2003, Comana 1984) e Santa Croce sull’Arno (Antifosso 1984), di norma recu-perati in giacitura secondaria, dà un’immagine suggestiva di questa rete di abitati, pienamente inseriti nella cultura che connota il Valdarno Inferiore del pieno VI e poi del V secolo a.C., in cui il centro urbano di riferimento è, allo stato attuale delle conoscenze, Pisa7.
Sono ancora i fiumi a svolgere un ruolo essenziale nel rinnovato sistema di insediamenti d’età ellenistica, ricom-posto dallo scorcio finale del IV secolo a.C. dopo la crisi dell’avanzato V secolo a.C., verosimilmente scatenata da avverse circostanze ambientali.
In un paesaggio e in uno scenario ‘politico’ profonda-mente mutati, per l’arrivo fino al piede dell’Appennino di genti liguri, sono ora gli abitati d’altura, tutelati da opere di fortificazione o dalla natura del terreno, a fungere da punti di riferimento anche per la più sottile rete di insediamenti che si dispongono lungo i due fiumi. Monte Castellare di San Giovanni alla Vena, posto a dominare il crocevia della ‘Terra dei Quattro Fiumi’, protetto dai dirupi naturali e dal terrapieno tuttora percepibile nella fotografia aerea e nell’indagine al suolo8, e Casa al Vento di Pieve a Ripoli, strategica posizione di controllo sull’Arno nell’incrocio con la via che porta alla Valdinievole dalla Valdelsa9, chiudono una sequenza di abitati ‘minori’ d’altura, come quelli colti dalla paziente ricerca di superficie di Giuliano Cappelli a Santa Maria Maddalena e alla Castellina, nei pressi di Ponte a Cappiano, sull’orlo delle Cerbaie che
18 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
domina il corso dell’Arme-Usciana10. Come lungo l’Auser, questi sono integrati da abitati dislocati lungo il fiume o nella pianura, quasi che le occasioni itinerarie che gene-rano anche luoghi di culto, come quello di Castelmartini in Valdinievole, in cui un devoto consacrò il bronzetto di Ercole promachos ritrovato nel 188711, rendessero accet-tabile il rischio di vivere in insediamenti ‘aperti’; da uno di questi provengono verosimilmente le ceramiche del III secolo a.C. (ceramica fine da mensa a vernice nera; pro-duzioni grigie ‘nella tradizione del bucchero’; impasti da cucina; frammenti di anfore greco-italiche, uno dei quali con contrassegno cruciforme, forse mercantile) ritrovati nel 1980 in terra di risulta da escavazioni in profondità nel territorio di Santa Croce, nell’area della Mensa Sociale di via San Tommaso.
I dati dello scavo del sito di Ponte Gini, in effetti, hanno rivelato che per gran parte del III secolo a.C. i sistemi di insediamento etrusco del Valdarno, pertinente
al distretto urbano (chora) di Pisa, ormai fedele socia di Roma, e quello ligure apuano dell’Appennino lucchese e pistoiese convissero nei proficui rapporti di scambio che a Casa al Vento sono fisicamente attestati da una fibula e da frammenti di una peculiare classe ceramica ‘apuane’12. Questa rete di contatti si dissolve con le spedizioni roma-ne nel territorio ligure degli anni Trenta del III secolo a.C., quando Ponte Gini viene abbandonato, probabilmente in maniera cruenta13; ancora in questo frangente, o nei tor-mentati scenari della guerra che Roma scatenerà contro i Liguri, all’indomani della conclusione della Seconda Guer-ra Punica, per conseguire il pieno controllo della frontiera nord-occidentale dell’Italia, si pongono gli scontri sul Monte Castellare che lasciarono drammatica testimonianza nelle ghiande missili in piombo ritrovate in gran copia nel Settecento sulle pendici del rilievo14.
In effetti si esauriscono, quasi senza eccezione, nei decenni di passaggio fra III e II secolo a.C. gli abitati
Fig. 1. Siti con frequentazione etrusca del VI-V secolo (in blu) ed ellenistica (in rosso) fra Arno e Usciana.
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 19
etruschi che avevano dato nuova vita alla terra fra Arno e Arme, e al margine meridionale delle Cerbaie; queste sono almeno le indicazioni proposte dalle restituzioni di Casa al Vento di Pieve a Ripoli15, mentre il sistema di insediamento a sud del fiume, stando ai materiali della necropoli di Fonte Vivo a San Miniato Basso, sembra uscire ridimensionato, ma sostanzialmente indenne, dal conflitto, la cui conclusione è segnata, almeno per questo tratto di Valdarno, dalla fondazione della colonia Latina di Lucca, nel 180 a.C.16.
A questo corrisponde la vitalità dell’Arno come via commerciale che ha trovato, per il III e II secolo a.C., una singolare spia nelle ceramiche a vernice nera e nelle anfo-re recuperate delle sabbie accumulate in località Gavena di Cerreto Guidi da cave provenienti dall’opposta sponda del fiume, sanminiatese; sono la prova archeologica del ruolo itinerario svolto dal fiume, e dalla via di terra che dovette assecondarlo dalla metà del II secolo a.C., stando al miliario posto da T. Quinctius Flamininus, console nel 155 o nel 123 a.C.17.
Fra i due fiumi si potrebbe essere disperso il pulviscolo di piccolissimi insediamenti che si profila, nel corso del II secolo a.C. sulle Cerbaie, anche per effetto della deporta-zione in pianura di parte dei Liguri18, ma occorre giungere agli anni del Secondo Triumvirato per vedere un nuovo, risolutivo punto di svolta nella storia di questo tratto del Valdarno.
La fame di terre da assegnare ai veterani delle legioni impegnate nelle guerre civili culminate nelle battaglie di Filippi (41 a.C.) e Azio (30 a.C.), concluse dalla pacifica-zione di Augusto, impegna in una sistematica opera di bonifica, accatastamento, distribuzione o redistribuzione di tutte le pianure dell’Etruria settentrionale, da Firenze a Lucca, passando per Pistoia, lungo il pedemonte appenni-nico, e da Firenze a Pisa lungo l’Arno.
Il reticolato di vie e fossato disposti su una maglia di straordinaria regolarità, con lato di 20 actus, equivalenti a circa m 710, che connota la centuriazione ‘classica’, era percepibile fino a qualche decennio fa nella cartografia della pianura fra Arno e Usciana, in particolare nel territo-rio di Santa Croce, in cui l’impronta del sistema agrario di origine romana permeva anche l’assetto agrario, fin nelle più minute partizioni: le prime immagini geometriche del territorio, intorno alla metà dell’Ottocento, ne offrono una convincente testimonianza.
La ricostruzione fondata sulla sola valutazione car-tografica19 ha trovato un singolare riscontro nel dato di scavo di Sant’Ippolito di Anniano a Santa Maria a Monte. Il complesso delle pieve tardoantica e altomedievale, esplo-rata fra 1999 e 2000, si è rivelato erede di un fondo agrico-lo – da identificare naturalmente nel *(fundus) Annianus del toponimo giunto sino all’Alto Medioevo – le cui strut-
ture, solidamente datate da stratificazioni tardoaugustee e tiberiane, rispettano puntualmente l’orientamento della centuriazione riconosciuta nel territorio di Santa Croce20; per di più, l’insediamento è collocato sull’asse ideale trac-ciato dal decumanus riconoscibile, ancora nelle immagini cartografiche degli anni Cinquanta del Novecento, nella Via Mugnaiola di Santa Croce, un asse viario attestato almeno nel Duecento21.
L’ipotesi più plausibile è che per soddisfare il bisogno di terre dei veterani delle due legioni (la XXVI e la VII) destinate al territorio di Lucca, sotto la cura di L. Memmius L.f., con titolo di praefectus Lucae … ad agros dividundos non furono sufficienti i distretti del territorio lucchese già colonizzati dopo la fondazione del 180 a.C., ma si dovette ricorrere ad aree del territorio coloniale rimaste sino a quel momento ampiamente desolate: la terra fra Arno e Arme; la Valdinievole22.
Fig. 2. Ceramiche del III secolo a.C. dal territorio di Santa Croce sull’Arno (Mensa Sociale di via San Tommaso).
20 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
Il caso di Anniano, in cui è stato possibile recuperare almeno il calcatorium e il lacus che sostanziavano la vitalità agricola dell’insediamento, con la vinicoltura a fun-gere da elemento trainante, rimane isolato nell’evidenza di scavo, ma ricerca di superficie e recuperi in opere di bonifica si integrano con la spettacolare sequenza di topo-nimi romani – in particolare prediali in – ano – nel dare consistenza alla colonizzazione d’età augustea che trasfor-
mò il volto di questo territorio, popolandolo delle fattorie che, dalla confluenza fra Arno e Arme all’attuale Padule di Fuccechio, hanno lasciato memoria in toponimi come Iunciano, Spontiniano, Mariniano, Plutiano, Surignano, Pompiano, Trabuliano, nel territorio oggi fra Montecalvoli e Santa Maria a Monte, fino allo stesso Anniano e alla fit-tissima sequenza di prediali nel territorio castelfranchese – di cui Paterno, Caprugnana, Catiana non sono che i
Fig. 3. Centuriazione e relitti toponomastici del sistema stradale d’età romana nel territorio fra Arno e Usciana.
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 21
più evidenti23 – e di Santa Croce sull’Arno: Saturno, in cui fu fondata intorno alla metà del secolo XI la chiesa di San-t’Andrea che ancora certifica la collocazione del sito24, ere-dita un toponimo che verosimilmente doveva essere stato generato da un luogo di culto della divinità agricola.
Sono del resto i toponimi a indiziare aspetti portanti del paesaggio centuriale. I toponimi strada, a strada, noti nel XII e XIII secolo lungo l’Arno, fino a Petriolo e a Catia-
na, o, meglio, fino al toponimo stradale per eccellenza, il Vigesimo in cui fu costruita la curtis intorno alla chiesa di San Pietro, cui era pertinente anche Saturno, impongono di ipotizzare che l’Arno fosse seguito anche da una via publica, strata25, che giungeva almeno sino a questo punto della destra del fiume: un diverticolo della via publica Pisis Florentiam già tracciata da T. Quinctius Flamininus, vero-similmente, che si attestava in destra del fiume dopo averlo superato forse non molto dopo il miliario tredicesimo, atte-stato dal Tredecim nel territorio di Calcinaia26. L’idronimo che intorno al Mille prevalse su Arme, Usciana, derivando da *(fossa) Augustiana, potrebbe per contro segnalare che i primi tentativi di regimazione del fiume si dovettero all’au-torità imperiale, forse allo stesso Augusto, e che in questo frangente potrebbero essersi formati i fondi di proprietà imperiale che giustificherebbero la presenza a Cappia-no dell’iscrizione di un liberto imperiale, probabilmente di Tiberio, coinvolto nella loro amministrazione, come indica il suo ruolo di procurator27. Alle opere di bonifica dovrebbe essere ascritto anche il toponimo Comana, con-servato ancora nel quadrante nordorientale del territorio castelfranchese, se deriva, con discrezione della presunta preposizione, da *(fossa) decumana, un ‘fossato che funge da decumanus’; nel Duecento, in effetti, è ancora attestato un ‘rio di Comana’, oggi perduto28.
La scarna evidenza archeologica, sopravvissuta alla continuità di vita e alle metamorfosi ambientali, come dimostrano le stratificazioni ancora leggibili, con materiali della prima età imperiale, lungo l’Antifosso, poco a est del ponte dell’antica Via del Bosco di Santa Croce sull’Ar-
Fig. 4. Il calcatorium (in alto) e il lacus (in basso) dell’insediamento agricolo di Anniano.
Fig. 5. L’iscrizione funeraria di un procurator imperiale d’età giulio-claudia. Firenze, collezione Antinori.
22 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
no, rivela piuttosto un addensarsi degli insediamenti sul dosso dell’Arme-Usciana, oltre che dell’Arno, e al piede delle Cerbaie, che proietta già nella prima età imperiale, e in misura ancor più significativa, nella Tarda Antichi-tà, la genesi del sistema di insediamenti prospettato dai documenti altomedievali. In effetti, i relitti di stratificazioni d’età romana emersi sul fianco delle Cerbaie in ‘Ascialla’, sulle pendici di Montefalcone, e a Casina Valle29 segna-lano attivi già nel I secolo a.C. i nuclei di insediamento testimoniati nel secolo XI nell’elenco delle ville dipendenti dalla pieve di Cappiano – Canova, Rignana, Poplo, lungo l’Usciana; Valle, sulle Cerbaie; Lapillo e Santo Vito sull’Ar-no – cui si aggiungono quelle lungo l’Arno pertinenti a Santa Maria a Monte (Saturno, da cui Villa Sant’Andrea; Vignale, dotata di un oratorio dedicato a San Tommaso)30. Ancora la sequenza di abitati tardoantichi emersi lungo l’Usciana, nel territorio di Castelfranco, da Arsiccioli a Comana31 rivela la sostanziale continuità nel sistema di insediamenti che motiva la conservazione dei toponimi e, almeno nei tratti di pianura risparmiati dalle esondazioni dell’Usciana – più che dell’Arno – del sistema viario: le vie del territorio santacrocese attestate nel Ducento – via donica, via di rivolta, via de l’apello (la via de lapillo, con discrezione dello pseudo-articolo), la via mugnaio-la – sono tutte attestate su kardines e decumani delle centuriazione, o su limites intercisivi32.
Nei secoli centrali del Medioevo, dunque, in un contesto politico e sociale straordinariamente mutato, se non fosse per le grandi pievi che fungevano da punto di riferimento alla vita religiosa (e in parte amministrativa) del territorio, a Anniano (poi traslata sulla dominante collina di Santa Maria a Monte)33 e a Cappiano, e per gli oratori che punteggiava-no il territorio, verosimilmente calamitando la formazione di nuovi poli demici, i paesaggi della terra fra i due fiumi non sarebbero apparsi molto diversi da quelli della Tarda Anti-chità, nel susseguirsi sull’Arno e sull’Usciana delle capanne precarie, di legno e di paglia, capaci di generare le stratifica-zioni con materiali tardoantiche emerse a Comana o a Casa Bruscolo di Fucecchio34, o che sembra di intravvedere negli atti d’età carolingia, come quelli che consentono di entrare nei paesaggi del vicus Leonianus, a Lignana di Santa Maria a Monte, o nel vicus Marinianus, sull’Arno35. La sequenza di campi e vigne che questi propongono, gli squarci sulla pesca nei due fiumi, tratteggiano scene di vita rurale che nel pieno Alto Medioevo non dovevano differire molto da quelle tardoantiche e forse neppure da quelle della prima età imperiale, se il tipo edilizio corrente doveva essere non tanto quello segnalato dal calcatorium di Anniano, ma la casa di legno splendidamente descritta da Ovidio come dimora di Bauci e Filemone36, i cui esiti archeologici sono compatibili con le stratificazioni lette a ‘Ascialla’ e a Casina Valle, ma anche negli agri centuriati della Valdera37.
La nascita di un castello: il Castellum Novum quod dicitur Sancte Crucis
Ancora ai primi del Duecento, dunque, la vita fra Arno e Usciana si svolgeva in paesaggi che conservavano il modello di insediamento sparso d’età romana. Nel 1213 Ubertello, che si affranca dai Visconti di Fucecchio, per il bel prezzo di novanta lire pisane, acquisisce anche l’appezzamento «in confinibus a la pelli quod est habitu-rium cum edificio super se»: un relitto dunque della villa di Lapillo, ancora non del tutto conglobata nel distretto di San Vito, citato comunque nel 1223, con la ‘capanna’ del venditore di un appezzamento di terra38. In un caso i documenti ci aprono uno squarcio di luce su questi edi-fici: nel 1244 un atto è steso «sub porticu» della casa del venditore39, proponendo il tipo di edilizia domestica in materiale deperibile, provvisto solo di copertura in lastre di ardesia o tegole laterizie, che emerge dai dati di scavo di Fucecchio40 e dalla cosiddetta ‘taverna’ di San Genesio41, ed è confortato dalla massa dei materiali provenienti da Villa Sancti Petri, recuperata in terra di risulta da scavi non controllati nel remoto 198042.
La genesi dei castelli, elemento ‘dominante’ nei pae-saggi medievali, ha in effetti un limitato impatto in queste pianure: le colline delle Cerbaie pullulano, già dai primi del X secolo, di insediamenti d’altura, che nel Ducento si dispongono a corona da Santa Maria a Monte a Pozzo, Montefalconi, sino a Fucecchio, sede degli amministratori imperiali di questo distretto valdarnese, cruciale nel garan-tire il potere imperiale nel ‘cuore’ della Toscana segnato da San Genesio43. Nella pianura, non lungi dall’Usciana, solo emerge il ‘castellare’ di Poppio, relitto dell’effimero tenta-tivo di una consorteria di Lambardi locali – i ‘Lambardi di Poppio’, o ‘figli di Camerino’ – di trasformare in castello, sul finire del X secolo, la loro curtis posta in loco Plubio44.
Se in questi paesaggi nasce Oringa, la vita, sua e dei suoi contemporanei, viene stravolta, subito dopo la metà del secolo, da un evento destinato a dare un impulso straordinario alla società locale. Crollato il potere impe-riale, con la repentina morte di Federico II, e subito acquisito il Valdarno a Lucca, rapida nel sostituire propri amministratori a quelli di nomina imperiale, nell’estate del 1252 la terra fra Arno e Usciana è teatro di una incursione, vittoriosa, dei Pisani contro i Lucchesi, culminata in uno scontro a San Vito; il successo finale arride però a Lucca, grazie all’alleanza con Firenze45.
Nella primavera del 1253 – il 14 aprile – compare a Lucca, davanti al notaio Ciabatto, a liquidare con 17 lire di grossi d’argento un debito con Goldo di Genovese Antichi, che aveva ricevuto in garanzia due volumi del Digesto e un sontuoso mantello da donna «sciamiti vermi-
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 23
Fig. 6. Carta archeologica (presenze d’età romana e medievale) del territorio fra Arno e Usciana nei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno.
Fig. 7. Distretti amministrativi e toponimi bassomedievali fra Arno e Usciana.
24 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
lii fodrati sendado giallo»46, Paolo del fu Rubbato. Questi agisce come ‘delegato’ (sindicus) degli ‘uomini’ del suo castello, «de valle Arni de novo castello quod dicitur San-cte Crucis», e dei Comuni di Mugnano e di Ventignano, ma il debito era stato contratto dai Comuni di Sant’An-drea, Vignale, San Vito, Ventignano, Mugnano. I primi tre sono dunque stati assorbiti nel Castellum Sanctae Crucis, così come, nello stesso periodo, fra l’estate del 1252 e la primavera del 1253, altre quattro comunità lungo l’Arno (Paterno, Caprugnana, Catiana, Villa San Pietro) si sono raccolte, per quartieri, nel Castrum Franchum Vallis Arni Inferioris, oggi Castelfranco di Sotto47.
La dedica del castello alla Santa Croce, simbolo di Lucca, non lascia dubbi sull’interesse della nuova città dominante a consolidare il potere sull’Arno con la brusca accelerazione ottenuta intrecciando l’incastellamento, tipi-
co strumento di controllo del territorio, e la trasformazio-ne degli assetti socio-economici da tempo affidata, anche in Toscana, alle ‘terre nuove’48.
Il Castrum Sanctae Crucis tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento: paesaggi urbani per la fondazione di Oringa
Il castello risucchia immeditamente l’intera popola-zione delle tre villae inglobate nel territorio della nuova comunità: nel 1259 un appezzamento è definito «in confi-nibus dicti Castri in territorio Sancti Viti», ‘nel territorio di detto Castello, distretto di San Vito’, luogo in cui, prosegue il documento – la più vistosa prova, per il Lami, dell’avve-nuto sinecismo – «dictus Alcherolus habitare actenus con-sueverat», ‘il detto Alcherolo aveva sin qui dimorato’49.
Ma anche il notaio Bugnoro, che era attivo in San Vito già nel 121450, e nel 1247 aveva casa nella Villa Sancti Andreae51, il 14 settembre 1256 roga un documento – il più antico fra quelli superstiti stesi in Santa Croce – nella sua casa di Santa Croce: «actum in Castro Sanctae Crucis in domo mei Bugnori»52.
Oltre alla popolazione delle tre ville, la nuova fonda-zione, con la sua immediata vitalità, richiama persone da Santa Maria a Monte, Cappiano, Lucca53; uno dei notai più attivi alla fine del Duecento è Iacopo da Ventignano54. La capacità attrattiva del castello coinvolge anche i domini di Rosaiolo, che in parte almeno risiedono in Santa Croce, ai primi del Trecento55.
A conferma dello spopolamento della campagna, non una dimora rurale compare nelle compravendite di fondi agricoli posteriori alla fondazione del castello; per contro, si è osservato che a Castelfranco ancora almeno per qual-che anno taluni – come Maurizio di Paterno – si ostinava-no a risiedere negli antichi ‘abituri’ delle ville56.
Il modello urbanistico applicato al Castrum Sancte Crucis è ben diverso da quello fondato su due assi di simmetria tracciato per accogliere gli abitanti delle quattro ville raccoltisi entro le mura di Castelfranco57: al tipo di palese derivazione ‘romana’, che si è proposto di associare all’opera di Biduino o – comunque – alle suggestioni clas-siche che impregnano la cultura pisana negli anni della fondazione di Bientina (1179), dove lo schema che ritor-nerà a Castelfranco conosce forse la prima applicazione in Toscana58, per il Castrum Sancte Crucis si preferisce l’assai più consueto schema dei borghi disposti a pettine sull’asse viario generatore della fondazione: i ‘borghi’ di Camaiore e Pietrasanta (nato come ‘Borgo di Sala’), pochi anni dopo, nel 1255, faranno tesoro delle lezione speri-mentata dai pianificatori lucchesi sull’Arno59.
Fig. 8. Una ‘terra nuova’ senese. Duccio di Buoninsegna, Maestà, predella nella collezione Flick.
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 25
La paratattica sequenza di ‘borghi’, con un solo asse di simmetria a gestire l’impianto, è fedelmente conservata nell’assetto attuale di Santa Croce, dove solo si è persa, con i consueti stravolgimenti toponomastici, la memo-ria delle antiche denominazioni delle ‘contrade’ (come sono denominate le vie già nei documenti duecenteschi), sopravvissute sino alle furie revisionistiche post-unitarie, ancora recuperabili sulle mappe catastali ottocentesche: San Vito, Sant’Andrea, San Tommaso, Santa Maria, Santa Croce, San Biagio, San Lorenzo, Sant’Iacopo, San Niccolò, San Michele. Un repertorio di culti in cui si intrecciano alla memoria delle antiche chiese sparse lungo il fiume, come Sant’Andrea, San Tommaso, San Vito, di altari che si aggiungevano al principale in questi luoghi di culto – San Niccolò ha un altare in San Vito60 – le devozioni rurali del Basso Medioevo. inserire fig. sanmichele_30135, sanlorenzo_30135, 14_13863, 54_13863, 62_13863
Con la distinzione del castello in terzieri61, l’assenza di San Donato ribadisce che la villa di Mugnana, la cui chiesa è dedicata al santo, non partecipa alla fondazione del castello: nel 1284 appare un Ranieri di Gentelmino da
Mugnana, e nel 1287 ancora vi si roga un atto62. L’assorbi-mento di Mugnana deve dunque esser posto nel processo di espansione del Comune, anche per il controllo delle vie alternative alla Francigena che da Lucca portano a San Miniato, che genererà lo scontro con Fucecchio63.
L’aspetto del castello in questo periodo può essere ricostruito almeno per linee generali, che dimostrano che l’impianto è quello ancora vitale.
Le ‘contrade’ sono perpendicolari alla via principale, la sola ad essere definita strata, dunque lastricata, di pietra o – sulla scorta dell’evidenza archeologica proposta dallo scavo della Piazza del Comune di Castelfranco – di mat-toni64; il ‘chiasso’ funge contemporaneamente da discrimi-nante e da giuntura fra le ‘contrade’.
L’edificazione delle case procede secondo il modulo che ancora impronta la base catastale del ‘castello’, suscet-tibile di ampi frazionamenti, in particolare con la divisione longitudinale. Nel 1288, ad esempio, si parla di un casa-mentum, ‘area edificabile’, sezionato longitudinalmente in due parti, su ciascuna delle quali sorge una capanna65. È ovviamente possibile accorpare più lotti, come sarà plaui-
Fig. 9. Santa Croce sull’Arno nel catasto leopoldino. ASP, Mappe, Comune di Santa Croce sull’Arno, sezione A, foglio 1.
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 27
bilmente accaduto per il palatium di Strenna di Pallo, il maggiorente santacrocese, in cui già nel 1289 si riuniva il consiglio comunale66.
La varietà del lessico notarile (domus, capanna, casa-mentum, casalinus, sedium) riflette in parte la genericità lessicale, ma con la sostanziale discriminante fra edifici ‘costruiti’, seppure di tono assai diverso (domus, capan-na), e ‘aree edificabili’ (sedium, casamentum, casalinus), lascia intuire la lentezza del processo con cui il nuovo castello viene urbanizzato. Se è comprensibile che nel 1259 il sedium seu casamentum che il podestà Bonifacio Piccadori aliena a Giovanni del fu Bellandino confini, oltre che con le vie pubbliche, con due sedia67, ancora nel 1274 una domus confina con un casamentum68, e nel 1294 una domus confina con una capanna e con un casamentum, oltre che con il chiasso e con la via69; ancora nel 1311 un casamentum è solo «pro certa parte accasatum», ‘edificato solo in parte’70. È possibile che la precarietà di qualche edificio concorra alla mutevolezza dei paesaggi castellani: la domus che il Comune concede a Oringa nel 1279 ha davanti a sé un medium – destinato alla costruzione del claustrum del monastero – e confina con la domus di Cortenova di Neri, che però, quando viene acquisita per il monastero da Oringa, nel 1283, è un semplice sedium71.
I documenti concedono appena qualche sguardo sup-plementare sul castello della seconda metà del Duecento: nel palatium di Strenna di Pallo, distinto dalla domus vetus dello stesso Strenna, si aprono ben tre apothecae, ‘botte-ghe’72, per attività commerciali, che integrano le elemen-tari attività industriali documentate: il mulino sull’Arno73, la fornace per produrre i laterizi indispensabili agli edifici castellani74. La collocazione della fornace di Vanni Moretti non è indicata, ma è ovvio che doveva trovarsi a qualche distanza dal castello, per ridurre al minimo il rischio del fuoco; solo per congettura, però, la si potrebbe collocare nella sequenza di fornaci che fanno del corso dell’Usciana un vero e proprio ‘asse portante’ del distretto produttivo del laterizio, nel corso del Duecento, così come risalta dalle fonti documentarie e dall’evidenza archeologica nel contiguo territorio di Castelfranco75.
I laterizi, anche nelle fini versioni decorate ancora leggibili nei tessuti murari esposti, sono indispensabili per il decoro della chiesa castellana, e si può sospettare che proprio l’impegno finanziario richiesto da questa sia responsabile dell’interminabile protrarsi dei lavori, a Santa Croce come a Castelfranco. La chiesa della Santa Croce, verosimilmente subito dotata della fedele replica del Volto Santo lucchese che ancora custodisce con venerazione, è già eretta a pochi anni dalla fondazione del nuovo insediamento, tanto che nel 1259 vi si radunano podestà e consiglieri76, ma nel 1279 doveva essere ancora assai lontana dal completamento, se il Comune prevedeva che
i beni del monastero di Oringa sarebbero stati impiegati per completare muri, tetto e porte della chiesa della Santa Croce’, nel caso che il monastero fosse stato abbandona-to77.
Se il Comune, anche per incrementare il ruolo itinera-rio del castello, e l’antagonismo con Fucecchio, gestisce uno ‘spedale’78, è assai lento a dotarsi di una propria sede amministrativa: ben diverso il caso di Castelfranco, in cui il dato degli scavi del 1995 ha confermato le indicazioni documentarie sulla immediata costruzione della domus Communis, intrinsecamente connessa alla piazza come cuore del nuovo castello79. Dalla serie documentale, appa-re che il podestà svolge la sua opera in edifici privati80, e il consiglio del Comune si riunmisce nella chiesa della Santa Croce, presso privati, o nella casa di Strenna di Pallo81. È plausibile che solo dopo la donazione del palatium di Strenna, del 131582, il Comune abbia trovato una sede propria.
La piazza è essenziale nella vita delle ‘terre nuove’ bassomedievali, luogo di mercato e punto centrale delle attività ‘sociali’: nel 1275 una ingiunzione del vicario luc-chese, residente in Fucecchio, deve essere bandita nelle
28 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
piazze di Santa Croce e Castelfranco83. È plausbile che la piazza duecentesca sia quella che ancora ‘dialoga’ con la chiesa della Santa Croce, così come a Castelfranco la piazza doveva essere connessa al portico della domus Communis, in cui si continuava84.
Nel rigore dell’impianto urbanistico, e nella mobilità degli edifici che lo coprono, svolge un ruolo del tutto particolare, sul finire del Duecento, la fondazione di Oringa. Dalla domus del 1279 si espande, comprenden-do successivamente una chiesa, un chiostro, un cimitero, inglobando, con acquisti o donazioni, altri edifici e aree edificabili, fino a formare un ‘blocco’ capace di incidere anche sulle strutture dell’impianto della fondazione. Già ai primi del Trecento è tracciata, su terre di proprietà del monastero, una via – l’attuale Viucciola – che raccorda ortogonalmente le ‘contrade’ di Sant’Iacopo, San Niccolò, San Lorenzo; nel 1321 viene concessa al Comune, in per-muta con il tratto finale della ‘contrada’ di San Niccolò, ormai inglobata nel monastero85.
Il monastero giunge ad addossarsi alle mura, da cui
è distinto sollo dalla via che ne segue il corso86. Queste sono citate per la prima volta in un documento del 1279, ma ovviamente dovevano essere state messe in opera già dalla fondazione87, indispensabili per la stessa connotazio-ne come ‘castello’ della fondazione, rigorosamente distin-to dai ‘borghi’ muniti al massimo – come a San Genesio o a Borgo di Sala/Pietrasanta – di un terrapieno eretto dai ‘tecnici’ lombardi88. La concreta affidabilità delle mura dei due nuovi castelli eretti sull’Arno doveva essere limitata, tanto che Lucca promuoveva nel 1258 il consolidamento delle opere di fortificazione di Santa Maria a Monte; ma se la facilità con cui i Ghibellini si impadronirono dei due castelli sull’Arno nel 1261, dopo la vittoria di Montaperti, potrebbe non essere imputata solo alla fragilità dell’ap-parato murario89, l’assenza di mura lungo l’Arno poteva inficiare la forza militareb del castello. Si deve osservare, in effetti, che nel 1301 e nel 1323 case confinano diretta-mente con la «platia de Arno», la ‘spiaggia del fiume’90, in cui potevano finir di confluire i fossati esterni, che hanno lasciato traccia nella toponomastica91
laterrafraiduefiuMi:paeSaggid’etàetruSCaeroMananelterritoriodiSantaCroCeSull’arno 29
Due, infine, le porte che si aprivano nelle mura, sulla strata Communis: la Porta Fiorentina92 e la Pisana. L’aper-tura della ‘via nuova’ che dal castello portava al ponte di Rosaiolo, tanto importante nella vita santacrocese degli anni Ottanta del Duecento93, e in cui assunse un ruolo di altissimo rilievo Oringa-Cristiana, la ‘profetissa domus oratorii Sancti Iacobi de Sancta Cruce’94 potrebbe aver portato all’apertura di una terza porta, la ‘porta reale’ della documentazionc cinquecentesca. Si dovrà osservare che la porta doveva immettere nel castello nelle immediate adiacenze del complesso monastico.
Note
1 per l’Autore: mancano le case editrici Si rinvia a G. Ciampoltrini - M. Cosci - C. Spataro, La Terra dei Quattro
Fiumi. Paesaggi fluviali d’età etrusca e romana nel Valdarno Infe-riore, di prossima pubblicazione: il testo è per il momento dispo-nibile (sprovvisto dell’apparato scientifico di note e bibliografia) all’indirizzo: http://www.segnidellauser.it/terradeiquattrofiumi.
2 Ibid.3 Sulle vicende dell’idronimo, e per le opere di regimazione rina-
scimentali, si veda P. Morelli, La regolamentazione delle acque dell’Usciana fra Cinque- e Settecento, in «L’Erba d’Arno», 58 (1994), pp. 34-52.
4 Edizione in E. Galli, Fucecchio. Scoperta di pezzi di aes signatum, in «Notizie degli Scavi», 1912, pp. 427 sg.; I lingotti con il segno del rame secco. Considerazioni su alcuni aspetti socio-economici nel-l’area etrusco-italica durante il periodo tardo arcaiaco, a cura di E. Pellegrini e R. Macellari, Pisa-Roma 2002, p. 79 (E. Pellegrini); G. Ciampoltrini - A. Andreotti, Etruschi e Romani sulle Cerbaie, in Le Cerbaie. La natura e la storia, Pisa 2004, pp. 49-58, in particolare p. 52.
5 Si veda G. Ciampoltrini - R. Manfredini - C. Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito di Santa Maria a Monte. Paesaggi e insediamenti nel Medio Valdarno Inferiore tra VI e II secolo a.C., Bientina 2008, pp. 15 sgg., in particolare pp. 29 sgg., con i riferimenti a I lingotti con il segno del rame secco, cit.
6 G. Ciampoltrini - E. Pieri, Etruschi e Liguri in Valdinievoloe (IV-III sec. a.C.). Insediamenti e itinerari, in Atti del convegno su L’Ar-cheologia in Valdinievole (Buggiano Castello 1996), Buggiano 1997, pp. 35-49; P. Perazzi, Su alcuni rinvenimenti archeologici a Pieve a Nievole. Nota preliminare sull’area di via Cosimini, in «Bollettino Storico Pistoiese», CVII (2005), pp. 111-115.
7 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit., pp. 16 sgg., con bibliografia precedente.
8 G. Ciampoltrini - M. Cosci - C. Spataro, L’insediamento etrusco del Monte Castellare di San Giovanni alla Vena (Vicopisano) tra evidenza archeologica e fotografia aerea, in «Science and Techno-logy for Cultural Heritage», XIV, 1-2 (2005), pp. 95 sgg.; Ciampol-trini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit., pp. 37 sgg.
9 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit.,, p. 37 sgg., con ampi riferimenti bibliografici.
10 Rispettivamente G. Ciampoltrini - E. Pieri - F. Fabbri - A. Catapano, Paesaggi perduti della Valdinievole. Materiali per l’insediamento etrusco e romano nel territorio di Monsummano Terme, in «Rassegna di Archeologia», 17 (2000), pp. 255-323, in particolare pp. 260 sgg.; A. Vanni Desideri, Archeologia del territorio di Fucecchio, Fucecchio
1985, pp. 31 sgg.11 G. Ciampoltrini, L’Ercole promachos di Castel Martini, in «Bollettino
Storico Pistoiese», XC (1988), pp. 79-85; G. Ciampoltrini, Devoti d’età ellenistica dal Valdarno Inferiore, in «Prospettiva», 95-96 (1999), pp. 51-58, in particolare pp. 51 sgg.; Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit., p. 52.
12 Ibid., pp. 54 sgg.13 G. Ciampoltrini, L’insediamento etrusco nella Valle del Serchio
fra IV e III secolo a.C. Considerazioni sull’abitato di Ponte Gini di Orentano, in «Studi Etruschi», LXII (1996), pp. 173-210, in particolare pp. 206 sgg.; G. Ciampoltrini, Culture in contatto. Etruschi, Liguri, Romani nella Valle del Serchio fra IV e II secolo a.C., in I Liguri della Valle del Serchio tra Etruschi e Romani. Nuovi dati e prospettive di valorizzazione, Atti della Giornata di Studio Lucca 8 ottobre 2004, a cura di G. Ciampoltrini, Lucca 2005, pp. 15-66, in particolare pp. 18 sgg.
14 Ciampoltrini - Cosci - Spataro, L’insediamento etrusco del Monte Castellare, pp. 37 sgg., con il riferimento a G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, I, Firenze 17582, pp. 351 sg.
15 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit., pp. 56 sgg.
16 G. Ciampoltrini, Il Museo Archeologico di San Miniato. L’antica collezione museale, in Sistema museale di San Miniato. Museo Archeologico, a cura di G. Ciampoltrini, Pontedera 2008, pp. 7-39, in particolare pp. 15 sgg.
17 CIL I, 652=XI, 6671; G. Ciampoltrini, L’insediamento tra Era e Elsa dall’Età dei Metalli alla tarda antichità, in Le colline di San Miniato (Pisa). La natura e la storia, Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, Suppl. 14, 1995, pp. 59-77, in particolare pp. 69 sg.
18 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Il cippo etrusco da Sant’Ippolito, cit., pp. 61 sg.
19 G. Ciampoltrini, Note sulla colonizzazione augustea nell’Etruria settentrionale, in «Studi Classici e Orientali», 31 (1981), pp. 41-55, in particolare p. 44.
20 G. Ciampoltrini - R. Manfredini, Sant’Ippolito di Anniano a Santa Maria a Monte. Preistoria e storia di una pieve sull’Arno, Pontedera 2005, pp. 9 sgg.
21 Si veda per esempio ASL, Diplomatico. Altopascio, 1241 aprile 21; Altopascio, 1, cc. 175r e sgg., ecc.
22 CIL VI, 1460; per l’ipotesi G. Ciampoltrini, Paesaggi urbani e rurali di una colonia augustea, in Ad limitem. Paesaggi d’età romana nello scavo degli Orti del San Francesco in Lucca, a cura di G. Ciam-poltrin, Lucca 2007, pp. 13-42, in particolare pp. 13 sg.
23 Si rinvia alla cartografia in G. Ciampoltrini, Castelfranchesi del Due-cento, in La “Piazza del Comune” di Castelfranco di Sotto. Lo scavo archeologico di Piazza Remo Bertoncini e la nascita di un antico castello del Valdarno Inferiore, a cura di G. Ciampoltrini e E. Abela, Poggibonsi 1998, pp. 17-53, fig. a p. 18.
24 G. Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi del Valdarno Inferiore, in Le terre nuove, Atti del Seminario Internazionale orga-nizzato dai Comuni di Firenze e San Giovanni Valdarno (Firenze - San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), a cura di D. Friedman e P. Pirillo, Firenze 2004, pp. 319-338, in particolare p. 325, nota 27.
25 Per questo si veda da ultimo G. Ciampoltrini - M. Cosci - C. Spataro, La silice. Vie romane nei paesaggi medievali della Toscana nor-doccidentale, in Tra città e contado. Viabilità e tecnologia stradale nel Valdarno medievale, Atti della II Giornata di Studio del Museo Civico “Guicciardini” di Montopoli in Val d’Arno (Montopoli in Val d’Arno, 20 maggio 2006), a cura di M. Baldassarri e G. Ciampoltrini, San Giuliano Terme 2007, pp. 13-24.
26 G. Ciampoltrini, Il territorio in età romana, in Pontedera dalle prime testimonianze al Quattrocento, Pisa 2004, pp. 57-71, in parti-
30 SantaCriStianaeilCaStellodiSantaCroCetraMedioevoepriMaetàModerna
colare pp. 57 sgg.27 CIL XI, 1733; da ultimo Tra ager centuriatus e silva. Ricerche sul
decumanus ‘del Colmo dei Bicchi-Botronchio’ nella Piana di Lucca, a cura di G. Ciampoltrini, pp. 67 sgg.
28 Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 21 sgg.29 Rispettivamente G. Ciampoltrini - R. Manfredini - C. Spataro, Villag-
gi e castelli, vie e porti. Aspetti del paesaggio medievale nel territorio di Santa Maria a Monte, Bientina 2007, pp. 13 sgg.; G. Ciampoltrini - F. Maestrini, Frammenti di storia. Archeologia di superficie nel Medio Valdarno In feriore, Pontedera 1983, pp. 29 sg.
30 Si veda Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit., pp. 323 sg., con il rinvio a A. Malvolti, La «contea» di Rosaiolo nel Tardo Medioevo, in Pozzo di Santa Maria a Monte: un castello del Valdarno lucchese nei secoli centrali del Medioevo, Atti del Conve-gno Villa di Pozzo 21 settembre 1997, a cura di P. Morelli, Santa Maria a Monte 1998, pp. 75-104, in particolare pp. 84 sgg.
31 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, op. cit. (n. 24), pp. 30 sgg. di quale nota si tratta?
32 Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit., pp. 323 sgg.; per il sistema viario, particolare riferimento ad ASL, Altopascio, 1, cc. 174r e sgg.
33 Per la storia archeologica della pieve si rinvia a Ciampoltrini - Man-fredini, Sant’Ippolito di Anniano, cit., pp. 21 sgg.
34 Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit., p. 322.35 Ciampoltrini - Manfredini - Spataro, Villaggi e castelli, vie e porti,
cit., pp. 13 sgg.36 Ovidi, Metamorphos., VIII, vv. 625 sgg.; per le evidenze archeologi-
che correlate nella Piana di Lucca si veda G. Ciampoltrini - M. Cosci - C. Spataro, I paesaggi d’età romana tra ricerca aerofotografica e indagine di scavo, in La Terra dell’Auser. I. Lo scavo di Via Martiri Lunatesi e i paesaggi d’età romana nel territorio di Capannori, a cura di G. Ciampoltrini e A. Giannoni, Bientina 2009, pp. 13-62, in particolare pp. 42 sg.
37 Per questi G. Ciampoltrini, La Valdera romana fra Pisa e Volterra, in La Valdera romana fra Pisa e Volterra. L’area archeologica di Santa Mustiola (Colle Mustarola) di Peccioli, Atti dell’incontro di studio del 13 maggio 2006, Peccioli, a cura di G. Ciampoltrini, Pisa 2009 (= I Quaderni Pecciolesi, 9), pp. 17-29, in particolare p. 24.
38 G. Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, V (= Deliciae Eru-ditorum XVIII), Florentiae 1769, pp. 5 sgg.; p. 32.
39 ASF, MSC, 1244 agosto 18.40 A. Vanni Desideri, La casa medievale del Poggio Salamartano, in
L’abbazia di San Salvatore a Fucecchio e la Salamarzana nel Basso Medioevo, Fucecchio 1987, pp. 107-118.
41 Con gli occhi del pellegrini. Il Borgo di San Genesio: archeolo-gia lungo la Via Francigena, a cura di F. Cantini, Firenze 2007, pp. 23 sgg.
42 Ciampoltrini - Maestrini, Villaggi e castelli, vie e porti, cit., pp. 40 sg.
43 Si rinvia a Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 21 sgg.
44 Per Poppio, nel territorio poi di Santa Croce, quasi al confine con Castelfranco, ibid., p. 22.
45 Per le vicende di questi anni, si rimanda a ibid., pp. 19 sgg.46 ACL, LL 27, c. 109r.47 Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 19 sgg.; Ciam-
poltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit., pp. 327 sgg.48 Si rinvia in merito agli atti Le terre nuove, cit., con la ricca serie di
contributo che hanno fatto il punto su questo strumento di ‘gestione del territorio’.
49 ASF, MSC, 1259 aprile 12; Lami, Charitonis et Hippophili Hodoepo-ricon, cit., p. 274.
50 ASF, MSC, 1241 novembre 10; 1240 settembre 18; ecc.51 ASL, Diplomatico. Altopascio, 1247 ottobre 18: «actum in Sancto
Andrea juxta domum mei Bugnori notarii …».52 ASF, MSC, 1256 settembre 14.53 ASF, MSC, 1294 agosto 22; 1284 marzo 17; est. 1311, passim.54 ASF, MSC, 1272 settembre 24.55 ASF, MSC, 1312 gennaio 31; Malvolti, La «contea» di Rosaiolo nel
Tardo Medioevo, cit., passim.56 Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., p. 43.57 Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit.,
pp. 327 sgg.58 Ibid., pp. 329 sg.59 Ibid., pp. 319 sg.60 ASF, MSC, 1309 aprile 11.61 ASF, MSC, 1349 aprile 25: si cita il terziere di San Vito.62 Rispettivamente ASF, MSC, 1284 novembre 30; 1287 febbraio 16.63 Malvolti, in questa sede.64 Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit.,
pp. 330 sgg.65 ASF, MSC, 1288 aprile 19.66 Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, cit., p. 289, documen-
to dell’11 dicembre 1289, perduto?67 Supra, nota 49.68 ASF, MSC, 1274 ottobre 30.69 ASF, MSC, 1294 agosto 22.70 Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, cit., p. 351, documen-
to del 10 novembre 1311, perduto? 71 Rispettivamente ibid., p. 285; ASF, Diplomatico. Costantini, 1279
novembre 14; MSC, 1283 ottobre 28.72 ASF, MSC, 1315 febbraio 13.73 ASF, MSC, 1301 gennaio 22.74 G. Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, II (= Deliciae Eru-
ditorum V), Florentiae 1742, p. 343; ASF, MSC, 1306 aprile 11.75 Per il sistema produttivo delle fornaci, si veda G. Ciampoltrini - A.
Andreotti - C. Spataro, Una fornace per laterizi bassomedievale a Orentano, in I Maestri dell’Argilla. L’edilizia in cotto, la produzione di laterizi e di vasellame nel Valdarno Inferiore tra Medioevo e Età Moderna, Atti della I Giornata di Studio del Museo Civico “Guic-ciardini” di Montopoli in val d’Arno (Montopoli in Val d’Arno, 21 maggio 2005), San Giuliano Terme 2006, pp. 121-127, in particolare pp. 125 sg.; E. Abela, La fornace medievale per laterizi a Comana di Castelfranco di Sotto (Pisa), ivi, pp. 115-120.
76 Supra, nota 49.77 Supra, nota 71.78 ASF, MSC, estimo 1311.79 Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 330 sg.80 Supra, nota 71.81 Supra, nota 66.82 Supra, nota 72.83 ASL, Diplomatico. Altopascio, 1275 apr. 15.84 Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 328 sgg.85 Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, cit., p. 377, documen-
to del 23 set. 1321, perduto?86 Ibid., p. 289, documento dell’11 dic. 1289.87 Supra, nota 71.88 Ciampoltrini, Archeologia delle terre nuove lucchesi, cit., p. 320.89 Si rinvia a Ciampoltrini, Castelfranchesi del Duecento, cit., pp. 45
sg.90 ASF, MSC, 1301 gennaio 22; 1323 ottobre 11.91 ASF, MSC, 1301 gen. 2292 ASF, MSC, 1321 lug. 4.93 Malvolti, in questa sede.94 Lami, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, cit., pp. 298 sgg.