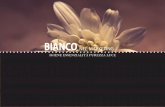"Ostension of the Holy Shroud in Piazza Castello: Architecture and Ritual"
La consistenza del castello di Empoli nel duecento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La consistenza del castello di Empoli nel duecento
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
PER UNA STORIA URBANISTICA DI EMPOLI MEDIEVALE
Del castello di Empoli sono ben note le due ultime cerchie.1 Dell’ultima,quattrocentesca, restano ampi tratti, benche inglobati nel tessuto edilizio, per-fettamente confrontabili con l’abbondante iconografia storica. Della penulti-ma, trecentesca, si possono osservare alcuni resti in elevato e si puo ricostruireil tracciato grazie a non pochi indizi archeologici e documentari.
Ma com’era Empoli nel 1260, al tempo del «gran rifiuto» di Farinata degliUberti? E questa l’occasione di chiedersi quale fosse l’effettiva estensione delcastello, la consistenza delle sue difese, la sua organizzazione viaria, l’emergen-za dei suoi edifici piu prestigiosi, ponendo come limite cronologico alla ricercal’alluvione del 1333 che spazzo via le mura segnando un punto di crisi dell’e-voluzione dell’insediamento fondato nel 1119.
Anche se si puo rispondere solo in modo parziale a questi interrogativi chela storiografia empolese si e costantemente posta da Vincenzo Chiarugi inpoi,2 vale la pena riprovarci alla luce di novita archeologiche e documentarie.In particolare, lo scavo di via Ridolfi – che viene presentato da Walter Maiuriin Appendice – ha restituito importanti elementi, cosı come il riesame delladocumentazione duecentesca edita: l’appendice documentaria agli studi co-munali di Pietro Santini, contenente la vendita di tre delle quattro parti delcastello di Empoli dai conti Guidi al comune di Firenze nel 1254-1255,3 il no-
1 M. FRATI – W. MAIURI, Nuovi studi sulle mura di Empoli, «Bullettino Storico Empolese», LII-LIV (2008-2010), pp. 183-194.
2 V. CHIARUGI, Della Storia d’Empoli, a cura di M. Bini, ivi, III (1959), pp. 323-398: 347-364;Empoli Archimedia - Ricostruzione dell’edificato del centro storico di Empoli nella seconda meta del’700, CD-Rom, Comune di Empoli, 2001.
3 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d’ora in poi ASF), Capitoli, XXX, cc. 132r-145r, parzialmenteediti in Documenti dell’antica costituzione del Comune di Firenze, 2 voll. a cura di P. Santini, Firenze,G.P. Vieusseux, 1895-1952, II, nn. 20, 22, 43.
1ª bozza 17-7-2012
— 103 —
to libro degli estimi dei danni inferti dai ghibellini ai guelfi nel 1260-12664 e leimbreviature di ser Lasta del 1280-1284.5 Molte altre nuove indicazioni sonoemerse dall’esame della sterminata documentazione trecentesca inedita segna-lata da Paolo Pirillo6 e del fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firen-ze, dal 2008 direttamente consultabile on-line.7
La struttura urbanistica del centro storico di Empoli e caratterizzata da uncircuito murario quadrato, dalla piazza centrale su cui si affaccia la collegiatadi Sant’Andrea, da due strade in direzione est-ovest (via del Giglio e via delPapa), e da una nord-sud (via Ridolfi) che insieme formano il ‘giro’. Mache cosa di questo impianto deriva dalle fasi due-trecentesche? Per prima cosae bene osservare la situazione nel suo momento finale e piu critico.
IL TRACCIATO DELLE MURA FINO AL 1333
La piena dell’Arno del 4 novembre 13338 distrusse le mura del castelloempolese in modo irreparabile, tanto che la repubblica fiorentina decise di ri-costruirle completamente tre anni dopo.9 La loro forma e consistenza, espres-sione dell’evoluzione urbanistica dell’insediamento (di cui ci occuperemo piutardi),10 potrebbe risalire proprio ai tempi di Farinata, dato che gia nel 1281 lacortina appariva bisognosa di riparazioni11 quindi verosimilmente la sua co-struzione potrebbe risalire almeno a qualche anno prima.
Il tracciato delle mura seguiva un perimetro approssimativamente quadra-to (Fig. 1), come pure le due successive cerchie del XIV e del XV secolo, dipoco piu ampie. Vediamone ora piu precisamente i punti di passaggio.
4 Liber Extimationum (Il libro degli Estimi An. MCCLXIX), a cura di O. Bratto, Goteborg,Elanders Boktryckeri Artiebolag, 1956, nn. 389, 398.
5 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, cit. da F. BERTI, Vita empolese del XIII secolo nelle im-breviature di Ser Lasta, «Bullettino Storico Empolese», XXI (1977), pp. 3-39.
6 P. PIRILLO, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, 2 voll., Firenze, Olschki,2005-2008.
7 Per la maschera di ricerca avanzata approntata dall’Archivio in collaborazione con la ScuolaNormale Superiore di Pisa: «http://www.archiviodistato.firenze.it/diplomatico/index.php?op=search.
8 G. VILLANI, Nuova Cronica, 3 voll. a cura di G. Porta, Parma, Guanda, 1990-1991, III, p. 9 = li-bro XII, cap. 1.
9 La ricostruzione delle mura «che alquanto n’erano cadute per cagione del grande diluvio» fuiniziata nel 1336, quando il comune di Firenze ne delibero i lavori (ivi, p. 113 = libro XII, cap. 51), eterminata nel 1340, quando fu regolato il pagamento della «fortificationem terre vestre et reparatio-nem et refectionem fortilitiarum, murorum, bertescharum, portarum et pontium» (ASF, Signori.Missive I Cancelleria, 6, c. 8r).
10 Vedi testo corrispondente alle note 75 e ss.11 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 9v.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 104 —
A est venne rintracciato all’inizio dell’Ottocento un resto di fortificazione,allora considerato «l’unico avanzo, che possa credersi essere stato ritrovato delprimo cerchio delle Mura nel 1805 nel farsi uno scavo sotto il non vecchioOratorio di San Giuseppe. Questo consiste in una porzione di muraglia assaisalda, diretta da Mezzogiorno a Tramontana, ed avente due aperture, chesembrano troniere voltate in faccia a levante, cioe verso Firenze».12 Questanotizia e purtroppo da assumere con una qualche cautela, benche il suo por-tatore sia piuttosto affidabile, perche oggi non puo essere confermata dall’os-servazione diretta. Ma continuiamo a seguire il ragionamento di VincenzoChiarugi: «Immaginando una linea tratta nella medesima direzione secondol’indicazione delle Porte, puo appena segnare tra questa, e la porzione di mu-raglia ritrovata una distanza appena di 60 braccia, lo che stabilir dee almenoda questa parte la differenza, che esister dovea tra il primo e secondo circui-to».13 L’allineamento di cui parla il medico empolese puo essere facilmenteriscontrato nella cartografia storica (in particolare il Catasto Generale Tosca-no)14 e, ormai solo in parte, nell’attuale divisione catastale.
Sul tratto orientale delle mura si aprivano due porte. La piu antica eradetta ‘Fiorentina’, come quella che piu tardi ne prese il posto nella nuovacerchia in corrispondenza della via Pisana (attuale via G. Del Papa);15 lasua prima menzione risale al 1323,16 presumibilmente molto dopo la sua co-struzione.
L’altra porta, situata all’imboccatura dell’attuale via del Giglio, non avevanome ma se ne puo datare l’apertura fra il 1313 e il 1317. Al tempo della di-scesa di Arrigo VII il comune di Firenze aveva rapidamente provveduto alcompletamento delle difese di Empoli,17 che quattro anni dopo apparivanogia danneggiate: nell’ordinare il ripristino di fossi e steccati si sollecitava la co-
12 CHIARUGI, Della storia, cit., p. 361. Sull’oratorio di San Giuseppe al Corso, W. SIEMONI,Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese, Empoli, ATPE, 1997, p. 38.
13 CHIARUGI, Della storia, cit., p. 361.14 ASF, Catasto Generale Toscano, Comunita di Empoli, sezione D, foglio unico, levato in scala
1:1250 nel 1820, pubblicato da W. SIEMONI, L’immagine della citta, in Empoli: citta e territorio. Ve-dute e mappe dal ’500 al ’900, Empoli, Editori dell’Acero, 1998, pp. 115-161: 129, Fig. 64. La chiesadi San Giuseppe e alla particella n. 413.
15 FRATI – MAIURI, Nuovi studi, cit., p. 190.16 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.17 Il comune di Firenze intimo a Giovanni dei Rossi capitano della terra di Empoli di ultimare
l’approntamento delle difese e far riprendere lo scavo dei fossati nel febbraio del 1313, e di non in-cludere gli uomini di Monterappoli nelle spese «fortificationis vel constructionis castri et fossorumEmpolis» nel marzo successivo. ASF, Archivi della Repubblica, Signori. Minutari, 3, nn. 20, 47,ed. in Acta Henrici VII. Romanorum Imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum hi-storiam illustrantia, 2 voll., Firenze, Cellini, 1877, II, pp. 224, 239.
— 105 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
struzione di ponti levatoi sulla porta aperta di recente nel circuito murario.18
Osservando il catasto di eta lorenese, si puo notare un restringimento dellastrada proprio in corrispondenza dell’allineamento suggerito dal Chiarugi:con ogni probabilita si tratta del sedime della porta che si potrebbe chiamaresemplicemente ‘Nuova’ e che al tempo del Convegno ghibellino non esistevaancora.
A sud i riferimenti sono piu labili. Qualche tempo fa e stato rintracciatonel convento agostiniano di Santo Stefano un possente muro, dubitativamenteattribuito a questa cerchia.19 La ricostruzione trecentesca del complesso20 im-plico certamente lo sconvolgimento della situazione viaria e immobiliaria pre-cedente, rendendola illeggibile. E dunque probabile che una parte della vec-chia cortina, slegata da altre strutture fortificatorie e dall’organizzazione viariae fondiaria primitiva, sia rimasta inglobata nella realizzazione del convento do-po la meta del Trecento.
Accettando questa ipotesi, va notato che il tratto meridionale delle mura sidistanzierebbe assai dalla strada (attuale via dei Neri) lasciando una profondi-ta sufficiente alla costruzione di case a schiera con resede posteriore. E dun-que e possibile che il provvedimento del 1281 di riparare le mura in rovina21
possa riferirvisi, in quanto fu concesso di ampliare le case con pali e muri finoa sostenere le strutture militari, imponendo pero il rispetto della strada fra l’e-dificato e il circuito («non impediendo corsorium et viam corsorii dicti mu-ri»).
Anche su questo lato si apriva una porta, suggerita dall’esistenza appenafuori dal castello di un borgo detto della Salaia (documentato nel 1333),22 cor-rispondente alla via Salaiola (attuale via Ridolfi), il cui inglobamento all’inter-no delle mura risale al pieno Duecento, come si vedra.
A ovest il passaggio della cerchia e indicato dalla posizione del Palazzovecchio dei Guidi, precisamente descritta per ben tre volte fra il 1254 e il
18 ASF, Signori. Minutari, 5, n. 98.19 M. RISTORI, Le mura di Empoli nuovo, «il Segno d’Empoli», VII (1994), 27, pp. 10-11.20 W. SIEMONI, La chiesa ed il convento di S. Stefano degli Agostiniani a Empoli, Castelfiorenti-
no, Societa storica della Valdelsa, 1986, pp. 25-64.21 BERTI, Vita empolese, cit., pp. 25, 37-38.22 «Item una domus cum curia et logia et cum domuncula post ipsam domum posite in dicto
populo [Sancti Andree de castro de Empoli] extra dictum castrum in burgo della Salaia loco dicto».ASF, Notarile antecosimiano, 3062, c. 87v, cit. da PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 438; II, p. 84,che offre diverse letture e interpretazioni del documento (quasi illeggibile).
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 106 —
1255: l’edificio si trovava davanti alla pieve e al mercatale e confinava con lecarbonaie, trovandosi sopra le ripe o fossi del castellare di Empoli.23 Esso eidentificabile con l’attuale Palazzo Ghibellino,24 ritenuto tradizionalmente lasede del Convegno del 1260. Le fortificazioni passavano dunque per l’irrego-lare allineamento che si puo notare con il retro del suddetto palazzo.
Verso Pisa si aprivano due porte, menzionate con una certa precocita:quella della Noce, lungo via Del Papa, nel 1281;25 quella cosiddetta dell’ospe-dale, al termine di via del Giglio, nel 1283.26 Entrambi i nomi vennero trasfe-riti alle corrispondenti porte della nuova cerchia del 1336-1340.27
A nord il piu convincente indizio della posizione della cortina e offerto dairecenti dati di scavo. La struttura muraria laterizia intercettata all’altezza delnumero civico 64 di via Ridolfi ha il considerevole spessore di 125 cm, com-patibili con una fortificazione. Essa e costituita da mattoni legati con malta lecui dimensioni (cm 27,5 61464) non hanno riscontri con gli edifici empolesidatabili entro il Duecento, bensı con quelli trecenteschi:28 potrebbe dunquetrattarsi di uno dei lavori di restauro documentati all’inizio del XIV secolo.29
La traccia archeologica recentemente individuata si trova lungo l’allinea-mento del retro degli edifici che prospettano su via delle Murina, pochi me-tri piu all’esterno di quelli affacciati su via Chiara: 30 cio richiama la gia citatadecisione del 1281 con cui il consiglio del comune di Empoli concesse di am-pliare le case fino alle mura, per ripararle, senza occuparne il corridoio inter-no.31
23 I conti Guidi vendettero la «quartam partem pro indiviso totius palatii veteris, quod est su-per foveis sive ripis ipsius castellaris Empoli ante plebem Empolis» nell’agosto del 1254; la «quartampartem pro indiviso palatii veteris de Empoli, quod positum est super ripa castellaris Empoli» nelsettembre successivo; la «quartam partem pro indiviso palatii veteris de Empoli ante mercatale, quodpositum est super ripa castellaris Empoli, hos fines habens: a primo latere carbonaria, a secundo do-mini Bonaccursi, a tertio comitis Tegrimi et predicti comitis Guidonis Novelli, a quarto via publica,que est mercatale» nel maggio del 1255. ASF, Capitoli, XXX, cc. 132r, 136v, 141r.
24 Terzo dei ‘casamenti’ descritti da CHIARUGI, Della storia, cit., p. 348, a commento dei «seigrandi casamenti senza le casipole» citati dalla cinquecentesca Storietta d’Empoli scritta da un empo-lese, a cura di M. Guerrini, Empoli, ATPE, 1986, p. 39.
25 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 10r.26 Una «Domus hospitalis pauperum» e nota fina dal 1282: ivi, cc. 21r, 30r.27 FRATI-MAIURI, Nuovi studi, cit., pp. 190-191.28 Sulla mensiocronologia del laterizio in area empolese, M. FRATI, Verso un atlante delle mu-
rature a Empoli: la mensiocronologia del laterizio, «Milliarium», X, in corso di stampa.29 FRATI – MAIURI, Nuovi studi, cit., pp. 189-190.30 L. GUERRINI – W. SIEMONI, Il territorio empolese nella seconda meta del XVI secolo, Firenze,
Gonnelli, 1987, p. 99; cfr. SIEMONI, L’immagine, cit., p. 129, Fig. 64.31 BERTI, Vita empolese, cit., pp. 25, 37-38.
— 107 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
Su questo lato non si apriva nessuna porta, visto che i documenti due-tre-centeschi non vi accennano e non se ne sono trovati i resti negli scavi su viaRidolfi che – come si vedra – era la principale strada urbica con andamentonord-sud. In effetti non c’era motivo di sfondare le mura da quella parte, lam-bita dall’Arno ma distante dall’approdo. E probabilmente la causa dei danniriparati nel 1281 fu proprio il fiume che, per quel che se ne sa per Firenze,nell’intorno di due decenni esondo almeno quattro volte:32 il primo di ottobredel 1269, il 15 dicembre 1282, il 2 aprile 1284, il 5 dicembre 1288.
Ammettendo un impianto pressoche regolare, tipico degli insediamenti dipianura, e difficile pensare a una forma diversa da quella quadrangolare33 siaper la collocazione delle tracce archeologiche che per gli snodi viari delle por-te. In particolare, il ritrovamento della cortina in via Ridolfi dimostra che anord-est le mura formavano un angolo pressoche retto; lo stesso doveva avve-nire a sud-est, come suggerito dalla presenza del borgo della Salaia sulla pro-secuzione della stessa strada verso sud.
Nulla e dato sapere sull’esistenza di torri angolari e rompitratta ne di altririnforzi alle fortificazioni, anche se e presumibile la loro esistenza in corri-spondenza delle porte, come sembra ne fosse munita quella ‘Nuova’.
LA TRAMA VIARIA DENTRO LE MURA
La situazione della viabilita fra XIII e XIV secolo a Empoli (Fig. 2) nondoveva essere molto diversa dall’attuale.
Il cuore del castello era costituito dalla piazza, la cui prima attestazionerisale al 1254, quando i conti Guido Guerra e Ruggero, fratelli e figli del fuMarcovaldo conte palatino di Toscana, vendettero al comune di Firenze la lo-ro «quartam partem pro indiviso mercatalis et platee, ubi fit mercatum deEmpoli».34 Piazza e mercatale sembrano essere la stessa cosa, come risulta an-cora nel 1325-1328,35 quando si parla di una ‘piazza del Mercatale’. Affacciati
32 VILLANI, Cronica, cit., libro VIII, capp. 34, 88, 97, 126. Sul rapporto di Firenze col Fiume, F.SALVESTRINI, Libera citta su fiume regale. Firenze e l’Arno dall’Antichita al Quattrocento, Firenze,Nardini, 2005.
33 A lungo ha tenuto banco una fantasiosa ipotesi locale che voleva per Empoli un tracciatoottagonale di sapore vitruviano: Cenni storici e guida turistica della Citta di Empoli, a cura di A. Mo-relli, Empoli, Comune di Empoli, 1975, p. 59.
34 Documenti, cit., II, p. 65.35 PIRILLO, Forme e strutture, cit., II, p. 439.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 108 —
sulla piazza si trovavano alcuni dei principali edifici del castello: la pieve diSant’Andrea, il vecchio palazzo comitale e dieci botteghe, tutti beni rimastiin totale possesso dei conti Guidi fino al 1255, quando fu completata la ven-dita del patrimonio da tre dei quattro rami della famiglia.
Il mercato,36 connaturato alla spianata antistante alla pieve probabilmentefin dalle sue origini, si svolgeva non solo nella piazza ma anche nelle stradecircostanti, come del resto accadeva un po’ in tutte le citta medievali ancoraoggi. Del suo buon funzionamento si preoccupo anche la Repubblica, che siappresto a intensificarne la sorveglianza.37
L’asse viario principale era costituito dall’attuale via del Papa che corre asud della piazza. Esso e tardivamente attestato presso la porta Fiorentina co-me ‘ruga da Piazza’ (1319),38 «ruga que respondet porte Florentine» (1339)39
oppure ‘ruga di Piazza’ (1350).40 L’idea che traspare dalle sue diverse defini-zioni e quella di un breve collegamento fra il mercatale e la porta Fiorentina,come se la piazza (altrove definita «via publica, que est mercatale»)41 si affac-ciasse direttamente sull’attuale via G. Del Papa, comprendendone una parte.
Dalla parte opposta, verso Pisa, il breve tratto che collegava il mercatalealla porta della Noce prendeva il nome di «contrata Porte Nucis» (1337)42
e forse girava verso sud costeggiando le mura fino all’angolo sud-ovest.Piu a sud, nella stessa direzione, si dipanava la via Ombretta, la cui piu
antica attestazione risale pero soltanto al 1367, dove si trovavano alcune casedi proprieta del convento agostiniano e dove ne sarebbe sorta la chiesa.43
A nord della piazza correva una seconda strada che attraversava il castelloin direzione est-ovest, dalla porta all’Ospedale a quella ‘Nuova’; essa era chia-
36 Sul funzionamento del mercato empolese, C.M. DE LA RONCIERE, Firenze e le sue campagnenel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, Firenze, Olschki, 2005, p. 155.
37 Il 19 febbraio 1282 si delibero «quod domini XIIIIcim hodie eligant tres et plures officiales, et
mittant eos Empoli». Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall’anno 1280 al 1298, 2 voll. a cura diA. Gherardi, Firenze, Sansoni, 1896-1898, I, p. 66.
38 «in castro, loco dicto Ruga da Piazza prope portam Florentinam» . PIRILLO, Forme e strut-ture, cit., I, p. 439.
39 ASF, Notarile antecosimiano, 13464, c. 38v.40 Ivi, 20642, c. 52v.41 Nota 23.42 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.43 ASF, Diplomatico, Empoli, S. Stefano (agostiniani), 1367 giugno 29. Cfr. SIEMONI, La chiesa,
cit., p. 28. Su questo episodio dell’urbanistica empolese e dell’architettura agostiniana converra ritor-nare in una sede piu opportuna.
— 109 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
mata via di Borgo Nuovo e corrispondeva all’attuale via del Giglio. La piu an-tica menzione della strada si trova in un atto del 1281 di vendita di una casaconfinante con la via e con un chiasso.44
Anche piu tardi (1311)45 il borgo appare innervato di chiassi fra una pro-prieta e l’altra, con torri e case dal carattere introverso e autosufficiente46 cheriflettono una concezione ancora in parte difensiva dell’abitare.
Questo piu antico Borgo Nuovo non e da confondere con la «istrada detaBorgo nuovo» e il «rischontro del Borgo nuovo», cosı chiamati nel XVI seco-lo47 per la loro recente sistemazione e corrispondenti all’odierna via Marchet-ti.
Ancora piu a nord si trova via Chiara, ricordata numerose volte dalle fonticon questo stesso nome. Su di essa si affacciavano case, orti, cortili che testi-moniano in pieno Trecento (1324, 1333, 1337, 1342, 1345)48 una certa dispo-nibilita di terreno agricolo all’interno delle mura. Via Chiara e l’unica stradaperfettamente rettilinea e a larghezza costante del castello: caratteri che si spo-sano alla regolarita e compattezza dell’edilizia circostante che manifestano l’a-desione ai modelli urbanistici piu aggiornati e di stampo popolare.
L’unico asse nord-sud completo era costituito dal borgo, ruga o via deiSalari, della Salaria o della Salaia, come vien chiamata fra 1281 e 133549 lavia Salaiola che nel suo tratto finale e oggi dedicata a Cosimo Ridolfi. Essaproveniva dalle saline di Volterra per portare il salgemma a Empoli e daqui in tutto il medio Valdarno.50 Nel castello due-trecentesco non aveva un
44 «unam domum positam in Empoli in burgho Novo cui a I via, a II classus, a III heredes Corsi,a IIII Peri Soffredinghi». ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 5v.
45 «domus posite in populo Sancti Andree de Empoli in castro de Empoli in via que diciturBurgus Novus cui... a primo via, a secundo Forensis ser Guidonis, a tertio Scheruccii Loteringhiet chiassus in medio, a quarto domini Bonifatii infra predictos confinos totam dictam domum»ASF, Notarile antecosimiano, 8910, c. 83v.
46 «unam domum in castro de Empoli in Burgo Novo cum quodam claustro posito cui a I via, aII Peri Soffredinghi murus comuni in medio usque ad altitudinem dicte domus vendite abinde nonsuper debet dictus Perus requagliari de maiori..., a III Boninsengne filii Bonacchursi de Empoli etcum toto puteo et claustro, a IIII Iohannis Degii murus comuni in medio vel alios»: ivi, 11550, c. 38v.
47 GUERRINI – SIEMONI, Il territorio, cit., pp. 97-107.48 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.49 Per le numerose e varie attestazioni, BERTI, Vita empolese, cit., p. 27, nn. 53-54; PIRILLO, For-
me e strutture, cit., I, p. 439.50 La distribuzione del sale a Empoli dovette essere avviata gia nel Duecento: V. ARRIGHI, Le
origini del Magazzino: la Gabella del sale, «Quaderni d’Archivio. Rivista dell’Associazione Amici del-l’Archivio Storico Comunale di Empoli», I (2011), pp. 15-28: 15-16. Una prima attestazione di unasocieta di empolesi impegnati nella vendita risale al Trecento: ASF, Diplomatico, Firenze, S. Miniatoal Monte (olivetani), 1327 maggio 16.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 110 —
proprio sbocco al fiume ma, probabilmente, terminava contro le mura colle-gandosi al corridoio infra muros.
Alla distanza di un isolato piu a ovest della via Salaria, e ad essa parallelo,si trovava il borgo al Pesco, di cui si e conservato il microtoponimo e il trac-ciato completo fino alla creazione dell’attuale piazza del Popolo. Esso dovevacomprendere via del Gelsomino e via del Pesco (piazza del Popolo), terminan-do contro le mura senza pero attraversarle: proprio in questo punto nel 1331era situata una casa confinante sia con la strada sia con la cortina.51
I BORGHI EXTRAMURALI
Benche all’interno delle mura non mancasse il terreno edificabile, nel cor-so del tempo si formarono alcuni borghi lungo le strade in uscita dal castello.
A est, fuori dalla porta Fiorentina, gia nel 1323 e attestata la presenza diun casamentum, cioe di un gruppo di alloggi piu consistente di una semplicecasa, dotato di muri, forse di protezione o piu semplicemente a recinzione diun cortile non documentato.52 Gia nel 1333, all’indomani dell’alluvione, illuogo era indicato come Borgo di porta Fiorentina53 e pochi mesi dopo comeBorgo Superiore di Empoli.54
Il borgo si estendeva davanti alla porta Fiorentina, com’e sempre indicatocon chiarezza dai documenti, ma probabilmente anche fino alla porta ‘Nuo-va’. Le due strade – la ruga di Piazza e il borgo Nuovo – uscendo dal castellosi dovevano presto ricongiungere nella via Pisana per Firenze dove poco oltresi trovava l’ospedale di Santa Lucia a Pietrafitta (nel popolo di San Michele aPontorme ma al di qua del torrente Orme), citato per la prima volta nel1349.55
51 «Item dimidiam pro indiviso unius domus quae inhabitatur posita in castro de Empoli inburgo al Pesco cui sunt confines a I via publica, a II Dree Berti, a III Francisci Berti, a IIIIº muruscastri de Empoli». ASF, Notarile antecosimiano, 13464, c. 8v.
52 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.53 ASF, Notarile antecosimiano, 3062, c. 87v.54 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 438. Il borgo orientale riuscı forse subito a emergere
dalle acque, trovandosi a 1-2 metri piu in alto del borgo occidentale e della zona settentrionaledel castello.
55 L. RIGOLI, La storia di Puntormo d’un Accademico Colombario, «Bullettino Storico Empole-se», V (1961), pp. 279-311: 304. GUERRINI – SIEMONI, Il territorio, cit., pp. 252-253.
— 111 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
A sud, come si e gia visto, si sviluppava il Borgo della Salaia, dove nel1333 e attestata una casa con una casetta, una corte e una loggia.56
Il borgo aveva due poli d’attrazione: la porta corrispondente alla via Sa-laiola e il convento agostiniano. Il primitivo complesso religioso, fondato en-tro il 1291 e dotato di una chiesa nel 1295-1296,57 nel 1311 appariva prossimoal fossato del castello,58 probabilmente nella stessa posizione occupata dalnuovo insediamento che, con la costruzione di piu ampie difese dopo l’allu-vione, si trovo protetto dal nuovo circuito murario.
La scelta dei frati e indicativa del rango ormai raggiunto da Empoli, la cuipopolazione poteva ben sostenere con donazioni in danaro e in beni mobili eimmobili una nuova comunita religiosa. Come spesso accadde nelle citta me-dievali, il convento fu collocato all’esterno delle mura, dove i terreni valevanomeno e dove gli agostiniani speravano di poter esercitare il loro apostolato piuliberamente, visto che nel 1117, prima ancora della fondazione del castello(1119), il pievano e i canonici di Sant’Andrea avevano ricevuto dal vescovoGottifredo degli Alberti il diritto di veto sulla costruzione di chiese, abbaziee cenobi nella parrocchia della pieve, poi confermato loro dai conti Guidoe Imilia.59
A ovest, ancor prima che a est, si era formato un borgo fra le due stradeper Pisa. Gia nel 1312 se ne ha notizia, quando avvenne la nomina del gover-natore dell’ospedale della Misericordia, ubicato proprio in prossimita dellaconfluenza delle due vie.60 Accanto all’ospedale, solo due anni dopo, vennevenduta al convento dei frati agostiniani una casa con orti,61 a dimostrazionedi una vocazione ancora rurale dell’area.
56 Nota 22.57 SIEMONI, La chiesa, cit., pp. 25-26.58 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, pp. 438-439.59 F. BERTI, Il piviere empolese dalle origini al XIII secolo, in Sant’Andrea a Empoli. La chiesa del
pievano Rolando. Arte, storia e vita spirituale, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1994, pp. 15-38, nn. 4-5.
60 «domus Misericordie posita prope castrum de Empoli inter duas stratas quibus itur versusPisas per dominum Ioseppum olim domini Gratie et filios de Empoli de ipsorum propriis bonis con-structa et hedificata fuit et deputata cum suis possessionibus et pertinentiis pro recipiendo et sub-stando pauperibus Christi ad ipsam domum confluentibus». ASF, Notarile antecosimiano, 16938,cc. 12r-12v.
61 «unam domum ad una stariora terre ortalis positam prope hospitale de Empoli cui domui etterre hos dixerunt esse confines: a I strata publica, a II Donati et Balduccii fratrum et filiorum serArmanni, a III et IIII Passarini Masschi. Ivi, c. 120r. Sulla base di questo possedimento, SIEMONI,La chiesa, cit., p. 27, ha ritenuto che la primitiva collocazione del convento agostiniano fosse qui.Sulle case dei frati in borgo, GUERRINI – SIEMONI, Il territorio, cit., pp. 187-188.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 112 —
Il borgo, come quello verso Firenze, aveva dunque gia assunto una forma
triangolare, con ai vertici le porte urbiche (qui quelle alla Noce e all’Ospedale)
e l’ente assistenziale che, trovandosi in aperta campagna, poteva esercitare la
propria attivita ventiquattr’ore su ventiquattro.
A nord non si puo parlare di un vero e proprio borgo, mancando un asse
stradale intorno al quale collocare edifici e attivita. Semmai e l’Arno, fonte di
energia e mezzo di trasporto a costituire un’attrattiva per alcuni piccoli inse-
diamenti poco distanti dal castello. Non molto spazio doveva esserci fra il ca-
stello e il fiume, se nel 1269, per rappresentare i beni di Buonaccorso di Bel-
lincione degli Adimari nel castellare di Empoli, bastava indicare come confini
l’Arno e la via Pisana.62
Accanto al castello, verso nord-ovest, si trovava una porzione di terra di
cinquanta staia a corda (3,5 ha), detta ‘Piaggia’ e situata nel 1254 «prope pa-
latium novum predictum, inter ipsum palatium et flumen Arni».63 Essa con-
finava anche con l’Arno e la curia di Pontorme, il cui limite settentrionale era
solcato da un fosso, detto ‘fossa Tagliata’;64 il castello e il fosso distavano al-
cune centinaia di metri,65 percio la Piaggia doveva consistere in un lungo lem-
bo di terra affacciato sull’Arno. Nel 1320 questo luogo era certamente abita-
to66 e nel 1342 ospitava un podere completo di casa, corte, pozzo, canali
vinari, colombaia e resede.67
Lungo l’Arno si trovava un porto, detto ‘di sopra’ nel 1283,68 presso il
quale erano gia installati due mulini. In portu – com’era anche denominata
Empoli romana69 – doveva essere collocato a nord-ovest del castello verso
62 Liber Extimationum, cit., n. 398.63 «quinquaginta [staria] ad cordam, et si plus eis pertinet, de terra et plagia posita prope pa-
latium novum predictum, inter ipsum palatium et flumen Arni, cui plagie a primo est dictum pala-tium et flumen Arni, II terra ponturmese, III flumen Arni». ASF, Capitoli, XXX, c. 132r.
64 «Fines vero seu confines curtis sive curie Empolis hi sunt: ex parte deversus Ponturmum iux-ta Arnum est quidam sulcus, qui est in medio, dividens plagias comitum a plagiis Ponturmensium» e«Hii sunt confines inter Empolenses et Ponturmenses: et ex parte occidentis est quedam fovea quevocatur fovea Talliata et tenet unum capud ad flumen Arni». Ivi, cc. 135r, 144r.
65 Cosı appaiono nelle mappe dei Capitani di Parte Guelfa: GUERRINI – SIEMONI, Il territorio,cit., pp. 177-181, 247-249.
66 Alcuni abitanti della Piaggia del comune di Empoli intervengono a un atto: ASF, Diploma-tico, Empoli, S. Stefano (agostiniani), 1320 agosto 21
67 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.68 BERTI, Vita empolese, cit., p. 29, n. 60.69 Da ultimo, W. MAIURI, La citta, il territorio, il porto: Empoli in eta romana, «Milliarium», VII
(2006), pp. 28-39.
— 113 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
l’attuale contrada di Rozzalupi dove si trovano i resti del piu antico mulinonoto a Empoli.70
Presso il fiume erano impiantate anche altre attivita produttive, come unafornace ad Arnum dotata di terra (si puo immaginare argillosa, utile al confe-zionamento di laterizi e ceramica) nel 1324.71
LA RICERCA DI MODELLI URBANISTICI
La situazione del castello, ormai cristallizzata fra XIII e XIV secolo, sem-bra rispettare un piano preordinato, i cui elementi caratterizzanti sono la for-ma quadrata, la piazza al centro, la bipolarita pieve-mercato, la doppia viabi-lita est-ovest. Cosı e stato finora immaginato che fosse il castello guidingo findalla fondazione nel 1119.72
Ma se si mette a confronto Empoli con i rarissimi centri di pianura fondatiin Toscana dai grandi signori laici ed ecclesiastici dal XII secolo in poi,73 pocosi trova in comune. I grossi castelli feudali erano collocati prevalentemente inaltura e il loro impianto risulta spesso irregolare, dovendo obbedire all’anda-mento del terreno collinare. Nel Valdarno, San Genesio (in corso di scavo),Pontorme (entro il 1120) e Bientina (1179-1181) mostrano una complessitamolto limitata rispetto all’impianto empolese, a cui si puo paragonare soloil grosso castello guidingo di Montevarchi la cui cronologia (fra il 1217 e il1254) e pero decisamente tarda. Anche molte abbazie erano state fondatesu terreni pianeggianti e vennero solo molto piu tardi circondate da muradal perimetro regolare (Sant’Antimo, Badia Isola, Settimo) ma, essendo lonta-ne dagli assi viari e costituendo esse stesse dei poli di autonoma organizzazio-
70 C. PAGLIAI, Il magazzino del sale sull’Arno, «Il Segno d’Empoli», XVII (2004), 65, pp. 5-6;66, p. 5. I due mulini sono probabilmente ancora gli stessi ricordati all’inizio del Trecento: PIRILLO,Forme e strutture, cit., I, p. 439.
71 Ivi, p. 438.72 M. RISTORI, Le mura di Empoli nuovo, «il Segno d’Empoli», VII (1994), 27, pp. 10-11.73 Da ultima, M.E. CORTESE, Assetti insediativi ed equilibri di potere: Semifonte nel contesto del-
le nuove fondazioni signorili in Toscana, in Semifonte in Val d’Elsa e i centri di nuova fondazione del-l’Italia medievale, atti del convegno nazionale (Barberino Val d’Elsa, 12-13 ottobre 2002) a cura di P.Pirillo, Firenze, Olschki, 2004, pp. 197-211: 201; EAD., Castra e terre nuove. Strategie signorili e cit-tadine per la fondazione di nuovi insediamenti in Toscana (meta XII-fine XIII sec.), in Le terre nuove,atti del seminario internazionale (Firenze-San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), a cura di D.Friedman e P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2004, pp. 283-318: 298-303; EAD., Una potenza in ascesa.Formazione, geografia e struttura dei domini guidinghi in territorio fiorentino (secoli X-XII), in La lun-ga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana, atti del convegno di studi (Mo-digliana-Poppi, 28-31 agosto 2003) a cura di F. Canaccini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 245-266: 258.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 114 —
ne territoriale, la loro distribuzione interna appare tutta incentrata sulla chiesae sul chiostro e priva di percorsi scoperti.
E, piuttosto, all’urbanistica del XIII secolo74 che si deve guardare per tro-vare sufficienti analogie. Esse, pero, sono solo esteriori, in quanto lo schema diEmpoli non e il risultato di una pianificazione coerente ma di una serie di am-pliamenti successivi, che ora vanno analizzati in sequenza.
LA DINAMICA INSEDIATIVA: IL PRIMO NUCLEO DEL CASTELLO LUNGO LA STRADA
E INTORNO AL BIPOLO PIEVE/MERCATALE
Com’e noto, il 10 dicembre 1119 la contessa Emilia degli Alberti, mo-glie del Conte Guido Guerra, prometteva a Rolando, pievano di Empoli,di far venire gli uomini dei popoli del distretto di Impori (Santa Maria,San Lorenzo, San Donato, San Mamme, San Michele, Santo Stefano, SanCristoforo, San Giacomo, San Pietro, San Martino di Vitiana, San Bartolo-meo, Santa Maria di Pagnana, San Rufino, San Giusto, Santi Simone e Giu-da), degli altri castelli e di Cittadella, dei borghi e dei villaggi ad abitarepresso la pieve di Sant’Andrea, dando a ciascuno un lotto per edificare lapropria casa, e costruirvi un castello, di cui il prelato veniva investito feu-dalmente.75
Il nuovo castello avrebbe sostituito come capoluogo della curia di Empoliil vecchio castrum, la cui esistenza e comprovata da documenti inediti di pochidecenni precedenti,76 situato lungo la via Pisana circa un miglio piu a ovest inlocalita Empoli Vecchio, com’e suggerito – oltre che dal facile toponimo –dall’incrocio di documenti duecenteschi, che collocano la chiesa di Santa Ma-ria a Ripa «in Castello» (1254)77 e «de Empoli Veteris» (1269),78 nel cui po-polo e attestata una ‘sospetta’ «domum mangnam cum curia et duas alias do-mos [...] quandam aliam domum ibidem, via in medio», che fa pensare a uncomplesso fortificato, residuo del castello guidingo, forse rimasto al ramo diTeudegrimo.
74 E. GUIDONI, Storia dell’urbanistica. Il Duecento, Roma-Bari, Laterza, 1989; D. FRIEDMAN,Terre nuove. La creazione delle citta fiorentine nel tardo medioevo, Torino, Einaudi, 1996, p. 129,n. 44; Le terre nuove, cit.
75 BERTI, Il piviere empolese, cit., n. 5.76 ASF, Diplomatico, Passignano, S. Michele (badia, vallombrosani), 1098 agosto; Passerini (do-
no), 1104 novembre 21.77 ASF, Capitoli, XXX, c. 136v.78 Liber Extimationum, cit., n. 389.
— 115 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
Il castrum di Empoli e il suo distretto restarono di pertinenza dei contiGuidi, salvo qualche intermittenza (1147-1164,79 1182-118780) e nonostantelo svuotamento progressivo dei loro diritti dal 1197 in poi,81 fino alla venditadei beni allodiali del 1254-1255, conclusasi solo nel 1273 con la sua confermada parte di Guido Salvatico.82
Le fonti duecentesche sono concordi nel distinguere fra un castelluccio o«castellare iuxta plebem» e il castrum vero e proprio. Il primo, ancora circon-dato da ripe e fossi nel 1254-1255 e quasi tutto di proprieta dei conti Guidi,puo essere considerato il nucleo castrense che comprendeva la pieve, la piazzacon le botteghe e il primo palazzo comitale (Fig. 3).
Del complesso pievano molto e stato scritto:83 qui e sufficiente richiamareil fatto che alla fondazione del castello la chiesa era probabilmente completadelle strutture essenziali a definirne la spazialita romanica. Essa, datata 1093da una tarda iscrizione che ne segna verosimilmente l’inizio, era forse ancorain piena costruzione nel 1106, quando per un atto di donazione di beni al pro-posto empolese si dovette ripiegare sulla meno rappresentativa, ma gia agibile,vicina chiesetta di San Giovanni Battista.84
Pieve e battistero, entrambi a pianta longitudinale, risultano ancora oggiaffiancati, invece che disposti assialmente come nella maggior parte dei casi
79 Dopo la resa del castello guidingo di Monte di Croce (1146-1147), gli empolesi aprirono leporte ai fiorentini: G. LASTRAIOLI, Empoli tra feudo e comune, Empoli, Editori dell’Acero, 20062, p.49. Ma dopo la morte del padre Guido Guerra II (1157) e alla fine della ‘reggenza’ della zia Sofia(1164), il conte Guido Guerra III ricevette conferma di «Impolim cum sua curte» da Federico II: N.RAUTY, Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana: le origini e i primi secoli (887-1164), Fi-renze, Olschki, 2003, n. 226.
80 Nel 1182 gli Empolesi promisero di portare a Firenze per San Giovanni un cero piu grosso diquello dei Pontormesi, vassalli dei conti Alberti, dichiarando di far parte del contado fiorentino: Do-cumenti, cit., I, p. 17. Nel 1187 l’imperatore Enrico VI limito il dominio di Firenze entro confinimolto angusti, reintegrando di fatto i Guidi della perdita – fra gli altri feudi – della corte di Empoli,che fu loro formalmente confermata con privilegio imperiale nel 1191: G. LAMI, Sanctae EcclesiaeFlorentinae Monumenta, 4 voll., Florentiae, Typographeo Deiparae, 1758, I, p. 671; LASTRAIOLI,cit., pp. 52-58.
81 L’istituzione della Lega Tuscia nel 1197 stabilı chiaramente l’assoggettamento del contadoalla citta: ivi, p. 59. I successivi diplomi imperiali di conferma (LAMI, Sanctae ecclesiae, cit., I, pp.70, 675) inviati da Federico II ai figli di Guido Guerra III (1220) e al conte Guido di Romena dopola divisione fra i quattro rami della famiglia (1247) non modificarono la sostanza dei rapporti: LA-
STRAIOLI, cit., pp. 60-61.82 ASF, Capitoli, XXIX, cc. 157r-157v, ed. da I. DA SAN LUIGI, Deliciae Eruditorum, 25 voll.,
Firenze, Cambiagi, 1770-1786, VIII, pp. 129-134.83 Si rimanda all’intervento di Italo Moretti in questo convegno.84 BERTI, Il piviere, cit., n. 2. Nel 1117 la pieve era intitolata anche al Precursore oltre che al-
l’Apostolo: ivi, n. 3.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 116 —
rurali di eta romanica.85 Il motivo di tale relazione, obliterata dalla costruzionedel campanile e del corridoio di San Giovanni, puo essere ricercata nella ne-cessita di non ingombrare il mercatale e di non mescolare le funzioni sacre aquelle commerciali che – soprattutto nel caso della fiera del bestiame – ave-vano risvolti poco igienici e non sempre decorosi.
Ma veramente insolito per la Toscana appare il netto isolamento del bat-tistero dalla pieve, quasi a voler imitare uno schema piuttosto diffuso nellaLombardia protoromanica, dove pero si tratta di edifici a pianta centrale. AEmpoli, invece, sembra che abbiano prevalso ragioni di ordine piu praticoche liturgico: semplicemente, l’aderenza alla pieve era impedita dalla presenzadi uno spazio pubblico.
Bisogna infatti immaginare che prima della fondazione del castello la pievedi Empoli si trovasse – come quella di San Genesio – lungo la via Fiorentina-Pisana e ad essa affiancata. Il mercatale posto di fronte alla chiesa si offrivacome un’espansione trasversale della strada, probabilmente piu larga dell’at-tuale piazza Farinata degli Uberti.
Le mura del primitivo castello ebbero il compito di proteggere il complessodella pieve, il mercatale e una congrua superficie per ospitare la popolazionerurale che avrebbe dovuto trasferirvisi costruendovi le proprie case. Percio ilprimo nucleo insediativo prese una forma allungata che dipendeva dalla longi-tudinalita della strada, dalla disposizione bipolare della pieve e della piazza edalla larghezza del mercatale. La via pubblica proseguiva protetta all’internodelle mura per due brevi tratti a est e a ovest della piazza: di essi resterebberotracce materiali nel vicolo fra le vie del Gelsomino e Ridolfi, e nei prospetti in-terni al n.c. 13 di piazza Degli Uberti, proprio a fianco di Palazzo Ghibellino.86
Il limite occidentale del castello era segnato dal palazzo vecchio dei Guidiche, come si e visto, e identificabile con il Palazzo Ghibellino. Nel 1255 essoera serrato a nord dai beni di Bonaccorso degli Adimari e a sud da una cucinadi esclusiva pertinenza dei conti Guido Novello e Teudegrimo che confinavacon i beni degli eredi di Baldovino Mazzangone e Fede.87 Le tracce dell’antica
85 M. FRATI, Lo spazio del battesimo nelle campagne medievali, in L’architettura del battistero.Storia e progettazione, a cura di A. Longhi, Milano, Skira, 2003, pp. 85-103: 90-92; ID., Spazi di gioia.I battisteri in Toscana dalle origini al tardo Medioevo, in Rinascere dalle acque: spazi e forme del bat-tesimo nella Toscana medievale, a cura di A. Ducci e M. Frati, Ospitaletto, Pacini, 2011, pp. 43-91:53-54.
86 M. RISTORI, Il decumano massimo, «il Segno d’Empoli», XV (2002), 59, pp. 5-7.87 «medietatem pro indiviso unius domus posite iuxta predictum palatium ante mercatale, que
— 117 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
via indicano che il palazzo ne controllava il passaggio verso ovest fra il merca-tale e – si deve supporre – la porta verso Pisa.
La sua consistenza originale e svelata da vecchie foto dei restauri al Palaz-zo che mostrano sotto l’intonaco muri in terra cruda a cui si appoggiano piutarde sopraelevazioni in laterizio;88 le pareti paiono costituite dall’allineamen-to perfettamente orizzontale e a giunti sfalsati di grossi blocchi di argilla cava-ta e spianata a scalpello89 con ampie fessurazioni verticali (solo raramenteriempite da mattoni e spezzoni) imputabili alla lenta essiccazione avvenutasuccessivamente sotto la protezione dell’intonaco (Fig. 4). La poverta dei ma-teriali indica l’urgenza della costruzione in una zona dove manca la pietra dacostruzione e in un tempo in cui ancora non si erano riscoperte le tecniche dicottura del laterizio (in Toscana non prima del secondo quarto del XII seco-lo);90 allo stesso tempo la lavorazione superficiale, tipica degli scalpellini, de-nota una qualita delle maestranze che imitano la muratura isodoma della pie-ve91 e le architetture del primo romanico maturo. Tutto concorre quindi adatare la struttura di Palazzo Ghibellino agli anni immediatamente successivial 1119.
Nel 1254 il limite orientale del castello era costituito dal palazzo nuovoche si trovava «super ripis eiusdem castellaris veteris sic terrafinatum: a duo-bus lateribus fovee sive carbonaria predicti castellaris veteris, a tertio terra fi-liorum Bencivenni Castagnuoli, fovea dicti palatii in medio, a quarto via pu-blica», e non distante da un terreno a sua volta posto «prope palatium novumpredictum, inter ipsum palatium et flumen Arni, cui plagie a primo est dictumpalatium et flumen Arni, II terra ponturmese, III flumen Arni»,92 quindi versonord. Si puo ipotizzare, nella totale assenza di riscontri archeologici, che il pa-lazzo possa corrispondere all’isolato circondato dall’antica via Pisana e dalle
fuit coquina dicti comitis, cum medietate soli et platee usque ad mercatale, a primo heredum Baldo-vini et Mazangonis et Fedi, a secundo mercatale, a tertio carbonaria, a quarto predictum palatiumvetus». ASF, Capitoli, XXX, c. 141r.
88 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI EMPOLI (d’ora in poi ASCE), Fondo fotografico, VII, nn.84-85, 102, 114-115, 126 = Archivio fotografico empolese, nn. 3277-3278, 3295, 3307-3308, 3318.
89 Sulla tecnica in Toscana, R. PARENTI, I materiali del costruire, in L’architettura civile in To-scana. Il Medioevo, a cura di A. Restucci, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1995, pp. 369-399: 378.
90 M. FRATI, Tracce lombarde nella Toscana protoromanica, in Architettura dell’XI secolo nell’I-talia del Nord. Storiografia e nuove ricerche, atti del Convegno internazionale (Pavia, 8-10 aprile 2010)a cura di M. Beretta, L.C. Schiavi e A. Segagni Malacart, in corso di stampa, n. 31.
91 P. TINAGLI, Le antiche «pietre» della Collegiata. Nascosto dall’organo posto sulla controfacciataun tratto dell’originario impianto murario, «il Segno d’Empoli», IV (1991), 14, p. 12.
92 ASF, Capitoli, XXX, c. 132r. Il palazzo sembra aver mantenuto la sua consistenza almenofino al 1345, quando ne viene data una descrizione (un palazzo con piu case, una curia, un pozzo,un orto: PIRILLO, cit., I, p. 439) simile a quella di un secolo prima.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 118 —
attuali vie del Gelsomino, del Giglio e Ridolfi, quindi un po’ piu a ovest didove lo collocherebbe un’ormai dimenticata tradizione.93
I due palazzi insistevano dunque sui terrapieni dei fossati che avevano so-stituito o addirittura costituivano la primitiva cinta difensiva del 1119, la cuilabilita consigliava ai notai, almeno dal 1254 in poi, l’uso del termine castella-re, cioe di vecchia fortezza. La posizione dei due palazzi comitali indica chia-ramente che il fossato passava dalle attuali vie G. Del Papa, Ridolfi, del Giglioe a meta dell’isolato di Palazzo Ghibellino.
Echi del castellare rimanevano vivi ancora alla fine del XIII secolo. Nel1280 fu affittata «unam domum cum curia retro se posita positam prope ca-strum Empoli in loco qui dicitur Castellare»94 e nel 1294 si replicava una pre-cedente proibizione di costruire oltre otto piedi sopra le ripe e i fossi del ca-stelluccio (ormai avvolto dall’espansione dell’abitato), con minaccia didemolire le strutture eccedenti.95 Ultimo riverbero dell’esistenza del castellarepuo essere considerato il cosiddetto ‘Castellaccio’: un ‘casamento’ che, secon-do l’Anonimo empolese seguito dal Chiarugi,96 «era presso la Chiesa di SanGiovanni e sulla Via Fiorentina», cioe lungo via del Papa.
Lo schema insediativo del castello empolese, con la bipolarita chiesa-piaz-za lungo l’asse stradale determinante una forma allungata (circa 220 m peruna larghezza massima di 105) come nei coevi casi toscani di crinale97 e inalcuni centri tedeschi di eta sveva,98 puo trovare solo parziali riscontri nelXII secolo nei vicini castelli: ad esempio, Vico Vallari-Borgo San Genesio99
per effetto dell’attrazione esercitata dal suo principale edificio religioso.
93 CHIARUGI, Della storia, cit., pp. 348-349: il ‘terzo casamento’.94 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 1v.95 «verum quia apparet esse concessus per comunem Florentie comuni et hominibus terre Em-
poli ius edificandi super dictis ripis et foveis usque ad certum modum et formam in altitudinemusque ad octo pedes». ASF, Capitoli, XLI, cc. 41v-42r, cit. da BERTI, Vita empolese, cit., p. 26, n.51, che la data al 1293 (al tempo del podesta Pino dei Vernacci da Cremona, che pero fu in caricanel 1294) e collega a questa proibizione una sanzione del 1296 (ASF, Capitoli, XXXV, cc. 101r-101v), relativa invece al mancato pagamento di censi arretrati (LASTRAIOLI, cit., p. 65, n. 32).
96 «Per questo sembra, che egli corrispondesse, ove e oggi la Casa dei Dazzi, e gia prossimo adun vicolo che fu distrutto nell’occasione di edificazione dell’attual prepositura [...] dee credersi cheegli appartenesse ai Guiducci». CHIARUGI, Della storia, cit., p. 349.
97 CORTESE, Castra e terre nuove, cit., p. 317.98 In particolare, il tipo della piazza del mercato con strade parallele: C. MECKSEPER, Recenti
ricerche sulle citta di nuova fondazione in ambito tedesco al tempo degli Hohenstaufen, in Le terre nuo-ve, cit., pp. 3-26.
99 Vico Wallari - San Genesio ricerca storica e indagini archeologiche su una comunita del medioValdarno inferiore fra alto e pieno medioevo, a cura di F. Cantini, F. Salvestrini, Firenze, FUP, 2010.
— 119 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
Nel Valdarno superiore, area quasi totalmente dominata dai conti Guidi,non mancano analogie. Ad esempio il particolare rapporto con la strada carat-terizza le pievi alla destra del fiume100 e anche il borgo di Montevarchi, dov’eattestato un mercatale fin dal 1164.101 Ma nulla di paragonabile alla comples-sita del capoluogo empolese.
Il castellare fu poi avviluppato da borghi cresciuti intorno alla viabilita ex-tramurale e inglobati dalle successive cinte murarie.102 La tenaglia del palazzoguidingo a ovest del castello scoraggio la nascita di agglomerati verso Pisamentre a nord era il regime torrentizio dell’Arno a sconsigliare l’edificazioneaperta. Solo a sud-est si pote sviluppare un piccolo insediamento lungo la cur-vilinea via del Pesco che, staccandosi dalla via Fiorentina, dettava la direzionedel futuro sviluppo.
IL PRIMO AMPLIAMENTO E IL BINOMIO CASTELLARE-CASTRUM
In un momento imprecisato il nuovo castello empolese era stato ampliato.Cio risulta chiaro dai documenti dal 1254 in poi in cui – come si e visto – sidistinguono il castellare dal castrum in cui era articolato l’insediamento (Fig.5).
La situazione del ‘castelluccio’, dopo la cessione dei conti Guidi, era rima-sta probabilmente la stessa, salvo che dal punto di vista patrimoniale. I benicomitali piu consistenti erano stati molto presto acquistati dai fiorentini Adi-mari, che gia avevano delle proprieta confinanti col palazzo vecchio dei Gui-di.103 E significativo che a Empoli nel 1260-1266, a seguito della sconfitta delpartito guelfo di cui erano esponenti, solo gli Adimari avessero subito gravidanni. Nel 1269 si riferisce che a Buonaccorso di Bellincione degli Adimarierano stati danneggiati «duo palatia cum quattuor domibus al castellare deEmpoli»: una proprieta tanto vasta da avere come confini l’Arno e la stra-
100 I. MORETTI, Pievi romaniche e strade medievali: la ‘Via dei sette ponti’ nel Valdarno Superio-re, in Terranuova Bracciolini e il Valdarno superiore fra Medio Evo e Rinascimento, atti della I Gior-nata di Studi in onore di Poggio Bracciolini (Ganghereto, 29 maggio 1983), Terranuova Bracciolini,Biblioteca comunale, 1986, pp. 25-70. Sul rapporto fra chiesa e strada in Toscana manca uno studiosistematico.
101 CORTESE, Castra e terre nuove, cit., p. 300.102 Cfr. BERTI, Vita empolese, cit., pp. 28-29, che li ritiene tutti fuori dal castello anche negli
anni ottanta del Duecento.103 Nota 23. Sulle relazioni, anche di parentela, fra le due stirpi di origine comitale, ivi, p. 19, n.
31, e, dello stesso autore, il contributo negli atti di questo convegno.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 120 —
da.104 Si tratta con ogni probabilita dei due palazzi dei Guidi, di tre dellequattro case occupate a vario titolo dal conte Guido Novello nel 1255105 edella casa che Buonaccorso gia possedeva a nord di Palazzo Ghibellino.106
Anche le dieci botteghe affacciate sulla piazza erano finite agli Adimari, main modo illecito:107 esse tornarono nel 1280 nella disponibilita del comunedi Firenze, che le affittava con contratti annuali.108
Il polo religioso del castello, invece, a meta Duecento si presentava assaipiu evoluto che nel 1119. Oltre alla pieve e al battistero erano stati realizzati ilcampanile, il chiostro e numerose case che lo circondavano. I nuovi edifici so-no il segno dell’avvenuto mutamento della struttura urbanistica del castello.
Il campanile e datato entro il 1267 da una tarda iscrizione tombale, untempo posta alla sua base,109 ma le sue strutture superstiti,110 realizzate inuna muratura a bozze di pietra, mostrano di essere assai precedenti. La suamole, fra la pieve e il battistero, poteva agevolmente controllare il passaggiodella strada, stringendone la carreggiata. Oppure si puo pensare che andassea occupare uno spazio pubblico dismesso. O, ancora, che avesse contribuito aprovocarne la dismissione, ingombrando la sede stradale.
Il chiostro della pieve, citato per la prima volta nel 1281, dovrebbe essersitrovato nella posizione dell’attuale.111 La sua esistenza, nelle forme presenti, eincompatibile con il passaggio della via Pisana, a meno di credere che questarasentasse il muro meridionale della pieve incuneandosi in un’angusta stret-toia col campanile (attuale cappella dell’organo).
104 «al castellare de Empoli ipsius domini Bonacorsi, I Arnus, II via, III ipsius, IIII Bonsengno-ris». Liber Extimationum, cit., n. 398.
105 Oltre alla cucina del palazzo vecchio (nota 87), i Guidi possedevano un imprecisato numerodi case nel 1230, oggetto della divisione fra i quattro rami della famiglia comitale: P. SANTINI, Nuovidocumenti sull’antica costituzione del Comune di Firenze, «Archivio Storico Italiano», s. 5, XIX(1897), pp. 276-325: 318-325.
106 Nota 23.107 BERTI, Vita empolese, cit., p. 19, n. 31.108 «sindicus comunis Florentie ad locandum et concedendum, pro ipsi comuni et nomine
ipsius comunis, ad pensionem apotecas comunis de Empoli pensionariis ipsarum apotecarum, seusindicis ipsarum apotecarum pro eis, a proximis kallendis ianuarii venturis ad unum annum, pro so-litis penssionibus ex nunc comuni solvendis, et cum solitis pactis et promissionibus». Le consulte, cit.,I, p. 12.
109 A. PAOLUCCI, Il Museo della Collegiata di S. Andrea in Empoli, Firenze, Cassa di Risparmiodi Firenze, 1985, p. 183.
110 Il campanile laterizio trecentesco, minato nel 1944 e rifatto ‘com’era dov’era’ nel secondodopoguerra, si appoggia a precedenti strutture lapidee. Manca uno studio di questo pur importantemanufatto.
111 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 8r. MAIURI, La citta, cit., p. 33, per lo scavo archeo-logico di una porzione del chiostro, dove e stato individuato un pozzo forse rinascimentale.
— 121 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
Accanto alla splendida facciata marmorea di Sant’Andrea nel 1284 si apri-va una bottega, circondata dalle proprieta della pieve:112 se fosse quella a de-stra, il documento non lo dice. Ma ormai la lacuna edilizia lasciata dalla strada«ante mercatale de Empoli» doveva essere stata colmata.
Solo dopo il 1281113 fu realizzato a sud della pieve e a filo della sua fac-ciata il palazzo comunale, dove il consiglio generale si riuniva «ad sonum cam-pane» nel 1326.114 La forma dell’attuale piazza Farinata degli Uberti andoprecisandosi nel corso del secolo: gia due anni dopo si era formato uno degliisolati che ne riducono la latitudine.115
Dove passava la nuova via Pisana? Dove si sviluppava il castrum? a sud o anord del castellare?
La pur eloquente documentazione del 1254-1255 non offre appigli sicuri,benche suggerisca l’abbandono delle fortificazioni su di un lato soltanto delcastellare.116 Quella, piu succinta, del 1269 sembra indicare uno sviluppo ver-so la pianura, piuttosto che verso il fiume, sempre foriero di pericoli. Anchel’estensore guelfo, che possiamo pensare sia lo stesso a rimborsare i danni diRuggero Rosso e di Buonaccorso, distingue fra il castellare, il castrum e in Em-poli. Come si vedra, i beni situati in quest’ultima piu generica localita si tro-vavano a nord. Dunque, il castelluccio del 1119 era stato ampliato a sud in-globando il borgo al Pesco e la strada pubblica si spostava sul sedime delfossato meridionale: una modalita frequente nelle addizioni con cui si sfrutta-va terreno gia demaniale.
Forse in concomitanza con l’ampliamento, fu realizzato un nuovo palazzoche nel 1254 appariva ben piu ampio di quello vecchio, essendo dotato di«curtem et claustrum et ortum»,117 tripartito ma compatto come una vera e
112 Essa confinava col mercatale, col muro della pieve e, su due lati, con i beni di essa. ASF,Notarile antecosimiano, 11550, c. 39v.
113 A quel tempo il consiglio si riuniva «in plebe Sancti Andree de Empoli». BERTI, Vita empo-lese, cit., p. 37.
114 «Actum in palatio comunis Empoli». ASF, Diplomatico, Empoli, S. Andrea (compagnia),1326 settembre 2.
115 «medietatem unius domus cum puteo et aliam, ipsam domum positam... in castro de Em-poli loco dicto piazza del Mercato, cui... dixit esse confines a I a II a III via et a IIII heredium VannisBindi vocati Zanzare». ASF, Diplomatico, Adespote (coperte di libri), 1328 marzo 6.
116 Il palazzo nuovo era circondato su due lati dai fossati del castellare (est e nord o sud): nota92; il palazzo vecchio da un terzo fossato (ovest): nota 23. Quindi, rimanevano tre lati del castellareancora efficienti mentre sul quarto (sud o nord) si affacciava il castrum.
117 Il palazzo era di esclusiva pertinenza del ramo del conte Marcovaldo: ASF, Capitoli, XXX,c. 132r. Il conte Ruggero probabilmente vi si trovo nel 1246: ASF, Diplomatico, Pratovecchio, S. Gio-vanni Evangelista (camaldolesi), 1245 febbraio 11.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 122 —
propria fortezza. Esso era a guardia dell’incrocio delle strade verso sud e versoest e il suo ruolo doveva essere, oltre che di piu comoda residenza comitale,anche quello di protezione del castello contro Firenze. Per l’epoca della sua co-struzione, si puo ipotizzare l’eta sveva (1187-1197), quando i Guidi tornaronopiu stabili nell’esercizio del proprio prestigioso ufficio di conti palatini e nelcontrollo del loro disperso territorio anche nell’ostile contado fiorentino.118
Nella prima meta del Duecento «in castro» si trovavano certamente giamolte case – anche se poche sono documentate119 – e vi doveva abitareuna buona fetta della popolazione della curia che nel 1254-1255 e stimabileintorno ai 1380 abitanti:120 cifra compatibile con l’intera nuova superficie rag-giunta dall’insediamento (piu di 3 ha)121 e non con quella del solo castellare(piu di 2 ha, parzialmente indisponibili alla residenza, essendo occupati dalmercatale e dagli edifici rappresentativi).
Resta del tutto incerta la datazione di questa fase di raddoppio. Puo essereutile ricordare che gia intorno al 1181122 gli empolesi si erano guadagnati unacerta autonomia, segno della raggiunta consistenza della popolazione locale e– si puo supporre – anche del capoluogo della curia.
Un possibile modello di addizione e fornito dalla citta arcivescovile diMagdeburgo dove nel 1152-1192 furono unificati tre diversi nuclei originaria cui fu poi aggiunta altrettanta superficie edificabile con la strada parallelaal fiume Elba posta a cerniera del ribaltamento.123
In Toscana i rari raddoppi di castelli124 ebbero piu il senso della segrega-zione sociale e/o clientelare. A Montecastelli (1202) l’insediamento nacque bi-
118 I. MORETTI, I conti Guidi e l’architettura toscana del loro tempo, in La lunga storia, cit., pp.157-169.
119 Nel 1255 Guido Novello asseriva di possedere diritti «in quadam domo posita in castro deEmpoli, que fuit olim Bottegai, cui a primo strada, a secundo Tancredi quondam Picconis, a tertiofiliorum Giunte Fantonis, a quarto Ughetti»: ASF, Capitoli, XXX, c. 141r. Nel 1269 Ruggero Rossodi Bellincione degli Adimari aveva una «domum in castro de Empoli, I via, II Inghirrami, III Volte, IIII
plebis de Empoli»: Liber extimationum, cit., n. 389.120 S.M. COLLAVINI, Le basi economiche e materiali della signoria guidinga (1075 ca.-1230 ca.), in
La lunga storia, cit., pp. 315-348: 337, n. 62; F. SALVESTRINI, Empoli, uno snodo tra Valdelsa e medioValdarno (secoli XI-XIII), «Miscellanea Storica della Valdelsa», CXVI (2010), pp. 11-19: 16. La cifrae ricavata dall’elenco dei fedeli e dei clienti di tre dei quattro rami dei conti Guidi ma si tratta di unaquantita per difetto perche il calcolo non puo tenere conto dei liberi esclusi dalla clientela.
121 La superficie corrisponde alla latitudine (155 m) per la longitudine (230 m) del castello.122 E. MANCINI, I ceri di Empoli e Pontorme a San Giovanni, «Miscellanea Storica della Valdel-
sa», L (1942), pp. 109-112.123 E. GUIDONI, Storia dell’urbanistica. Il Medioevo. Secoli VI-XII, Roma-Bari, Laterza, 1991, p.
268.124 CORTESE, Castra e terre nuove, cit., pp. 287-288, 309-310, a cui si puo aggiungere A. BAR-
— 123 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
partito per ospitare gli uomini del presule volterrano e dei Guaschi di Rocca-tederighi. A Carmignano i Lambardi risiedevano nella rocca mentre il Populusnel Castello, poi ad essa riunito dalle nuove mura (1225) volute dai Pistoiesi.A Massa Marittima (1228) la Citta Nuova fu voluta dal comune finalmenteautonomo dalla signoria del suo vescovo, che continuo a risiedere nella con-tigua citta vecchia. A Gambassi, invece, il nuovo castrum di Gambassino (fra1172 e 1183) costruito in aderenza al vecchio non rispecchio la separazione frai lambardi e il popolo, entrambi dipendenti dal vescovo di Volterra e costi-tuenti insieme il comune.125
A Empoli, tutta fedele ai conti Guidi anche durante la soggezione al co-mune fiorentino, si stabilı forse una sorta di gerarchia fra la popolazione inse-diatasi nel castellare subito dopo il 1119 e quella affluita successivamente e si-stematasi prima nel borgo e poi protetta dalle mura del castrum. Il nuovoincastellamento potrebbe essere avvenuto sotto l’egida dei fiorentini negli anniottanta del XII secolo, quando il comune cittadino entro in possesso dei benidegli Alberti in Valdelsa (1184)126 consolidando il controllo sul confine occi-dentale, oppure intorno al 1200, quando la repubblica si fortifico verso Pistoiacon il castello di Montelupo (1204).127
IL BORGO NUOVO E IL SECONDO AMPLIAMENTO
L’area settentrionale del castello empolese appare caratterizzata da unastrada ampia e rettilinea (via Chiara), da isolati di grandi dimensioni e da lottiregolarmente disposti (Fig. 6). Cio basterebbe a dimostrarne la seniorita ri-spetto alla zona meridionale dove la viabilita e curva e i piccoli isolati sonoseparati da numerosi chiassi.
Se nel 1281 la sua strada principale (via del Giglio) era ancora chiamata«Burgho Novo»,128 essa doveva risalire a non molto tempo prima ed essereforse l’ultimo fra gli assi viari cresciuti intorno al castellare. Del resto, la proi-
LUCCHI, Societa e istituzioni a Carmignano tra XII e XIV secolo, in Carmignano e Poggio a Caiano:Agricoltura, proprieta e territorio fra Medioevo ed Eta contemporanea, cura di A. Contini e D. Tocca-fondi, Firenze, Edifir, 2001, pp. 35-41.
125 A. DUCCINI, «Castrum vetus et novum»: l’incastellamento a Gambassi e nel suo territorio (fineX-XIII secolo), «Miscellanea storica della Valdelsa», CIV (1998), pp. 41-56.
126 Documenti, cit., I, n. XVI.127 CORTESE, Castra e terre nuove, cit., p. 308. Montelupo fu abitato dalla popolazione di Fib-
biana, ancora suffraganea del piviere empolese nel 1206: BERTI, Il piviere empolese, cit., n. 7.128 Nota 44.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 124 —
bizione del 1294 di costruire fuori terra sui fossati del castelluccio129 dimostrache la saldatura fra castellare e castrum era ancora in corso, che si andavanosopraelevando le casupole alte solo un piano e/o si colmavano le ultime lacuneedilizie.
Una certa attivita costruttiva e infatti dimostrata negli anni precedenti daun contratto del 1284 con il quale un certo Chele di Benvenuta, vendendo adAliotto del fu Amizo una casa con chiostro nel borgo Nuovo, precisa il dirittodi impedire al vicino di costruire sopra il muro comune oltre l’altezza dellacasa in vendita.130 Essa doveva essere una delle tante della schiera affacciatasu via del Giglio: i suoi confini laterali erano infatti i due muri a comunecon le case di fianco mentre sul retro si sviluppava il chiostro col muro di re-cinzione interamente di proprieta del venditore.
Non e possibile stabilire con certezza in che momento le mura abbianoavvolto anche il borgo settentrionale. Quando nel 1281 il comune di Empolidecise di ripararle senza ricostruirle,131 probabilmente esse esistevano gia an-che da questa parte. Nella documentazione fino al 1283, pero, i beni immobilisituati qui sono sempre localizzati genericamente «in Empoli» e solo dal 1284in poi «in castro de Empoli»: puo darsi che col ripristino delle fortificazioni idiritti castrensi siano stati estesi anche al nuovo borgo. A questo punto la cintainglobo anche il borgo della Salaia,132 che sostituiva nelle comunicazioni versosud il borgo al Pesco, ormai facente parte del castrum.
La piu antica attestazione di un edificio posto «in Empoli» a ridosso delcastellare (ma non «in castro») risale al 1255,133 seguita da quella di una torrecon quattro casupole distrutte a Ruggero Rosso degli Adimari dopo il 1260.134
Questa nutrita presenza puo far ipotizzare che all’epoca di Farinata il borgomurato esistesse gia.
129 ASF, Capitoli, XLI, cc. 41v-42r. La misura di 8 piedi corrisponde a circa 3,5 m, cioe all’al-tezza di un solo piano. Per il discusso dimensionamento del piede fiorentino (circa 43 cm), M. FRATI,Resti e contesti. Le tracce dell’abbaziale protoromanica di San Salvatore a Settimo nel quadro della pre-mier art romane, in I Cadolingi, Scandicci e la viabilita Francigena, atti della Giornata di studi (Badia aSettimo, 4 dicembre 2010), «De Strata Francigena», XVIII (2010), 2, pp. 81-111: 85, 98, n. 37. Se siassume il piede come meta del braccio (58,6 cm), la misura risulta ancora piu piccola (meno di 2,5m).
130 Nota 46.131 BERTI, Vita empolese, cit., pp. 37-38.132 «in Empoli» (1283): ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 26v; «in castro» (1312): PIRIL-
LO, cit., I, p. 439.133 «domo olim Henrici Passagerii, posito, I via, II carbonaria castelluccii, III Contardi, IIII filio-
rum Braccii», in cui Guido Novello vanta dei diritti. ASF, Capitoli, XXX, cc. 141r-141v.134 «turrim cum quattuor domibus parvis in Empoli domini Rogerii Rossi quondam domini
Bellincionis, I via, II Iohannis, III Corsi, IIII Pieri». Liber extimationum, n. 389.
— 125 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
La fascia periferica del castello si riempı progressivamente di edifici dipregio materiale e/o funzionale.
Lungo la via Salaia, all’incrocio con la via Fiorentina sul sito di casa Pan-dolfini,135 venne collocato entro il 1291 il deposito del comune di Firenze,136
detto poi «l’Abbondanza».Sul borgo Nuovo si affacciavano le proprieta di un certo Piero di Soffre-
dingo, nominato come confinante nel 1281 e nel 1284.137 Con i suoi beni con-finava anche la torre degli Adimari:138 resti di questa costruzione potrebberocorrispondere al primo dei piu antichi ‘casamenti’, localizzato dal Chiarugi invia del Giglio di fronte a via del Gelsomino.139
Molte sono le attestazioni di edifici minori, che fanno pensare a una pro-gressiva saturazione del castello fra XIII e XIV secolo, dopo che il consigliocomunale, su proposta dell’empolese ser Niccolo del fu ser Amadore medico,aveva adottato una soluzione economica al problema delle mura in rovina,dando insieme un’immediata risposta alla necessita militare e soddisfazione al-la spinta speculativa offrendo la possibilita ai proprietari di ampliare le casecon pali e muri fino alla cortina.140
Lungo il borgo Nuovo, oltre alle proprieta di Piero di Soffredingo e degliAdimari, si trovavano una casa presso la porta dell’Ospedale (1283)141 e un’al-tra «in via que dicitur burgus novus» venduta a un forestiero nel 1311.142 Suvia Chiara sono documentate almeno sei case fra 1324 e 1333.143 In via Fioren-tina ne risultano solo due nel 1281144 e nel 1319.145 In piazza del mercato cin-
135 CHIARUGI, Della storia, cit., p. 349.136 «de CL libris ad eos perventis vel perveniendis de ordeo comunis quod erat apud Empoli».
Le consulte, cit., II, p. 63.137 Note 44 e 46.138 Nota 134.139 «Il primo casamento secondo l’Anonimo scrittore citato, quindi compreso nella via oggi
chiamata del Giglio, era elevato contro alla via del Gelsomino, ossia Chiasso di Malacucina; e pare,che divenisse quindi una casa del Galli, vicino al canto che a preso il nome da questa Famiglia. Que-sta Casa a gran facciata in larghezza, ma e molto alta, ma ornata di antchi pietrami, mostra nel suointerno non piccola antichita; ed il suo nuovo acquirente facendovi alcuni lavori, nel demolire alcunimuri laterali, incontrossi in alcuni muraglioni di circa due braccia di grossezza, con volta reale, e cheportando circa un braccio di calcestruzzo, par che servisse di fondamento ad una Torre antichissima,fatta di pietre, e di saldi mattoni». CHIARUGI, Della storia, cit., p. 348.
140 BERTI, Vita empolese, cit., p. 25.141 Nota 26.142 Nota 45.143 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.144 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, c. 10r.145 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, p. 439.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 126 —
que fra case e casamenti, oltre al palazzo, alle chiese e alle botteghe, nel 1312-1348.146 In via della Salaia ben sette case appaiono fra il 1281 e il 1335.147 Nelborgo al Pesco due nel 1311 e una nel 1341.148
Nella seconda meta del Duecento il castello aveva raggiunto una formapressoche quadrata (dimensioni medie 2406230 m di lato) per una superficiedi 5,5 ha che lo poneva alla stregua della Citta Nuova di Massa Marittima(1228), del castello-mercatale guidingo di Montevarchi (fra il 1217 e il1254), delle terre nuove fondate nel 1252-1255 dai Lucchesi (Camaiore, Ca-stelfranco, Pietrasanta, Santa Croce). Tali dimensioni rendevano il castelloempolese in grado di contenere piu di un migliaio di abitanti, quantita com-patibile con quella (2800) che popolava la sua curia nel 1310:149 piu del dop-pio di quelli presenti mezzo secolo prima.
Nonostante il castello fosse tripartito fra castellare, castrum e burgo, nonsembra di assistere, come invece a Colle di Val d’Elsa e San Miniato al Te-desco, a un caso di segregazione. Le fortificazioni del castellare (semplici ripee fossi) vennero progressivamente sopraelevate dalle case e colmate dalle stra-de, cosı da costituire una cerniera fra le tre aree, piuttosto che un recinto.Probabilmente, pero, i principali proprietari – i canonici di Sant’Andrea, iconti Guidi, gli Adimari, Piero di Soffredingo – non mancarono di costituireall’interno del castello delle piccole concentrazioni immobiliari (la pieve e ilpalazzo vecchio con le rispettive botteghe sulla piazza, la torre con le sue ca-supole e le case a schiera sul borgo nuovo) funzionali a raccogliere la propriaclientela.
Nonostante la crescita dell’insediamento intorno alla pieve di Sant’Andreasia avvenuta in piu fasi, la sua consistenza appare negli esiti paragonabile conl’urbanistica del tempo, adottando modelli aggiornati e – fors’anche – antici-pandone alcuni.
146 Ibid.147 ASF, Notarile antecosimiano, 11550, cc. 10r, 11r, 26v, 36v; PIRILLO, Forme e strutture, cit., I,
p. 439.148 ASF, Notarile antecosimiano, 13464, cc. 8v, 11r; Diplomatico, Empoli, S. Stefano (agostinia-
ni), 1341 agosto 19. In questa stessa zona, durante le demolizioni in piazza del Popolo, fu rintracciatauna costruzione medievale ritenuta impropriamente turriforme da G. BUCCHI, in «Miscellanea Sto-rica della Valdelsa», XLI (1933), p. 145. Sulle demolizioni, cfr. le foto di Pietro Caponi in ASCE,Fondo fotografico, V, nn. 81-88; VII, n. 1 = Archivio fotografico empolese, nn. 125, 295-300, 1586-1587.
149 F. SALVESTRINI, Empoli, cit., pp. 16-17. Ringrazio l’autore per la discussione e la segnalazio-ne di ASF, Notarile antecosimiano, 8910, cc. 81r-83r.
— 127 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO
La forma quadrata della cerchia muraria e condivisa con Pontedera (primameta del XIII secolo) e Castelfranco di Sotto ma anche con la bastide di Mira-mont de Guyenne e i centri di eta sveva di Hohenmaut e Wiener Neustadt.
La tipica bipolarita chiesa-mercatale longitudinale alla strada e comune aPontedera e alle terre nuove lucchesi di Camaiore, Pietrasanta e Santa Crocesull’Arno. La coppia di strade parallele (ciascuna con le proprie porte) che fa-sciano la piazza centrale si trovano anche a Montevarchi, nella tedesca Chem-no e nelle bastides duecentesche di Beaumont du Perigord, Monpazier, Mi-rande e Miramont de Guyenne.
La piazza disposta trasversalmente alla viabilita principale e presente aMonteriggioni (1213), Massa Marittima, Camaiore, Pietrasanta, Santa Croce,Ponsacco e, in Germania, a Neubrandenburg (1248) e Soldin-Mysliborg. Stra-de dritte e ortogonali come via Chiara a Empoli sono un carattere assai diffusonella pianificazione toscana: a Massa Marittima, nelle terre nuove lucchesi,nelle citta nuove tedesche (Neubrandenburg), nelle bastides francesi (Ville-real, 1267), che solo molto tardi compare nelle iniziative fiorentine in cittae nel contado (San Giovanni Valdarno, 1299).
La grandezza e complessita raggiunte da Empoli nel corso del Duecentoverso la fine del secolo si rivelarono insufficienti alla pressione demografica.Ad esempio, nel 1297 il vicino e simile castello di San Genesio poteva vantareuna superficie doppia, in grado di contenere ben sei chiese.150
Al Trecento appartengono infatti le prime attestazioni di abitazioni fuoridalle mura lungo le strade principali, concorrenti a formare nuovi borghi: inquello verso Pisa gia nel 1314;151 nel borgo superiore verso Firenze tre case frail 1333152 e il 1334;153 due nel borgo della Salaia verso Siena nel 1333.154
Dei tre borghi principali ne sopravvivranno solo due, quelli disposti lungola via Pisana-Fiorentina, costituendo quella formazione a barca che rende lastruttura urbanistica di Empoli cosı caratteristica e riconoscibile.
MARCO FRATI
150 Nel 1297 esistevano ancora le rovine delle sue ragguardevoli mura: dal lato nord il borgomisurava 790 braccia; dal lato sud, 720 braccia; ad ovest, 440 braccia. Dal lato est le misurazioninon poterono essere effettuate perche impediti dall’Elsa che evidentemente lambiva l’abitato. Essecorrispondono mediemente a 4506260 m (11,5 ha). R. STOPANI, La Via Francigena. Una strada eu-ropea nell’Italia del Medioevo, Firenze, Le Lettere, 1988, p. 22, n. 28.
151 ASF, Notarile antecosimiano, 16938, c. 120r.152 Nota 53.153 PIRILLO, Forme e strutture, cit., I, 438.154 Nota 22.
MARCO FRATI – WALTER MAIURI
— 128 —
APPENDICE
LO SCAVO DI VIA RIDOLFI
Tra il 16 febbraio e il 30 aprile 2010, su incarico della dott.sa Lorella Alderighifunzionario archeologo della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana e inaccordo con l’Ufficio Tecnico del Comune di Empoli, e stata effettuata dall’Associa-zione Archeologica Volontariato Medio Valdarno, nella persona dello scrivente, lasorveglianza archeologica ai lavori di risanamento conservativo e nuova pavimentazio-ne del piano stradale di via Ridolfi nel tratto compreso tra via del Giglio e via Salva-gnoli.
Il progetto prevedeva la sostituzione, con nuova tubatura della condotta idricadell’acquedotto comunale di via Ridolfi.
Per far cio si e reso necessario procedere alla realizzazione di una trincea profon-da tra m 1,60 e 1,80 (rispetto al vecchio manto stradale in catrame) e di larghezzavariabile tra m 1,30 e 1,50 al livello del piano stradale moderno; sul fondo della trin-cea la larghezza della stessa variava da m 0,60 a 0,90 circa.
TRA VIA CHIARA E VIA DELLE MURINA
Durante i lavori di scavo (Fig. 7), all’altezza del numero civico 64 di via Ridolfi, estata intercettata una struttura muraria laterizia composta di mattoni legati con maltadi dimensioni cm 27,561464; il muro, dallo spessore nel punto di rasatura, di circacm 125, ha una direzione est-ovest perpendicolare all’attuale via Ridolfi in passato de-nominata via degli Asini (Fig. 8).
E presumibile che la struttura sia un tratto della terz’ultima cerchia muraria diEmpoli esistente fino al 1333 e distrutta dalla disastrosa alluvione che in quell’annodevasto il territorio empolese e molte zone del Val d’Arno. La struttura difensiva, nel-la parte messa in luce, ha dimostrato un’alta resistenza anche all’azione della bennache nel momento dell’intercettazione ne ha scalfito, senza grossi danni, la sola inter-faccia superiore; quest’ultima porta i segni di una rasatura e smontaggio gia compiutiin antico.
A causa delle forti infiltrazioni d’acqua di falda che allagavano la trincea, non estato possibile indagare piu in profondita ma si e potuto comunque notare come vifossero altre file di mattoni poggianti sul lato nord del muro non ad esso ben connes-
— 129 —
si. Questi erano posizionati di testa e avevano una resistenza strutturale assai minorerispetto alla parte centrale del lacerto murario emerso. Non e stata individuata tracciadi fondazioni probabilmente a causa delle problematiche idrologiche poc’anzi accen-nate.
Proseguendo verso nord, all’altezza del numero civico 58, e stata intercettata unaseconda struttura in laterizi (dimensione dei mattoni: cm 29,561564,5) anch’essacon evidenti segni di rasatura e smontaggio in antico (Fig. 9). E molto probabileche si tratti della penultima cerchia muraria difensiva di Empoli risalente agli anni1336-1340. In questo caso e emerso una struttura articolata avente alcune file di mat-toni (dimensioni: cm 2861266) non in asse perpendicolare con via Ridolfi ma chebensı mantengono una direzione ruotata di circa 30-40 gradi sud. Questa particolaritapuo essere ragionevolmente spiegata associando il muro messo in luce con una por-zione di cio che resta dei piloni della porta urbica del versante settentrionale dellacitta medievale, denominata Porta ad Arno.
TRA VIA DELLE MURINA E VIA SALVAGNOLI
Appena attraversata via delle Murina in direzione nord (presso il numero civico56) e stato riportato alla luce una sovrapposizione, all’apparenza caotica, di strutturein mattoni (dimensioni: cm 25,761364,5) riferibili a vari periodi storici (Fig. 10).
Si nota una canalizzazione fognaria voltata con direzione N-S diagonale rispettoall’asse di via Ridolfi, defunzionalizzata da una struttura sempre in mattoni molto de-gradati (dimensioni: cm 27610,764,5), forse pertinente a una fondazione non piuidentificabile. Quest’ultimo elemento murario poggia su di un’altra struttura murariache presenta i danni tipici di uno smontaggio sistematico. In un rilievo planimetricodel 1827, eseguito per il progetto di demolizione della Porta ad Arno dell’ultima cer-chia muraria si puo chiaramente notare come, in quest’area, insisteva un ambiente in-dicato come ‘Capanno demolito’ (Fig. 11).155
Poco piu a nord, presso il numero civico 54 di via Ridolfi, e emersa ancora un’al-tra struttura muraria questa volta composta da un nucleo in opera cementizia (maltamagra e ciottoli di fiume di media pezzatura) e un paramento in opera laterizia (di-mensione mattoni: cm 2961467); tale porzione di muro, di notevole spessore (cm285 nel punto di rasatura) e resistenza all’azione della pala meccanica, e senza dubbiopertinente all’ultima cerchia muraria di Empoli costruita tra i XV e il XVI secolo(Figg. 12-14). In particolare questo rudere di mura difensive, prima della demolizioneper il passaggio delle tubazioni moderne, conservava ancora parte del barbacane (Fig.15); siamo a fianco di una delle porte urbiche del castello rinascimentale empolesedenominata dai documenti Porta ad Arno e demolita intorno al 1825.
155 ASCE, Comunita, 188; W. SIEMONI, L’immagine della citta, in Empoli: citta e territorio. Ve-dute e mappe dal ’500 al ’900, Empoli, Editori dell’Acero, 1998, pp. 115-161: 134.
— 130 —
Infine, giunti all’angolo tra via Ridolfi e via Salvagnoli, e venuta alla luce un’altrastruttura muraria, anch’essa estremamente resistente all’azione della pala meccanica,orientata est-ovest e costituita, questa volta, da pietre di media-grande pezzatura le-gate con malta pertinenti probabilmente al ponticello o al punto di battuta del pontelevatoio che permetteva l’attraversamento del fossato (Fig. 16).
A sud del muro in pietra si appoggia una fogna/cunicolo voltata in mattoni (di-mensioni: cm 3061465) anch’essa con andamento est-ovest; il probabile cunicoloda un lato e intercettato e distrutto dalla fogna maestra di via Ridolfi, dall’altro eostruito dalle fonazioni dei casamenti tuttora esistenti di via Salvagnoli.
Su entrambi i lati, settentrionale e meridionale, della coppia di strutture poc’anzisegnalate, si rilevano cospicui butti di materiale laterizio frammentario e ceramicapertinente ai secoli XV e XVI.
La fogna/cunicolo e in parte danneggiata da una canalizzazione fognaria ascrivi-bile al XX secolo.
ALL’INCROCIO CON VIA SALVAGNOLI
In quest’area dei lavori, circoscritta all’incrocio delle vie Ridolfi e Salvagnoli, sisegnala la presenza del raccordo delle fogne maestre delle due strade costruite pro-babilmente in epoca lorenese e piu volte sottoposte a opere di manutenzione; fabbri-cate in opera laterizia (mattoni) presentano diverse proporzioni in base alla portatad’acqua prevista per ciascuna canalizzazione (Fig. 17).
Negli strati terragni al disotto delle fognature del XX secolo, smantellate per lasostituzione di una parte delle nuove tubature del gas, sono stati recuperati frammenticeramici anch’essi ascrivibili al XV e XVI sec.
Attualmente la posizione e l’ingombro delle emergenze archeologiche individuatee segnalate nel presente articolo, sono state evidenziate, nella moderna pavimentazio-ne di via Ridolfi, attraverso una diversa orditura delle pietre.
WALTER MAIURI
— 131 —
LA CONSISTENZA DEL CASTELLO DI EMPOLI NEL DUECENTO