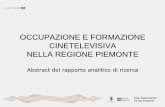Salzani P., L'industria litica in pietra scheggiata di Castello d'Annone.
Transcript of Salzani P., L'industria litica in pietra scheggiata di Castello d'Annone.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismoDirezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Comune di Castello di Annone
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
LA MEMORIA DEL PASSATOCASTELLO DI ANNONE TRA ARCHEOLOGIA E STORIAa cura di Marica Venturino Gambari
LineLab.edizioni
Da Castello di Annone provengono complessivamente poco più di un centinaio di elementi litici scheggiati, recu-perati nelle campagne di scavo e nei cumuli (cfr. M. Ven-turino Gambari et al., supra). L’attribuzione cronologica del materiale, privo di un contesto stratigrafico affidabile, è avvenuta esclusivamente su base tipologica e di carat-terizzazione delle materie prime utilizzate. L’ipotesi che il materiale litico scheggiato possa essere attribuibile per lo più al Neolitico medio si basa da un lato su considerazioni meramente quantitative relative alle frequentazioni del sito rilevate dall’industria ceramica, in cui quella neolitica risulta preponderante rispetto a quelle dell’età del Rame e delle successive età del Bronzo e del Ferro; dall’altro tale attribuzione sembra plausibile grazie al confronto e all’analisi della litica degli altri contesti ne-olitici ed eneolitici piemontesi (NegriNo et al. 2006). A Ca-stello di Annone non sono inoltre stati rinvenuti strumenti di sicura attribuzione all’età del Rame, per cui anche gli elementi del débitage, che non possono assumere alcun valore cronologico se privi di contesto sicuro di riferimen-to, sono stati riferiti al Neolitico medio-recente. La quantità di materiale litico scheggiato risulta assolu-tamente irrisoria di fronte alla grande mole di ceramica presente nel sito (cfr. S. Padovan - P. Salzani, supra), ma è assai significativa sia per la presenza di elementi ritoccati importanti dal punto di vista cronotipologico, sia per la varietà delle materie prime utilizzate nel sito (selce appen-ninica, selce sudalpina, selce bionda francese, ossidia-na, quarzo ialino). L’identificazione delle differenti materie prime è stata condotta solo sulla base dell’analisi delle caratteristiche macroscopiche delle rocce visibili a occhio nudo (opacità, vetrosità, presenza di eventuali macchie, flocculi o striature di colore), ad eccezione dell’ossidiana (C. Lugliè et al., infra; E. Ferrara et al., infra). Tale varietà può essere rappresentativa non solo degli scambi in atto durante il Neolitico medio/recente in Italia settentrionale, ma può possedere anche una forte valenza cronologica.
Il Piemonte è ubicato in prossimità delle Alpi occidentali, principali aree di reperimento delle rocce metamorfiche di alta pressione (eclogiti, Na-pirosscniti, onfacititi e giadeiti-ti) con cui tra Neolitico ed età del Rame sono stati confe-zionati oggetti di ornamento ma soprattutto lame di stru-menti da taglio in pietra levigata (VeNturiNo gambari 1996; 2004a; PetrequiN et al. 2005). La regione sembra invece, allo stato attuale delle ricerche, relativamente povera di materie prime scheggiabili di buona qualità, anche se geograficamente contigua ad aree con importanti fonti di materia prima silicea (Francia; Liguria; Emilia; affioramenti selciferi sudalpini), e per questo i litotipi considerabili al-loctononi consentono di ipotizzare un’importante rete di scambi con altri contesti culturali. L’approvvigionamento e la circolazione di materie prime scheggiabili sono infatti strettamente correlati ai grandi cambiamenti culturali che si manifestano in Italia settentrionale durante il Neolitico medio/recente.
I MATERIALIL’industria litica è stata analizzata seguendo la metodolo-gia tradizionale, che consiste nella classificazione tipolo-gica analitica degli strumenti (LaPLace 1964). Per il gruppo dei foliati si è fatto riferimento alla classificazione effettua-ta da Bagolini (bagoLiNi 1970). Non è stato possibile effet-tuare l’analisi metrica (litometrica e litotecnica) dei manu-fatti non ritoccati (bagoLiNi 1968) a causa della carenza numerica di elementi interi non ritoccati, insufficiente per tale tipo di approfondimento.La maggior parte degli elementi si presenta frammentario (privo di tallone o di parte distale). È stato dunque im-possibile utilizzare la terminologia corrente, dal momento che essa è relativa alla descrizione dei manufatti integri basata sulle loro dimensioni. Si è deciso dunque di adot-tare le distinzioni e la terminologia introdotta da Bagolini per i pochi manufatti integri misurabili, mentre per tutti i
IL NEOLITICOPaola Salzani*
324 PAOLA SALZANI
manufatti frammentari si è utilizzata la generica denomi-nazione di frammento di lama/scheggia, priva di ogni va-lenza metrica, anche se la quasi totalità dei frammenti litici scheggiati di Castello di Annone potrebbe essere inserita nella categoria dei microliti (frammenti di microlamelle e microschegge).Numerosi elementi, anche provenienti dalla setacciatu-ra del terreno, risultano di dimensioni millimetriche non-ché privi di tallone o parte distale. Questi residui sono interpretabili come residui prodotti dall’operazione della scheggiatura o della lavorazione di un supporto (debris).Dallo scavo 1994 provengono complessivamente 18 ele-menti litici scheggiati, più una piccola quantità di ele-menti recuperati dalla setacciatura di parte del terreno (frazione 2/5). Dal colluvio inferiore provengono solo 4
elementi in selce (3 in selce bionda francese e forse 1 elemento in selce sudalpina), oltre ad alcuni elementi in quarzo ialino; nessun elemento litico scheggiato provie-ne dal corpo di frana e i materiali rimanenti provengono da diverse unità del colluvio superiore. Tra i materiali li-tici scheggiati recuperati durante questa campagna di scavo non compare nessun elemento in ossidiana, men-tre i litotipi presenti sono rappresentati da selce bionda francese, selce sudalpina, selce appenninica, quarzo ialino. I materiali litici scheggiati, complessivamente 18 elementi, sono suddivisi tipologicamente in:
� 1 frammento di raschiatoio foliato doppio (F7B) su scheggia, in selce bionda francese (fig. 294, 2);
� 2 frammenti di raschiatoio foliato semplice (F7C) su lama e su lamella (fig. 293, 5), in selce completamente
Fig. 293. Strumenti in selce sudalpina e appenninica.
325IL NEOLITICO
alterata dal fuoco; � 1 frammento di raschiatoio foliato doppio (F7B), a ri-
tocco piatto invadente/marginale bifacciale bilaterale, in selce bionda francese (fig. 294, 6);
� 1 frammento di punta profonda (P2) a ritocco sem-plice, in selce patinata probabilmente francese (fig. 294, 5);
� 1 punta foliata a faccia piana, a peduncolo e spalle (F1B), a ritocco piatto diretto coprente, inverso inva-dente (su peduncolo e punta), in selce appenninica (fig. 293, 2);
� 1 frammento di lamella raschiatoio (L1), in selce sud-alpina (fig. 293, 4);
� 1 frammento di astiforme, a ritocco piatto bifacciale coprente, in selce sudalpina (fig. 293, 3);
� 1 frammento di raschiatoio su scheggia (R1), in selce bionda francese;
� 1 tranciante trasversale triangolare (F6B) a ritocco piatto bifacciale invadente, in selce bionda francese;
� 5 frammenti di scheggia e 1 microscheggia, di cui 2 in selce bionda, 1 in selce sudalpina, 2 in selce appen-ninica, 1 alterato dal fuoco;
� 1 probabile frammento di nucleo, in selce sudalpina; � 1 frammento di lamella in quarzo ialino.
Tra i 17 elementi in selce analizzati, solo 6 elementi, di cui 2 in selce bionda, 1 in selce sudalpina, 1 in selce appenninica, 2 in selce alterata dal fuoco, presentano tracce di cortice.Dallo scavo 1995 provengono complessivamente 97 elementi litici scheggiati. Nessuno di essi proviene dalle unità stratigrafiche del colluvio inferiore né dal corpo di frana e, nella maggior parte dei casi, da ogni unità stra-tigrafica provengono solo pochi elementi. Nelle unità più ricche, come us 2051 e us 2052, i diversi litotipi (selce appenninica, selce sudalpina, selce bionda francese, ossidiana, quarzo ialino) si trovano associati tra loro. Per quanto riguarda i materiali in selce (72 elementi), essi sono suddivisi tipologicamente in:
� 1 frammento di foliato attribuibile a una punta foliata peduncolata semplice (F1C) a ritocco piatto bifaccia-le invadente in selce bionda;
� 1 frammento di strumento foliato attribuibile a un tranciante trasversale triangolare (F6B) a ritocco piatto bifacciale invadente, completamente alterato dal fuoco;
� 1 raschiatoio foliato semplice su lama (F7C), a ritocco piatto marginale parziale, il cui supporto è rappresen-tato da una grande lama in selce bionda, della lun-ghezza di più di 12 cm (fig. 294, 1);
� 1 elemento geometrico, forse in corso di lavorazione, di forma trapezoidale, su frammento di lama in selce bionda (fig. 294, 4);
� 1 elemento a ritocco piatto sommario, invadente bi-facciale, in selce bionda francese (fig. 296, 4);
� 1 frammento di lamella raschiatoio, a ritocco semplice marginale in selce bionda francese;
� 10 elementi laminari, costituiti da frammenti di lama/lamella, dei quali 2 in selce bionda, 3 in selce sudalpi-na, 2 in selce appenninica, 3 bruciati dal fuoco;
� 4 microschegge (3 in selce francese e 1 in selce sud-alpina) e 25 frammenti di scheggia, riferibili per lo più
a microschegge, dei quali 5 in selce bionda, 5 in selce sudalpina, 5 in selce appenninica, 9 bruciati dal fuoco;
� 27 residui di lavorazione, per lo più di dimensione assai ridotte e quindi di difficile classificazione per quanto riguarda il litotipo; sembrano identificabili comunque elementi in selce bionda, in selce sudalpina, in selce appenninica, mentre alcuni risultano bruciati dal fuoco.
Non sono stati rinvenuti nuclei o schegge di ravvivamen-to. Un solo elemento, classificabile come residuo di la-vorazione in selce scottata, presenta tracce di cortice.Sono stati rinvenuti anche elementi in ossidiana e in quarzo: � 4 frammenti di lamella in ossidiana, uno dei quali (fig.
296, 1) sembra presentare tracce di ritocco o pseudori-tocco nella parte prossimale. L’ossidiana appare com-plessivamente molto vetrosa, anche se alcuni elementi presentano striature interne più opache o una specie di smerigliatura superficiale;
� 19 elementi in quarzo ialino, di cui 6 frammenti di lama, 9 frammenti di scheggia, 3 residui di lavorazione e 1 piccolo elemento sferico dalla superficie picchiettata e arrotondata (ciottolino?);
� 2 elementi in quarzo, dall’aspetto più lattiginoso e opa-co, classificabili come residui di lavorazione.
Su un totale di 114 elementi, escludendo quelli provenien-ti dalla setacciatura dello scavo 1994 non adatti a essere impiegati nel calcolo statistico, tra i litotipi impiegati il 78% è rappresentato da selce, il 18% da quarzo (quarzo ialino eccetto 2 elementi), il 4% da ossidiana.Per quanto riguarda il tipo di materia prima utilizzata per gli 88 strumenti in selce scheggiata, è molto importante sottolineare come, nonostante l’alta percentuale di ele-menti bruciati (20%) e di elementi incerti (27%), la selce bionda di origine francese sia presente in quantità mag-giore (22%) rispetto alla selce sudalpina (19%) e alla sel-ce appenninica (12%).Alcuni strumenti significativi, sia dal punto di vista tipolo-gico, sia per la materia prima utilizzata, sono stati rinvenu-ti nella setacciatura dei cumuli: � 1 punta foliata doppia a losanga (F3B), a ritocco piatto
bifacciale invadente, in selce bionda (fig. 295, 1); � 1 foliato triangolare a tranciante trasversale (F6B), a
ritocco piatto diretto invadente, inverso marginale, in selce bionda (fig. 295, 2);
� 1 raschiatoio foliato doppio su lama (F7B), a ritocco piatto marginale diretto bilaterale - invadente parte prossimale, in selce appenninica;
� 1 raschiatoio foliato doppio su lama (F7B), a ritocco piat-to, diretto marginale margine sinistro - bifacciale inva-dente margine destro, in selce sudalpina (fig. 293, 8);
� 1 punta foliata a peduncolo e spalle (F1B), a faccia pia-na, a ritocco piatto bifacciale invadente, in selce sud-alpina (fig. 293, 1);
� 1 grattatoio frontale lungo (G2) su lama in selce di ori-gine sudalpina (fig. 293, 7);
� 1 ravvivamento in selce bionda (fig. 295, 3); � 2 frammenti di lama raschiatoio marginale in ossidiana; � 3 frammenti di lama in ossidiana; � 1 frammento di lamella raschiatoio in quarzo ialino; � 3 frammenti laminari e 1 frammento di scheggia in
quarzo ialino.
326 PAOLA SALZANI
STRUMENTI, LITOTECNICA E MATERIE PRIME
Gli strumenti in selce sono perfettamente inquadrabili nel contesto tipocronologico rilevato dall’analisi della ceramica neolitica, per lo più attribuibile al Neolitico medio e recente.Il grattatoio frontale lungo (G2) su lama in selce di origine sudalpina presenta una tipologia che risulta la più carat-teristica delle fasi di Neolitico medio padano, diffusa sia nei siti V.B.Q. I (come Quinzano: biagi 1972, p. 462; Fi-mon Molino Casarotto: guerreschi 1986, p. 74, 94), sia nei principali siti V.B.Q. II (es. Chiozza di Scandiano: bagoLiNi - barfieLd 1971, p. 34; Razza di Campegine: biagi et al. 1983, p. 27); nella Caverna delle Arene Candide tali stru-menti sono presenti in quantità modesta negli strati V.B.Q. degli scavi Bernabò Brea (starNiNi - Voytek 1997, p. 366) mentre sono ben rappresentati, ma su supporti laminari in selce bionda francese, negli strati Chassey (starNiNi - Voytek 1997, p. 382 e database 6).La punta a dorso e peduncolo (PD7), forse in selce bion-da francese, è avvicinabile a due esemplari rinvenuti nei livelli V.B.Q. delle Arene Candide (starNiNi - Voytek 1997, fig. 15, F130 e F131) e a un esemplare rinvenuto a Chioz-za (bagoLiNi - barfieLd 1971, fig. 20, n 14)Gli strumenti appartenenti alla famiglia dei foliati, che con 14 elementi conta il maggior numero di esemplari, appar-tengono a tre classi tipologiche principali (punte foliate, foliati a tranciante trasversale, raschiatoi foliati).
Punte foliate � La punta foliata a doppia a losanga (F3B, fig. 295, 1)
a ritocco piatto bifacciale invadente, in selce bion-da francese, è confrontabile con analoghi esemplari provenienti dagli strati Chassey delle Arene Candide (starNiNi - Voytek 1997, figg. 30, F295 e F300) e in ambi-to padano è avvicinabile a tipi rinvenuti nel sito di Rivoli Rocca, sia nella subfase Rivoli Rocca I (barfieLd - ba-goLiNi 1976, p. 89, fig. 76a, 16) sia nella subfase Rivoli Rocca II (barfieLd - bagoLiNi 1976, p. 98, fig. 90a, 27);
� la punta foliata a peduncolo e spalle (F1B, fig. 293, 1), a faccia piana, a ritocco piatto bifacciale invaden-te, in selce sudalpina, pur avendo il peduncolo molto slanciato e le spalle oblique appena accennate, è da considerarsi un elemento di tipologia padana. Le punte foliate peduncolate a faccia piana sono infatti caratte-ristiche della Cultura V.B.Q., sia nella sua fase arcai-ca (Fimon: Guerreschi 1986, fig. 33-34) sia nella sua fase media (La Vela di Trento: Pedrotti 1990a, fig. 6, 17; 2001b, p. 151, fig. 33);
� la punta foliata a faccia piana, a peduncolo e spalle (F1B, fig. 293, 2) a ritocco piatto diretto coprente, inver-so invadente (su peduncolo e punta), in selce appen-ninica, non trova confronti tra i materiali dei livelli V.B.Q. e Chassey delle Arene Candide, mentre è assimilabile a tipi a peduncolo e spalle, dall’aspetto però molto più slanciato, presenti a Chiozza (bagoLiNi - barfieLd 1971, fig. 21, 1-3) e a Casatico di Marcaria (biagi et al. 1983, fig. 36, F28-F30);
� il frammento di foliato attribuibile forse a una punta foliata peduncolata semplice (F1C) a ritocco piatto
bifacciale invadente in selce bionda, proveniente dal colluvio superiore degli scavi 1995, di dimensioni e spessore notevole, non trova al momento confronti.
Foliati a tranciante trasversale � I tre esemplari di tranciante, e precisamente il folia-
to triangolare a tranciante trasversale (F6B, fig. 295, 2) a ritocco piatto diretto invadente, inverso margina-le, in selce bionda, il foliato triangolare a tranciante trasversale e il frammento attribuibile a un tranciante trasversale triangolare (F6B) a ritocco piatto bifacciale invadente, completamente alterato dal fuoco, trovano confronto con un esemplare rinvenuto negli strati Chas-sey delle Arene Candide (starNiNi - Voytek 1997, fig. 31, F304).
Raschiatoi foliati � 4 esemplari di raschiatoio foliato semplice (F7C), 3 su
lama, di cui 1 a ritocco piatto marginale parziale, diretto sul margine sinistro, il cui supporto è rappresentato da una grande lama in selce bionda della lunghezza di più di 12 cm (fig. 294, 1), e uno su scheggia (fig. 294, 2) in selce bionda, unitamente a 3 esemplari di raschia-toio foliato doppio su lama (F7B) (uno a ritocco piatto diretto margine sinistro - bifacciale margine destro, in selce sudalpina (fig. 293, 9), un frammento a ritocco piatto bilaterale bifacciale invadente e uno a ritocco piatto marginale diretto bilaterale - invadente parte distale, entrambi in selce appenninica) si inquadrano perfettamente nel contesto del Neolitico medio sia ligu-re che padano. Raschiatoi foliati, semplici e doppi, si rinvengono comunemente nelle industrie V.B.Q. pada-ne (biagi 1972, p. 456; bagoLiNi - barfieLd 1971, p. 38; biagi et al. 1983, p. 28), mentre il ritocco piatto sembra essere meno caratteristico dell’industria litica dei livelli V.B.Q. delle Arene Candide (starNiNi - Voytek 1997, p. 404; starNiNi 1999, p. 231) e le lame raschiatoio foliato, su supporto in selce bionda, assumono una certa im-portanza a partire dai livelli Chassey del sito (starNiNi - Voytek 1997, p. 383, figg. 31-33);
� il frammento di foliato (fig. 293, 3) a ritocco piatto bifac-ciale coprente e invadente, in selce sudalpina, classifi-cabile come perforatore/astiforme (BagoLiNi et al. 1982, p. 14), è significativo dei contatti con la III fase V.B.Q., trovando confronto in siti come Gazzo Veronese-Scolo Gelmina (saLzaNi 1998-1999, tav. XVI, 7a; tav. XXXIII, 10), Aica di Fiè (bagoLiNi et al. 1982, F.2, fig.8) e Ca’ dei Grii (biagi - marcheLLo 1970, fig.17, p. 288), contatti docu-mentati a Castello di Annone anche da alcuni elementi ceramici (cfr. S. Padovan - P. Salzani, supra).
I gruppi del sostrato (LaPLace 1964, p. 60), e precisamente quelli a ritocco semplice delle punte, lame raschiatoio e raschiatoi su scheggia, degli erti indifferenziati e dei den-ticolati, sono rappresentati solamente da 2 frammenti di lama raschiatoio, di cui uno in selce sudalpina (fig. 293, 4) e uno in selce francese (fig. 294, 6), e da 1 frammento di raschiatoio su scheggia in selce francese (fig. 294, 2).Tra i due strumenti di incerta interpretazione, l’elemento geometrico forse in corso di lavorazione (fig. 294, 4) di forma trapezoidale, su frammento di lama in selce bion-da, potrebbe, per la presenza di alcuni ritocchi piatti,
327IL NEOLITICO
rappresentare il supporto di un tranciante trasversale; l’e-lemento a ritocco piatto sommario bifacciale in selce bion-da francese (fig. 295, 4) pone al momento alcuni problemi interpretativi. Non sembrerebbe infatti assimilabile ai tran-chet chasseani conosciuti nei siti provenzali e rinvenuti in 4 esemplari ad Alba - Collezione Traverso (gambari et al. 1992, p. 118 e fig. 43, 1-5), che utilizzano come supporto sottili schegge larghe di forma subtrapezoidale slanciata.
Tale elemento non trova al momento alcun confronto, che sembrerebbe comunque, visto il litotipo utilizzato, da ri-cercarsi in ambito transalpino occidentale.Pur non potendo contare su un campione numeroso di elementi ritoccati, gli strumenti analizzati possono pre-starsi ad alcune considerazioni generali. Alcuni di essi, realizzati in selce bionda francese (la punta a doppia lo-sanga e i trancianti trasversali, ma anche alcuni raschiatoi
Fig. 294. Strumenti in selce bionda francese.
328 PAOLA SALZANI
foliati doppi) (fig. 295, 1-2, 6) sono sicuramente di ambito culturale chasseano/occidentale. In particolare le cuspi-di foliate a losanga e a tranciante trasversale sono da considerarsi elementi di tipo occidentale (bagoLiNi 1979, p. 157) diffusi anche in ambito padano, sia nei siti che presentano una cultura materiale di tipo spiccatamente occidentale (come ad esempio Spilamberto: bagoLiNi et al. 1998, p. 133, tav. XXVII, 8 e11; Ronchetrin: cheLidoNio 1989, p. 154, fig. 7, 1-2), sia in siti che manifestano solo alcuni influssi di tipo occidentale (come ad esempio Rivoli Rocca: barfieLd - bagoLiNi 1976, p. 89, fig. 76a, 16; p. 98, fig. 90a, 27; p. 106, fig. 101b, 24).Altri elementi (fig. 293) come la punta foliata a faccia piana, il grattatoio frontale lungo, una lamella raschiatoio e il fram-mento di astiforme in selce sudalpina sono invece strumen-ti che rimandano più strettamente all’ambito padano, sia a livello tipologico che per l’uso della materia prima.Anche tra gli strumenti in selce, seppur in modo quanti-tativamente non così significativo, è dunque presente la dicotomia culturale ravvisata nella ceramica.Del complesso dei materiali litici scheggiati, l’elemento che colpisce maggiormente è una certa disomogeneità dell’insieme. Per quanto riguarda gli elementi in selce, sono abbastanza ben rappresentati gli strumenti (15%), i residui di lavorazione (55%) e gli elementi frammentari (microlitici per un totale del 25%). Sono invece molto scar-si i supporti interi (microschegge 3%, nessun elemento laminare), mentre sono quasi completamente assenti (en-trambi rappresentano solo l’1%) i nuclei e i ravvivamenti ad eccezione di un ravvivamento in selce bionda spora-dico (fig. 295, 3) e di un probabile frammento di nucleo in selce sudalpina. Tali dati possono suggerire due diverse ipotesi interpretative. L’estrema scarsità di elementi quali nuclei e supporti integri è principalmente legata alla na-tura dei depositi, vista l’abbondanza di residui di lavora-zione (anche da setacciatura) che sembrerebbero sug-gerire una lavorazione in situ della materia prima in selce. Altra ipotesi potrebbe vedere la materia prima legata alla scheggiatura arrivare a Castello di Annone per la maggior parte sotto forma di semilavorati (supporti), che vengono ipersfruttati e trasformati in strumenti (da cui i numerosi residui di lavorazione). Allo stato attuale delle ricerche le difficoltà di attuare sui materiali litici scheggiati del sito una puntuale lettura di tipo tecnologico ci sembrano le-gate soprattutto alle particolari modalità del rinvenimento. Per quanto riguarda le materie prime scheggiabili rinve-nute, quelle di cui risulta più difficile determinare con sicu-rezza una provenienza precisa sono sicuramente le selci, sia quelle cosiddette sudalpine, sia quelle appenniniche e i diaspri/ftaniti. Il problema del riconoscimento delle diverse litofacies è da porsi innanzitutto rispetto al tipo di analisi effettuata. Esistono infatti due metodologie principali nello studio delle fonti di queste materie prime (barfieLd 2000, p. 61): l’analisi macroscopica (a occhio nudo) e l’analisi micro-scopica (volta al riconoscimento delle caratteristiche pe-trografiche, geochimiche e paleofossili). Secondo alcuni studiosi, solo un’analisi degli elementi in traccia (difratto-metria a raggi X) potrebbe fornire dati certi e incontestabi-li per il riconoscimento delle fonti di approvvigionamento della materia prima.
La difficoltà principale da affrontare in questo tipo di stu-dio non è data solamente dal tipo di metodologia impie-gata nell’analisi del materiale, ma anche dalla scarsità di bibliografia di riferimento sulle rocce silicee scheggiate, che si sviluppa in Italia settentrionale solo a partire dalla fine degli anni ’70 (biagi et al. 1980; cremaschi 1984).Per la selce sudalpina, sia di ottima qualità (ad esempio quella proveniente dai Monti Lessini), sia di qualità inferio-re, mancano a tutt’oggi una mappatura degli affioramenti e un database sulle principali caratteristiche degli stes-si, dati di fondamentale importanza per la comprensione dello sfruttamento e dei traffici di questa selce durante il Neolitico (barfieLd 2000, p. 64). Anche per la selce ap-penninica o per i diaspri/ftaniti, in particolare per l’area nordoccidentale degli Appennini (per l’Appennino pada-no-adriatico: ferrari et al. 1998), la situazione non appare assolutamente diversa. Attualmente alcuni gruppi di ricer-ca stanno operando per cercare di colmare tali lacune, sia in ambito sudalpino (Università di Ferrara, Museo di Storia Naturale di Verona), sia in ambito appenninico li-gure e padano-occidentale (NegriNo - starNiNi 2003). Gli studi pubblicati sui complessi in pietra scheggiata rinve-nuti alle Arene Candide hanno infine maggiormente evi-denziato e chiarificato la comparsa e l’uso in Italia nor-doccidentale di un altro tipo di selce – la cosiddetta selce bionda di origine francese/provenzale –, lo scambio della quale potrebbe forse essere collegato a quello dell’eclo-gite (starNiNi 1999, p. 235).Proprio la selce bionda di origine francese (probabilmen-te dalla Vaucluse1) risulta attualmente la materia prima più rappresentata a Castello di Annone, con una percentuale (basata solo sui materiali degli scavi 1994-1995) attorno al 22%; i materiali in questo litotipo comprendono, come si è visto, alcuni strumenti (una punta foliata, trancianti trasver-sali, raschiatoi foliati), residui di lavorazione e un ravviva-mento di nucleo2. “La selce bionda traslucida abbonda par-ticolarmente nelle formazioni secondarie (urgoniane) della Provenza occidentale: Veaux, Murs e Chateauneuf-du-Pa-pe in Vaucluse. È una materia prima assai eccezionale in ragione della finezza della sua grana, della sua omogenei-tà… È la materia prima principe del débitage Chasseano per pressione… È effettivamente associata allo Chasseano nella maggior parte dei siti provenzali, in Liguria e in nume-rosi siti della Linguadoca…” (biNder 1984, p. 74). Per interpretare nel modo più corretto questo dato, è im-portante riportare qui brevemente le percentuali di questa materia prima nelle diverse fasi dell’occupazione neolitica delle Arene Candide. La selce bionda3 fa la sua comparsa in questa grotta già nel Neolitico antico (7,5% negli stra-ti Bernabò Brea: starNiNi - Voytek 1997, p. 353; 10% ca. strati Tinè: starNiNi 1999, p. 224); nello strato 13 dello sca-vo Tinè (la cui attribuzione culturale è a tutto oggi fonte di discussione tra gli studiosi) la percentuale è del 2,7%; negli strati attribuiti alla Cultura V.B.Q. la sua presenza diminuisce, poiché è attestata in basse percentuali negli strati Bernabò Brea (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1) e attorno al 3% nello strato 12 dello scavo Tinè (starNiNi 1999, p. 231). La situazione cambia negli strati attribuiti alla Cultu-ra Chassey (presenti solo nello scavo Bernabò Brea), ove la percentuale di selce bionda sale oltre il 50% del totale (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1 e p. 379).
329IL NEOLITICO
L’importazione di tale materia prima risulta quindi chiara-mente connessa, nel Neolitico medio/recente, all’arrivo in Liguria di nuovi gruppi umani portatori di una cultura ma-teriale di origine occidentale di tradizione chasseana, in-terpretato come una delle probabili cause dell’improvvisa fine dello sviluppo della Cultura V.B.Q. in questa regione (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1 e pp. 379-382).Anche a Castello di Annone l’uso di questa materia prima risulta essere indissolubilmente legato a contatti di tipo transalpino occidentale. Essa sembra penetrare, durante il V.B.Q. II anche in area emiliana occidentale, dove nei siti di Le Mose e Pontetaro sono attestati due oggetti confe-zionati in selce bionda francese; mancando in questi siti tracce legate a una lavorazione sul posto, è probabile la circolazione di singoli manufatti (mazzieri 2012, p. 110).Per quanto riguarda la selce di tipo sudalpino rinvenuta a Castello di Annone, in base alle caratteristiche macrosco-piche di vetrosità, presenza di flocculi e colori (prevalen-temente tonalità di grigio), è possibile genericamente ipo-tizzarne una provenienza dai Monti Lessini/Monte Baldo, prevalentemente dalle formazioni del Biancone. I pochi elementi in selce di importazione sudalpina (2 strumenti su supporto laminare, 1 punta foliata e alcuni residui di lavorazione) raggiungono una percentuale pari al 19%. Nel Neolitico antico la selce sudalpina veniva utilizzata,
per le sue pregiate qualità tecniche, dalla maggior parte dei gruppi neolitici dell’Italia settentrionale, probabilmente veicolata dalla Cultura di Fiorano (PessiNa 1998, pp. 96-101), con la significativa eccezione della Cultura della Ce-ramica Impressa ligure, come attestato nella Grotta delle Arene Candide, dove essa inizia a essere importata solo alla fine del Neolitico antico (strato 13 scavo Tinè) ed è presente nella prima fase del Neolitico medio (strati della Cultura V.B.Q.) (starNiNi - Voytek 1997; starNiNi 1999). Il traffico di questa materia prima potrebbe essere uno dei motivi che portarono la regione padana in contatto con quella ligure (starNiNi 1999, p. 235). Nel Neolitico medio la troviamo diffusa in tutto l’areale della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata – I e II fase – (barfieLd 2000, p. 62), ma la quantità e l’importanza che essa assume sembra variare da sito a sito. Mentre in alcuni contesti V.B.Q. (depositi neolitici della provincia di Reggio Emilia, Casatico di Mar-caria) la selce sudalpina è assolutamente predominante, in altri casi prevale l’utilizzo di rocce appenniniche, come ad esempio nel sito modenese di Spilamberto, ove l’im-portazione di selce sudalpina diventerà prevalente nella fase Chassey-Lagozza (cremaschi 1984, p. 98).In Liguria, alle Arene Candide la selce sudalpina è stata rinvenuta, per la prima volta nella sequenza neolitica, nello strato 13 dello scavo Tinè in una percentuale pari al 6,7%
Fig. 295. Strumenti e ravvivamento di nucleo (3) in selce bionda francese.
330 PAOLA SALZANI
(starNiNi 1999, p. 227); negli strati V.B.Q. dello scavo Ber-nabò Brea la sua presenza si attesta attorno al 7% (starNiNi - Voytek 1997, p. 362), mentre negli strati V.B.Q. dello scavo Tinè la sua percentuale è del 5,8% (starNiNi 1999, p. 231). L’uso di questa materia prima non è più attestato negli strati chasseani (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1).A Castello di Annone alcuni elementi, tra cui due strumen-ti – una punta e un raschiatoio foliati – e alcuni residui di lavorazione, pari a una percentuale attorno al 12%, sono re-alizzati in selce appenninica, probabilmente di origine emi-liana sudoccidentale. L’utilizzo di questi materiali, di qualità più scadente, è sicuramente legato all’estrema carenza di materie prime scheggiabili reperibili nelle vicinanze e alla conseguente necessità di sopperire a tale mancanza impor-tando selce, sia di ottima qualità (sudalpina) sia ricorrendo a materiali più scadenti ma reperibili a distanze minori (sel-ce appenninica), per i quali sembra delinearsi una direttrice prevalentemente orientale (Appennino ligure-emiliano).Ciò che caratterizza la fase V.B.Q. meandro-spiralica però, al contrario delle precedenti del Neolitico medio, è la diffusione maggiore di litotipi esotici e dalle caratteristi-che di vetrosità e lucentezza particolari, quali l’ossidiana e il quarzo ialino (mazzieri 2012, pp. 110-112).A Castello di Annone sono stati rinvenuti alcuni elementi in ossidiana (fig. 296) (C. Lugliè et al., infra; E. Ferrara et al., infra), e precisamente 22 frammenti di lamella, alcuni dei quali (fig. 296, 6) presentano tracce di ritocco e posso-no essere classificati come lamelle-raschiatoio. Nel com-plesso questa materia prima raggiunge una percentuale del 4%. È da sottolineare come si tratti esclusivamente di elementi laminari, mentre non sono stati rinvenuti nuclei o residui di lavorazione.
Nel Neolitico antico dell’Italia settentrionale le attestazio-ni di ossidiana sono abbastanza scarse (cfr. C. Lugliè et al., infra): in Liguria alle Arene Candide e alla Pollera – strati riferibili alla Cultura della Ceramica Impressa – sono presenti elementi in ossidiana di origine sarda e pontina (starNiNi - Voytek 1997; starNiNi 1999; odetti 1991); alcu-ni elementi, tra cui 1 nucleo di origine sicuramente sar-da, sono stati rinvenuti a Monte Alfeo presso Godiasco, sito attribuibile al Neolitico antico, Cultura del Vhò (simo-Ne - starNiNi 1994); un elemento in ossidiana (non deter-minato) viene da Savignano sul Panaro, sito databile al Neolitico antico - Cultura di Fiorano (berNabò brea et al. 1988); 2 elementi in ossidiana, 1 di origine sarda e 1 lipa-rota, sono presenti a Formigine di Villa Gandini, generi-camente databile al Neolitico antico (thorPe et al. 1979); infine 11 elementi sono stati rinvenuti a Sammardenchia (solo 1 proviene da una struttura, il resto da raccolte di superficie), dove per la maggior parte l’ossidiana risulta di origine liparota, in 1 caso carpatica/sarda. In Piemonte l’unica attestazione di ossidiana databile al Neolitico antico sembrerebbe essere rappresentata da un nucleo in ossidiana rinvenuto a Casalnoceto (scavo 1993: PadoVaN et al. 2004a, p. 144). Numerosi in tutta l’Italia settentrionale sono invece i ritro-vamenti di ossidiana databili alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (I e II fase); si tratta di materiali di provenien-za sarda, pontina e liparota (anche alle Arene Candide); spesso si tratta di pochi manufatti in ogni sito, ad ecce-zione del Pescale, dove sono stati rinvenuti 950 elementi, tra cui numerosi nuclei (thorPe et al. 1979), e del sito di Gaione-Catena dal quale provengono 99 elementi con molti nuclei (berNabò brea et al. 1988). Un elemento in ossidiana è stato rivenuto nel sito di Rivarolo Mantovano, Campo Pecorone III (aNghiNeLLi - aNghiNeLLi 1984, fig. 6, 3), inquadrabile in un momento arcaico/iniziale della III fase V.B.Q. (bagoLiNi 1984, p. 353).Il 18% del materiale litico scheggiato rinvenuto a Castello di Annone è realizzato in quarzo ialino (fig. 297). Si tratta in prevalenza di frammenti laminari e di scheggia, oltre a pochi residui di lavorazione. Solo un elemento, e pre-cisamente un frammento di lama (fig. 297, 1), su cui è presente un ritocco semplice marginale, è interpretabile come strumento (lama-raschiatoio).Il quarzo è una roccia polimorfica costituita da silicio e ossigeno, con caratteristiche fisico-chimiche di durezza e inalterabilità. È costitutivo di numerose rocce policristal-line o sedimentarie e allo stato isolato si presenta come quarzo comune (agglomerato monocristallino di cristalli di quarzo xenomorfi) di colore traslucido/lattoso o come quarzo ialino, detto anche cristallo di rocca, totalmente trasparente (brisotto 1999). Il quarzo ialino è sicuramente la varietà di quarzo più utilizzata in preistoria, reperibile nei filoni dei massicci cristallini, in posizione primaria o secondaria (morene), delle Alpi occidentali e in Alto Adige nelle Alpi orientali (Dolomiti, Alpi Aurine). Molto sfruttato
Fig. 296. Frammenti di lamelle in ossidiana.
331IL NEOLITICO
in periodi precedenti al Neolitico in Italia settentrionale, sia occidentale (Alpe Veglia, Alpi Lepontine), che orien-tale (Dolomiti), è attestato nel Neolitico antico in Liguria alle Arene Candide (starNiNi - Voytek 1997; starNiNi 1999) e in Piemonte ad Alba (1 scheggia in quarzo: VeNturiNo gambari et al. 1995a). Numerosi sono i rinvenimenti di quarzo ialino in siti da-tabili al Neolitico medio, tra cui possiamo citare in Pie-monte il Monfenera (fedeLe 1973), Aisone (PerNich 2002-2003), Casalnoceto (scavo 1991: saLzaNi - VeNturiNo gambari 2004, p. 200), S. Valeriano in valle di Susa, dal quale provengono schegge e punte foliate in quarzo iali-no (bertoNe 1987, p. 518); in Pianura Padana elementi in quarzo, sempre associato anche a ossidiana, sono sta-ti rinvenuti a Gaione-Catena (berNabò brea et al. 1988), Casatico di Marcaria (biagi et al. 1983), Razza di Campe-gine (cazzeLLa et al. 1976). Alle Arene Candide la quanti-tà di quarzo ialino negli strati V.B.Q. dello scavo Bernabò Brea si aggira intorno al 6% (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1) e in quelli coevi dello scavo Tinè è attestata all’8,2% (starNiNi 1999, p. 231), mentre è solamente lo 0,4% negli strati della Cultura Chassey dello scavo Bernabò Brea (starNiNi - Voytek 1997, fig. 1). L’ossidiana e in particolare il quarzo ialino sembrano circolare, in modo più limitato nel Neolitico antico e in quantità maggiori nel Neolitico medio, principalmente in aree come l’Italia nordoccidentale (Liguria, Piemon-te) o nordorientale (Friuli e Carso Triestino), povere di materiale litico di buona qualità (barfieLd 1981, p. 41). Nel Veronese, area dominata dalla ricchezza di selce di
ottima qualità dei Monti Lessini/Monte Baldo e delle mo-rene del Garda, durante il Neolitico il quarzo ialino non risulta essere mai attestato, mentre l’ossidiana presenta solo sporadiche attestazioni nel sito di Gazzo Veronese-Ponte Nuovo, attribuibile alla II fase V.B.Q. (saLzaNi 2002, p. 82; 2005), nel sito di Pieve di Colognola ai Colli (saLza-Ni 1992), oltre alla presenza di un vecchio rinvenimento sporadico a Bellori, attualmente considerato poco atten-dibile (thorPe et al. 1979, p. 85). In Trentino una lamella di ossidiana è stata rinvenuta nel sito de La Vela di Tren-to, che presenta un’importante occupazione durante la II fase della Cultura V.B.Q., con elementi di contatto con la Cultura di Serra d’Alto dell’Italia meridionale (bagoLiNi 1990c; Pedrotti 1990a). La presenza, molto spesso in associazione, di queste due materie prime in molti siti della fase media della Cultura V.B.Q. della Pianura Padana sembrerebbe suggerire l’i-potesi che esse circolassero associate. Tali materie prime parrebbero inoltre possedere, rispetto alla selce, anche un carattere più esotico e di prestigio, inteso come più legato al rituale stesso dello scambio, più che un valore effettivamente di tipo utilitaristico (barfieLd 2000, pp. 55-56; mazzieri 2012, p. 110).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVEIl sito di Castello di Annone non ha restituito un campione numericamente molto rilevante di materiale litico scheg-giato, che appare ancor più scarso se paragonato alla grande quantità degli elementi ceramici rinvenuti. Esso risulta comunque molto significativo sia per quanto ri-guarda l’ampia gamma di materie prime utilizzate, sia dal punto di vista crono-tipologico.Tra gli strumenti, accanto a elementi di tipo occidentale in selce bionda francese (punta foliata a losanga, trancian-ti trasversali, raschiatoi foliati) e di tipo padano in selce sudalpina (punta foliata a faccia piana, grattatoio fronta-le lungo e lamella-raschiatoio), è importante sottolineare la presenza di un perforatore foliato/astiforme, strumen-to che si diffonde in Italia settentrionale a partire dalla III fase V.B.Q.A prescindere dalle considerazioni di carattere quantita-tivo, a Castello di Annone, in accordo con i dati emer-si dall’analisi della ceramica, anche nell’industria litica scheggiata sono quindi ben delineate due diverse com-ponenti culturali, una di tipo occidentale (Chasseano) e una di tipo padano (Cultura V.B.Q.).Pur nella difficoltà di riconoscere le catene operative, è possibile ipotizzare per la selce sudalpina, la selce fran-cese e il quarzo ialino una lavorazione in situ (anche gra-zie ai microresti provenienti dalle setacciature), mentre l’assenza di nuclei in ossidiana potrebbe essere imputata sia alla lacunosità del materiale sia all’importazione esclu-siva di supporti laminari.L’insieme delle materie prime presenti nel sito (selce
Fig. 297. Frammenti di lamelle e scheggia (5) in quarzo ialino.
332 PAOLA SALZANI
bionda francese, selce sudalpina e selce appenninica, quarzo ialino, ossidiana) è rappresentativo del materiale che circolava nel Neolitico medio e recente sia in ambito ligure (starNiNi - Voytek 1997; starNiNi 1999), sia in ambito padano (ove però non sembra arrivare la selce bionda francese) (mazzieri 2012, p. 110).Ciò che stupisce è la notevole presenza di selce bion-da francese (22% del totale dei materiali in selce prove-nienti dagli scavi 1994-1995), materia prima sicuramente importata nel sito da gruppi umani di origine chasseana, ma correlabile a una scarsa quantità di materiale cerami-co chasseano, che a Castello di Annone risulta percen-tualmente molto inferiore a quello attribuibile alla Cultura V.B.Q. (cfr. S. Padovan - P. Salzani, supra). Questo ci in-duce a sottolineare come il campione di materiale litico scheggiato analizzato non sia da considerare rappresen-tativo della reale situazione del sito e sia indicativo di un’e-vidente lacuna nella documentazione disponibile, da rife-rirsi ovviamente anche alle altre fasi cronologiche presenti
nel sito quali l’età del Rame e del Bronzo.La varietà di materie prime rinvenute non può essere correlata solo alla carenza di pietre scheggiabili nelle vicinanze del sito: da un lato la presenza di selce bion-da francese è significativa della penetrazione verso est di nuovi gruppi umani chasseani, con i noti mutamenti culturali che investiranno progressivamente tutta l’Italia settentrionale; dall’altro, se durante il Neolitico antico l’ossidiana raramente penetra in Italia settentrionale, con la II fase V.B.Q. sembra diffondersi in modo abbastan-za capillare soprattutto nella fascia centrale della Pia-nura Padana, spesso associata al quarzo ialino, fino a raggiungere aree ricchissime di selce di ottima qualità (come il Veronese) e penetrando fino in Trentino. Questo fenomeno risulta significativo sia dell’apertura di nuovi canali di scambio verso l’Italia centro-meridionale, sia della valenza non tanto economica, ma culturale (ele-mento esotico e/o di prestigio) di queste particolari ma-terie prime.
1 L’identificazione di questo litotipo, ef-fettuata solo a livello macroscopico, ha ricevuto conferma dalla visione del materiale da parte del dott. F. Negrino, che si ringrazia sentitamente per la di-sponibilità e la collaborazione.
2 In Piemonte l’importazione di selce fran-cese sotto forma di nuclei è stata ricono-sciuta a Chiomonte-La Maddalena, sito in cui la maggioranza dei materiali ceramici mostra forti affinità di tipo transalpino oc-cidentale (bertoNe - fedeLe 1991, p. 74).
3 Il materiale in selce bionda francese delle Arene Candide sembrerebbe provenire dalle stesse zone di approv-vigionamento di quella rinvenuta a Ca-stello di Annone (starNiNi - Voytek 1997, p. 353, nota 3).
NOTE
* Scuola di Dottorato in Studi Umanistici - Università degli Studi di Trento | via G. Beltramini 6 | 37124 Parona [email protected]