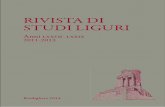LA VIA DELLA "PIETRA VERDE". ll territorio di Piadena tra Neolitico ed Età del Bronzo
Transcript of LA VIA DELLA "PIETRA VERDE". ll territorio di Piadena tra Neolitico ed Età del Bronzo
archaeotradeantichi commerci in Lombardia orientale
a cura di
Marco Baìoni e Claudia Fredella
"$ uaglET
ffiPll;l'l:ryilfllxx,ì
#,
Regionelombordioculturc. Identità e Autononiè
vAIi,(slt
csu
{w
ffi@ry]tc
tr,"Ff
sii
;8.ù; l ;'1rìn
qr@comùne cavianl
Catalago a cura diMarco Baioni e Claudia Fredella
trfarco Baioni, Claudia Fredella, Brunelia Portulano
Per la reuìsione deì texi si ingraziano Clementina Coppini e Maria Gíuseppina Ragqiero
Edito a Milano nel 2008rSBN 978,88 86752-35,0
Realizzazione editorialeEJizioni Eraf:.o Indh.ndenza. l2 - 20129 Mìlano
MusEO Cr\,rco ARCHEOLocrco "PLATINA", PnDENA, CRtMot.-A
IA VIA DELLA "PIETRA VERDE"ll territorio di Piadena tra Neolitico ed Etàr del Bronzo
Marcc' Baioni, Eliabetta Starnini
. epoca preistorica uno dei principali stimoli per
,.ilLrppare contatti, anche a lunga distanr-a, era la
::essità da pane di queste antiche cornunitìL di pro-::lr:rsi rnaterie prime necessarie e idonee alle latora-:rni di particolari oggetri e strumenti.:pprorrigionamento di rocce (selce, diaspro, ecc.)
::: c.rrarreristiche tecniche che 1e rendesscto facil-:::re lavorabili rramite percussione per ortenerne
.::lenti taglienti è stato un obbiertivo di fonda-:::r;le imporranza poiché intimamente collegato. rrrategie di sussisterza e alla sopravvivenza dei
::,:ri umani fin dal Paleolitico.
--::do poi, con il Neolitico, alla tecnica di scheg
: :::ra si :rggiunse quella della levigatura della pietra,..i.rrono fonti di approrvigionamento anchc per
' ::.rgic d; rocce completamente diverse, adatte a
, .:: lerìgatc e a tagliare il legno (giadc, eclogiti,,,, :olo in quelle aree d'Europa dove non erano
. rl. ,lrern,rire all.r 'el.e. que'r'ulrina mrrerir- - : . ie ne adatrata e Ievigara anche per produlrc le
: :::::io con il NeoliticoAntico dell'ltaliasctten-gro'.omodo corri'ponde ir . "ro-. ' -:.:iocarbonica calibrata alla seconda rnetà
. . ,-.rllcnnio a.C., che la circolazione di rnatctie: _ -. ::iuǹ una dimensione mai vista, con una
, :,::r . e rcLczione deLle lonti tli buona qualirìr,
:::: leme o la "pietra verde" pcr le lame
d'ascia/accetta(1). La circolazione di rnanulàtti lei ig:::raggiunse tale dilfusione da porer essere p,rr,rgon.:i:
a quella dell'ossidiana(2) e non è da escluderc;h-que'ri mJreriJli 'egui*ero lc merle' ne d r<-r r
Ir que'ro periodo ino.re la re.e'.ir r di pro. ' .
materie prime adatte alla produzionc di urtnsilisembra prolondamente connessa con la slessr di\Iri-buzione delle culture archeologiche presenti sul rcr
ritorio(4).Varistudiosi hanno inlatti notato comc l'arca c1ì .1iifusione delle due principaii culture archeoiogich.neoLitiche, la Cultura di Fiorano e quella del Vho d:
Piadena e Ia loro inttinseca interrelazioDe. serrrblrr,.l
da mettere in relazione a1 tcntativo di conrroll.r. i
lìu*i di dit'ererrri ripolog e di rn;reric prin ,
La Cultura di Fiorano, una delle compagini culmr.rl:meglio conosciute del Neolirico Antico dell lr.rli:Settenrrionale. è dilfusa dal Veronese all EnrilLr
Rornagla fino allaToscana settentrionale (fìg. I I L.:
ben anescara presenza di oggerti cararterisrici di qLrcsi.r
cultura in siti appartenenti a tuttì i principrìì gruppiculrurali conremporanei sparsi neLla pianura Lnel:I'esistenza di una rete di contatti intensì e, probabil
(l) BARFTF.TD 2ooo.(2) Si veda il conúiburo di D. Lo Vero in quc*o .ohn..(3) TYKor i996, ì'r\srNA 1998.(4) PEssÌN^ 1998.(5) IJrssrNA 1998, p.98 eseg.
{4Gruppo
dell'lsolino
G&Dpo\r€3k.
lìnènica
t. Cnfti ddl lúlin sette ttionah ton gli areali delh principaÌír,t:ione dí C. Liborío).
men(e, ura sua certa posizione di preminenza(6).
QLresto fenomeno è sraro recentemenre spiegato con: 1.o.'ibrle,onrrollo chc qrre'ra .ulruu e'e-cir:r:sull area dei Monti Lessini nelVeronese, quella che è
.Lrrn,erte la prin.iprlc lorrre di :poronigionr-r r.r r^ di .cl.e di brronr qu.rlir.r de l lLal a 'errenrrìon:ler7). La scoperta diar€e di lavorazione della selce
nelì insediamento di Lugo di crezzana (\rR) (8) e laronnessìone evjdenre tra oggetti tipici della cuÌtura diFìorano col la presenza di selce di tipo lessinico finonelÌ area toscana(9), confermano questo quadro.
r I'È' un. dcsùi,ione del Neolitico Antico prdano si veda
- ll ]rirLì) 1993.. \1,,.:rL t000, ì\{osFR, f[DRorrr 1996.
I'r.. \r 19,18. p. 99, Dora n. 8.
cahnte delNeoliíco antíco pada o (da PEsstNA t998, ieÌibo-
l,a Cultura delVho diPiadena è documentata anual-menre in un areale che va dal Piemonre meridionaleall'Emilia occidentale fino alla Lombardia orientale(fig. 1). Pur essendo uno dei gmppi culturali norigià nell'800(10), al momento rimane quello menor ono\cruro! rono.tonLe al.uni re.errri rin"enimenr,effettuati a Isorella. nel bresciano(rr). Da una som-maria analisj della produzione ceramica di qLresto
gruppo, è immediaramente percepibile la lorte pre-senza di elementi stilistici e formali propri dellaCultura di Fiorano, segno senlaltro di uno stretto con-
Uno dei possibili morivi che potrebbero spiegare le
(10) B^coLrNl 1980.(l 1) SùRNÌNI 1l zllt 2000.
0 Km 50N
A
:. a:nna di Llistibuzion. dtlk pìend leùgata nell'halia settottrionale (rielaboruzíone S. Paba).
:finirà rra quesd due ambiti culturaliporrebbe essere
propLio il Luolo di tramite che la CL ùra del Mro rive-!iira nella c;rcolazione della pietra levigara. lnfatti lerrincipali lontidi appron igionamento dellc mateLie-r n. r.rrli pcr li pr"Ju/ion, Ji q,re.rioggelr \orìo:'i. ,r ne h p-rre o,. idenrrle de Lerrrrorio ,orr.
::ollaro dalVho(ì2) (fig. 2). A questo punto è inte-::srnre sonolilcare la norevoÌe presenza di vie flLr.':li e soprattutro del fiume Po nel suo areale, che
:': : : ...-r. proprio urilizzaro come pÍincipale viaor transrco. Nel panoramà del Neolitìco àntico prdanodrrqu. qrre.re due crr'rrrre .ernbrano;rer gro.aroun ruolo prcminentc e complementare per la circo-
(11) L,LssrNA Ì998.
lazione dì particolari risorse litiche in lt:lia serr.rrrr"r.rl.. ru"l".lre pu".r'r dcrernìina,o u ì ',.. f ..influenza cukurale, quesr'uhima parricolaLm.n:.apprczzabile soprartutto nella pLoduzionc d.Ì.:.
Lcstrazionc c la lavorazione della pietra le. ir:r.:devono avere avuro anche conseguen'z-e fondanen:rnell'evoluzione sociale di quesrc comLrniri. J:.momenro che tali attività presuppongono Ia prtsr:ru..di irrdrridu: 'pecirlizz.rri :ll irre roJe: grrpl 'r ,
Neìì'area deì Vho è scato indivìduato anche ì inrci.!sante atelier di lavoLazione deila pierra ler ig.rr.r J:Rivanazzano, nelPavese, anche se l'ativira prodLLn..:piu ,onsisre,rre dcl .rro .cmbrerebbe riL-. ..
rilerirsiad un momenro pìù àvanzaro del \eolìrLl.
3.Lanedidsc;aíPietraurdehlVhodi?iatlzna:nlineclogirctlalkLatteiddiPíùdenL;n2ineclos;tedaSanLarenzoGnzzone (fongrafn dí G Pedersaní)'
Dur non polendo comunque e'cludere un in izio del-
iu,'ti,ro d.ll "r.,
gii , pariire dai \eolirico anrico 'Linnovazione teJnologica introdotra a partire dal
Neolirico con la levigatura delle rocce è fortemente
Lonne\5a (on le e"ie"enze delle nuovr economia di
'u'\r'(en/e e con5enìe di produrre quello 'he
è giu-
.e-.nte .onsiderato unÀ degli strumenti simbolo
della neolitizzazione: l'ascia dì pietra (fìg 3)'
l.ì \idi ndt, pp- 99-101.
Con l'awento del Neolitico, e a partire proprio dalle
sue fasi pìir antiche, l'uomo inizia infatti a produrre
" ad u,are oer la prima rolla nuovi 'trumenti di lavoro
immrnicaii in leeno e forniti di lame in pier ra levigarr
,he averano la'ío,-" e l" funzione delle moderne
asce/ac(elte e .calpelli in metallo Quorisrrumenrrcostituiscono non solo l'indizio e la prova indireta del-
lìnizio della orarica dellabbanimenro degli alberi e
della bo.caglia per ooenere lo 'pazio da 'ohivare pe-
il pa*olo d"eglianimali e per la co'rruzione di in'e
=t,tpìo mopafca di uo di n'cia h ?ietla l€r';1ata (da
. ,-!:Lt\ - PFIREQU:N l98B)
-:.. nr, *;b,li. ma ajlche della I;uor.rzione del legno.
.rr.rrilizz.rro per la 'osrruzione di 'rrurrure
::::nne. ripari per animali ecc ) e infrastrutture
- -,.r'o",, prti,)"t' \rrurrure Per oorzi d a'qu''
,-.:: ... , i.eri ,bit''i non'[e da 'onhu'ribile, -, .,1a,'. le ;birazioni fare lu'e nell o'curitl e
, ,..... ti .iS" e la ceramica ?urtroppo' di tutto
- --- ".,iei"".t. dtl legno preistorico non è giunto
- - "r,.it"rrr. m' p*'i'lmo;mm;ginarne la rr'-
- - .];,i;...," consi\rente e d'rllr di'er'iri di
: -: e dimensioni degli strumenti che sono servttt
:-- r.,-"1r...t'. 'i ti"'"engono nei 'rti.archeologi'i'- ...-,'menrali hanno di'no.tr aro che
' on un a'
- --.n
tama ln piet.a verde si rie*ono arl:hbatrere
l'. - ..Lair.."o ZO Z5 cenrimerri in 20 21 minuri
. -..o. rouer.lle di 12-15 cm di diamerro in B-10
minrrri, menrre per un irgg o Ji Jr ' rr lr 'l ìîr' rr":;.:;'1,;i; t'o,, . nì"" d rr\"'" ' -
nieso/rraffilarura di berr rre ac'€(r<rlrt .'
ìliioo,,,nrr.b.l'*iÀ dofe " r\'í( rLll ' : ":: -
i.i N.àìi ""
Anri(o non (ide'e pero I r r Ju: ':'i-.r.-".f a,,i'a aa pa'ifi'o:grr'olrore ll rr r'" '
;.:i;;;li,'À.',."*;ne di r'lheim nerr' t" r r r -.ììi.l-, ta."*r.. -" Jr individu; gerr"ri ll'inr'r 'ì.ì.ì,iì,'.t .""" per ferire i nlerre' c-r. ro J'
:.ce ìn pier ra le' iP,:ta' la ha definiriv:mente ro't' ttr
li" tJi,i "'i,,i'o'"
lascia fu arrhe 'trun'enro J'
"n'r, ,,","'. n. 'i't Neolirico più aranraro dilerrne
l''".,i. iìììi','*1" legaro ailo rarr*nciale d'l
;.""'i; ';,1;.";.
Bulrriero e percrò ac' orra nellr
tradizione'epolcrale megalirica'
La oroc.duri di produzione di quest i 't tttment t ut t-
i',,"",.ìr*t. Ii ^'r*titico è +ara oggerro arrche di
'' "ii l*n'.",4; i *'ti rrtrrverso la replica dei ge'r'
. deeli ar rrezzi in u'o duranre il \eoliti'o sonortu-
ìJJ"..ii,,it. i. .'alit' di e'ecuzione e r' Le' rologi't
"nr.i." p., la manifarturr delle '5(
e rn Prerr'r
i:;ì;;,,li . ó"..,, ,..nica rima"e in u'o fino all eta
ii'"eì"-..;à., "a 'or"o delh quale 'enne
defini'
iì,-.1,. '.Jol-'"', aalla produzione di piir efìì*' i
srr.rmenri in merallo Lo 'rudio della re\nr\r pro
J",'i",. aaf. car:rteri'riche ripologiche può 'on-ì.",i'. a-l ."fì*'" gti oggenidi pierru lerigata rrel
iìiìi "
ai ." tu"g-' t"-i ai Lempo '1al Neolirico
i",ì..,ri ""^ '0""ri'o dal vl al tl m;llcnnio I C'
ir'..."i* aAf, f.'i*t''ra si ba'r su PrinciPi PiutLo'to
semolici, m; inplica un lavoro \o\rJnte e \Pe\\o Prut
ì",,5 i"ì*..i"i'.o"'fiB qr' Perque+o mori'o fin
a" ì.Ui'""f *.. ..r.0 àr "corcirre il pii.r po*ibile
ì,.-rf a-' i*.',, '"' 'cegliendo per esempio cioooli
iì'i"i.,.i.ir. Jr'geerrlo 'he ri uoleu"eali'z,'e '
;;;;J" ;;i "",.b:'"'zarur" medianre lo 'recco
di
'il;.' ".' awicin;ni ulreriormenre alla 'agom r
delo"ír.umenro Suc'e'sir'rmenre si operava unr pr'
(14) A-Lr VAcu - VAHL 1995'
(t5) DrLc Ro 2005
93
i E:enpio etnogafco delk catend optmtiu delln pietra
thienatura con un grosso Percussore per elìminare
. er rrri rrrcgolarirr e poi 'r pa.'at I al'a ur ra e proprir
ler ig,rtura, che spesso non veniva eseguita su tutto Lo
rrrùrento: I'ascìa per esempio era levigata solo nella
zon.r del taglio, mentre corpo e tallone erano lasciati
sclbri pcr fare aderire meglio I'inmanicaturaLe lcrigatura era eflettuata mcdiantc continuo, lento
. regoliìre slrofinamento del supporto da lavorare su
LLn blocco di roccia (arenaria' qLrarzite o granito),
..r rterizzato da sLÌperficie abrasiva detta levigatoio,
ton il contributo di varie sostanze abrasive, quaLi
.rt'bi:r e paglia, c di acqua. Il levigatoio' che può
:sscrc lisso (una grande roccia) o mobile (una pietra
: I r.rr-:k .prernrr.ol;r.lnìcnIeJmpie'r'irrure(on.'i,enità appuntite, disposte in serie spesso parallele'
. :oppcllc oraLi piir o meno marcate (lLg 6)'
L r.'c^.rzioni etrioerafichc hanno rivelato che la levi-
6. Exnttio etnogtdlìto di leuigatoia
gxtura è considerata un'attìvità enr;nertemenremaschìie e ciò pare confetmato dagli usi funerari del
NeoLitico europeo: essa spesso è connorltà 'li v'lenze
scssuali e dunque vietata alf interno deivillaggi o dci
campi colti'ati, perché ne vioierebbe la sacralirit(r"
Oltre alle asce, con qucsta tecnica venivano prodotte
irccettc, accettine, scalpellini a doppio tagliente c
;rrelloni in picrr:. Quc'Li rrlr imì. . ar.rr teri'r i.; 'oPr':rturto deL Neolitico Antico, necessitavano anche dì
úna pclforaziorr€, ottenùta Presumibilmente con un
,r"p"no " -"no o ad arco; sono comunque docu_
rnerr:ri loridr v,l| ,ipi rr.lc'.irlrr. rrorr.o.orr;.'ciLindrici), che probabilmente somendono tecniche dif--
ferenti (frg. 7).Le rocce
-utilizzare dovevano possedere particolari
(16) PÈrRIQUìN PnÌRlQUrN Ì99J
7. Anelane;n seryentìníte da San Lorenn - Vho di Piadena (fonsafa di G. Pedesaní).
caratteristiche recniche, ben diverse da quelle che siusavano p€r produrre mediante scheggiatura cohelli,raschiatoi ed alrri srrumenti ricavati da materialisìlicei. Il dato esteriore piir evidente è un colore ver-dastro pìir o meno scuro, da cui deriva il termine'pietre verdi". Queste rocce, a grana fine e particolar-mente tenaciJ con durezza pari a 6-6,5 gradi dellascala Moss e peso sp€cifico elevaro, sono adarte a
sopportare un lavoro e uno stress determinato dallapercussione da lancio, come quello delle asce/accetteusare per spaccare il legno. Esse erano, per le loroeccellenti qualità tecniche, acclrraramente selezionace,
talvolta ricercate e trasportate dall'uomo anche .r
grande distanza.ln Italia gli affìoramenti di queste rocce verdi, iL cuicolore è dererminro in realr) dalla loro origire mcr"morfi c: (eclogiti. giadeiri, onfacir iri. \erpennnir:.ecc.). .ono ubicarinelle Aipi Occidenrali e ir parricolare nella formazione delle Metaofioliti d'alta pres-sione del Gruppo di Voltri, in Liguria, del Monr ìso.
della Valle di Susa e della Valle d'Aosta(i-). DuranreI prei'rori.r. comunque. l uomo poreua ,pp'o'
' 1916-
(Ì7) D'AMlco -SrARNrNr 2007.
9)
i:.,: JrLh mrrerir prima sia prelevando blocchidagìi
.:-lor.rmenri primari, ma anche, molto piir agevol-
::enrc. uccogliendo nell'alveo de; firmi ilcinrnhme
','porrr.n.,pe,,,ruu. Lri oggcrrr finiri.o ir,or'r-rJi lar orazione, rinvenutì nei siti archeologici e la sco-
pen.r di veri e propri ateliers di Produiore, com€
quello di Rivanazzano(18), ci testimoniano I'esistelza
.n 1 '*rr" Jierrrrrmbe le prurr.he t'ploraziolr'on-dorre tra Liguria e Piemonte nella Val Pellice, Val
Chisone, VaLli di Lanzo, Valie dell'Orco e nei bacini
dei rorrenti Erro e Orba hanno dimostrato la relativa
.rbbondanza di quesre rocce Dei greti sotto lorma di
cìottol:rme proveniente dallo smanrellamento dì
,rnriche morcne glaciali e di conglomerati Oligoccnici.
Snrdì petrografici accerrad di càrattcrìzzazione e com-
posizionc diqueste rocce verdi hanno permesso di ma-
bilire che le lame d'ascia ìn pietra levigata, realizzare
con le metaofioliti alpine, hanno circolato durante ilNeolitico in tutta l'ltalia settentrionaLe clando origine
- u r,r terr e proprir e.porrJ/iune d i m.rrer:r Prima o
li ogg<.r fi niri. Llme di r\e/.,. (erre iî e. logire e gi,deìte alpina hanno addìrittura raggiunto le lsole
Blitanniche e sono state ritrcvare verso nord in molte
locaLiriL dell'Europa centro occidenúle soPrattutio
sotto forma dioggetti particolarmente rifrnitì, coD le
superfici levigate a specchio, diventando' a dimosrra-
ziorr. .rclh lo-o ri. er.rrezu.r " , i r. cce . he 'rrumenr:cli lavoro, verì e propri simboli tlì prestigio
Con la stessa recnica di levìgazione della pietraimpieeara per le asce si labbricavano in ltalia setten-
tri'nale.rn.l'c anel'orri lir:.i, rrrrlirzando'ir roc.c
erdi .',ro'e cone 'rrperririri..'orrro.ci.ri c 'er-penrinoscìsti, sia il marmo,la cui clestinazi"'.e doveva
esscrc ornamentale, come testimon;aro dxlla Posi-zione di questi oggetri osservata in alcune sePoltùre
neolitiche scavatc in alcune località europee, nelle
qu.rli questi anelloni sono sratì rirvenuti indossati
comc bracciali.M.8., E.S.
:5 D 1\1rco - S rARNrNt 2006.'q lìr.,t nL Bo!ÀRD 1996.
Strumenti in pietd lru;gdta da Piadena e tltnrt''
Le stazìoni preistoriche deì Piadenese sono nc'i: ::studiosi giir a parrire daLl'Ottocento (20), rllorqL:'l-
i lavori agricoli ponavano alla luce mareriale :r::.:logico specialmente intorno all'abitaro di Pi:,r::: ,
al suo sobborgo olientale dcl Vho. 'fanto che og:.::ìn pietra levigata da quesr'ultima localìtà entraror, -
ternpo a far parte delle collezionì del Museo l'ig..di Roma c del Museo del Castello Sfones..: :l\4: ano /' . A que'ri 'poradici reperri r'nr.nt t
'opiir in modo del rurto .a'u.rle dai 'onr,d :
rggi.rn'ero rel rempo , ollczioni d' manul:rrr -
di ricerche e scavi piìr sistemarici, condotrì dopimetà del secolo scorso, soPrattutto Per oPer.::Bernardino Bagolini e Paolo Biagi(22), durante il l.:paziente lavoro di ricostruzione e sintesidel NeoL::-
in Pianura Padana e in Italia setrcntrìonale Qu:rultimireperti, costituiti da lame d'ascia/accetta. .;-: -
pelli e anelloni ìn pietra verde levìgaca, sono:::ren,po in gran prrrc confìuiri nelle collez o r ':
Cìvìco Museo Archeologico Plarina di Piadena, do :
.orro c'po't'aJ pubblr.o .n'ieme alle piir recenri r-q
'izioni. Urr r..ur:,o.rudio didcrerminarrone ' .:
tifica delle rocce, condotto di recente sulle collezio::
di Piadena e i cui ristltati sono stati pubblicari n:200 r 'u pnrrig:o'o periodi' o nrtion;re di pre' ror ''tl Bullettino di Palemokgia baliana(2:l), ha rivelr!.che le materie prime utilizzate per la manifattur:.
delle "pietre verdi" sono originarie dell'arco alpin.'
occidcntale e sono state dunque trasportate per alcun:
centinaia di km fino alla Pianura Padana centrale
Questo approwigionamento da lunga distanza è ini-
(20) PAìì"Azzr 1890.(21 Iì r'e rl, provi, rr drl Vrocorrr.:i'MLropo*rr' r, J.11., .o rz o:'c d' .rp-oI "'rel r.o i\rd'1R*ì, rir-B^, 1e75. BALoLINI .r,r/1987.(22) fra i molti hvori pubblicati, si vcdano in parri.olar.:BAGo! rNr - BìA.cr 1975j BAGollNl - BIAGr 1976(23) STARNrrr ctaltr2006.
ziato già a parrire d la lase piir antica del Neoliticolocale, corrLpondente al fiorire del gruppo culturaledel Vho. .he derir a il 'uo norne proprio Jal[ .r: u io re
preistorica scoperta al Vho di Piadena ed è continuaro per rutta ia durata del periodo NeoLitico. Per
quanto rìguarda la lunzione di questi strumenti è
necessario soctolìneare che essi, nel Piadercst, rrrostari sempre rinvenuti privì dell'immanicatura ligneae pertanto non è possibile stabilire con ccrtezza se 1e
lame lossero orìginariamente fissàte con il taglicnte
lJr.ìllelo al mr ni, o. owero . on lurrzioni d i accena oscure, oppure perpendicolarmente, assùnendo così lalìnzione di asce. Neppure l'osservazione della mor-tilogr., del reperro e de e rrac.e d u.o re'idre rirrrrno.r comprenderne la funzione spccifica, poiché le strieprc enr. .oro qua'i 'en-p,e
riÉeribili alla levrgazronc
e riaffilatura del tagliente in corso d'uso, mentre ìlcosrante riciclaggio della matetia prima, che come:bbiamo visto era particolarmente ricercata per lesue orrime qualità tecliche, determila il cambia-nento di funzione dei manularti nel corso della loro'.ire. talvolta fino al loro ultimo stadio di urilizzo:ome percussori. È per queste morivazioni che pare
riu corretto definire <luesti oggetti col termine biva--:rre dì asce/accetre (figg. 8 e 9), mentre gliscalpelli::erenrano ula morfologia piir specifica, con dimen'r:oni dir.erse rispetto alle asce/accetre, e sono carate:::zarì da ula lunghezza proporzionalmenre mag-r. r. r ,loro l,rgherz,. lnolrre la loro pre.enza.i' e.
:..riica in contesti Liferibili alla Cultura dei Vasi a: r:ca Quadrata consente dì stabilìre la cronologia::...r comparsa degli scalpelli nello srumentarìo delle:::olazioni neolitjche dell'Italìa sectentrionale, pre-::::nente all'nrizio del Neolitico meclio.
-::.:lirà del Piadenese che hanno resrituìto manu-:-::r in pierra verde levigata sono Campo del Ponte,
l:::po Costìere, S. Lorenzo Cuazzone Cascina.::;hi. Campo Ceresole, Campo Sera-Mattina,.--.-i: e t r.rell.rro. Molrr di q.rc'ri reperri'oro
:::::renrari perché si tratta di oggetti rinvenuci nellej::r: Ji discarica degli insediamenti preisrorici, dove
8. Lana tli ascia ;r onfacite da Canpo Ceretole. :tan t 9 6(faagraf a di G. Petunmi).
veriv:no gerrrri rurri i rifi urr inrrilizz:bili. si po.."ricolosceresopmtuno lrammenti del fiIo del mglicnre
e framment; di ralloni, che ci tesrimoniano quanrolosse intensa la lavorazione del leglo legli insedi.r-
menri.DaÌ Campo Sera-Mattila proviele una beÌlissìm,rl..rna d,'c.r/:c.err; ir giadeirire @. rirrenurr rsuperficie, ma probabilmente affiorata dai resti del-ì'insediamenro del Neolitico antico. docunentaro da
sondaggi eseguiti neglì anni '70 delsecolo sconoll-- .
Que'ro oggerLo. .orferiorìJro r on urr mJre j" p- nJ
di un belverde quasi tmslucido, con le supeLfici accu'raramente levigate e Iucidate per tutta la loro esten
''one. e drrlque di par rLolcre pregio e\ren.o. .i l,u.considerare, anche alla luce di una particolare somi
gliezza che ne pregiudica I'utilizzo come stmmenro da
lavoro, come uno deì rarissimi esempi di "ascia cerì'moniale" dell'Italia settenrrionale.
(24) BÀcoLrNI - Llr/\(jr 1975.llmanùfàÍo è esporo n.lIilL(rìArcheoìogico di Remedello @.
9. Lanr diastìa in vpantinlte dalvho di Piar{e d (fotogafa
\ rri ^ggerr in pierr: .erde Prrri\orJrmerre (rrrrri
nella lavorazione erano i cosiddeni "anelloni litici",urìlizzàti come ornamento Personale con funzìoni dì
bracciali. Dalle srazionì dei Neoliico Anrico clel ter-
ritorio di Piadena ne provengono diversi esemplai(2i),
rra i quali si disringue per la sua beÌlezza quello inregro
.n .. perri rire rinverruro a \. lorenzo Curzuone,.'.in"Ronchi tfig. -r. Clialrri. ben. hc lr;mmcntrri.ri tcsrimoniano quanto questi oggetti facessero Parle.r(l .o'IlIre.ultur:le d.l'epo,,. r"nro che Prarila-nìcnte ogni stazione ne ha rcstituito almeno un pezzo.
I J lr/nìnrerìr: \ono Pre'enri anche rrrelloni ir ' or'",' 'orrzrone. rotrr in ror"o d oper.r ' . he re*i no
r.r 'no.ir la rvorrziore .ul po'ro Ji que'ri oggerri. 'iala tecnica con cui erano prodottì Si partiva dunque
J,r un .rbbozzo ìniziale dì forma discoidale, ottenutor r.cn,lo n ediarrre .chcgg arurr e pcr.u"ione :
mrnello un blocco di pietra, al centro del qLrale si
:ominciava a creare una depressìone su entrambe le
:: i:iR\r\r rrul;i 2006.lr ! 'r\r\! ..rr;2006. fig 8, nó 2-3-
10. Fnmnento di anelkne in xtpentinxe in torso tli lato
't";ne ,la.\an Lornzo - Vho tli Piad.ena.
facce, prima a percussione e, successivamente, con un
uro strumento a cui si imprimeva un moto ro!a_
torio, onelendo così la perlorazione cenrrale. Quindi.se la perforazione era portata a termine con srccesso.
ovvero senza che ìl disco sì romPesse, come talvolta
aweniva in questa lase delicata, si completava I'oggetto
levigandone accuratamente le superfici, similmente a
quanto si faceva per i taglienti delle asce/accerre. SuL
tim nenro dr rnellole,n ri.ro par.rgonir co. Irn-
venuto à Campo Costisss{ur) (fig. 11,2), sono visibili
lor: di rip.lrazrone. e'eguiri qurndo que.rroggerrr "rompc!rno nel cor\o d(l lo-o u',r con_e or nrmerrri per-
.on.rli. l" .ura n.lla -ip.lrerione re'ttmonia renz.r
dubbio il loto valore, determinato molto probabil-
mente ànche da1 materiale esotico con cui erano cor_
feziolati.Infine, larne d'ascia/accetta in pietra verde sono state
raccolte anche durante le ricerche a1 Castellaro del
Vhò. un insediamento risalente all'età del Bronzo
Medio /8 . { giud'.,re Jrll; loru morfolog:, 'i .rrnrperò, molto probabilmente, di oggetti neolitici che gli
àbiranti dell;epoca trovavano nelle numerose località
del circondario e che, sempre per le onime qualìtir delle
(27) Sr RNrNr ct,1it2006, fig.2, n 5.(28) fRoN rr\r 2001r S r:ARNìNr .r rr;2006, pP. 32_35
t t. Frannmti di anellone con fori lalVbo li t'iarlena: n.
I in metabnsdha dal?azùto XXXIB di Canpa Cere:ale; n.
2 ín sciîto ?aftgo1lìtico dd Campo Costierc.
rocce con cui erano stati prodotti, venivano raccoltiper e*ere riurilizz:rr. principalmerrre,ome per.u'.ori.Non è tuttavra da escludere che, fino a quando le
lame d'ascia/accetta in bronzo non hanno completa-
-r.r,re .o'riruiro quelle ir pierr.l rrello.rrumenrariopreisrorico, contiruasse a essere attiva lavia di approv-ligionamento delle rocce verdi occidentali, seppurnon così intensamente come duranre il Neolitico.
's.
L'atelier di Riuan'x.zano lP\:) :')
La colleziole dì Rivanazzano è cos:::r::.:. .:.: :rore"olequrrrir) m.rnria iin 1'.rr" - '
fi. re roltre 00repcrti.di,u't00firo- .. r.
rirvenrrri di'pe^i .u rrn drcr p.urto\t^ (.-.La Cascinetra. I reperti rigrardano prc\:l.r:.r : ..narerirli in lavor:u ione, rd e'.eu iore d' . - .
le'igaro di rrinpezzar:..roè,bbo.,r . - .'stadio di lavomzione, scheggc e pcrcuss,:lri. cra:i:::buire, anche sulla base della presenza di nunì.1r..:abbozzì di scalpello tipici delLa fase iniziale d:l :CultLrra dei Vasi a Bocca Quadrata, a un atrii irà J:arrllrr risalenre probabilmente a1 Neolitico Iledio. I
sondaggi eseguìtì receltemente daila Soprinrendenz.r
per i Beni Archeologici della Lombardia non hanno
purtroppo consegùito risultari suf6cielti ad accen:-re
I'esistenza di un sito di abitato e a de6nire latt.ibu-zione cronologica della frequentazione deli'arrllrr' ': .
Tirttavia la natura di siro di produzìone dì Rit'.rn.rzzrno
nor puo renirc me\u in di'. u*ionc DIoDno .' ..'r, .
dellr parrr.olrre ripolog a dei mrn.rlan rin'.n'.trrutti r;conducibili a diversi sudi della catena ope-
rativa per la produzione di lame d'ascia/accerr.rlevigare, della quale è stato possibile ricostruirnc l:r
sequenza completai a panire dal ciottolo grezzo fìLr-
vialeÉ2).Dal punto di vista perrografico, la raccolta <1i
Rivanazzano si presenta litologicamenre unica nel
quadro delllr:rlia 'errerrrrionale: e'.a inhr i mo. r,
accanto ai piir comuni litotipi HP-meraofiolitici r.rr-
colti negli insediamentì dell'ha1ia senenrrionale (gi:rd.-.
eclogiti, omfaciti), un'alta quantìtà dì rocce gliruco-
(29) Scheda úàtrx.la Sr RNr\r Étalil2006.(30) D'Aì\flco ù nlìì 2003. D'AMlco Sl\1.r\! Zr,i::Sr,\RN1Nl2004j MiN\oNì STARNINT Sr\1c,\E Z.ìrrr lr'rbI nànufarii dì Rivanazzrno sono conscNarì pre$o ìl \lL,.i,Archeologico di Crsteggio (l'V).
131) SrvroNE ZoPFi 2004.(32) D'AJ'lrco .tzltt2003, fig. l, 3.
11. \4?nùl",ti ì pte!'a lct 4a'r dd Rin z ano N t 2'i1 ,.)"i," d' 'ar;,,"
r,i's,rc '[u4'nfr ' dì t <'"-ìn'4'7 abbaai Aì hma lì ascia;
ielaborazione S. Paba)
n.I abba o lti td:llknte lli lam'1: n
onrel fr
. ,, ,, p-,n k 4"," r, n;**-"i",,ii,"1;1;;1:;;i;ii,i;",íí!;f;i{,':,'::::;i,:":,:::{;:;:"t -,,,t ,tt,,udin",a t8-tl fnntn'nrt d
oI
,I o) ll ratro 'he que're lirolo-gie 'iano, .,.:..,.."00r...n,r,.,ra i mrnuf;Lri finor:
r Jci .lri di al-riraro autorirra a Prerrimere
.bi"no r ro! dro o po\o mercaro per l-e\por_'
." ' 'i,, ài ."""' o maggior dilÎ' olra
- .,'l*. f, f,'"'';'n' e 'iano
rim;*e nel'
' Ri':n:rr;no in form: di 'emilr\nri'r o
, -:one litologica di Rivanazzano apPare diversa' ,',.' i.ì's."ri,i'" 'qnri'o e inve'e lirolo-j ,.'ri ''rnit., ouelle dei 'iri del Neolirrco
: . :he confermerebbe la datazione ProPosta
:': tì: a Atcheolagica Pkùna Piadena
- ,', ìegli Studi dí Venezia
': :.;,ttíuì@aniae it
BIBLIOGRAFIA
ALI K.\.,V", Ll\!/.\1(\l' ' r'to( l; 1 "r' / rt '/rr'
^ )"::r;,'"*"' " ,, d'a baadken" t t'' \1 "
q''t 0'
'r-'rt'i'i i,)''n,;tt."".;n l-'rrdl<rI l'r' 'rr' B:d<
\virrrembelg. z0, pP l')5-21".- ,
ri- " - e rfeo. ',,1,,/'uiaa'
dt ^e'lt
' l' tt tt '
";,4/c. Pordenonc
"i:.;ilí; ;;;,;, ';À- B\ n, , B B\P, r, c \\ \\
"*,,".'',..^ii.. a l. ( Àl\LA!q'V rq^- \r'l '
i:;:,,';,;i ̂ ,:;,",";t:,.,"'t,, oap, cea'a"'.\ t dì t n t' n
';,;-:;;,t;, tr/'.to'o. n tt N'ottio n tnt t' \ti àettt
"{íi"*,"";.". 5';' rr iri a dell lltP rr'enz' - 0
""".mbr€ l98i), Frenzc Pp 4r)-abo
s^.",.::." À ni.' r' ; ''it\'t?"tttt'dctvt"'d tt"'l''ti" pretrtoLiaAlpina ,1I PP I-4)
o^i^l Ilà-il^ ii '"-" ria
'aqpo'a"or" wa tc'6
in trcrrorir Alpina l2 PP lrì0B^- ; ; i rj ;["j &e ttpt" nna orlnt ;n tt'" vo'r;""il",,i,, ,",:0",, i,a/; in A's ro r \- D \ 'n A ed.''
'',.,,),;,",",r' Iirhi' \rLdret\o'iell Oc'ù:onJ l"PE'' '
''i:',1'ii,,i,.:::":::;':.':^:{:ilb':':!.::'",::::)'' ì ) tt,"t, ;.-
" ",* "^ o' t n" e o adc we r\ d'n' 2J'
ll "'-f i"í'i""'r' '"ai trrro \uDr lqq ) Pp 556ú'
n Àii o'",,r'.:oo,r o\,\i'oC Vr\{Ì N4 \r^e\'\r",- t"ì.,'iir' lifr(tar ú p'"d"i,ac di a\c ia phú?
t,,,ii'.,t; ni,,"",-"" r\' Ddt; a'&P,qtt'ì't' Icao
)".li)i) i." ,d;,;*'r.À t "oa"nia dcth p'cir.o";a
ii;;:,: ;;' ;;; : ;,'; " "'t norn ;'u "
t' e:' la qa at ti'z'
;-"i ; a: t o,,; ar-nbo a'ea A ti de'la xX\\ tuurtrotre
...i"..i;"ì *'r irrr L'p,,r' 2 giugno 2000ì ri'enr' o0
98r-186.
^;-"""t \ÀìoN'Zor' l \I\aNv12n04" it"^',,i,",ì
'" Ldt a ivtt^:n.\..t' RNcc\''B\n
iì ,,."- ai,. Atla onqm'a dclt'App"n'itn tP ltia'';.;,;;)ii",ort, c"i"" L''u' "o ota ro t" pp
201-205n:o-,,-à i, :l\F\r\r f 2u0o taztt{ '/i R:uaaa'2oaa
" ^ri' ',;)''','"''"*
t;rctay;'d n'01tta nct 4ua'tro 't'ttc
")) )i1l:i ,a,'" i' ràt vnn' onP n rn rc'"
::;'ii";,': ,;'";;"," " ctùIf iu 'i'a'd" d Bt "'"1 ''"iili)i' ^',i
aa'*"'sno rud:or' r \ 2 ' 'e r'n'br'
)oA5). Ud,ne. PP lT-54Dî; ',;.; io'u'' r :oo- La't4 nza"P4c n1't'
101
::::.t:.. :i h,tlìn Sette,tt iotúh .le'untn .ldUe attociazio"i dì.-]":.rìùfìÒt;ti de r !ìetn utle ei iti archeolagí.i, ttl.::, Jcl Ì\'Consresso Nazionaìc diArcheomerria, Scienza. B.nì Culru.ali (Pisa, l-3 febbraio 2006), Pafton ed.,r,rLoenr pP roJ r À.
l.:! rR() D. 2005, ,4r.a rmtte e wtí in 'iietta rnlr" delle1:i o.Lkhnfu|i, "-rechnologhia , 1, pp. 13-19.
: ...ì \ r r\ r P. (. cura di) 20 01 , Cl'klktu del Vbò. Cdn?d{nd.i: \tao t996-1999. Scaùì d?Ue Ciùhhe mbe areh lqirhea.r -t1r1aao, Newpress, Como.
\fi\\o\Ì f., STARNìNì E., StMoNE ZorFr L. 1996,Rrrrr.zdl,r, in VENTURINo GAMBARI M. (a cura di), Z,| |.l.Ii píeùr,.ft{?. Li d6hìn ktíca leùkata wua ?reiitnidil! hatìa *tentríonalt,'forino, pp. 119'Ì22.
Lrto;dli ifth?ologi.i delk mnpagna di ratn 1993. iiI: A..Vu.lÒC G.urd) tnNco'tti, a-ionpt"aOrìette t Orìtunte, Att\ del Convegno (Udiîe, 23-24.lprìle Ì999), Pasiai diP.aro (UD), pp. 125-Ì50.
\1(\[R L., pEDRorrI A- 1996, L'abian neolìtìco dí Lugo dìG"zÀnra (Vtu"d): r.kzia e prclími,t1n, iD BLLLazzo G.,S ìLzr\r L. (a curi di), D,là tetra al n$ea. Caralogo dellaùorrra, l-€gnigo, pp. 2l-34.
I .r G d,l0. D,poi,tannto,ttnVhù.,etiaacr?.iBPl , XVI, pp.85-97.
lrr\Ì\AA. 1998, ,4r1dt .z bnati e ltobknatìche &l primo\'.otìtra d?\|'Ita/in lettdtriozlc, in PEssrNAA., Muscro G.t crrr di), Settemila anni fa il prino ?i e, dnbienîi e
,,1,," delk 'aúetà
nealitiche, Caraìogo della nosrra, Museor rr L rro dr .roru N"rur:1" L dr re. pp. or l0q.
l.:r:.eLr\ A. M., PErREeutN P. 198a, Le nlolíthiqt d6k6.Púhltaùz tb! k6 dz Chakín et de Ckìrmu (4000-2000.:r./-C), Collection des Héspérides, ! Editions Enance,l'rris.
I']i :{relÌ\ lÌ, PErREetrrN A. M. 1993, Eralagie d't outil:.l; Idche de pierte en ltian laya (Iadonésìe), CNRS\lonographie, 12.
R.L 't oL DoUARD M. 1996, l'éîtugftphie et socíhés néali-:i 4o ea kdncc n&lixta ée e. Lbutilkge en Pieùt lolie,\'oro:-r. pl :edu( RA.n. l0 ( \R\Idi on..
i: r,r\L ZopFr L.2004, R;"d ntnno (PV), Locatità Ldt..ttirena. Soùaggí nall arc/1 detl allcina dì ar. dí pìetut: . '?i. ìn \SAL" (200l-2002),pp.25-26.
ì -:{\i\r ù a/;i2000. STARNÌNr E-, GHrsorrr F., GrRoD 4,,\:r':t R.. N o,i ddti t,l Neolirno antico dclk Pianuta''.:...trù\nnl. dÌl lita dí Isarclk (Ùrc!.id), in PFjstNA A.,\1- f, :,, G. ia .un di). La Neoli;údzia e tn Oie te e
Oc.iddte, Ari del Contegno (Udine,23-24 apr;le 1999Pasian di Pnro (UD), pp. 231-2ti.
SrîRNrNl crli;2006. STARNTNT E., D',A,vrco C., BÌAGj IGHF.DìNÌ M., PrrrÌ G. 2006. St/une tí í" ?íct /rùS,t::./a/k Lonbaùia lriental?: dlpetti arch?onetici e &h ft;:in "BPI", 95 (2004) ser'e XIll, pp. 2l-82, Roma.
'f\Kot k. H. 1996, Obtidia prcamnent ind disîibutia, ,:the Central aul tX/e*ern Medirenaneall, ;n "Jovnal o:MediremDean Archaeologj/",9, pp. 39 82.