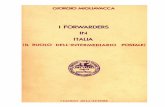Conati Barbaro C. 2010 - L'insediamento dell'età del Bronzo di Colle della Mola (Rocca Priora)
Il ruolo dei mercenari Shardana nella guerra del Tardo Bronzo
Transcript of Il ruolo dei mercenari Shardana nella guerra del Tardo Bronzo
3
Il Ruolo dei Mercenari Shardana
nella Guerra del Tardo Bronzo
Francesco Ignazio De Magistris
Tesi di Laurea Triennale discussa presso l’Università di Firenze in data 1
Luglio 2003
4
Introduzione: sui mercenari e sugli Shardana
Nel 1850 il filosofo britannico Herbert Spencer presentò la sua teoria sulla natura dell’atto
guerresco: la guerra, disse, non è un fattore evolutivo come un altro, ma l’attore principale
di quel colossale show che è stata l’evoluzione umana, il giudice che garantisce al tempo
stesso la morte al più debole e la sopravvivenza al più adatto. In quel darwinismo applicato
alla lotta fra civiltà che è l’ottica spenceriana, il movimento guerresco non può che portare
all’evoluzione della specie umana: in un campo nel quale la società più adatta domina,
elimina o assoggetta alla propria potenza gli elementi incapaci di confrontarsi con essa, si
innesca una corsa alla sopravvivenza delle società, che continuamente si adattano ai passi
in avanti compiuti dai contendenti. “Everywhere the wars between societies originate
governmental structures, and are causes of all such improvements in those structures as
increase the efficiency of corporate action against environing societies”1. La guerra
elimina le società arretrate, selezionando quelle più evolute; promuove ad abitudini la
cooperazione e la coesione sociale, stimolando l’unione di simili contro il diverso; rende
possibile la vita civilizzata, basata sulla spartizione dei lavori. Forzata dalla guerra,
l’evoluzione sociale conduce progressivamente alla formazione di società più grandi, più
complesse, meglio strutturate. La tesi che si porterà rispecchia infatti quest’idea: nella
storia del mondo spesso ci si è rivolti a forze che potessero controbilanciare artificialmente
gli avanzamenti tecnici dei nemici, a persone che delle armi avevano fatto un mestiere e
che, in possesso di capacità particolari, potevano combattere e vincere le battaglie altrui in
cambio di un salario: i mercenari.
La lotta per il controllo del gu-edinna, un territorio ricco di colture e pascoli che le città-
stato di Lagash ed Umma si contesero con alterna fortuna2, rende l’idea di quelle che
devono essere state le prime guerre fra stati confinanti: schermaglie -frequenti ma di breve
durata- fra forze contrapposte che dovevano essere semplici e di ridotte dimensioni.
Eserciti costituiti da un nucleo militare professionale di “specialisti della guerra” e da
1 Spencer, Principles of Sociology, terza edizione (Londra 1906) P. 520, in D.Dawson (1996) p.8 2 M. Liverani (1991) p.192
5
milizie cittadine, soldati di leva addestrati da militari di professione. Appare ovvio come,
nel caso di operazioni difensive, una piccola milizia coscritta e addestrata dal corpo
centrale potesse essere più che sufficiente. Ma operazioni di altro carattere ed a più vasto
raggio, come le incursioni contro città lontane a spese delle quali si voleva acquisire un
ruolo egemone nello scacchiere delle città stato del tempo, richiedevano un diverso tipo di
armata.
Fra il 3100 e il 2300 a.C., la guerra dominò la vita della bassa Mesopotamia “determinando
la sostituzione dei sacerdoti-re coi condottieri, la specializzazione militare e lo sviluppo
accelerato della lavorazione delle armi in metallo, nonché, probabilmente,
l’intensificazione del combattimento fino al punto in cui si può cominciare a parlare di
<<battaglia>>”3. Già lo stendardo di Ur (2500 a.C. circa) mostra dei soldati con quella
che è stata identificata come un “prototipo di corazza”4. In questo periodo, si assiste a vere
e proprie campagne militari in piccolo, soggette a limiti spaziali e temporali ristretti, legati
alla necessità di tornare a casa in tempo per la semina. Operazioni militari prolungate,
assedi di città, guerre interregionali, velleità di conquista dei regnanti, non potevano essere
sostenute da eserciti di contadini se non a costo di disastrose carestie, e ciò comportò
un’evoluzione delle caratteristiche e nella composizione degli eserciti, favorendo la
formazione di un corpo di specialisti della guerra a tempo pieno, non più soltanto guide e
nerbo delle milizie cittadine, ma elemento costitutivo di interi corpi d’armata.
Professionisti della guerra, questi, che potevano essere tanto indigeni facenti parte di una
classe guerriera cittadina altolocata(nelle economie primitive gli uomini armati sono infatti
titolari di diritti sul raccolto per non ricadere nella comune condizione di lavoratori5),
quanto mercenari al soldo del miglior offerente, ma inevitabilmente attratti dalla stabilità
economica.
Nella scelta fra forze armate locali e mercenarie, la bilancia pendeva spesso dalla parte
delle “soldatesche in affitto”. Vari i motivi di questa scelta: il fatto che le caste militari
interne, invariabilmente, arrivassero ad un livello di ricchezza tale da non voler più
rischiare la vita per soldi; il fatto che l’utilizzo dei mercenari come forze di polizia
garantiva un rispetto dell’autorità che i poliziotti “locali” non avrebbero potuto ottenere (
non a caso il nome della tribù nubiana Medjay divenne sinonimo di “poliziotto” in
3 J. Keegan (1993) p.134 4 Ibidem 5 J. Keegan (1993) p. 18
6
egiziano)6; il fatto che il mercenario sia fedele a chi lo paga, finché gli è garantita una
remunerazione soddisfacente; il fatto, poi, che un esercito mercenario ha da essere
mantenuto solo quando necessario, mentre un esercito regolare rappresenta una spesa
continua nel tempo; il fatto che i mercenari siano apprezzatissime guardie del corpo, sia
per il prestigio che ne derivava al loro sovrano (disporre di un intero corpo di mercenari
come guardia personale rivelava grande potenza economica) sia per la sicurezza personale
del medesimo sovrano ( perché ad eventuali congiurati non è agevole reclutare dei
mercenari, che difficilmente parlano la lingua del luogo in cui operano.
Una particolare costante nella storia dell’uomo è che il mercenario provenga da quelle che
William McNeill definì “aree di insufficienza alimentare”7: deserti, foreste, montagne. Da
questo punto di vista, il Vicino Oriente Antico non fece eccezione, dato che gli abitanti di
zone di confine non potevano non essere attirati dalle fiorenti piane della Mesopotamia e
dall’opulenza dell’Egitto: dall’altopiano iranico provenivano gli aristocratici Maryannu, i
guerrieri del carro che cambiarono la storia militare dell’epoca benché i costi elevati della
loro attrezzatura e la complessità del loro addestramento imponessero ai palazzi reali di
assumerli a tempo pieno con grandi spese8, dalla Nubia veniva buona parte dei mercenari
egiziani e dai monti fra il Levante e la Mesopotamia arrivavano elementi meno “pregiati”,
come gli Hushbu o gli Hapiru, bande di rozzi e turbolenti nomadi. Il termine “mercenario”,
nel tardo secondo millennio, era talmente generico da identificare tanto questi elementi –
già fra loro diversissimi- quanto un nuovo gruppo, che le fonti egizie definiscono “Šrdn
bštw”: ovvero, “ Shardana ribelli di cuore”9.Nel tempio di Medinet Habu, come nel papiro
Harris, il faraone Ramses III parla di una confederazione di popoli mediterranei che, dopo
aver invaso e distrutto la Cilicia, l’Anatolia sud-occidentale, Cipro e la Siria settentrionale,
erano stati sconfitti e distrutti dal suo esercito: “Io massacrai i Denyen nelle loro isole,
Tjekker e Peleset furono ridotti in cenere. Gli Shardana e i Weshesh del mare furono
annientati, catturati assieme e portati in Egitto come prigionieri (numerosi) come la
sabbia della spiaggia “10.
In questa confederazione, che l’egittologo francese Gaston Mapero definì efficacemente
“Peuples de la Mer”11, è possibile riconoscere un popolo che già dal periodo amarniano,
6 S. Yalichev (1997) p.35 7 Citato in J. Keegan (1993) p. 77 8 M. Liverani(1991) p. 457 9 G. Cavillier (2002) p. 68 10 Papiro Harris 1, 76,5 -10, in Cavillier (2005) p. 18 11 M. Dothan (1989) p. 59
7
ovvero un secolo e mezzo prima, giocava un ruolo importante nello scacchiere del
Levante: gli Shardana, appunto. Già nelle lettere di El-Amarna, infatti, troviamo menzione
di questi mercenari, quando Rib-Addi, il re della citta di Biblo, scrive ad Amenothep IV
richiedendo un distaccamento di Shardana o di Nubiani che possano rinforzare la sua
stessa guarnigione12. Si ha qui la prima di una lunga serie di citazioni, che vedono questi
mercenari combattere, richiestissimi, al servizio dei sovrani d’Egitto, di Ugarit, di Biblo.
Nella pratica bellica del tardo bronzo gli eserciti si avvalevano di armi da lancio come
l’arco o il giavellotto, e di armi scarsamente efficaci nel corpo a corpo come la mazza o la
daga (una sorta di lungo e spesso pugnale); mentre non è attestato l’uso delle letali spade
lunghe. È possibile che la ragione di questo vada ricercata nel loro costo elevato, sia per la
manifattura dell’oggetto, sia per l’addestramento necessario per farne uso efficacemente.
Per questi motivi, mercenari già armati ed addestrati all’uso di un’arma risolutiva nella
mischia sarebbero stati molto apprezzati, perché capaci di portare immediati benefici tattici
nella manovra bellica e nella battaglia,.
La parola egiziana bštw, cui prima si è attribuito il significato di “ribelli di cuore”, può
essere tradotta anche come “turbolenti”13, un aggettivo che connoterebbe un’arte militare
completamente al di fuori della prassi guerresca del tempo: l’ armamento leggero – elmo,
armatura composta da strisce di cuoio, piccolo scudo rinforzato da borchie metalliche -
sembra suggerire una grande abilità nelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione,
come la protezione dei carri alleati e gli assalti a quelli nemici o alle loro fortificazioni;
mentre la spada, lunga e affusolata, capace di colpire tanto di punta quanto, soprattutto, di
taglio14, appare perfetta per una guerra di mischia. Dotati di un esercito composto
prevalentemente dagli arcieri –tanto appiedati quanto sui carri da combattimento, i Faraoni
d’Egitto non potevano disinteressarsi alla stessa esistenza di una simile fanteria. A più
riprese, attaccati, catturarono e inquadrarono nei propri ranghi gli utilissimi mercenari
Shardana. I benefici dalla loro presenza nelle fila dell’esercito egiziano furono tali e tanti,
che in breve tempo altre dinastie regnanti del Levante decisero di arruolare i propri
Shardana, controbilanciando i progressi tecnici dei nemici.
È convinzione dello studente che la manifattura di questa tesi richieda un approccio di tipo
descrittivo, prima ancora che evenemenziale. In primo luogo perché di avvenimenti,
12 S. Yalichev (1997) p. 23 13 G. Cavillier (2002) p. 68 14 D.H. Gordon, (1953) p. 75
8
ovverosia di battaglie combattute dagli Shardana, ne conosciamo pochi, ed in secondo
luogo perché credo fortemente che, prima di fare entrare gli inquilini, sia necessario
costruire ed arredare una casa. Il primo capitolo si limiterà quindi alla costruzione della
casa stessa, ovvero alla descrizione del mondo del tardo bronzo e degli stati che,
componendolo, saranno coinvolti nella narrazione. Il secondo capitolo, per continuare con
la metafora dell’abitazione, porrà i mobili dentro l’appartamento, presentando la struttura
militare dell’epoca, le caratteristiche dei suoi uomini, dei suoi corpi, della sua mentalità,
per poter individuare quelle esigenze tattiche che gli Shardana, guerrieri tanto particolari
per l’epoca, avrebbero potuto soddisfare. Il terzo capitolo, infine, porrà le vicende “in
moto”, andando finalmente a descrivere quale fu storicamente l’utilizzo di questi mercenari
nei loro luoghi accertati di utilizzo.
9
Capitolo I: Il Tardo Bronzo nel Vicino Oriente Antico
I.1 Introduzione
Voler parlare degli Shardana senza parlare del contesto storico e culturale in cui si sono
mossi sarebbe inutile. Prima ancora di poter analizzare la portata del fenomeno “Shardana”
sugli scenari di guerra, è necessario infatti delineare il mondo all’interno del quale queste
guerre si combattevano, individuando dove, come, quando, e soprattutto, chi le
combattesse.
Nell’area del Levante e dell’Asia Minore, il periodo che si usa definire del “Tardo Bronzo”
ha convenzionalmente inizio attorno al 1570 a.C., e finisce, altrettanto convenzionalmente,
circa 4 secoli dopo, attorno al 1175 a.C. In quel sedicesimo secolo l’area Levantina era
politicamente frammentata, maculata da piccoli stati perennemente in lotta fra loro, da
nessuno dei quali ci è pervenuta una grande quantità di documenti. La scarsità delle
attestazioni –qualora non dipendesse dall’esiguità dei ritrovamenti o da altri fattori
contingenti- potrebbe essere indicativa di una economia debole o di un controllo
debolissimo1. Nella quasi totale assenza di documenti, l’unico paese che -pur nella
pochezza delle nostre informazioni- assuma caratteri propri distinguibili dagli altri è il
frammentatissimo Egitto, il cui delta è dominato dai diversi principati di una popolazione
che le fonti locali definiscono “i principi dei paesi stranieri”: gli Hyksos. Ma tra la fine del
sedicesimo e l’inizio del quindicesimo secolo la situazione migliora gradualmente, fino a
capovolgersi: vengono a formarsi veri e propri stati territoriali, che comprendono e legano
con una interazione economica mai sperimentata prima diverse città e le loro campagne. È
il caso per esempio della Siria Settentrionale, che nella prima metà del secondo millennio
aveva visto il proliferare di numerose città-stato e che in questo momento si vede invece
riunificata dal nascente regno di Mitanni2. Ed è anche il caso del nuovo regno Hittita, che
1 M. Van De Mieroop (2007) p. 133 2 Ibidem
10
nel suo sviluppo arriverà a raccogliere ed integrare l’Anatolia centrale e la Siria Nord-
Occidentale. Unica eccezione, in questo fiorire di stati regionali, fu l’area siro-palestinese
dove, forse a causa della forza e dell’irruenza dei vicini –Egitto da una parte, Mitanni e poi
Hatti dall’altra- continuò a sussistere il vecchio sistema delle città-stato.
Quello del Vicino Oriente nel secoli XIV e XIII fu un mondo culturalmente variegato e
dotato di una complessità che, a livello della politica internazionale, poco o nulla avrebbe
da invidiare a quella odierna. La scoperta e lo studio degli archivi statali di El-Amarna in
Egitto, di Boghazkoy in Turchia e di Ras Shamra in Siria (Akhenaten, Hattusa ed Ugarit
rispettivamente) hanno infatti consentito al mondo accademico di conoscere da vicino un
ambiente perfettamente organizzato, edificato su una fitta rete di contatti internazionali che
arrivava a coprire l’intera area civilizzata dell’epoca. Si trattava di un mondo composito,
caratterizzato da una lingua internazionale - il babilonese-, da intrecci dinastici, da un
riconoscimento culturale reciproco, da una ideologia in alcuni tratti (la guerra) comune, e
soprattutto da rapporti commerciali tanto intensi da far sì che, come oggi avviene su scala
planetaria, il variare delle condizioni economiche di una regione influiva, a volte
pesantemente, sulle altre3. Mesopotamia, Siria, Palestina, Egitto, Cipro e Anatolia, fino alle
propaggini più estreme -e meno documentate- del mar Egeo e dell’altopiano iranico,
rientravano tutte in un sistema di equilibrio regionale perfettamente bilanciato: un mosaico
costituito da poche potenze di dimensioni medio grandi, che contenevano ed avevano
influenza su un gran numero di piccole città-stato e potenze locali. Questa bipartizione
gerarchica è resa esplicita nella documentazione proveniente da Akhenaten (l’odierna El-
Amarna) tramite l’utilizzo delle locuzioni “grande re” e “piccolo re”: un sovrano è
“grande” nel momento in cui è abbastanza potente –militarmente e commercialmente- da
poter essere libero da ogni controllo, mentre al contrario è piccolo quando deve pagare un
tributo per la “protezione” ad un re superiore e non ha una vera autonomia sulla scena della
politica internazionale, se non quella –possibile solo per le zone di frontiera- di passare alla
fedeltà del grande re confinante, cui dovrà, parimenti, la propria stabilità sul trono.4
I limiti spaziali del sistema sembrano essere quelli definiti dalla documentazione a nostra
disposizione, (pare difficile credere che “la base documentaria sia così distorta da omettere
completamente una regione che effettivamente interagisse con il nucleo centrale del
3 C. Edens, The dynamics of trade in the ancient Mesopotamian “world system” (1992), in Frank (1993) 4 M. Liverani, (1991) p. 466
11
sistema, allo stesso livello e con le stesse procedure”5), e dal quadro che ci è offerto i
grandi regni sono: l’Egitto del Nuovo Regno; l’Anatolia Hittita; l’alta Mesopotamia (prima
col regno di Mitanni e poi con quello Assiro); Cipro; Arzawa (l’Anatolia sud-occidentale,
poi riassorbita da Hatti); La Babilonia Cassita. I piccoli regni sono essenzialmente quelli
della fascia siro-palestinese. Sul controllo dei sovrani minori e della loro lealtà si
intersecano le vicende politiche e guerresche del tempo: i re maggiori –in mezzo a cui
fanno la parte del leone Hittiti ed Egiziani- erano infatti estremamente interessati al
controllo della zona, baricentro delle vicende politiche e guerresche perché snodo vitale
degli scambi commerciali sia sull’asse Nord-Sud, con il controllo dell’area costiera, sia su
quello Est-Ovest, essendo la zona siriana l’anticamera dell’alta Mesopotamia6. Dal canto
loro, i re di Siria e Fenicia pagavano un tributo ai loro signori, godendo di tutti i vantaggi
del vassallaggio: un trono al sicuro dalle mire del grande re, un supporto militare in caso di
aggressione e commerci facilitati con i vicini e con lo stato centrale7.
Poco dopo il 1200, comunque, questo intero sistema politico, mantenutosi abbastanza
stabile per secoli, sembra sia crollato improvvisamente. Nelle iscrizioni del tempio di
Medinet Habu, così come nel papiro Harris, il faraone Ramses III parla di una
confederazione di popoli mediterranei che, dopo aver invaso e distrutto la Cilicia,
l’Anatolia sud-occidentale, Cipro e la Siria settentrionale, erano stati sconfitti e distrutti dal
suo esercito. A seguito dell’urto di questa confederazione -che l’egittologo francese Gaston
Mapero definì efficacemente “Peuples de la Mer”8- le economie centralizzate controllate
dai palazzi si disintegrarono, i mercati furono distrutti, i contatti diplomatici andarono
perduti9. La sola presenza degli invasori non basterebbe però a spiegare un tale crollo
economico e sociale, ed è allora necessario pensare che, se l’impatto sulle formazioni
statali fu pesantissimo, fu perché quegli stati erano in qualche misura già svuotati
internamente della loro capacità di resistere. La crisi era infatti già presente: dal punto di
vista climatico, la sequenza dendrocronologica di Gordion, in Frigia, registra attorno al
1200 un totale di sette-otto anni particolarmente secchi10; dal punto di vista del
comportamento umano, invece, il fatto che in Anatolia e Siria la popolazione abitasse
oramai le sole vallate irrigue, assieme all’accresciuta concorrenza internazionale (anche e
5 M. Liverani, (1994) p. 22 6 M. Liverani, (1991) p. 464 7 Cambridge (2008) p.506 8 M. Dothan (1989) p. 59 9 James ed al. Century of darkness: a challenge to the conventional chronology of old world archaeology.
London (1991) in Frank(1993) p.398 10 M. Liverani, (1991) p. 630
12
soprattutto di carattere militare), all’asservimento di intere regioni al pagamento di un
tributo ai grandi stati regionali e alle deportazioni diffuse e massicce è un sintomo di una
crisi che gli stati più forti cercarono di sanare con apporti esterni. L’arrivo dei popoli del
mare andrebbe quindi riletto come un tratto costitutivo della crisi interna, una conseguenza,
piuttosto che come una causa della stessa11.
Questo primo capitolo, descriverà quindi l’ambiente politico ed economico dell’epoca,
delineando le caratteristiche e le necessità di ogni re, grande e piccolo, e di ogni
popolazione che ha avuto, direttamente o indirettamente, a che fare con gli Shardana.
I.2. L’Egitto
Nel 1570, l’Egitto non è la “terra dei faraoni” cui solitamente si pensa: florida, unita,
dominata dalla personalità del suo faraone. Al contrario, è un paese internamente diviso,
dominato da una popolazione che tutto è, meno che egiziana: gli Hyksos. Di probabile
origine cananea, questi Heqau-Khasut – “i capi dei paesi stranieri” - avevano preso il
controllo di tutto il ricco delta del Nilo verso il 1625, alleandosi con la Nubia e lasciando ai
faraoni della XIII e della XIV dinastia il dominio della sola Tebaide. Agli occhi del resto
del mondo, i faraoni “legittimi” dovevano essere i cananei, se pensiamo che la titolatura
del re Yaqub-Har è stata trovata in una giara nel palazzo di Cnosso, su un leone in granito
trovato a Baghdad, e su un vaso trovato ad Hattusa, in Turchia12. Con i faraoni della XVII
dinastia, Seqenra Taa II e Kamose, sembra sia cominciata la riconquista dell’Egitto, portata
a compimento solo dal successore di Kamose, Ahmosis, che nel 16esimo anno di regno
assediò e conquistò la roccaforte di Sharuhen, nella Palestina sud-occidentale. I faraoni
della XII dinastia avevano avuto dei contatti in Asia, interessandosi militarmente alle terre
a nord del Delta solo per brevi raid a fini economici (l’accesso alle miniere ed alle cave del
Sinai) o di carattere punitivo, ma, a seguito della dominazione straniera, gli Egiziani
cominciarono a considerare Canaan - e alle terre ancora più a nord- come regione
importante sia economicamente che strategicamente. Ai loro occhi diventò una “regione-
cuscinetto”, capace di tener lontani dai loro confini una qualsiasi nuova minaccia
“asiatica”. Ancora ai tempi di Hatshepsut e Thutmosis III, quando ormai Sharuhen era stata
conquistata da quasi un secolo, la casa regale vantava di aver cacciato gli Hyksos ben oltre
i confini.
11 M. Liverani, (1991) p. 639 12 N. Grimal, (1988) p.249
13
Questa politica toccò l’apice con l’anno 33 del regno di Thutmosis III, quando l’esercito in
armi passò l’Eufrate per contrastare la minaccia legata all’espansionismo del regno Hurrita
di Mitanni. La vittoria a Megiddo nel 1457 a.C. contro le forze combinate del re di Qadesh
e dei cananei stabilì le basi per il controllo della regione. Qualche anno dopo, una
spedizione nelle terre della costa mediterranea, un’invasione anfibia a Biblo e la marcia
verso l’Eufrate, colpirono al cuore l‘impero mitannico13. La guerra durò fino all’ultimo
quarto del quindicesimo secolo, quando venne definito un accordo che lasciava la Siria a
Mitanni e la Palestina all’Egitto, fissando il confine fra Qatna e Qadesh sull’Oronte e
Alalakh e Ugarit sulla costa. Ma, soprattutto, questo accordo poneva il regno di Mitanni
come vero e proprio “stato cuscinetto” fra il paese del Nilo ed il nascente impero Hittita di
Tudhaliya II.
Nella seconda metà del XIV secolo, approfittando del debole regno del sovrano
Amenothep IV/ Akhenaton (1352-1336) -più impegnato a costruire la propria capitale ed il
proprio, particolarissimo culto che non a seguire militarmente il destino del proprio impero
(anche se sembra sia morto mentre organizzava una spedizione in Asia14)-, l’esercito
Hittita guidato dal re Shuppiluliuma (ca. 1352-1320) sconfisse e assoggettò il regno
hurrita, portando i propri confini a coincidere con quelli d’Egitto. In principio, Egitto ed
Hatti sembra non avessero alcuna ragione per farsi guerra, ed è probabile che vi fosse
addirittura un trattato a regolare i rapporti fra i due stati. Ma questo accordo, per quanto
specifico riguardo a molte aree di confine, era ambiguo riguardo ad alcune zone
strategicamente importanti: la valle della Beka’a e l’alto corso del fiume Oronte, dominato
dalla città di Qadesh. Non ci volle molto che la regione di Amurru, con i territori
dell’Oronte, assumesse rilevanza strategica fondamentale nel confronto fra i due imperi15.
La vicenda di Zannanza, il giovane figlio di Shuppiluliuma inviato in Egitto per sposarne
la principessa e diventare faraone ma ucciso lungo la strada, portò alla rottura dei rapporti
diplomatici, e ad un’azione dell’esercito hittita il quale, passate le frontiere Siriane, prese la
città di Amqa e catturò qualche migliaio di prigionieri. Questi, malati di peste, portarono la
piaga nel loro paese16 17. Era cominciato lo scontro che avrebbe condotto alla battaglia di
Qadesh contro l’Egitto di Ramses II.
13 A.Santosuosso(1996) p.(1996) p. 427 14 A.R Schulman (1964) p.58 15 A.Santosuosso(1996) p. 428 16 T. Bryce, (2005) p.183 17 L’episodio-Zannanza è stato profondamente contestato da diversi autori, non ultimo G. Del Monte, il
quale, per quanto riguarda l’episodio, dice che “ricordi storici e derivazioni probabilmente contemporanee
14
La difficile situazione generatasi nel paese del Nilo dalla rivoluzione Amarniana e dalla
successiva fine della diciottesima dinastia con la morte di Tutankhamon portò alla nascita
di una nuova dinastia. Salì al potere il generale Horemheb, un conservatore, un uomo che
con tutta probabilità aveva già affrontato gli hittiti negli scontri a seguito della vicenda-
Zannanza18. Sotto la sua guida l’Egitto ricostruì i quadri dell’amministrazione,
dell’esercito, e si preparò a rinsaldare le sue posizioni in Asia19. Dopo circa 27 anni di
regno, Horemheb morì senza eredi, lasciando sul trono - attorno al 1293/2 a.C.- il suo visir
Ramses I, iniziatore della XIX dinastia. Questi doveva essere già anziano al momento della
salita al potere, e deve aver regnato poco, dato che non è stata trovata alcuna datazione
superiore al suo secondo anno di regno20. Il figlio, Sethi I, indossò quindi la corona di re
dell’alto e basso Egitto attorno al 1290, cominciando una serie di guerre che avrebbero
riportato l’Egitto ad un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Nel corso di
quattro campagne consecutive, (una, la seconda, sul versante occidentale del delta del
Nilo) riuscì a riportare molto a nord il confine Egiziano, e secondo i suoi resoconti, nella
quarta –ed ultima- campagna arrivò a sconfiggere l’esercito Hittita da qualche parte a nord
di Qadesh. Dato però che il figlio di Sethi I, Ramses II, dovette combattere per conquistare
la valle dell’Oronte, si suppone che quella conquista sia stata effimera21. Mentre il fatto che
la sua seconda campagna militare sia stata combattuta in Libia e non in Asia dimostra che
la pressione sul delta occidentale da parte dei Libu e dei Meshwesh –che tanti problemi
avrebbe causato ai suoi successori- era già cominciata. 22
Ramses II –“il grande”- salì al trono attorno al 1279, ed è uno dei sovrani il cui nome è più
noto ai nostri contemporanei. Si può dire che, sotto la sua guida, l’Egitto raggiunse l’apice
della potenza, e di sicuro –avendo egli regnato 77 anni- fu uno dei faraoni che lasciarono
più monumenti e più notizie delle proprie opere. Il suo fu un regno caratterizzato da una
marcata attitudine ad intrattenere proficue relazioni con l’estero: lo dimostrerebbe anche
uno dei suoi primi atti come faraone: la costruzione di una nuova capitale nel delta del
Nilo, Pi-ramesse, non lontano dall’antica capitale degli Hyksos, Avaris. La vecchia
sono fusi ad elementi tratti dalla fiaba e dalla novella popolare” ( (1993), p. 42). La sua opinione è che
l’episodio della peste andasse spiegato ad un popolo, come quello Hittita, fornito di una profonda concezione
giuridica, e che per fare questo, dato che è possibile ipotizzare che le ricerche oracolari avessero individuato
fra le cause della pestilenza la violazione di un trattato fra Hattusa e l’Egitto, si sia ricercato un modo per
dare la colpa, in ogni caso, agli Egiziani, presentando il re hittita come un “padre ferito”. 18 J.L. Miller (2007) p.255 19 N. Grimal, (1988) p. 317 20 Cambridge (2008) p. 217, N. Grimal, (1988) p. 319 21 Cambridge (2008) p. 220 22 Cambridge (2008) p. 221
15
capitale, la bellissima Tebe, era infatti troppo lontana dai confini dell’impero per essere
davvero utile. E fu proprio Ramses II a dover affrontare le prime incursioni dei “pirati”
Shardana23, nel secondo anno del suo regno; decidendo poi di arruolarli nel proprio
esercito. Nel quarto anno di regno, Ramses compì la sua prima campagna in Asia, e nella
primavera del 1275, quinto anno del suo regno, utilizzò le sue roccaforti in Siria e Palestina
come basi per attaccare l’impero hittita; nella sua marcia verso il nord pare non abbia
incontrato opposizione di sorta, dato che giunse in soli 30 giorni24 nel luogo del primo
scontro, a Qadesh, dove si svolse una battaglia fondamentale, che sarà analizzata in
dettaglio nel terzo capitolo di questa tesi. In ogni caso va rilevato che proprio a Qadesh
l’esercito di Ramses II dovette muovere in ritirata, cosa di cui profittarono gli Hittiti che
avanzarono fino a Damasco, prendendo il controllo di Amurru e della regione di Upe, ben
al di qua della tradizionale frontiera egiziana25. Questa campagna militare fu per gli
egiziani un insuccesso clamoroso, e la conseguente perdita di prestigio, come era ed è
normale che accada in questi casi, ebbe non poche conseguenze: molti piccoli stati colsero
l’occasione per ribellarsi, e lo stesso Ramses II, fra il sesto e l’ottavo anno di regno,
dovette muovere contro Ascalona, la Galilea e l’oramai hittita regione di Amurru,26.
Successivamente, nell’undicesimo anno, invase la Siria, dove di sicuro acquisì il controllo
di Tunip, Qatna e Qode, penetrando molto a fondo nel territorio hittita27. Ma lo stesso
Ramses II, nell’anno XXI di regno, resosi conto dell’impossibilità di tenere a lungo
posizioni così lontane dal delta del Nilo, e mise fine a 16 anni di ostilità, firmando con gli
hittiti un trattato in cui le due potenze si riconoscevano eguali (una cosa assolutamente
senza precedenti per i Faraoni d’Egitto) e tracciavano una zona di frontiera comune:
probabilmente la stessa che sussisteva sedici anni prima. La guerra era servita quindi solo a
far si che le potenze contrapposte si rendessero conto dell’impossibilità di sopravanzare i
nemici. A pace firmata, le relazioni fra le due superpotenze divennero d’un tratto amicali,
come dimostra la pianificazione di una visita diplomatica del re hittita in Egitto28, anche se
tale visita pare non sia poi avvenuta realmente (forse per la paura del re Hattushili di
diventare strumento della propaganda interna Ramesside29).
23 Cambridge (2008) p. 226, N. Grimal, (1988) p. 326 24 A.Santosuosso(1996) p. 429 25 A.Santosuosso(1996) p. 443 26 Cambridge (2008) p. 228 27 Cambridge (2008) p. 229 28 Cambridge (2008) p. 229 29 M.Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(1992) p.20
16
Negli anni in cui Ramses II non ebbe da combattere in Siria e Palestina, fu comunque
costretto a impiegare il suo esercito altrove. Sappiamo, infatti, di una spedizione contro
Moab, Edom e nel Negeb – probabilmente poco più che una rapida avanzata per punire
qualche incursione nelle terre egiziane- e di altre spedizioni ben più impegnative in Libia,
dove certe tribù che da secoli contrastavano l’Egitto – come i “tehenu”- si erano unite ad
altri nemici: i Meshwesh e i Libu, che, spinti dalla fame, cercavano di forzare i confini ed
invadere il delta per sistemarvisi. Già dai tempi di Sethi I i faraoni avevano respintogli
assalti di queste tribù30, ed è significativo – benché fino al quarantaquattresimo anno di
regno di Ramses II si abbiano solo vaghi accenni delle guerre contro il libici- che il faraone
avesse deciso di costruire una linea di fortezze lungo le strade della zona occidentale del
paese31.
Alla morte di Ramses II, nel 1213, il più che cinquantenne figlio Merneptah, prese il
potere, ereditando una situazione difficile: via via che l’età avanzava, infatti, Ramses II
aveva allentato la vigilanza sulle frontiere e sull’esercito, tanto che i libici avevano ripreso
a compiere raid nel delta, terrorizzando la popolazione d’Egitto. Non fu quindi un caso che
Merneptah, una volta assiso al trono del padre, procedette subito ad una riorganizzazione
dell’esercito, grazie al quale, nel quinto anno di regno, poté affrontare e vincere una
coalizione che, oltre ai soliti Libu, Meshwesh, Kehek, annoverava i “popoli del mare”,
termine che, in questo caso, fa riferimento a varie popolazioni, quali gli Shardana, i Lukka,
i Tursha, guidate dal principe Mauroy32. Il fatto che questo principe portasse con sé la sua
famiglia, i suoi tesori e le sue bestie ha fatto pensare che l’ennesimo attacco di queste
popolazioni non fosse una della solite “razzie” ma avesse per obbiettivo proprio
l’invasione stabile del delta del Nilo egiziano33. Lo scontro avvenne in una località non
identificata chiamata “Pi-er”, dove gli invasori vennero messi in fuga dopo sei ore di
battaglia lasciando sul campo 6000 morti, moltissimi prigionieri, ed un grande bottino per
gli Egiziani34. Merneptah celebrò questo trionfo in vari luoghi, ma il maggior numero di
notizie lo si trova nella grande iscrizione nel tempio di Karnak e nella “Stele d’Israele”35.
Dopo la morte di Merneptah, alla fine del XIII secolo, la diciannovesima dinastia si spense
in una sequela di brevi regni ed intrighi dinastici di cui si sa poco. Non siamo nemmeno
30 Cambridge (2008) p. 230 31 Cambridge (2008) p. 230 32 R.Drews, (1993) p.19 33 N.K. Sandars (1985) p.105 34 Cambridge (2008) p. 234 35 R.Drews, (1993) p. 19
17
certi riguardo la successione dei suoi re: ne contiamo cinque, di cui uno solo –Sethi II, che
regnò per sei anni- fu riconosciuto da Ramses III come legittimo predecessore36. La data
dell’inizio della ventesima dinastia non è stata individuata con precisione, ma è ormai
opinione comune che questo periodo caotico sia durato poco più di dieci anni, ragione per
cui si considera che esso sia stato avviato dall’ascensione al trono di Sethnakth –primo
faraone della XX dinastia- databile intorno al 1186. Circa due anni dopo37, nel 1183, il
trono passò a suo figlio, Ramses III (1183-1152), l’ultimo grande faraone della storia
d’Egitto.
Fra il quinto e l’undicesimo anno del suo regno, si combatterono 3 guerre importanti e di
grande rilevanza per questa tesi: quella contro i libici nel quinto anno, quella contro il
nuovo pericolo rappresentato dai popoli del mare nell’ottavo anno –questa tesi ne tratterà
diffusamente nel paragrafo dedicato a questi popoli- e nell’undicesimo anno la rinnovata
guerra contro i Libu. Le vittorie di Ramses III in queste campagne di guerra risparmiarono
all’Egitto gli orrori della catastrofe che in quegli anni sconvolse il resto del vicino oriente.
Il paese sopravvisse, anche se con una forza ed una ricchezza nettamente inferiori rispetto
a quelle che aveva conosciuto nei secoli precedenti.
Le vittorie di Merneptah e Ramses III non furono altro che il canto del cigno del Nuovo
Regno Egiziano, perchè la crisi del Levante si abbatté inesorabilmente anche sul paese del
Nilo. In meno di un secolo, si succedettero otto sovrani, ognuno dei quali regnò per breve
tempo; la decadenza imperante, se non la miseria, misero il paese in ginocchio, minando
alla radice la stessa istituzione monarchica. All’estero, I successori di Ramses III tentarono
di conservare una qualche presenza nel Levante, ed ancora sotto Ramses IV (1152-1145) si
trovavano guarnigioni egiziane a Beth-shan e alcuni altri luoghi strategici a sud del paese
di Canaan; ma l’ultimo indizio del potere egiziano in Asia è la statua bronzea di Ramses VI
(1142-1134) a Megiddo.38
In campo economico l’Egitto si era aperto al Vicino Oriente già ai tempi della XII dinastia.
Questa apertura aveva fortemente condizionato la ripresa dell’importazione di materie
prime39 e la loro modalità, e si pensa che le guerre combattute dalla XVIII dinastia siano
state causate essenzialmente da motivi economici: la lunga guerra contro gli Hyksos aveva
36 Cambridge (2008) p. 235 37 N. Grimal, (1988) p. 602 38 R.Drews, (1993) p. 19 39 N. Grimal, (1988) p. 257
18
determinato una “militarizzazione” dell’Egitto ”40 che necessitava di impiegare stabilmente
il suo esercito mastodontico. Cominciò a farlo con la conquista della Nubia, considerata
necessaria per accedere al suo oro, necessario a comprare i materiali che l’Egitto non
produceva, come il legname del Libano, necessario per costruire navi. Fu quasi naturale, di
conseguenza, concepire la conquista della Palestina (all’epoca un coacervo di città stato
troppo piccole per opporre una seria resistenza) e attraverso questa garantirsi l’avanzata
fino alla Siria. I potentati locali minori, consci della loro inferiorità, fecero poco o nulla per
opporvisi e si piegarono spontaneamente41, ma altri dovettero essere piegati con la forza.
È possibile delineare tre modalità di controllo nell’evoluzione dell’ impero egiziano: il
primo fu quello cominciato da Thutmosis I, che aveva costituito un periodo di espansione
nel quale buona parte delle energie della nazione era stato speso nella conquista e nel
consolidamento immediato delle zone annesse, ma che aveva mantenuto una
amministrazione delle terre occupate quasi rudimentale42. Il secondo è il periodo
cominciato da Thutmosis III circa mezzo secolo dopo, e nel quale il figliastro di
Hatshepsut puntò ad una sottomissione completa dei territori asiatici e nubiani e alla loro
annessione burocratica. Consolidato il controllo della regione fino ad Ugarit sulla costa e
Qadesh nell’interno, il dominio egiziano venne organizzato in tre distinte gradazioni: in
primo luogo, le province di Gaza (Canaan), Sumura (Amurru) e Kumidi (Ube, la Beka’a, e
la zona di Damasco), ognuna delle quali fu sede dei governatori egiziani, dei magazzini e
delle guarnigioni. Sono, queste, le zone limitate sotto la diretta gestione egiziana, quali i
porti, quelle zone agricole che venivano destinate all’approvvigionamento delle truppe, ed
alcuni siti-chiave dal punto di vista strategico. Queste città erano anche i punti di
riferimento per il secondo tipo di dipendenza, quella indiretta dei piccoli re. Questi ultimi,
come testimoniano pure le lettere di El-Amarna43, ricche di lamentele da parte loro, erano
legati da un giuramento di fedeltà verso il faraone, senza però che il faraone fosse a sua
volta loro legato. Questo squilibrio fu causa endemica di lotte locali alle quali il faraone,
incassato il tributo dovutogli, assisteva indifferente. La terza modalità di controllo è quella
nella quale, in realtà, il controllo non esiste: quella delle zone marginali di frontiera, delle
montagne, dei deserti, e di tutte quelle zone nelle quali l’Egitto, mancando di interlocutori
fissi come le città palatine delle pianure, non ha la possibilità di prelevare tributi ma è
40 S.Curto in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2002) p. 33 41 A.J. Spalinger (2005) pp.47-49 42 Oren (2000) p. 6 43 Citando le più importanti si ricordano: EA 68,93,95,102,129,129a,138 e forse 94 e 101 da Rib-Adda di
Biblo, EA 146 E 155 da Abimilki di Tiro, EA 285, 290 e forse 291 da Abdi-Heba di Gerusalemme, EA 144-
145 da Zimreda di Sidone.
19
obbligato al contrario a temere i danni che provengono dalle popolazioni nomadiche44. Fu,
questo, un periodo che condusse al disastro le popolazioni native, costrette a pagare tasse e
tributi regolati sulla ben più ricca produzione agricola del delta del Nilo, costringendo
quindi la popolazione a fuggire verso le montagne e gli altri territori di confine. Per l’inizio
della XIX dinastia, infine, i territori asiatici dell’Egitto erano quindi organizzati con un
buon sistema amministrativo, e il paese vi consolidò il proprio controllo attraverso la
costruzione di una lunga strada militare e di numerose stazioni di posta. Il fatto che
l’interesse egiziano verso i territori del Levante sia cresciuto esponenzialmente sotto i
Ramessidi può esser dovuto a varie ragioni: innanzitutto, perché la XIX dinastia era
originaria del Delta, e quindi questi faraoni dovevano essere avere una maggiore
familiarità con la Palestina che non i predecessori; In secondo luogo, il fatto che il periodo
di pace nato con l’alleanza con Mitanni stava oramai terminando: il nuovo potere Hittita
cresceva in Asia minore, e i suoi interessi verso la Siria dovevano avere ben spaventato gli
interessi egiziani. Infine, gli attacchi degli Shasu, beduini che ormai si erano introdotti nel
paese, facevano si che fosse necessaria una continua e diffusa presenze di corpi di polizia.
In conclusione, comunque, si può affermare che fra la cacciata degli Hyksos e il collasso
del mondo Vicino-Orientale, si venne a creare per la prima volta una vera e propria
comunità di interesse fra l’Egitto e l’Asia occidentale45.
I.3 Hatti
La seconda grande potenza di cui è necessario tracciare la storia è quella legata
all’Anatolia: gli Hittiti. Parlare di “hittiti” e di “regno hittita”, di per se, è inesatto. Il nome
di “Hittiti” attribuito dai moderni a questa popolazione viene dalla parola biblica “hittim”,
indicante una piccola tribù cananea dell’inizio del primo millennio a.C.46, e si usa questa
parola perché, per quanto ne sappiamo, agli “hittiti” dell’età del bronzo non corrispose mai
una singola denominazione che li identificasse etnicamente o politicamente. E se, in questo
periodo, il regno egiziano era etnicamente definito per contrapposizione agli Hyksos, il
regno hittita, frutto di matrimoni politici, adozioni, colpi di stato ed unioni forzate di
elementi diversi, era uno straordinario melting pot culturale che comprendeva diversi
elementi etnici –indoeuropei, hattici, hurriti, e probabilmente, un crescente numero di
popolazioni mesopotamiche e siriane che verosimilmente pare non parlassero nemmeno la
44 M. Liverani, (1991) pag 158 45 Oren (2000) p. p. 7 46 T. Bryce, (2005) p.18
20
lingua ufficiale del regno. Ciò che dava loro un’identità comune era il fatto di vivere in una
regione geograficamente ben definita –ovverossia il “triangolo” che va dal Mar Nero alla
piana di Konya ed alle pendici del Tauro-, che li differenziava dagli altri sudditi del re
distribuiti fra gli stati vassallo47. Tutti questi elementi si unirono –per avvicinamento
politico o per adozione-alle famiglie da cui provenivano coloro che di volta in volta
finivano per occupare il trono. A giudicare dai nomi dei re e delle famiglie regali, infatti, a
fondamento dell’inclusione nella classe dominante non vi era una concezione etnica, anche
se, una volta arrivati al trono, tutti si piegavano al costume ed all’uso del “nesita”, la lingua
di governo48.
Il regno di Hatti fu una delle grandi potenze del tardo bronzo, un paese capace di
rivaleggiare e sorpassare nel XIV secolo paesi, come Egitto e Mitanni, originariamente
molto più potenti. Fondato nel XVII secolo, la sua capitale fu stabilita ad Hattusa -150
kilometri ad est di Ankara- dal primo re Hattushili, sopra un picco roccioso che la
proteggeva dai due lati e le permetteva di dominare un’area straordinariamente produttiva
dal punto di vista agricolo49. Da qui, nell’arco di circa 500 anni, i re del paese giunsero a
controllare una rete di stati vassalli che, all’apice dello sviluppo, estendevano il proprio
potere dalle coste egee dell’Anatolia a Damasco ed alle frange occidentali della
Mesopotamia. Lo stato hittita prende forma sulle carte geografiche quasi inaspettatamente,
quando, in un cinquantennio, i suoi primi due re riescono a dar vita ad una formazione
politica di rango regionale, arrivando ad abbattere i due maggiori regni del tempo
(Yamkhad e Babilonia) ed avviando un profondo riassetto politico di tutta l’area dell’alta
Mesopotamia. Il re Hattushili prende nome dalla città di Hattusa, creata ed eretta a capitale
di un altopiano centro-anatolico riunito sotto la sua persona50. Che Hattusa fosse la neonata
capitale di un nuovo regno, ha fatto si che la documentazione disponibile per gli storici
cominci bruscamente da questo re, alla morte del quale “il paese di Hatti”, prima
inesistente, compare come un’entità definita destinata a restare tale nei secoli. Il successore
di Hattushili, Murshili I, adottato dal vecchio re sul letto di morte, diede avvio alla
conquista del mondo siriano, con la vittoria sul re di Yamkhad e sui suoi alleati. Per mano
di Murshili I Aleppo fu espugnata e distrutta, e la Siria divenne hittita51. Ma la sua fu una
vittoria effimera, perché il suo successore, Hantili, perse il controllo della regione. E’ bene
47 T. Bryce, (2005) p.19 48 T. Bryce, (2005) p.17 49 N. S. de Martino (2009) p. 35 50 M. Liverani, (1991) p. 427 51 M. Liverani, (1991) p. 434
21
precisare, però, che Hantili, pur restando a lungo sul trono, non ebbe un regno semplice,
dato che fu costantemente impegnato a combattere contro Mitanni sulla linea dell’Eufrate,
e a limitare i primi attacchi dei Kashka dei monti. Sappiamo, comunque, poco del suo
regno; e ancora meno del regno dei suoi successori Zidanta I e Ammuna, sotto i quali –non
senza lotte da parte di Ammuna- la regione del sud-est anatolico, Arzawa, e quella del sud-
ovest, la Cilicia, col nome di Kizzuwatna52, si distaccarono dallo stato centrale, fondando
veri e propri regni a se stanti. Con la Cilicia –Kizzuwatna- se ne andò la Siria, per cui si
pensa che anche lo stato centrale, esposto agli attacchi degli Hurriti a sud-est e dei Kashka
a nord, fosse in pericolo53. Dopo il brevissimo regno di Huzzyia, prese il potere Telipinu,
personaggio particolarmente noto agli studiosi perché autore di un editto che racconta
l’intera storia del regno Hittita fino a quel momento, e che pone delle regole chiare per la
successione monarchica. Telipinu ottenne qualche successo nel recuperare alcuni dei
territori perduti, ma senza avvicinarsi alla riconquista dei più importanti. Nel secolo
successivo alla morte di Telipinu, il regno Hittita fu tutto meno che forte. Fu un periodo,
spesso definito “medio regno hittita”, nel quale una folla di re effimeri si contendevano il
trono di un regno troppo debole perfino per difendersi, tanto che Hantili II dovette
fortificare la capitale54.
Fra il 1450 e il 1400 si registra una ripresa dell’attività militare e politica hittita sotto la
guida di re Tudhaliya II. Questi, assicuratosi il trono con l’ennesimo colpo di stato55, riuscì
prima a soggiogare il regno di Arzawa, che ormai costituiva un pericolo per lo stato
centrale, e poi a ristabilire, almeno per un breve periodo, l’autorità hittita su Kizzuwatna ed
Aleppo56. L’epoca di Tudhaliya II, del suo successore Arnuwanda, e di Tudhaliya III fu
centrale per il processo di organizzazione interna del regno hittita, ma sotto quest’ultimo si
dovette affrontare una crisi talmente grave da poter essere avvicinata solo a quella del
1200: il regno, invaso da nord, da sud-est e da sud-ovest, impegnato dalla lotta con i
montanari Kashka, con Kizzuwatna e con un Arzawa ormai tanto importante da essere
ammesso al consesso internazionale (anche se non col grado di “grande re “ e nemmeno
attraverso la lingua Accadica57), venne letteralmente distrutto, forse dall’azione dei
Kashka, una minaccia costante nella storia Hittita. I Kashka erano una popolazione
seminomade, dedita alla razzia, dispersa sulle montagne della parte settentrionale
52 M. Liverani, (1991) p. 498 53 T. Bryce, (2005) p.103 54 T. Bryce, (2005) p.113, N.S. de Martino (2009) p. p. 41, Cambridge (2008) p. 660 55 T. Bryce, (2005) p.122 56 M. Liverani, (1991) 502 57 EA 31-32
22
dell’Anatolia. Non essendo inquadrati in un’organizzazione statale, erano anche
difficilmente controllabili da parte del re e truppe hittite. 58 specialmente in alcuni periodi
più difficili per la storia hittita, le frontiere con le loro terre erano sempre vulnerabili. Sotto
il regno di Tudhaliya III, i generali di confine scrivevano spesso di come i Kashka fossero
entrati quasi indisturbati nel territorio hittita, per saccheggiarne le terre, anche in gruppi
numericamente consistenti (600 individui, in un caso)59. Sotto il regno di Tudhaliya III,
spesso le relazioni inviate dai generali di confine segnalavano un’entrata semi-indisturbata
dei Kashka nel territorio hittita a saccheggiarne le terre e talvolta lo facevano anche in
gruppi numericamente consistenti (600 individui, in un caso)60.
A Tudhaliya III succedette Shuppiluliuma I, quasi contemporaneo con la fine, in Egitto, del
regno di Amenothep III e dei primi anni di Amenothep IV, e per questo motivo si suppone
sia lui il re delle lettere Amarniane. Quando Shuppiluliuma salì al trono di Hatti, il regno
era in condizione precaria. Secondo fonti posteriori, il re fu costretto a combattere per
vent’anni, alla fine dei quali la Cilicia-Kizzuwatna, l’Arzawa e la Siria perdettero la loro
autonomia e le loro dinastie regnanti, diventando parte integrante del paese hittita. Il tratto
saliente del re Shuppiluliuma è la cura –soprattutto diplomatica- con cui pianificava le sue
azioni. Avendo intenzione di riconquistare il paese di Isuwa, conscio di dover passare
attraverso il territorio di Mitanni per farlo,e sapendo che ciò avrebbe inevitabilmente
causato una guerra, Shuppiluliuma cercò sempre di mantenere relazioni pacifiche con
l’Egitto. Data l’alleanza fra il paese del Nilo e Mitanni, non voleva rischiare di mettersi
contro entrambe le superpotenze dell’epoca. Quindi, in previsione della campagna militare
in Siria- che gli serviva per riconquistare un “posto al sole” nella scena internazionale ed
entrare in contatto con Egitto e Babilonia- decise di trascurare Arzawa (per concentrare le
sue forze su un solo fronte) e di annettersi politicamente –per coprirsi le spalle- la regione
del Ponto mediante opportune alleanze fondate su matrimoni dinastici. Il momento
dell’attacco e le fasi d’esecuzione furono scelte con cura sapiente strategia61:
Shuppiluliuma prima appoggiò uno dei due contendenti, di nome Artatama, al trono di
Mitanni; e quindi isolò il suo nemico da tutte le maggiori fonti di possibile aiuto stipulando
un gran numero di trattati d’alleanza62. Grazie a questa pianificazione accurata,
58 S. de Martino (2009) p. 44 59 T. Bryce, (2005) p.146 60 T. Bryce, (2005) p.146 61 T. Bryce, (2005) p.156 62 T. Bryce, (2005) p.158
23
Shuppiluliuma arrivò dall’Eufrate al Libano in un solo anno di guerra 63. In seguito,
alleatosi anche con Amurru e Ugarit, ebbe facilmente ragione di tutti gli avversari,
arrivando senza problemi fino a Qatna e Qadesh. Qui si arrestò per non entrare-per il
momento- in guerra con l’Egitto, che deteneva ancora molti possedimenti in Palestina e
Siria meridionale64.
La già citata vicenda-Zannanza, comunque, portò a degli scontri con l’Egitto ed alla
parziale invasione hittita del suo territorio. A seguito della presa della città di Amqa furono
catturati e portati fino al paese di Hatti qualche migliaio di prigionieri malati di peste, che
diffusero il morbo nel territorio hittita. Grazie all’opera di Shuppiluliuma, comunque,
quelli che un tempo erano stati vassalli di Egitto e Mitanni, vennero in questa maniera
sottomessi al regno Hittita. Nell’organizzare le province dell’impero, Shuppiluliuma pose
sul trono delle città più importanti (Aleppo per tradizione, Karkemish per posizione
strategica) 65 due suoi figli, assegnando in particolare al re di Karkemish un ruolo
praticamente da viceré Hittita in Siria. Gli stati che gli si erano spontaneamente sottomessi
–come Ugarit- videro confermati i loro regnanti e premiata –tramite acquisizioni
territoriali- la loro sottomissione.
Shuppiluliuma non visse abbastanza a lungo da godersi le sue conquiste: morì –forse della
peste portata in Hatti da Amqa- poco tempo dopo, lasciando un impero molto più grande di
quello che aveva trovato. Il suo erede diretto, Arnuwanda II, regnò per poco tempo, forse
appena 18 mesi, prima di ammalarsi, morire, e lasciare sul trono il giovanissimo Murshili
II. Convinti che il giovane re non avrebbe avuto la forza per sottometterli, tutti i paesi
conquistati dal padre si sollevarono66. Ma si sbagliavano. Murshili, impegnato tanto contro
Arzawa quanto contro la Siria riuscì a ristabilire l’ordine nelle regioni, con una serie di
nuovi trattati, fra cui quello punitivo stipulato con Niqmepa di Ugarit. Ma mentre per la
Siria si trattava di una riconquista, su Arzawa Shuppiluliuma non aveva mai conseguito
successi decisivi, per cui continuava a sussistervi una vera formazione statale composita,
con un gran re – benché non riconosciuto tale dalla comunità internazionale- e una serie di
piccoli re sottoposti ali suoi ordini. Perciò, conquistata anche l’area di Arzawa, Murshili le
diede un assetto organizzativo simile a quello siriano. Per tanto, alla fine del suo regno
63 M. Liverani, (1991) 506 64 T. Bryce, (2005) p.158 65 M. Liverani, (1991) 507 66 M. Liverani, (1991) 509
24
tutta l’Anatolia centromeridionale, dall’Egeo all’Eufrate, era hittita, sia sotto controllo
diretto, come nel caso di Kizzuwatna, sia mediante regni vassalli67.
Con il tredicesimo secolo si assiste al risveglio delle mire espansionistiche di Assiria ed
Egitto. È probabile che, fin dal primo momento, la minaccia derivante dal “risveglio” delle
maggiori potenze dormienti sia stata percepita nettamente dal successore di Murshili,
Muwatalli, il quale fin dall’inizio del regno si mosse per pacificare il nord, facendo una
guerra ai Kashka e riuscendo a tenerli lontani dalla sua capitale fino al disastro del 120068.
Nel frattempo l’Assiria di Adad-nirari I riuscì ad invadere il morente regno mitannico,
assoggettandolo alla propria sfera d’influenza e facendo sì che la città di Karkemish, un
tempo centro di controllo del governo hittita al di qua dei monti del Tauro, diventasse città
di frontiera fra Hatti ed Assiria.
Dall’altra parte, l’Egitto della rampante XIX dinastia aveva recuperato il controllo delle
sue regioni asiatiche, incluse Canaan e Biblo. Sethi I era poi riuscito, come si è detto, a
conquistare perfino la regione a nord di Qadesh, e si dibatte se essa fosse stata
riconquistata o meno69. Di sicuro, comunque, il figlio Ramses II nel suo quarto anno di
regno dovette combattere nella piana prospiciente Oadesh, città strategicamente
fondamentale per mantenere il controllo sull’alta valle dell’Oronte. Morto Muwatalli,
all’incirca attorno al 127270, si determinò una crisi dinastica, che vide a il fratello di
Muwatalli, Hattushili, contendere il trono al legittimo erede, il figlio del re Urki-Teshub,
che fu detronizzato e mandato in esilio71. Al regno di Hattushili corrispose un ribaltamento
in politica estera, conseguente alla firma di un trattato paritetico con l’Egitto di Ramses II.
La stessa idea che i regnanti hittita ed egiziano trattassero “alla pari” fra loro testimonia
quanto fosse divenuto potente il regno di Hatti: solo un secolo prima un simile trattato
sarebbe stato impensabile, per l’Egitto faraonico72.
Il problema assiro richiese invece una vera e propria guerra aperta, condotta dal figlio di
Hattushili, Tudhaliya IV. Fu, questa, la guerra nella quale Ugarit pagò un fortissimo
contributo in denaro per essere esentato dall’inviare le proprie truppe di rincalzo agli
eserciti di Hatti. Nonostante la guerra, però, il confine fu confermato lungo l’Eufrate, e la
città di Karkemish rimase esposta a nuove aggressioni.
67 M. Liverani, (1991) p. 510 68 M. Liverani, (1991) p. 511, T. Bryce, (2005) p.223 69 T. Bryce, (2005) p.233 70 Cambridge (2008) p. 256 71 Cambridge (2008) p. 257 72 M. Liverani, (1991) p. 514
25
La situazione si deteriorò nell’ultimo decennio del XIII secolo, durante il regno degli
ultimi due re Arnuwanda III e Shuppiluliuma II (l’uomo che compì l’effimera conquista
hittita di Cipro). Lo sforzo di mantenere il controllo di territori alquanto più vasti rispetto al
paese centrale, la crisi economica causata, fra le altre cose, da una carestia tanto grave che
perfino Merneptah inviò del grano verso Hatti73, avevano deteriorato una situazione sociale
e prostrato il paese alla vigilia dell’arrivo dei popoli del mare, che avrebbero largamente
approfittato della situazione segnando, assieme all’ultimo e definitivo attacco dei Kashka,
la fine del paese di Hatti.
Il sistema di controllo hittita sulle sul suo impero si instaurò con l’opera di Shuppiluliuma,
raccogliendo l’eredità mitannica ed erodendo buona parte dei domini egiziani. Da un certo
punto di vista, essere un piccolo re era molto più semplice sotto il controllo Hittita che non
sotto quello del Faraone, in quanto il sistema hittita era basato su un rapporto di fedeltà
reciproca esplicitato da un trattato scritto. Quest’ultimo, infatti, assicurava al vassallo
fedele una protezione adeguata, stabilizzando così la Siria. La presenza hittita era però
alquanto più pesante di quella mitannica, e non consentiva patti fra piccoli re, rimandando
tutte le decisioni allo stato centrale. In alcuni casi però –soprattutto nei confronti dei regni
più importanti- il trono veniva affidato a membri della casa regale di Hattusa, per poter
controllare con più sicurezza la zona74.
I.4. Ugarit
Fra le città Siriane del secondo millennio, certamente quella conosciuta meglio è la città di
Ugarit. Questo fiorente porto mercantile, infatti, al contrario di altre città è stato scavato
quasi completamente ed il numero di tavolette scritte in alfabeto cuneiforme trovate in
edifici pubblici e privati è tale da soddisfare la maggior parte delle aspettative degli
studiosi75. Ed anche la maggior parte delle informazioni utili per lo sviluppo di questa tesi
(comprese le notizie politiche riguardanti la corona) provengono da tavolette degli archivi
di palazzo e da una biblioteca che stava fra i due santuari più importanti della città.76
Quella di Ugarit è la storia di una città sottoposta ad interessi più grandi di lei e priva di
una vera forza militare per decidere autonomamente del proprio destino. Dei suoi inizi
sappiamo poco. Di sicuro, la città era già fiorente e in affari nel XVIII secolo a. C., ma, in
73 Cambridge (2008) p. 234 74 M. Liverani, (1991) p. 559 75 Cambridge (2008) p. 130 76 A.F.Rainey (1965) p.104
26
mancanza di notizie adeguate, fino agli inizi del XIV secolo ignoriamo anche i nomi dei
suoi re.
Con le campagne della XVIII dinastia – ed in primis quelle di Thutmosis III- l’esercito
egiziano si spinse tanto a nord da passare l’Eufrate, costruendo poi delle fortificazioni su
entrambe le rive del fiume Eleutero. Nulla però fa pensare che l’esercito del faraone si sia
spinto più a nord di Ullaza77. Se ne può dedurre, quindi, che Ugarit, negli anni delle
conquiste territoriali di Thutmosis III (1459-1426) e di Shaushtatar di Mitanni fosse una
città di frontiera stretta fra le potenze del momento78. All’inizio del 1400 a.C., ed in pieno
periodo amarniano, re Ammishtamru I (? -1354) potrebbe essere il capostipite di una nuova
dinastia. In quel periodo Ugarit è sicuramente in buoni rapporti con i regnanti del paese del
Nilo, ma si discute vivacemente per stabilire a quale categoria di “buon vicinato” fare
riferimento: sulla base delle stesse fonti alcuni studiosi –come Liverani- sostengono che
Ugarit fosse un vassallo d’Egitto, altri parlano di un’indipendenza completa della città
commerciale, di una semplice influenza esterna, o addirittura di una doppia e condivisa
influenza di Mitanni ed Egitto79. Di sicuro, comunque, sappiamo che le navi egiziane
avevano accesso garantito ai porti ugaritici80; ma si suppone che durante, la prima parte del
quindicesimo secolo a. C., Ugarit sia stata sotto la protezione di Shaushtatar di Mitanni, i
cui successori, però, dovettero ritirarsi a nord dell’Eufrate incalzati dagli Hittiti, che
accettarono la “<<spontanea>> sottomissione di Ugarit”81. Infatti quando, qualche
momento dopo il periodo amarniano82, partì l’offensiva del re Shuppiluliuma I contro la
Siria, il re di Ugarit ,Niqmaddu, si trovò preso fra i due fuochi: a sud il paese di Amurru
(nell’odierna Siria), nemico storico di Ugarit, a nord, l’avanzata trionfale del re hittita. E
questo mentre le truppe egiziane erano bloccate a Biblo. Niqmaddu non poté fare altro che
arrendersi ed accordarsi con entrambi, accettando Shuppiluliuma come “grande re” di
Ugarit. Il trattato fra loro due, che ci è pervenuto in diverse copie scritte in accadico ed in
una versione in ugaritico (PRU 4,37-52)83, fu conveniente tanto per il regno siriano –che
guadagnò il l’area un tempo appartenente al regno di Mukish, incrementando di circa
quattro volte il proprio territorio84- quanto ovviamente per quello hittita, dato che il tributo
77 I.Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.622 78 M. Liverani, (1991), p. 484 79 I.Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.626 80 I.Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.627, Cambridge (2008) p. 133 81 M. Liverani, (1991), p. 486 82 Cambridge (2008) p.137 83 I. Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.634 84 Cambridge (2008) p. 138, A.F.Rainey (1965) p.110
27
che versava ad Hatti indica come fosse il vassallo hittita più ricco della Siria Settentrionale
85. Non sembra poi che la città abbia avuto a soffrire una qualche occupazione hittita, ed
appare chiaro, tanto dai resti archeologici che dalle lettere rinvenute, che abbia continuato
ad esercitare il proprio ruolo di polo commerciale.
Due figli di Niqmaddu si succedettero sul trono: il primo, Ar-Khalba (1317-131486), regnò
per pochissimo tempo (di lui sono attestati solamente sei testi giuridici87) fino a che la Siria
non si ribellò al dominio hittita. Mursili II dovette riconquistare la città-stato di Ugarit e in
questa circostanza la privò delle sue due province più ricche88 mettendo sul trono un re che
considerava a sé più fedele: il secondo figlio di Niqmaddu, Niqmepa (1313-125189)90. Ciò
nonostante, Ugarit rimase al fianco degli hittiti, pur non concedendosi esclusivamente ad
essi. I contatti commerciali con l’Egitto, infatti, non furono mai interrotti: c’erano degli
egiziani erano residenti ad Ugarit ( si ha notizia di terre date loro dal re) e l’artigianato
siriano era tanto apprezzato che i faraoni continuarono a farne richiesta (lo proverebbe
anche il ritrovamento di una spada col cartiglio di Merneptah in una casa privata, ragion
per cui si è pensato che egli stesso lo avesse commissionato senza però mai riceverlo in
consegna)91.
La Ugarit del tredicesimo secolo era una città grande (220 mila metri quadri)92, popolosa
(7600 persone circa93, con intorno una popolazione rurale di circa 25000 persone94) e ricca
(il palazzo -sede del governo e di buona parte dell’industria- era di circa 19 mila metri
quadri95), una delle più grandi e ricche del Vicino Oriente Antico, d’opulenza tale che Rib-
Adda di Biblo arrivò a cantarne la bellezza addirittura col Faraone96. Il re di Ugarit era un
85 T. Bryce, (2005) p.164 86 M. Van De Mieroop (2007) p 308 87 Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.637 88 Ci si è chiesti se questa sottrazione sia stata causata dalla volontà da parte del re hittita di punire il paese di
Ugarit o meno. Il fatto che, dopo la guerra, i signori di Mukish abbiano ricevuto un diniego alla loro richiesta
di avere indietro i territori assegnati da Shuppiluliuma ad Ugarit, e quello che invece abbia avuto successo la
causa intentata dal paese di Siyannu per separarsi dal regno di Ugarit, ha fatto ricercare una ragione diversa
dalla punizione. È stato ipotizzato che il motivo per questa separazione vada ricercato nel concetto del divide
et impera: una Siria frammentata oliticamente, infatti, difficilmente si sarebbe rivelata un serio pericolo per
Hatti (Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.640) 89 M. Van De Mieroop (2007) p 308 90 Cambridge (2008) p. 139 91 Cambridge (2008) p. 144 92 W.R Garr (1987) p.35 93 W.R Garr(1987) p.39. In questo articolo, l’autore utilizza diverse formule e teorie per calcolare la
probabile popolazione di Ugarit, ottenendo cifre che vanno dalle 2.200 alle 13.380 unità per la sola città. Per
ovvi motivi, si è scelto quella mediana. 94 M. Liverani, (1991) p.542 95 M.C. Astour (1965) p.35, Garr (1987) p.35 96 EA89
28
principe mercante, “almost a renaissance type of banker-prince”97 capace di fornire ai
propri alleati più oro (ben cinquanta mine) che non uomini98, ma anche in grado, se
necessario, di schierare più di mille carri in un colpo99.
Il periodo di pace fra i due imperi rivali di Egitto ed Hatti a seguito della battaglia di
Qadesh diede modo ad Ugarit di godere a pieno della sua situazione politica. Il regno,
infatti, possedeva molti dei requisiti necessari ad uno sviluppo economico esplosivo: un
territorio vasto - anche se non fertilissimo- che produceva grano, olio, vino, lana, e legni
pregiati; una lunga zona costiera con almeno tre porti più la baia stessa di Ugarit, e,
ovviamente, la favorevolissima posizione, che la portava ad essere il centro degli scambi
commerciali dell’epoca.100 Il fatto che il terreno non fosse poi così fertile rendeva la base
agro-pastorale insicura e priva di grossi margini di guadagno, facendo sì che l’economia
del paese fosse basata anche sui centri di lavorazione artigianale del palazzo101. I settori
trainanti erano quello tessile e quello legato alla metallurgia del bronzo, sviluppatasi anche
e soprattutto grazie al rame di Cipro. Il tributo al re Hittita conferma questa struttura
dell’economia ugaritica, dato che risulta fosse composto anche da tessuti di lana e da
attrezzi o armi di bronzo102. In ogni caso, la prosperità di Ugarit dipendeva per buona parte
non dall’industria, ma dai traffici commerciali. Basterebbe a dimostrarlo il fatto che,
durante l’intero secondo millennio a.C., le grandi potenze abbiano combattuto per
controllarne le rotte. Ma gli archivi della città ce ne danno ulteriori prove concrete, dando
dimostrazione di come i due secoli di dominio hittita abbiano giovato alla città103. Favorita
dal suo essere punto di incontro fra l’Egeo ed il Levante, Ugarit era una città che doveva al
commercio gran parte della sua enorme ricchezza: le sue navi visitavano tutte le coste, le
sue carovane portavano i beni in tutti i centri maggiori dell’Asia, e grandi compagnie di
mercanti egiziani, assiri, ciprioti, cilici, ne occupavano interi quartieri come base dei propri
affari. Ugarit aveva navi da carico capaci di trasportare 150 tonnellate di grano104. La sua
marina doveva essere di proporzioni stupefacenti: è stato infatti ritrovato il testo di un
messaggio di un comandante militare della città che chiedeva al re 150 navi di “rinforzo”.
Se si presta fede al catalogo delle navi presentato nell’Iliade, nessuna città greca poteva
97 N.K.Sandars (1985) p. 38 98 A.F.Rainey (1965) p.111 99 M.C. Astour (1965) p.257 100 M.C. Astour (1965) p. 252 101 M.Liverani (1991) p.548 102 M.Liverani (1991) p.549 103 Cambridge (2008) p. 506 104 Cambridge (2008) p. 508
29
mettere in mare una flotta delle stesse dimensioni105. E nella stagione favorevole agli
scambi (montagne, steppe e deserti non si attraversano agevolmente tutto l’anno) carovane
di asini attraversavano una rete di strade e connessioni guidate da mercanti in veste anche
di agenti del governo, che viaggiavano per conto del re106. E data la loro importanza per
tutte le economie locali, sulle rotte, che passando da Aleppo puntavano su Carchemish -per
connettersi alla rete dell’Eufrate verso Babilonia e verso l’Assiria- o si dirigevano verso
l’Anatolia centrale107 attraverso Mukish, si esercitava lo stretto controllo di ognuno degli
stati attraversati, fortemente interessati a quei traffici.
Sulla fine di Ugarit si è dibattuto a lungo perché, nonostante il fatto che buona parte delle
tavolette che ne documentano la storia appartengano agli ultimi cinquant’anni di vita della
città108, l’unica cosa di cui si può esser certi è il nome dell’ultimo re: siamo infatti in
possesso di una lista del tardo tredicesimo secolo che elenca tutti i re ugaritici fino al
secondo millennio. L’ultimo nome è quello di “Ammurapi (‘mrpi) 109, che quindi
corrisponde probabilmente a quello del re sotto il quale Ugarit è stata distrutta. M.
Schaeffer, che ha speso quarant’anni della sua vita a scavare ad Ugarit, convinto a lungo
che i popoli del mare fossero responsabili della sua distruzione, oggi ha maturato un’idea
diversa: pensa, infatti, che Ugarit possa esser scesa a patti con gli invasori -cui potrebbe
addirittura essersi alleata in funzione anti-egiziana-110 dopo averli convinti a ignorare la
città. Motivo per cui lo stesso Schaefer propende a credere che la distruzione di Ugarit sia
avvenuta per cause naturali, come un terribile terremoto che l’avrebbe rasa al suolo poco
tempo dopo l’arrivo dei popoli del mare. Dovrebbe essersi trattato, comunque, di un
disastro improvviso e completo, causato anche da un vasto incendio – lo si deduce dallo
strato di cenere che ricopriva gran parte dell’area metropolitana – che, pur lasciando il
tempo di scappare agli abitanti (gli scavi non hanno riportato alla luce scheletri sulle
strade) deve aver finito di rovinare completamente la città. 111 Invece, la professoressa
Yon, altro archeologo che ha passato una carriera intera negli scavi ad Ugarit, propende per
l’idea che la città abbia vissuto terribili combattimenti (lo proverebbero le tante punte di
105 Cambridge (2008) p. 509. 106 Cambridge (2008) p. 506 107 Cambridge (2008) p. 132 108 Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.704 109 M.C. Astour (1965) 254 110 R.Drews, (1993) p.34 111 Cambridge (2008) p.147, R.Drews, (1993) p. 34
30
freccia rinvenute fra le rovine) al termine dei quali gli abitanti furono portati via in catene
dagli invasori. 112
I.5 Cipro/Alaysha
Alaysha sembra sia stato il nome di Cipro durante l’età del bronzo. L’identificazione pare
essere certa, poiché le fonti la descrivono come una grande isola raggiungibile da tutte le
coste del Levante, dalle cui montagne arriva il rame di cui parlano alcune lettere hittite113.
Il fatto che si sia caratterizzato come un “grande regno” sembra dipenda, più che dalla
potenza economico-militare del suo stato -oggettivamente limitata- dalla sua insularità e
lontananza, che gli garantì a lungo l’indipendenza dalle mire degli imperi della terraferma.
Durante la prima parte del secondo millennio a.C. tutti i villaggi, o comunque gli
accampamenti di Cipro, erano concentrati nella zona di Kyrenia, lungo la costa a nord
dell’isola.114 Attorno al 1600 a.C sembra si sia modificato il sistema degli insediamenti con
il sorgere di nuovi e potenti cittadine (fra cui le prospere Enkomi e Hala Sultan Tekke, con
la prima che guadagnò velocemente la supremazia115) sulle altre coste. La loro esistenza
supporta di per se l’idea di uno sviluppo commerciale dell’isola fondato sulla forte
domanda d’oltremare per la produzione di rame (essenziale per fabbricare manufatti in
bronzo). Fu la domanda di questo metallo ad indurre le élites del paese, probabilmente
cananei a capo di una popolazione fornita di componenti semite (come si deduce dal nome
di un fuggitivo cipriota alla corte Hittita, “Yaduba’al”)116 a stabilire alleanze politiche con
l’Egeo e i paesi del Levante117. L’assenza ad Enkomi di locali per conservare il grano nelle
abitazioni private dell’élite ha fatto pensare che l’economia di questo centro costiero si
reggesse su un sistema finanziario in cui i prodotti agricoli, immagazzinati nelle campagne
circostanti, venivano redistribuiti a cura del governo e/o di privati specializzati. Il prestigio
e lo status di Enkomi ,d’altronde, fanno pensare che la sua monarchia fosse abbastanza
forte da regolare d’imperio sia la produzione che gli scambi118.
L’importanza dell’isola cipriota nel periodo Amarniano ci è testimoniata da sette lettere
rinvenute nella vecchia Akhenaten119, che documentano uno scambio di “doni” costituiti,
112 R.Drews, (1993) p. 35 113 Cambridge (2008) p. 490 114 B.Knapp (1997) p.46 115 B.Knapp (1997) p.65 116 Cambridge (2008) p.490 117 B.Knapp (1997) pp. 47-48 118 B.Knapp (1997) p.62 119 EA 33-39
31
per un verso, da una grande quantità di rame e, per l’altro, da vari materiali preziosi, come
ebano, olii ed argento120. E non è improbabile che Cipro fosse la testa di ponte per i
collegamenti fra il Levante e l’Egeo: nel silenzio degli archivi di Ugarit riguardo Creta e le
terre greche, nonostante siano stati ritrovati non pochi vasi di origine e stile egeo in giro
per il mondo levantino, si è supposto che le le merci provenienti dalla Grecia arrivassero
proprio a Cipro, per poi raggiungere il continente asiatico su altre navi121.
In ogni caso, oltre ai rapporti commerciali di cui è rimasta traccia scritta fuori dai confini
dell’isola, ciò che sappiamo di Cipro deriva dai suoi siti archeologici: gli scavi ad Enkomi
e Larnaca (l’antica Kition), ad esempio, ci hanno confermato il contenuto di quelle lettere,
dimostrando che il tredicesimo secolo fu, per Cipro, un periodo di prosperità, cui, però, in
poco tempo seguì una fase di declino. Un’opera di fortificazione ad Enkomi, databile alla
fine del tredicesimo secolo13, è stata variamente interpretata come prova dell’invasione di
Shuppiluliuma II, come tentativo cipriota di proteggersi contro i ripetuti raids che, varie
fonti attestano essere stati compiuti sull’isola dai pirati Lukka122 o come difesa contro i
tentativi di invasione ad opera dei popoli del mare. In una lettera trovata ad Ugarit si legge
di un consiglio del re di Alaysha al sovrano dell’odierna Ras Sharma, cui si suggerisce di
circondare le “ tue città di mura” e si raccomanda: “fai entrare le tue truppe e i tuoi carri,
sta’ attento all’arrivo del nemico, e sii molto saldo”123. Questa lettera fa pensare che il re
cipriota avesse già fatto altrettanto.
Peraltro non si sa per certo se Cipro sia stata risparmiata o colpita dall’ondata migratoria
dei popoli del mare; ma anche se non fosse stata invasa (secondo Knapp le fortificazioni
sarebbero motivate da scontri interni, perché “the absence of material evidence for foreign
intereference or domination on Cyprus in the late 15th century BC is rather striking”124), la
conquista dell’Egeo e del Mediterraneo Orientale, operata abbattendo i palazzi dei
governanti e minando la domanda di rame che Cipro riusciva a soddisfare, avrebbe
distrutto economicamente la società cipriota. Il sito di Larnaca (l’antica Kition), comunque,
presenta evidenza di una invasione e distruzione alla fine del XIII secolo da parte di
popolazioni di origine Greca che vi si sarebbero stabilite subito dopo125.
120 Cambridge (2008) p.490 121 N.K. Sandars (1985) p.39, Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.675 122 N.K. Sandars (1985) p. 43 123 Ugaritica Vol. V, pp 85-86 in Liverani 1994 124 B.Knapp (1997) p. 68 125 Cambridge (2008) p. 370
32
I.6 I Popoli del mare
Nel corso di pochi anni, nella prima metà del XII secolo a.C., 1cade una coltre di nebbia
che rende difficile ai nostri occhi sapere qualcosa sulla Grecia, l’Anatolia e l’intero
Levante. Di quel mondo illuminato alla nostra comprensione dai documenti di Ugarit,
Hattusha e Akhenaten, non vediamo più niente. Nello stesso arco di tempo, mentre
l’impero Hittita abbandona la sua capitale indifendibile e L’Egitto si chiude in sé stesso,
preda di una nuova, profondissima, crisi interna, tutte le floride città del levante
semplicemente smettono di esistere, abbattute dall’invasione di un “nemico” esterno: i
“popoli del mare”, una “coalizione” di popolazioni dedite al saccheggio. Non in uno stato
solo ma in gran parte del mondo civilizzato la storia pare interrompersi, e tutto questo
grosso modo allo stesso momento in un’area abbastanza grande, probabilmente a seguito di
un attacco esterno. In ambiente accademico si è spesso discusso sulla possibilità che
un’invasione, per quanto disastrosa, abbia potuto causare il totale annichilimento del
mondo civilizzato. Pochi, infatti, sembrano tenere in considerazione come i fattori “interni”
ed “esterni” del disastro del XII secolo a.C. siano profondamente interconnessi: “Invaders
were more likely to succeed when their target was already economically and
politically/militarily weakened by its own and regional or system wide crisis”126.
Ma a prescindere dal fatto che questi “Popoli del Mare” abbiano avuto un ruolo più o meno
determinante nello sviluppo della crisi, c’è da dire che nessuna di questi popolazioni, nel
1200 a.C., era una novità per il mondo levantino. Se si accetta poi l’ identificazione
universalmente condivisa fra gli Ekwesh delle fonti egiziane e gli Ahhiyawa di quelle
hittite, la menzione più antica di un movimento invasore o comunque portato a razzie, da
parte di uno dei “Popoli del mare” sarebbe l’hittita “editto di Madduwattas”, databile circa
al 1440 a.C., documento in cui il re hittita lamenta il saccheggio e il rapimento di donne di
Cipro da parte degli Ahhiyawa127. Già negli annali di Tudhaliya I/II infatti, il primo
termine della lista è “[ ]ugga”. Se la prima lettera fosse da intendere come una L, allora
avremmo una probabile prima citazione dei Lukka già duecento anni prima della
catastrofe128. Anche in epoca amarniana, troviamo non pochi accenni ad alcune di queste
popolazioni: il faraone Akhenaten si era lamentato col re di Alaysha dei raid compiuti dai
pirati Lukka sulle sue coste, arrivando ad accusare i ciprioti di proteggerli, e il re di Cipro
126 N.K. Sandars (1985) 403 127 Wachsmann in Oren (2000) p.103 128 T. Bryce (2005) p. 125
33
gli aveva risposto dicendo di essere di essere stato colpito lui stesso dagli stessi attacchi129.
Sappiamo però che, in realtà, gli attacchi di pirati Lukka sulle coste di Cipro erano una
costante130.
In altre lettere131, poi, il re di Biblo Rib-Addi raccontava di come un mercenario Shardana
al suo servizio avesse cercato di ucciderlo, e di come uno dei suoi sia stato ucciso. E su
alcune tavolette trovate ad Ugarit si riporta una lettera indirizzata da un innominato re
hittita ad Ammurapi nella quale si parla di un riscatto che Ugarit avrebbe pagato per la
liberazione di un certo Lunandusu, preso prigioniero dai “Sikala che vivono nelle navi”132.
E non è sorprendente che i documenti hittiti presentino spesso i pirati Lukka133, dato che le
fonti egiziane li indicano come alleati agli hittiti durante la battaglia di Qadesh, assieme ai
Teresh e gli Ekwesh. Sappiamo poi di raid compiuti da pirati Shardana durante il regno di
Ramses II, ed il fatto che nella stele di Tanis di loro si dica che “nessuno aveva saputo
combattere fin da sempre”134 rafforza l’idea che fossero conosciuti come pirati. Sotto
Merneptah il Delta egiziano fu fatto oggetto di altri attacchi: “Il misero capo libico Meryw,
figlio di Ded, è sceso nel paese di Tehenw con i battaglioni di Shardana, Shekelesh,
Ekwesh, Lukka, Teresh, i migliori di ogni guerriero e di ogni corridore nel suo paese”135.
Va rilevato che, mentre al tempo di Akhenaten venivano nominati solamente i Lukka, e al
tempo di Ramses II solamente gli Shardana, all’epoca di Merneptah questo testo menziona
per la prima ed ultima volta una vera e propria unione di popoli, e ciò avviene poco prima
del “disastro” del XII secolo a.C..
Ad Ugarit, all’interno di un forno per tavolette, sono state trovate delle lettere indirizzate
all’ultimo re della città, Hammurabi. Non si tratta di originali, ma di traduzioni operate
dalla cancelleria regale e cotte al forno. In un primo momento si è pensato –sarebbe stato
indubbiamente un dettaglio affascinante- che fossero state lasciate a cuocere, nella
convinzione di estrarle a cottura terminata, nello stesso forno in cui furono trovate tremila
anni dopo, perché nessuno era mai andato ad estrarle136. Il fatto che numerosi documenti
fossero però spezzati, ed i cocci sparsi anche a diversi metri di distanza dal forno, fa oggi
129 EA 38 130 N.K. Sandars (1985) 107 131 Ea 81-122 132 N.K. Sandars (1985) 112 133 G.A. Wainwright (1939) p. 149 134 KRI II 290.1-4 135 KRI IV 3.15-4.2 in Cavillier (2005) p. 17 136 M.C. Astour (1965) p. 254
34
pensare che le tavolette siano cadute da un piano superiore in cui erano state conservate137.
Una di queste, traduzione in ugaritico di una lettera diplomatica, comincia con “ˁm špš kll
midm šlm”: “con Il Sole, tutto va bene”. “Il Sole” è il re Hittita, siamo quindi di fronte ad
una lettera mandata da un “Grande Re” al suo vassallo. La titolatura iniziale contrasta con
il testo interno della lettera, (qui nella traduzione inglese di Michael C.Astour)138
(31) ib. ˁltn. a[...] y the enemy [advances?] against us
(32) w. spr. in [..] ˁ (?)dm and there is no number [...].
(33) sprn..tr [.....] our number is pure(?) [ ]
(34) atr. it. bqt whatever is available, look for it
(35) w. štn. ly and send it to me.
La situazione è quella di una guerra, ed il re Hittita comanda al suo vassallo di inviargli
ogni uomo possibile. Evidentemente Hammurabi deve aver obbedito, perché in una lettera
al re di Cipro scrive:
"behold, the enemy's ships came (here); my cities (?) were burned, and they did evil
things in my country. Does not my father know that all my troops and chariots (?)
are in the Hittite country, and all my ships are in the land of Lycia?... Thus, the
country is abandoned to itself. May my father know it: the seven ships of the enemy
that came here inflicted much damage upon us."139
Da altre lettere, si deduce che la flotta, inviata ad ovest a chiudere il passaggio dall’Egeo al
Mediterraneo, sia stata quantomeno aggirata, e che l’esercito unito di Ugarit e Hatti sia
stato sconfitto. Di sicuro, si è ritirato, lasciando che il nemico prendesse prima Lawasanda
in Cilicia e poi che distruggesse tutto quello che stava dietro ai monti Amanos. Ewir-
Sharruma, era re di Mukish, una città appena a nord di Ugarit, inviò infatti una lettera ad
una “Signora” (adty), forse la regina madre di Ugarit, scrivendo :
(27) w. hn. ibm. šsq ly and, behold, the enemies oppress me,
(28) p. l. ašt. Atty but I shall not leave my wife (and)
137 Singer in W.G.E. Watson – N.Wyatt (1999) p.705 138 PRU V, No. 60, in M.C. Astour, (1965), p.257 139PRU V, No. 24, in M.C. Astour, (1965), p.255
35
(29) nˁry. th. I pn. ib my children.. before the enemy140
I nemici erano ormai alle porte di Ugarit. Non sappiamo se gli abitanti siano stati uccisi o
se siano scappati, ma, di sicuro, la città fu presa, i palazzi più importanti dati alle fiamme e
gli altri abbandonati al proprio destino. Al contrario di altre città, che furono ri-popolate
dagli invasori, Ugarit cadde in rovina. Nello stesso periodo, la città di Hattusa veniva
abbandonata dalla popolazione e dalla corte, lasciando in città solo una guarnigione a
vigilare su quella che era stata la capitale dell’impero. Più o meno in contemporanea
l’insediamento di Mileto in Caria è incendiato, in Cilicia cadono Mersin e Tarso. Le città
della zona interna della Siria furono anch’esse danneggiate: risalendo il corso dell’Oronte
nel 1200 si sarebbero trovate Alalakh, Hamath, Qatna e Qadesh, Tutte e quattro furono
saccheggiate e date alle fiamme141. Anche Sidone fu distrutta, mentre i suoi abitanti
fuggivano a Tiro. Tell-abu-hawwa, un vasto sito nella costa palestinese, pure, ed in questo
caso è possibile attribuire una presenza certa di greci in questi luoghi –gli Ekwesh di
Merneptah- dato che sono stati trovati vasi del tardo elladico C. L’identità di questi
“nemici”, appare ormai chiaro, è quella degli stessi “Popoli del Mare” che attaccarono
successivamente anche l’Egitto. Infatti secondo il racconto di Ramses III questi popoli
avrebbero provato ad invadere anche l’Egitto, che si sarebbe però salvato in battaglia.
Dal controllo incrociato delle fonti egiziane (le iscrizioni di Medinet Habu e il papiro
Harris) si possono rilevare i nomi di 9 popoli: Lukka, Denyen, Shardana, Peleset, Tursha,
Shekelesh, Meshwesh, Tjeker Weshesh. La loro provenienza è quantomeno controversa: i
due testi di Ramses III parlano di una vittoria del faraone in difesa del paese contro
popolazioni che avevano cospirato “nelle loro isole” 142. Per molto tempo si è quindi
cercato di identificare questi popoli con gli abitanti di qualche isola, individuandole
solitamente fra quelle nel mar Egeo143. Ma il testo egiziano non dice “isole” (e secondo
alcuni egittologi l’egiziano non aveva nemmeno la parola, o il concetto, di “isola”144) ma
userebbe quindi il termine “rww”, solitamente tradotto con “isole”, ma che, essendo spesso
usata per indicare la costa continentale, dovrebbe indicare invece la vicinanza al mare.
Sulla base di questa nuova lettura alcune teorie li indicano ora come barbari invasori
provenienti da qualche luogo a nord145 o a sud146 dell’Anatolia, altre – la maggior parte-
140PRU II, No. 12, in M.C. Astour, (1965), p.257 141 R.Drews, (1993) p. 14 142 J.Wilson in Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, in R.Drews, (2000) p. 176 143N.K. Sandars (1985), A. Yasur Landau (1999) 144 R.Drews, (1993) p. 52 145 T. Bryce, (2005) p.334
36
puntavano il dito sull’area egea. Per questo motivo cercare la provenienza dell’insieme dei
popoli può rivelarsi più complicato che non cercare la provenienza dei popoli uno per uno.
I Lukka sono molto comunemente identificati coi Lici147, anche se non sono poche le
discussioni accademiche sul dove collocarli con precisione. Alcuni studiosi sono arrivati a
sostenere che vi fosse una originaria “patria dei Lukka” nella zona centro-meridionale
dell’Anatolia, dalla quale si sarebbero mossi verso stati con una vera organizzazione
politica, più a sud e più ad ovest, fino a stabilirsi in quella che, in epoca classica, sarebbe
stata definita “Licia”148. Forse per questo motivo, Omero nomina due Licia: una a nord-est
della Troade, ed una più lontana, probabilmente in Caria149. Data la frequenza dei loro
attacchi verso Alaysha, e data la loro presenza a Qadesh al fianco di Muwatalli150. Si
dovesse sceglierne una sola, la seconda opzione sarebbe assai più probabile che non la
prima. I Meshwesh, secondo professor Wainwright, sarebbero in realtà il nuovo nome con
cui venivano individuati i Tehenu –una popolazione con cui gli egiziani si erano scontrati
fin dall’antico regno- nel periodo Ramesside151, mentre altri studiosi, come ad esempio
Drews, li hanno identificati come gli abitanti dell’area di Tunisi, dove in epoca storica
Erodoto locava una popolazione berbera chiamandola Maxyes152. Gli Ekwesh compaiono
per la prima volta al fianco dei libici, presso i quali formano il contingente maggiore. Sono
solitamente identificati con gli Ahhiyawa/Achei, e quindi provenienti da
Millawanda/Mileto, una colonia achea153 delle fonti Hittite. Suggestivo, da questo punto di
vista, il fatto che nell’Odissea (XIV, 246) Ulisse dica che gli achei avevano fatto una
spedizione contro l’Egitto ed erano stati sconfitti. Contrasta, con quest’identificazione con
gli achei, il fatto che Merneptah, nelle iscrizioni per la vittoria a Karnak e Athribis, dica di
aver ucciso numerosi Ekwesh, e di aver tagliato le mani ai cadaveri per poterle contare154.
Il fatto che solitamente, ai popoli non circoncisi non erano rimossi gli arti superiori, ma i
genitali, ci dice con buona probabilità che gli Ekwesh avessero adottato una pratica del
tutto estranea al mondo indeuropeo ma comunissima in ambito semitico ed egiziano155. I
Teresh sono stati avvicinati ai Taruisha delle fonti Hittite, e ai tyrsenoi del mondo greco,
146 G.A. Wainwright (1961) p.71 147 M. Liverani, (1991) p 634, N.K. Sandars (1985) p.37, G.A.Wainwright (1961) p.72 148 T. Bryce, (1992) p. 130 149 N.K. Sandars (1985) p.37 150, G.A. Wainwright (1961) p.68 151 G.A. Wainwright (1962) p.89 152 R.Drews, (1993) p. 50 153 Ibidem p.73 154 Cambridge (2008) p. 368 155 Ibidem
37
dai quali proverrebbero gli Etruschi. Sarebbero, quindi provenienti dalla Lidia, così come
gli Shekelesh156. Così come gli Shekelesh sono mostrati come barbuti, e fin dai tempi di
Champollion sono stati identificati, in coppia, come Etruschi e Sicelioti, anche se prove per
un arrivo etrusco in Italia già a quest’epoca non sono mai state prodotte157. I Peleset sono
unanimemente considerati essere i filistei della bibbia, e che si sarebbero stabiliti in
Palestina a seguito della catastrofe del 1200. È interessante notare come, di loro, non si
dica mai che siano popoli “del mare”, uno dei motivi che ha fatto sì che li si ritenesse
provenienti dalla Cilicia occidentale158, dove, con ogni probabilità, erano già stabiliti
attorno al 1500 a.C. 159. Di sicuro, comunque, erano indeuropei160, e Yassur-Landau,
seguendo la definizione già fatta propria da Singer e Niemer, li identifica invece con i
Pelasgi dell’Egeo161. Dalla Cilicia orientale proverrebbero invece i Tjekker, che sarebbero
poi i Teucri delle fonti greche162.I Denyen sono solitamente ricollegati ai Danai ma
secondo Wainwright sarebbero, anche loro, provenienti dalla Cilicia, e ciò li avvicinerebbe
a Teucri e Filistei.
Infine, gli Shardana, che come mercenari sono conosciuti fin dai tempi di Amenothep III,
all’inizio del periodo Amarniano, hanno un’origine misteriosa. I caratteristici elmi cornuti
non sono di ambito egeo, mentre nella tradizione levantina sono conosciutissimi163. Nella
documentazione Hittita non esistono164 (e nonostante questo, si è pensato provenissero
dalla piana di Sardi, in Asia Minore165), e, benché alcune raffigurazioni da Pisaskion e dal
vaso dei guerrieri di Micene mostrino dei guerrieri con il loro caratteristico elmo
cornuto166, e benché fossero circoncisi come i semiti167, spesso si è cercato di ricondurli
alla civiltà Nuragica e a quella delle Torri della Corsica. Di sicuro la Sardegna era già
conosciuta nel Vicino Oriente, non si sa se in maniera diretta o indiretta, come produttrice
di rame168. Nell’isola sono stati trovati infatti numerosi pani di rame e ceramiche micenee
tarde, che proverrebbero da Cipro, isola con cui la Sardegna, ancora in tempi storici aveva
156 G.A .Wainwright (1962) p.89 157 Cambridge (2008) p. 368 158 G.A. Wainwright(1961) p.79 159G.A. Wainwright(1959) p.76 160 G.A.Wainwright(1959) p.83 161 A. Yassur Landau (2010) p.180 162 G.A.Wainwright(1961) p.79 163 N.K. Sandars (1985) p.106 164 G.A.Wainwright (1939) p. 150 165 Cambridge (2008) 742 166A. Yassur Landau (2010) p.182 167 Machinist in Oren (2000) p.68 168 N.K. Sandars (1985) 199
38
non poche relazioni169. La presenza di una somiglianza fra gli Shardana delle immagini
Egiziane e alcuni reperti rinvenuti nelle due isole -le statue bronzee in Sardegna, che però
appaiono solo dal IX secolo, e alcuni menhir ritrovati in Corsica170 - ed il fatto che una
stele (sempre del IX secolo) ritrovata a Nora, un porto nuragico e fenicio in provincia di
Cagliari, chiami l’isola “Be-Shardan” ha senza dubbio rinforzato l’ipotesi di una
connessione fra questo popolo e l’isola in mezzo al mediterraneo171. Si discute ancora però
sul se l’avvento di questa popolazione sia avvenuto prima o dopo il 1200, ovvero se gli
Shardana egiziani provenissero dalla Sardegna o se vi siano arrivati in un secondo
momento. A favore dell’ultima ipotesi, si noti come nessun tipo di arma –nemmeno i
caratteristici elmi, o le particolarissime spade- del quattordicesimo secolo sia stato trovato
nell’isola da cui si dice che siano partiti questi mercenari172, e che le figurine di bronzo,
che tanto hanno fatto discutere, siano, come si è detto, più tarde.
I.7 Conclusione
In questo capitolo si è cercato di dare una descrizione, per quanto non esauriente, dello
sviluppo storico del mondo levantino nel tardo Bronzo. L'intento, oltre che essere quello di
offrire al lettore una conoscenza di fondo delle dinamiche di potere dell'epoca, ha cercato
di definire anche le ragioni, le cause, economiche e sociali per l'impiego di mercenari da
parte dei vari paesi. Oltre alle guerre d'espansione, che ogni paese prima o poi ha svolto
alla ricerca di nuovi elementi e tributi coi quali accrescere la propria economia, ogni paese
aveva il suo motivo di combattere.
In Egitto, come si è visto, la formazione dell’impero fu conseguente, fra le altre cose, alla
volontà di rassicurare il paese centrale “allontanando gli Hyksos” (Antonio Santosuosso,
per spiegare questa politica estera, parla addirittura di “trauma caused by the hyksos
invasion and domination”)173. E una volta formato l’impero, fu necessario mantenere un
esercito per difenderlo dagli attacchi esterni e dalle spinte centrifughe provenienti dai paesi
sottomessi. Ma una volta formato, si rese necessario il mantenimento di un esercito in
grado di difenderlo dagli attacchi e di pacificare le spinte centrifughe che i paesi sottomessi
avrebbero potuto avviare. Ma non solo: la presenza, nelle zone montagnose e di confine, di
nomadi come gli Shasu e gli Hapiru, arricchiti nel numero dai non pochi fuoriusciti dai
169G.Lilliu (1982) p. 113 170 Cambridge (2008) p. 368 171 Nella traduzione inglese di Frank M. Cross “He is now at peace with the Shardina, and his army is at
peace: Milkaton, son of Subna, The officer of Pummay” (1986) p. 120 172 L.Vagnetti in Oren (2000) p. p.319 173 A.Santosuosso(1996) p. 426
39
villaggi -spesso a causa del peso delle tasse imposte dallo stato centrale- imponeva un
costante utilizzo di forze di “polizia”174, tanto per mettere al sicuro i territori – soprattutto
quelli a diretto controllo del faraone- quanto per proteggere le carovane commerciali. Non
molto diverse erano le necessità degli Hittiti, i quali però, al contrario dell’Egitto, non
avevano alcuna barriera naturale a proteggere la capitale, e per tutta la loro storia ebbero da
affrontare gli attacchi dei Kashka dal nord dell’Anatolia. Le necessità militari di Ugarit
erano invece fondamentalmente legate all’economia: la protezione delle rotte commerciali
di mare e di terra, la difesa dei propri interessi commerciali nelle varie parti della Siria, il
mantenimento della stabilità statale richiedevano tutte un esercito forte e pronto ad essere
dispiegato.
Il mantenimento dell’esercito erose la struttura economica dei paesi, preparando così
l’avvento dei popoli del mare ed una nuova fase della storia del Vicino Oriente Antico.
174 Oren (2000) p. 7
40
Capitolo II: La storia militare e gli Shardana
II.1 Introduzione
Per poter capire il ruolo degli Shardana nelle vicende militari del tardo bronzo è necessario
delineare le caratteristiche della guerra del tempo. Se il primo capitolo è incentrato sulla
descrizione storica del periodo, con le sue guerre, i suoi scontri, le organizzazioni imperiali
ed imperialistiche, questa seconda parte del testo sarà invece tutta concentrata sulla storia
militare. Si cercherà infatti di descrivere come funzionasse la guerra del tempo dal punto di
vista tattico, di individuare le caratteristiche degli Shardana stessi, e di vedere quale fosse
la necessità, dal punto di vista militare, di schierare tali mercenari. Gli Shardana infatti
erano particolarmente conosciuti ed impiegati in vari luoghi del mondo a loro
contemporaneo, ed è quindi possibile ipotizzare che possedessero delle caratteristiche
ritenute congeniali alle necessità dei re, grandi e piccoli, del tempo.
È pero necessario sottolineare che, per quanto riguarda la guerra nel mondo antico
preclassico, si sa poco. È stato detto addirittura che gli storici dell’ ars pugnandi sarebbero
“grossolanamente ignoranti”1 sull’argomento: in mancanza di un Cesare o un Senofonte a
descrivere lo svolgersi delle battaglie, infatti, le uniche ricostruzioni possibili sono basate
sulle caratteristiche fisiche delle armi –attraverso il lavoro dell’archeologia sperimentale- e
sulle raffigurazioni propagandistiche, e l’unica battaglia della quale si sappia davvero
qualcosa è quella di Qadesh, che comunque necessita di un filtro capace di distinguere fra
la propaganda faraonica e la realtà dei fatti.
È stato stimato che, nei circa cinquemila anni che sono trascorsi dal momento in cui si è
cominciato a registrare i fatti, ve ne siano stati solo trecento di pace in tutto il mondo2. Il
secondo millennio avanti Cristo nell’area del Vicino Oriente -dove le superpotenze erano
sempre alla ricerca di un modo per inclinare verso il proprio piatto la bilancia del potere,
1 “Warfare in the preclassical world is a subject on which we evidently will never know very much
(…)beyond ca .700 questions begin to multiply, and about the second millennium we are grossly ignorant.”
In R.Drews, (1993) p.97 2 T.Bryce (2002) p.98
41
dove Hittiti, Assiri ed Egiziani espandevano e contraevano le loro sfere di influenza a
grande velocità, dove gli imperi ricercavano sempre nuove alleanze che li portassero a
sopravanzare i nemici3- non fa eccezione a questa tendenza universale della storia umana.
Anzi: il tema della guerra doveva essere, in tutte le sue accezioni, centrale nelle società
dell’epoca, essenziale alla concezione politica dello stato, all’affermazione e al
mantenimento del prestigio e del consenso del sovrano4.
La guerra non era importante solo ai fini politici perché era anche un vero e proprio
business: i costi per la mobilitazione degli uomini necessari (si stima che le campagne
militari hittite contro le grandi potenze coinvolgessero circa 10 mila soldati provenienti dal
paese centrale5) erano concepiti come un investimento ripagato dalle risorse procurate con
i saccheggi in caso di vittoria e dai tributi che si ottenevano con la conquista di una
provincia. Così come, peraltro, la cattura di prigionieri rappresentava una fonte regolare di
schiavi, da usare tanto nei campi quanto al servizio delle milizie regali.
C’è sempre stata una sorta di influenza reciproca nelle popolazioni che vanno in guerra
l’una contro l’altra: ognuna impara gli attacchi dell’avversaria, li limita, li replica, li
modifica, li riusa. Nuove tattiche di battaglia e nuove armi introdotte da un esercito
vengono assimilate e ripresentate da quello del paese vicino a poca distanza temporale. Le
armi e le protezioni, le fortificazioni e l’artiglieria pesante, le organizzazioni sociali e
militari, subiscono lo stesso influsso di continuo mutamento, in una eterna, cangiante,
sequela di adattamento e differenziazione rispetto al nemico. È, questo, un concetto
fondamentale, da considerare continuamente nel momento in cui si voglia comprendere la
guerra di ogni periodo storico: eccettuato l’elemento sorpresa, gli eserciti di paesi vicini si
assomigliano tutti, ed è possibile cercare, mutatis mutandis, gli stessi elementi nei due
contendenti. Questo principio indurrebbe una sorta di livellamento tecnologico -e di
conseguenza di equilibrio militare- fra le grandi potenze, fino al punto che avversari simili
in peso militare e caratura tecnica sarebbero incapaci di superarsi in modo netto6. Per
quanto riguarda il periodo preso in esame, si può vedere la prova di questa teoria andando
ad analizzare lo scontro fra Hittiti ed Egiziani: dapprima, nello sforzo di vincere lo scontro
senza migliorare l’apparato tecnico, l’esercito egiziano passò dalle tre divisioni delle
3 T.Bryce (2005) p.19 4 R.Dolce in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 149 5 T.Bryce (2002) p.102 6 M. Liverani (1994) p. 133
42
campagne d’Asia di Sethi I alle quattro messe in campo a Qadesh dal figlio Ramses II7 e in
un secondo momento i contendenti puntarono alla pace, nella convinzione che nessuna
delle due potenze avrebbe potuto superare l’avversaria8. Nelle ricerche e nelle opinioni di
Mario Liverani, questo equilibrio militare avrebbe portato, in attesa di innovazioni
tecniche, ad intendere la guerra come “un modo più drastico di argomentare”9: quando tutti
gli argomenti retorici e giuridici si fossero rivelati inefficaci, sarebbe stata la guerra, e nella
fattispecie la battaglia, come una gigantesca ordalia, a stabilire chi avesse ragione e chi
torto. A riprova di ciò, si noti come non sia possibile trovare nella lingua egiziana un
termine che significhi “guerra”10. Dei cinque termini conosciuti, tutti significherebbero
“battaglia”, o “scontro”. Questo non significa che non ne possedessero il concetto, ma che
la loro mentalità fosse più concentrata sulla singola battaglia decisiva11.
In una lettera del re hittita Shuppiluliuma è possibile trovare una schematizzazione della
composizione di un esercito del tardo Bronzo: “principi e alti ufficiali, con fanteria e
carristi”12. L’esercito di un paese dell’epoca era diviso in due corpi separati, i cui
appartenenti godevano di un prestigio –militare, sociale, ma anche economico-
completamente diverso: la fanteria, il corpo più numeroso e quindi meno prestigioso, e la
carreria, i combattenti sul carro che esprimevano la vera essenza del combattimento nel
tardo bronzo. Il loro apporto era tanto fondamentale che si potrebbe affermare che la
potenza militare di un paese fosse misurata dal numero dei suoi carri e dei suoi cavalli: un
regno con un migliaio di maryannu era infinitamente più forte di uno con centinaia. Il
ruolo della fanteria era invece diverso e, con ogni probabilità, separato, dato che non
abbiamo notizie dirette dell’utilizzo in battaglia di fanti in congiunzione coi carri da guerra
(eccettuato il ruolo, su cui si tornerà, dei pḥrr). È probabile infatti che le fanterie fossero
utilizzate contro popoli non considerati “civili”. I regni, e le città in particolar modo,
risiedevano in pianure fertili, che potevano essere controllate e difese dai carri. Quando un
re ne attaccava un altro, o qualora avesse avuto bisogno di difendere i suoi confini contro
popolazioni barbariche –come Merneptah contro i libici- si ritiene che lo scontro sarebbe
avvenuto principalmente fra carristi. Diversamente, in caso di battaglie combattute contro
popolazioni barbariche o nomadi, come gli Hapiru o i Kashka, o in zone montagnose dove
7 A.J. Spalinger (2005) p.190 8 Cambridge (2008) p. 229 9 M. Liverani (1994) p.162 10 Da intendere come “serie di operazioni militari culminanti in “battaglie” che a loro volta si frantumano in
“scontri” fra reparti o singoli armati”. 11 S.Curto in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p.124 12PRU IV,49 in Rainey (1965) p.17
43
i carri avrebbero avuto difficoltà a muoversi, un re avrebbe avuto bisogno di una forte
fanteria in grado di controllare il territorio.
II.2 I combattenti su carro
Il carro era un mezzo di trasporto conosciuto da almeno un millennio: lo si trova
rappresentato già sullo stendardo di Ur (2500 a.C), ed un vero e proprio carro da guerra
compare nel monumento di Eannatum di Lagash (circa 2450 a.C)13. Tuttavia, fu solo con le
innovazioni tecniche del XVII secolo -nella fattispecie la ruota a raggi- che cominciò
l’epopea del carro da guerra14. Il fatto che le ruote non fossero più piene alleggerì il carico
portato dai cavalli, e con questo nuovo carico, alquanto alleggerito, due animali appaiati ed
aggiogati erano facilmente in grado di trainare due persone a velocità sostenuta. La ragione
per la quale si svilupparono i carri e non si cavalcasse direttamente dovrebbe risiedere nelle
dimensioni degli animali dell’epoca: a giudicare dalla grandezza delle stalle trovate ad
Ugarit e dalle mummie di cavalli della XVIII dinastia egiziana, gli animali dell’epoca
dovevano essere di dimensioni alquanto ridotte15, e per questo motivo difficilmente la loro
groppa avrebbe potuto sostenere un uomo in tenuta da battaglia16.
L’origine del carro a due ruote, e l’idea di addestrare un cavallo a trainarlo in battaglia, fu,
con ogni probabilità, indoiranica: la terminologia tecnica connessa all’addestramento
comprende infatti frasi e termini indoiranici riportati letteralmente in testi in lingue diverse,
come l’accadico e l’hittita, e che sembrano essersi diffusi di pari passo col diffondersi del
fenomeno17. Anche il termine Maryannu, “giovane guerriero del carro”18, che indicava
questo tipo di combattenti è etimologicamente indoiranico: in sanscrito, “giovane
guerriero” si dice infatti maryah. Trascinata dalle vittorie sui campi di battaglia, questa
nuova arma si diffuse a macchia d’olio: ci sono prove che attorno al 1650 a.C. i carri da
guerra fossero usati dai re di Hatti (nel testo di Zukrasi, databile al regno di Hattusilli I, si
parla di “duecento carri”19), di Aleppo, e dagli Hyksos che –con ogni probabilità anche
grazie a quest’arma- conquistarono l’Egitto. Per il 1600 i carri da guerra erano diffusi
dall’Egeo alla valle dell’Indo20. Oltre che diffondersi in un orizzonte il più largo possibile,
13 M. Liverani, (1991) p. 194 14 R. Drews, (1993) p.105 15 Cambridge (2008) p.494 16 R.O.Faulkner (1953) p. 43 17 M. Liverani, (1991) p. 454 18 A.F. Rainey (1965) p.19 19 R.H. Beal (1992) p.141 20 R. Drews, (1993) p.106
44
i carri cominciarono a proliferare anche all’interno dei paesi che già li avevano adottati in
precedenza: se nel 1600 schierare un centinaio di carri significava mettere in campo una
forza considerevole, già nella battaglia di Megiddo (1458 circa) un gran re come
Thutmosis III non aveva difficoltà a schierarne più di un migliaio21, mentre il regno di
Mitanni ne poteva mettere in campo diverse migliaia22. Alla battaglia di Qadesh, Muwatalli
schierò un minimo di 3.500 carri23, ed è ragionevole supporre –per lo stesso motivo che
supporta il numero dei carri di Thutmosis III- che la cifra egiziana non si discostasse poi
molto. Alla vigilia della Catastrofe del 1200, il piccolo re di Ugarit aveva un numero
sufficiente di cavalli da mettere in campo mille carri24.
Si è detto come l’invenzione della ruota a raggi abbia trasformato il carro da guerra. Il
cocchio sumerico a ruota intera -da cui con poche differenze discende quello hittita- era
molto solido, ma la sua rigidità rendeva impossibile assorbire gli urti derivati dai rilievi nel
terreno, in larga parte impedendo che un arciere potesse agevolmente ed efficacemente
prendere la mira dal carro in movimento25. Al contrario i carri con le ruote a raggi, come
quello ritrovato nella tomba di Thutankamon, la cui struttura meccanica risale al 1337 (e
quindi con alle spalle qualche secolo di sviluppi tecnici), offrendo un “alto grado di
flessibilità e di assorbimento dei disturbi dovuti alle irregolarità del suolo”26 era poco
resistente –di sicuro non progettato per lunghi viaggi- ma più stabile e quindi più
confortevole per minori percorrenze. È quindi evidente che alla base del design particolare
dalla ruota a sei raggi e della struttura elastica e leggera27, vi fosse un obbiettivo diverso
dal trasporto. Il cocchio trovato nella tomba di Thutankamon doveva essere in grado di
supportare un carico statico di più di 100 chili, e a seconda della forza degli animali
avrebbe potuto agevolmente toccare i 50 chilometri orari28. La sua velocità e la sua
flessibilità – assorbendo gli urti si sarebbero dati meno scossoni ai passeggeri, i quali
avrebbero avuto una maggiore facilità nel tiro con l’arco- ne fecero la fortuna in campo
militare29.
21 “The Asiatic coalition was able to muster at least 924 chariot (…) owing to the number of enemy chariots,
I feel it most probable that the Egyptians had more than that number in order to win”. A.J. Spalinger (2005)
p. 90 22 R.Drews (1993) p.107 23 T.Bryce (2005) p.235, A. Santosuosso (1996) p.437 24 M.C. Astour (1965) p.257 25 Rovetta in Pecchioli(2005) p.317 26 Ibidem p. 319 27 Ibidem p. 317 28 Ibidem p. 318 29 Ibidem p.321
45
Si pensa che il carro in battaglia abbia avuto usi molteplici: come piattaforma mobile per
l’uso di armi da lancio, come massa d’urto contro la fanteria, come mezzo di inseguimento
di un nemico in rotta, come arma e come mezzo per coprire l’esercito in marcia. La
possibilità che venisse usato per caricare lo schieramento nemico è alquanto contestata:
alcuni argomentano che i cavalli si sarebbero rifiutati di puntare su di un ostacolo fermo
come una linea di fanti; altri sostengono che i veicoli non erano costruiti per poter
sostenere un urto, e che nemmeno fossero equipaggiati di armi vere e proprie30 – come per
esempio delle falci che sporgessero dai mozzi- e quindi sembra difficile che fossero
lanciati direttamente contro i nemici. Ma i testi del tempo indicano chiaramente la carica
come qualcosa di abituale31, ed inoltre si suppone che difficilmente lo schieramento dei
fanti sarebbe rimasto tanto solido e tanto fermo di fronte al pericolo quanto sarebbe stato
necessario per spaventare il cavalli32. Diversamente, l’uso come piattaforma mobile per il
lancio di dardi contro il nemico –provato da una grande quantità di raffigurazioni, oltre che
dal fatto che assieme al carro si diffuse ovunque l’utilizzo dell’arco composito33- è
universalmente accettato. Si pensa che, arrivati a distanza di tiro dalla fanteria, i carri si
fermassero, o girassero attorno ai fanti, scagliando dardi alla ricerca di punti deboli34. I
rilievi di Abido per la battaglia di Qadesh, poi, rappresentano i carri marciare al fianco
dell’esercito, con l’evidente funzione di proteggerlo in un momento di particolare
vulnerabilità, mentre quelli di Merneptah nella battaglia contro i libici35, o di Ramses III a
Karnak36 illustrano l’inseguimento e lo sterminio del nemico in rotta al termine della
battaglia.
Per quanto riguarda le armi a disposizione di coloro i quali combattevano sui carri da
battaglia, dando per scontato un ruolo centrale dell’arco composito. indiscusso ed anche
numericamente indiscutibile - Thutmosis III, dopo la battaglia di Megiddo, afferma di
essere entrato in possesso di 924 carri e 502 archi nemici37-, argomento spesse volte
dibattuto è stato l’utilizzo della lancia: i guerrieri dei carri hittiti ed egei sono infatti
30 A.R. Schulman, (1963) p. 86 31 Di Ramses II, in una delle tante descrizioni della battaglia di Qadesh, è detto che “Started forth quickly and
entered at a gallop into the midst of the battle for the sixth time of entering in amongst them”. Gardiner,
Kadesh,pp.215-225 32 M. Liverani, (1991) p. 456 33 R. Drews, (1993) p.106 34 A.R. Schulman, (1963) p. 86, Y.Yadin, (1963) p.4, Darnell-Manassa (2007) p.64 35 R. Drews, (1993) p.121 36 A.R. Schulman, (1963) p. 85 37 R.Drews (1993) p.120
46
raramente armati di archi, ma molto spesso forniti di giavellotti e lance38. È stato affermato
che una tattica militare potesse essere quella di puntare decisamente contro un carro
nemico per tentare di trapassarne il guidatore con l’asta. Vi sono varie ragioni che portano
a non accettare l’ipotesi: in primo luogo, sarebbe stato impossibile, nel pianale di un carro
in movimento, avere la propulsione o l’agilità necessaria ad utilizzare efficacemente
l’arma, ed in secondo luogo il fatto che la distanza alla quale una lancia –la cui
propulsione, si ricordi, è legata alla mera capacità muscolare- sarebbe stata in grado di
colpire un nemico, sarebbe stata di gran lunga inferiore rispetto a quella di un arco
composito, lasciando quindi quasi indifeso l’uomo armato di lancia39. Si deve quindi
ritenere che queste armi fossero usate non nello scontro attivo, ma per finire gli avversari
caduti dai carri, che è probabile portassero delle lame corte come difesa personale40.. Si
noti poi come, i documenti di Ugarit associno alla guerra fra carri –oltre agli elementi già
nominati- anche la fionda, la mazza, lo scudo, e l’oscuro mdrm, forse un tipo di arco41, e
che nei rilievi egiziani sia alquanto comune che tanto gli arcieri quanto i carristi vestano
una sorta di tunica composta da fasce orizzontali blu, gialle e rosse. Si tratta probabilmente
di un’armatura in cuoio che i testi chiamano “sariam”(un nome che è attestato, con poche
variazioni, in diverse lingue42).
Una leggenda che si raccontava ad Ugarit inseriva un carro fra le cose più preziose che un
uomo potesse desiderare43, ed in effetti i costi legati ai reparti di Carreria dovevano essere
importanti: nella Bibbia, Salomone (regnante nel IX secolo) è detto aver pagato 600 sicli
d’argento per un carro e 300 sicli per una coppia di cavalli44. Elevato doveva poi essere
anche il costo degli archi compositi -armi molto efficaci ma dalla manifattura lunga e
difficile45- e quello delle protezioni per i carristi e per i loro animali46. Ma queste spese
erano comunque il minimo, dato che il maggiore costo che le casse statali dovevano
affrontare era –con ogni probabilità- quello legato all’addestramento ed al mantenimento di
uomini e cavalli47. Soprattutto il nutrimento e l’addestramento di questi ultimi dovevano
essere alquanto costosi, richiedendo anche infrastrutture particolari: nelle stalle regali di
38 M.A. Littauer (1972) p.147, R. Drews (1993) p.114 39 R.Drews (1993) p.114 e ss. 40 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 105 41 A.F. Rainey, (1965) p.23 42 R.H. Beal (1992) p.151 43 A.F. Rainey, (1965) p.19 44 Re I, 10.29. Per operare un raffronto, si consideri che in Esodo 21.32 uno schiavo è detto valerne 30. 45 Cambridge (2008), p.497 46 R.Drews (1993) p.110 47 M. Liverani (1991) p. 457
47
Ugarit, infatti, è stata trovata una sala pavimentata lunga trenta metri, che con ogni
probabilità serviva all’addestramento dei cavalli da battaglia48. Doveva essere necessario
che gli animali, non fossero addestrati unicamente per la velocità, ma anche per essere in
grado di esprimerla dopo viaggi lunghi a volte centinaia di chilometri49.
In tutti i paesi e le regioni del Vicino Oriente, l’introduzione delle nuove tecniche di
guerra portò alla specializzazione degli eserciti: le milizie nazionali stipendiavano armate
di uomini in grado di compiere questi necessari e richiestissimi servizi, accordando loro
status e privilegi particolari. I carristi divennero i corpi speciali d’élite al servizio del re e
della sua famiglia, mentre dal canto suo la corona li muniva di mezzi economici sotto
forma delle rendite di campi coltivati50. Questa modalità di mantenimento dei Maryannu–
condivisa, con ogni probabilità, da tutte le economie del tempo- è testimoniata anche dalla
lettera che Iturlim, signore di alcune terre confinanti con Ugarit, mandò al re siriano per
lamentarsi del fatto che i suoi guerrieri, seminando, avessero sconfinato nel suo territorio51.
I combattenti su carro egiziani erano invece spesso uomini appartenenti alle più alte classi
sociali, spesso veri e propri principi del sangue52. Infine si noti come il fatto che l’acquisto
dei carri e dei cavalli, il mantenimento degli animali e dei carristi, l’addestramento e la
costruzione degli spazi ad esso necessari fossero un costo alquanto gravoso potrebbe
smentire la ricostruzione “omerica” dell’Iliade, dove i carri sono usati solo per condurre un
guerriero da una parte all’altra del campo di battaglia. Non avrebbe avuto senso, infatti,
sostenere un tale sforzo economico per con un così limitato beneficio.
II.3 La fanteria
Mentre sappiamo molto dei carri e dei loro guerrieri - la quantità di risorse investite faceva
infatti sì che i palazzi tenessero attenta contabilità su di loro, sul loro mantenimento, sui
loro carri - sappiamo molto poco riguardo la fanteria. Alcuni studiosi hanno ritenuto, sulla
base delle evidenze testuali, che il ruolo della fanteria nella guerra del Tardo Bronzo fosse
“subordinato”53, di second’ordine54, o che addirittura spesso non avesse alcun uso55 (anche
se è vero che potesse giocare un ruolo importante la speranza che la grandezza del proprio
48 Cambridge (2008), p.493 49 T.Bryce (2002) p.112, M. Liverani (1991) p. 458 50 Cambridge (2008), p. 495 51 PRU, IV, 220 in A.F. Rainey, (1965) p.20 52 Darnell-Manassa (2007) p.64 53 Gurney, the Hittites (1961) in R. Drews (1993) p.138 54 R.H. Beal (1992) p.151 55 R. Drews (1993) p.138
48
esercito inducesse il nemico a cercare la pace senza combattere56). Questa nozione
contrasterebbe però con un fatto essenziale: il costo da pagare per l’allontanamento dai
campi di una gran massa di abitanti per un periodo che andava dalla primavera all’autunno
inoltrato, ovvero quello in cui la necessità di forza-lavoro per i lavori agricoli era più alta.
Nel suo “The end of the Bronze Age “ Robert Drews riserva alla fanteria alcuni compiti
fondamentali: l’inseguimento dei nemici su terreni dove i carri non potevano andare; la
difesa notturna degli accampamenti militari; l’assedio57. Ma se si pensa che nell’esercito
hittita il 90% degli effettivi era composto da fanti (per la precisione lancieri)58, e che gli
altri eserciti non erano poi molto diversi; se si considera che in ogni altro periodo della
storia la fanteria era al centro della battaglia; se si ricorda che i carri non potevano essere
usati lontano dalle grandi pianure59, nei terreni in salita e negli assedi60, allora ci si rende
conto che, anche se oggettivamente “subordinata”(in tutti i palazzi i guerrieri del carro
sono chiamati per nome, mentre i fanti, il cui sostentamento comportava costi minori, sono
semplicemente numerati61), in alcun modo la fanteria del tardo bronzo potrebbe essere
detta inutile. Considerati tutti questi fattori, appare allora possibile ritenere che il primo
scontro di una battaglia fosse quello fra i guerrieri sul carro, e che la fanteria sarebbe
avanzata alle loro spalle per cercar di sfruttare una possibile apertura nei ranghi nemici, in
maniera tale da dividere lo schieramento o, nel caso peggiore, per contenere l’avanzata
avversaria qualora le cose fossero andate male62.
In una tomba trovata a Saqqara, in Egitto, risalente al periodo amarniano, si trovano alcune
raffigurazioni dell’addestramento di un gruppo di carristi affiancato a degli uomini
appiedati ed armati alla leggera63. Schumann li definisce, molto semplicemente, “running
soldier”, “corridori”, traducendo alla lettera la parola egiziana pḥrr. Non esiste modo di
equivocare il significato del termine: la parola è solitamente scritta con il determinativo di
uomo che corre (a volte l’uomo del determinativo è perfino armato di scudo e giavellotto)64
e si traslittera esattamente alla stessa maniera del verbo che significa “correre”65. I testi
sono molto chiari nel farli partecipare alle battaglie, dove è probabile che le loro funzioni
56 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 111 57 R. Drews (1993) p.141 58 T.Bryce (2002) p.111 59 R. Drews (1993) p.140 60 A.R. Schulman (1964) p.86 61 R. Drews (1993) p.112 62 R.O.Faulkner (1953) p. 43, M. Liverani (1991) pp. 452-456 e (1994) p.152 63 A.R.Schuman (1964) p. 58 64 Gardiner (Grammar) in A.R.Schuman (1963) p.89 65 J.C. Darnell, in R. Drews (1993) p.143
49
fossero quelle di proteggere i cavalli, correndo accanto ai carri per contrastare i corridori e
gli skirmisher66 nemici67; finire i carristi caduti; occupare qualsiasi zona del terreno
inarrivabile ai carri; fermare con la loro presenza la carica dei maryannu avversari,
intrappolandoli fra loro e gli aurighi alleati; rinfoltire le file dell’esercito durante un
attacco68. Nella battaglia di Qadesh, i corridori sono attestati anche fra gli hittiti, dando
così conto della presenza del “terzo uomo” dei loro carri, che potrebbe facilmente essere il
corrispettivo Hittita del pḥrr69. Mentre non sembra vi sia nulla di simile al “corridore”
egiziano nei testi di Ugarit70, nei documenti ritrovati a Nuzi, un centro secondario nel
regno di Mitanni del XIV secolo, si parla degli aḥu, una parola che –benchè significhi
anche “fratello”- pare esser stata data a un certo tipo di guerriero, con ogni probabilità un
fante affiancato alla carreria, così come il piran huyatalla hittita71 (che però dovrebbe
significare qualcosa come “corridore a fronte” ed indicare quindi un “leader” della fanteria,
una sorta di sergente, più che un corridore72).
II.3.1 Le più comuni armi della fanteria
Nel corso del tardo bronzo, la fanteria dei vari eserciti arrivò ad utilizzare un grande
numero di armi diverse, che potevano essere sia capaci di colpire a lunga distanza, come il
giavellotto e l’arco, sia a corto raggio, usate essenzialmente per il combattimento corpo a
corpo. Quasi sempre le armi erano prodotte nei laboratori statali, o comunque su richiesta
del governo73.
L’arco era di gran lunga l’arma più diffusa, soprattutto nelle fila dell’esercito egiziano,
tanto che l’ideogramma di mš’, che significa essenzialmente “corpo armato” (nel senso di
esercito) rappresenta un arciere74. Aldilà dell’importanza dell’arco composito –oggetto
troppo costoso e dalla produzione troppo elaborata per poter essere un arma a grande
diffusione ed impugnata dalla fanteria - alcune raffigurazioni mostrano come armi più
semplici fossero diffuse fra i soldati che non facevano parte della Carreria: in un
bassorilievo del tempio di Luxor è possibile vedere come a soldati di diversa etnia
66 In assenza di un termine italiano che traduca con precisione quello inglese di “Skirmisher” (da “skirmish”,
schermaglia) si è usato quello proposto da R.Drews. 67 J.C. Darnell-C. Manassa (2007) p.64 68 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.56 69 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.65 70 R. Drews (1993) p.142. L’argomento sarà approfondito nel prossimo capitolo. 71 R. Drews (1993) p.146 72 R.H. Beal (1992) p.202 73 R.H. Beal (1992) p.139 74 S. Curto in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2002) p.30
50
corrispondesse un diverso tipo di arco75. Alcune di queste armi –per l’esattezza quattordici-
sono state trovate nella tomba di Thutankamon, ed hanno fornito agli studiosi qualche
informazione in più: i quattordici pezzi misurano dai 65 ai 200 centimetri (anche se dodici
di questi misurano fra i 120 e i 180 cm)76, e la loro diversa lunghezza doveva dipendere
dalle diverse necessità del soldato: i più lunghi –spesso più alti degli arcieri stessi- non
potevano essere usati per ovvie ragioni da soldati di movimento, e dovevano quindi essere
utilizzati dalle retrovie della battaglia con l’intento di fermare i nemici prima che
arrivassero allo scontro con la fanteria di mischia. È probabile che una gran quantità di
dardi, scagliati in contemporanea, avrebbe posto fine alla battaglia contro un nemico privo
di protezioni, e che invece contro uomini armati di scudo avrebbe rallentato e sfoltito le fila
nemiche, supportando così l’avanzamento degli skirmisher(questa fu, grosso modo, la
tattica che fu utilizzata dall’esercito di Ramses III contro i libici)77; Gli archi più corti -che
nel bassorilievo di Luxor sono in mano ai mercenari libici- potevano facilmente essere
utilizzati in corsa ed in manovre rapide, ed erano perfetti per combattimenti a medio e
corto raggio78.
Il giavellotto aveva dimensioni ed aspetto –corpo in legno e testa in metallo- di una grande
freccia, si teneva in mano e serviva come arma a medio raggio79. Sviluppatosi soprattutto
come arma per l’attività venatoria80, si pensa che fosse l’arma perfetta per “cacciare” un
altro tipo di animali, alquanto comune sui campi di battaglia: i cavalli dei maryannu. Era
un’arma leggera, molto diffusa fra i pḥrr, i quali potevano scagliarli direttamente in corsa e
portarne diversi con sé, ed era anche un’arma che serviva allo scopo: un giavellotto andato
a segno, anche se non avesse ucciso il cavallo (ed abbiamo visto come fossero animali di
grande valore e non è quindi difficile che li si preferisse vivi) lo avrebbe comunque
fermato, arrestando così la corsa del carro e permettendo ai corridori di attaccarne i
passeggeri. Le punte che sono state trovate ad Ugarit, sul luogo di una battaglia, sono
lunghe fino ai 9 cm, e, poiché non sono dentellate, è possibile sostenere l’ipotesi che siano
punte di giavellotto e non di freccia. La dentellatura era infatti una caratteristica molto utile
in una freccia: una volta conficcata nella carne, rendeva quasi impossibile estrarre la
75 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.72, figura 9 76 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.71 77 N. Stillman - N. Tallis (1984) p.54 78 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.73 79 Y. Yadin, (1963) p.10 80 È stata espressa a riguardo l’idea che la sua utilità fosse di tipo magico, perché in quanto arma nata per la
caccia agli uccelli, il suo uso contro i nemici avrebbe “magicamente attribuito loro le proprietà degli
uccellini” J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.74
51
freccia senza lacerare i tessuti, con conseguente copiosa perdita di sangue e, con essa, la
morte del ferito. Diversamente, le teste di giavellotto ritrovate ad Ugarit non erano
dentellate, con tutta probabilità perché fosse possibile estrarle dal corpo del nemico ucciso
e riutilizzarle nella concitazione della battaglia81. A sostegno di questa ipotesi, si pensi che
in diversi scavi sono venute alla luce delle punte di giavellotto in cui era stato inscritto il
nome del proprietario82: mentre non ci sarebbe necessità di incidere il nome sulle punte di
freccia –sarebbero troppe- un probabile numero di giavellotti sarebbe stato alquanto più
limitato. Non è poi difficile che esistessero delle specie di “grosse faretre” dove era
possibile portare i giavellotti necessari alla battaglia83,
Molto più variegate erano invece le armi che potevano essere utilizzate per i combattimenti
a corto raggio. L’arma tecnologicamente più semplice per il corpo a corpo, e per quello
quasi scomparsa dai campi di battaglia dell’epoca, era la mazza. Il suo utilizzo non doveva
essere molto diverso da quello della clava preistorica: colpire e distruggere. È probabile
che, data la sua scarsa adattabilità, la sua utilità quale strumento di guerra fosse già
diminuita nel momento in cui si diffuse fra gli eserciti l’utilizzo dell’elmo84. Alcuni
studiosi, probabilmente basando le loro impressioni sui molti ritratti di sovrani egiziani che
eliminano un nemico colpendolo alla testa con una mazza (una sorta di topos dell’arte
egiziana) 85, hanno ritenuto che la mazza servisse solo come arma per porre fine alle
sofferenze di un nemico già abbattuto86.
In termini di diffusione, l’arma più comune nel tardo bronzo per il corpo a corpo era però
l’ascia. Sono disponibili agli studiosi un gran numero di queste armi -oltre che una gran
quantità di rappresentazioni, come quelle dei fanti di Ramses II a Karnak87- che aiutano a
capirne l’utilizzo: così come la mazza, consisteva in un manico di legno relativamente
corto al termine del quale veniva fissata la parte contundente, in pietra o in bronzo, ma,
contrariamente alla stessa, l’ascia era un’arma da taglio e da stoccata. La scelta fra i due
aspetti possibili era direttamente determinata dal tipo di protezione del nemico: l’ascia
tagliente era efficace contro chi era privo di protezioni, mentre in presenza di una qualche
forma di armatura in cuoio o metallo, si rendeva necessaria un’arma in grado di trapassarne
81 R. Drews (1993) p. 189 82 R. Drews (1993) p. 189 83 Y. Yadin, (1963) p.10 84 Y. Yadin, (1963) p.11 85Si veda a titolo di esempio la raffigurazione di Narmer nel periodo protodinastico in N. Grimal (1988) p. 48 86 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.74 87 Y. Yadin, (1963) pp.77-78
52
la protezione88. Durante il periodo preso in esame, basandosi sulla forma stretta e lunga, si
può presumere che l’ascia fosse studiata per penetrare le difese, fossero esse quelle di uno
scudo o di un’armatura avversaria89. Il limite più grande legato a quest’arma era che, per
poter essere utilizzata propriamente, era necessario che il soldato utilizzasse un ampio
movimento a campana, calando un colpo secco dall’alto verso il basso: questo avrebbe
inevitabilmente esposto il soldato a grande rischio, dato che nel momento prima di colpire,
il fante sarebbe stato vulnerabile, soprattutto sul fianco del braccio alzato, quello destro90.
La diffusione dei carri da guerra e quella degli archi, causando la contestuale evoluzione e
maggiore diffusione di scudi e delle protezioni per il corpo nei campi da battaglia. Questo
rese l’ascia quasi superflua, portando alla diffusione, nel periodo del tardo bronzo, del
Kepesh91, un’arma che all’osservatore moderno potrebbe ricordare una sorta di falcetto
oblungo. Ve ne erano due tipi principali, il cui funzionamento era, in entrambi i casi, molto
simile a quello di una lunga ascia. Il kepesh più grande, più spesso ma meno affilato,
doveva essere utilizzato per aprire i ranghi o indebolire le protezioni dei nemici, quasi
fosse, più che una lama, una clava92, mentre i kepesh più piccoli, molto più affilati,
sarebbero stati utilizzati più come arma da taglio che non, ovviamente, da stoccata93.
Anche se non in ambito militare, spade a forma di falce sono documentate anche nel
mondo hittita, raffigurate come portate in spalla da dodici divinità della camera B di
Yazilikaya94.
La lancia, infine, era una sorta di grande giavellotto che non veniva lanciato. Era un’arma
da stoccata, in grado di trapassare i nemici a distanza95, e spesso efficace contro i cavalli96.
L’armamento delle truppe hittite –pur se mai menzionato esplicitamente nei testi di
Hattusa- viene descritto spesso in ambiti mitici, dove la lancia è una delle armi più
frequentemente citate, a volte anche nel contesto delle battaglie97 ed i rilievi egiziani,
mostrando la fanteria hittita armata di scudi e lance, sostengono l’idea che fosse l’arma più
rilevante nell’armamentario indeuropeo98 (il che fa pensare ad un’organizzazione militare
88 Y. Yadin, (1963) pp 12 89 I. Shaw (1991) p.37 90 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.75 91 Y. Yadin, (1963) p.10 92 J.C. Darnell – C. Manassa (2007) p.76 93 ibidem 94 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 106 95 I. Shaw, (1991) p.37 96 Y.Yadin, (1963) p.10 97 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 104 98 R.H. Beal, (1992) p. 200
53
di tipo avanzato, come quella che si sarebbe poi affermata nella guerra dell’età del ferro,
quando la lancia si sarebbe diffusa come arma perfetta per le formazioni strette (difficile
ferire il tuo vicino se la lama si trova a due metri da te)99). Si pensa anche che fosse l’arma
da taglio perfetta per i carristi, per provare a colpire dai carri i pḥrr nemici100.
Un’altra componente dell’armamentario dei vari eserciti del Tardo Bronzo è lo scudo.
Questo svolge, e svolgeva, una funzione di barriera fra il soldato e l’arma del nemico, di
opposizione attiva ai suoi attacchi, che integrava e in un certo senso si contrapponeva a
quella passiva fornita dalle protezioni per il corpo. Nella storiografia militare, quello dello
scudo è un elemento tanto essenziale quanto complesso perché non poteva esistere
l’oggetto perfetto, utile per qualsiasi evenienza: uno scudo abbastanza grande da coprire il
corpo, sarebbe stato troppo pesante per rendere possibile al portatore una buona velocità di
movimento, mentre al contrario una protezione abbastanza piccola da far sì che il soldato
potesse muoversi non avrebbe potuto garantire la sicurezza all’operatore. In caso di assalti
rapidi, i reparti di fanteria potevano anche legare gli scudi alle proprie spalle, per poter
avere entrambe le mani libere per il combattimento; ma in presenza di arcieri nemici
sarebbe stato necessario unire gli scudi per coprire la fanteria101.
La maggior parte degli scudi del tardo bronzo era fatta di legno o cuoio, e in alcuni casi i
bordi erano coperti di metallo102. Vi erano svariati generi di scudi in circolazione all’epoca:
lo scudo egiziano aveva i bordi squadrati – forse per poter facilmente combattere in
formazioni chiuse - era arrotondato in cima – per proteggere la testa- e leggermente più
stretto alla base103. Lo scudo in uso presso la Siria e la Palestina potrebbe essere stato
quello che veniva usato precedentemente dai sumeri, tanto largo e pesante (forse in legno)
da poter coprire un uomo completamente104. Alcuni rilievi egiziani fanno pensare però che
fosse in circolazione anche uno scudo più piccolo e convesso105. Gli scudi caananiti sono-
nelle rappresentazioni di Ramses II sulla battaglia di Qadesh- oblunghi. Lo scudo Hittita,
infine, era abbastanza diverso dagli altri: il più diffuso pare essere stato quello a forma di 8
con le estremità arrotondate e i bordi ridotti, seguiva le linee del corpo umano,
probabilmente con l’intento di usare le aperture per colpire con armi da taglio106, ma in
99 R. Drews, (1993) p. 192 100R. Drews, (1993) p. 192 101 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.55 102 Y. Yadin, (1963) p. 83 103 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.99 104 Y. Yadin, (1963) p. 48 105 Y. Yadin, (1963) p. 84 106 Ibidem, R. Drews (1993) p. 178,
54
alcuni rilievi di Sethi I e Ramses II gli scudi dei carristi sono rettangolari, dalla forma
simile a quella degli scudi egiziani, e si pensa avessero uno spessore di circa trenta
centimetri e fossero larghi quarantacinque107.
Così come lo scudo anche le protezioni per il corpo potevano essere d’intralcio ai
combattenti: una cotta di maglia avrebbe lasciato le mani libere per combattere, ma
avrebbe anche limitato i movimenti di chi la indossava. Già si è parlato della sariam, la
cotta di maglia in cuoio che riusciva a proteggere dalle frecce nemiche. Lunga a volte fino
alle caviglie, limitava i movimenti di chi la indossava, e per questo motivo era diffusa
soprattutto fra i maryannu, che ottenevano così una gran protezione senza pagarne il
prezzo108. Sembra inoltre che fosse diffusa, in una versione più economica e meno
limitante, anche fra alcuni fanti, ma in linea di massima si utilizzavano dei corsaletti
composti da strisce di cuoio e piastre metalliche109, la cui utilità doveva essere notevole: è
stato infatti osservato dall’archeologo sperimentale B.Molloy come un corsaletto o una
sariam difficilmente sarebbero stati superati da un colpo dato col taglio di una spada, e che
solo una stoccata avrebbe potuto penetrare la protezione110
II.3.2 La Spada
La spada era un’arma che, benché conosciuta, prima del XIV secolo non aveva avuto molta
fortuna nel mondo levantino. Produrla doveva essere alquanto difficile, perché una spada,
data la sua lunghezza, in assenza di metalli straordinariamente duri è un’arma alquanto
debole, condannata alla rottura non appena messa alla prova111. Secondo D.H. Gordon una
spada spessa almeno 26 cm è probabile che sia stata pensata per tagliare, dato che questo
spessore garantirebbe una maggiore resistenza, evitando piegature al momento del
colpo112. In assenza di sensibili quantità di metalli duri, e della capacità di realizzare
oggetti con queste caratteristiche113, la spada era condannata ad essere un’arma di nicchia,
poco diffusa.
107 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 102 108 R. Drews (1993) p. 175, N. Stillman- N. Tallis (1984) p.97 109 Ibidem 110 B.Molloy (2010), p.419 111 Y. Yadin, (1963) pp10, R.Drews (1993) p.194 112 D.H. Gordon (1953) p.71 113“Our experimental work has shown that casting very long, thin artifacts such as these requires a
complexity in moldmaking and pyrotechnology that was not needed for daggers” B.Molloy (2010) p. 414
55
Il modello della spada proviene da quello della daga, un’arma corta -e per questa ragione
robusta- tagliente da ambo i lati114. Nonostante questa discendenza, i loro utilizzi
differiscono enormemente115: mentre la daga può avere usi di tipo non militare (ed in
campo guerresco è un’arma di seconda scelta, necessaria nel combattimento di mischia per
colpire braccia e gambe, ma come si farebbe con un pugno116), la spada nasce e si sviluppa
come arma da guerra, pensata in primo luogo per il combattimento del singolo nella
mischia di una battaglia117. Appare difficile che il concetto alla base della spada fosse
quello di cercare un’arma da stoccata che potesse raggiungere un nemico più lontano:
questo infatti era già stato ottenuto con l’invenzione della lancia. E quindi pare per
esclusione evidente che il concetto alla base dell’invenzione della spada sia stato quello di
un’arma lunga da taglio che potesse essere usata in battaglia, invece che con nemici oramai
inermi.
Per avere un’idea dell’importanza di quest’oggetto e al tempo stesso della sua irrilevanza
numerica nel mondo del mediterraneo orientale prima della catastrofe, si pensi al fatto che
nella lista del bottino ottenuto dall’Egitto di Merneptah contro i libici, le spade sono la
prima e più importante voce118. Comunque sia, nel XIV secolo, la spada cominciò a
diffondersi nel mondo levantino. La lunga vita che questo tipo di arma aveva avuto –ed
avrebbe continuato ad avere- nell’Europa occidentale ha fatto presumere, pur con una
debole argomentazione post hoc ergo propter hoc, che le zone di origine dell’arma siano
l’Europa continentale e i Balcani119. È probabile che la sua diffusione nel mondo palaziale
sia stata dovuta all’impiego di mercenari barbari provenienti dai Balcani presso le corti
micenee. Questi, portando con sé le proprie armi, le avrebbero diffuse nel mondo
Egeo120prima, e in quello orientale successivamente. Il fatto che i Meshwesh, pur essendo
un popolo dalle caratteristiche nomadiche ed arretrate, si fossero procurati tante armi
(quasi una per guerriero, dato che Merneptah dice di aver preso 9111 spade, e di aver
ucciso 9376 libu121), ha fatto pensare che fossero state acquistate, con ogni probabilità, dai
popoli del mare122, giacché un popolo con le caratteristiche nomadiche ed arretrate come
quello libico non avrebbe infatti avuto le risorse, materiali e tecnologiche, per produrle da
114 B.Molloy (2010), p.413, D.H. Gordon (1953) p.68 115 B.Molloy (2009) p.413 116 Ibidem 117 B.Molloy (2009) p.424 118 Wainwright (1962) pp. 94-95 119 N.K.Sandars (1985) pp.92, R.Drews (1993) 195 120 N.K.Sandars (1985) pp.93-94 121 G.A.Wainwright, (1962) p.95 122 G.A.Wainwright, (1962) p.94
56
solo, men che meno in un numero tanto elevato123. A supporto di questa ipotesi sta il fatto
che armi simili, che sono dette venire con i tributi dal paese di Keftiu-Caphtor, sono state
ritrovate, in Egitto, nella tomba di Rekhmire, vissuto sotto il regno di Amenhotep II124.
Anche lo scarso numero di spade ritrovate dagli archeologi ha fatto pensare che i
ritrovamenti riflettano l’uso del tempo, ovvero che sia stato trovato un numero ridotto di
armi perché poche erano le spade usate. Benché le lame lunghe non sembrano aver
incontrato il favore degli hittiti125, uno dei migliori esemplari di spada che sono stati trovati
è quello, in giacitura secondaria, rinvenuto a Boghazkoy nel 1991. L’arma, databile al
1400 a.C. circa126, è identificata dall’iscrizione sulla lama come bottino di guerra (cosa
confermata anche dal fatto che il manico sia stato piegato per renderla inutilizzabile)127 è
ritenuta essere di origine Egea, cosa che rafforzerebbe ancora la teoria della provenienza
non levantina dell’utilizzo in massa della spada.
II.4 Le caratteristiche degli Shardana.
II.4.1 Introduzione
La citazione più antica di mercenari Shardana si trova nelle lettere degli archivi di El-
Amarna, dove il re di Biblo, Rib-Adda, scrive al faraone: “Un uomo con una spada di
bronzo(…) è sorto contro di me, e lo šerdanu che (mi stava) a fianco è scappato presso
Abdi-Ashirta”128, e ancora “Pahuru ha commesso un’azione grave contro di me: ha
mandato dei Sutei che hanno ucciso uno šerdanu e hanno portato tre persone in Egitto”129.
Che il testo ricorra al termine šerdanu senza spiegare a chi o cosa lo riferisca fa pensare
che identifichi un tipo umano già conosciuto, e infatti all’epoca il problema degli attacchi
dei pirati Shardana era già antico, essendosi mostrato per la prima volta durante il regno di
Amenothep III 130. La prima volta che vengono nominati in Egitto, i pirati Shardana stanno
attaccando il paese del Nilo:
Šrdn bštw ḥˁt iw.bw rḫ.tw ˁḥ3.w dr nḥḥ iw.sn sḫm-ib.sn sḳd.n.sn m ˁḥˁw m
ḥr-ib p3y ymIw.bw rḫtw ˁHˁ r-ḥˁt.sn ḥˁḳ.n.f sn m nḫtw n ḫpš.f ḳh inw r Kmt
123 Ibidem, p.93 124 R. Maxwell-Hyslop (1946) p.59. Si ricordi come, secondo G.A. Wainwright (1959) p.76 Keftiu, che lui
identifica con la Cilicia, sarebbe la terra d’origine dei Peleset, i quali portano questo genere di arma nelle
immagini egiziane della Catastrofe. 125 R.H. Beal in F. Pecchioli- M.C. Guidotti(2005) p. 103 126 M. Salvini- L.Vagnetti (1992) p. 236 127M. Salvini- L.Vagnetti (1992) p. 235 128 EA 81, in Liverani (1998) p. 177 129 EA 122, in Liverani (1998) p.216 130 Cambridge (2008) p.226
57
Gli Shardana ribelli di cuore, che nessuno aveva saputo combattere fin da
sempre, essi vennero prepotenti navigando sulle loro navi da guerra dal
mezzo del mare e nessuno poteva opporsi a loro. Ma egli li catturò con la
forza del suo valido braccio e li portò in Egitto. 131
Dai tempi di Narmer in poi, qualsiasi nemico che avesse fisicamente mostrato di essere una
minaccia per l’Egitto era stato sconfitto ed ucciso. Tutti i regnanti, perfino quelli percepiti
come “pacifici” come Akhenaten132, perfino le regine, si erano fatti raffigurare nell’atto di
spaccare con una mazza la testa del nemico. Il Faraone sconfiggeva gli aggressori affinché
gli egiziani potessero “dormire tranquilli”133. Per qualche motivo, gli Shardana non
seguono questo destino, e la loro cattura non prefigura nemmeno la schiavitù, ma
l’arruolamento. Il perché può suggerirlo un episodio di 150 anni prima, all’incirca il 1436
a.C. quando Thutmosis III, dopo l’assedio della città di Arvad, avendo catturato un gran
numero di maryannu, invece che ucciderli e sprecare le loro rarissime abilità militari aveva
considerato più intelligente arruolarli nel proprio esercito134. Appare evidente che, come
Thutmosis prima di lui, Ramses II abbia notato qualcosa in questi fanti, qualcosa che li
avrebbe resi più utili da vivi che da morti: gli Shardana sarebbero stati un’anomalia,
portatori di un qualcosa che sarebbe potuto essere impiegato a vantaggio dell’Egitto.
Questo qualcosa, già si è detto, è stato visto in quel bštw, che Cavillier traduce anche come
“turbolenti”, indentificando quindi in questa “turbolenza” e dinamicità la loro caratteristica
peculiare: le loro particolari tecniche guerresche sarebbero state diverse, per non dire
opposte, rispetto al modo normale di fare la guerra. N.K. Sandars per prima attribuisce loro
la caratteristica di essere combattenti di mischia, riservando alle truppe di nativi egiziani
l’uso delle armi da lancio come l’arco135. Secondo R.Drews la fanteria autoctona esisteva,
ma mentre il resto dell’esercito egiziano –e di tutti gli eserciti del Levante- combatteva in
maniera sistematica e coordinata, in maniera da non esporsi troppo136, gli Shardana
sarebbero stati in grado di agire anche da soli, come “loose formation troops”137. La prima
testimonianza della particolarità dell’elemento Shardana negli eserciti del tardo bronzo –ed
in quello egiziano in particolare- è offerta dal loro stesso nome, o meglio, dai geroglifici
che lo compongono: la resa fonetica della parola “Shardana”, infatti, è alle volte
131 KRI II, 290.1-4 in G.Cavillier (2002) p.68 132 A.R. Schulman (1964) p.57 133 KRI II, 335.3 in G.Cavillier (2002) p.69 134 A.J.Spalinger (2005), p.110 135 N.K.Sandars (1985) p. 106 136 R.Drews, (1993) p.152 137 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.56
58
accompagnata da un determinativo “particolare”: un guerriero con un elmo fornito di
corna, solitamente fornito di un piccolo scudo rotondo e una spada o una lancia138. Un
determinativo di Shardana, che riprendeva una per una tutte quelle caratteristiche che è
possibile riconoscere nelle immagini a disposizione degli studiosi: un elmo cornuto, spesso
con un disco solare esattamente al centro di esso; un piccolo scudo, tondo, rinforzato da
spuntoni di acciaio; una spada lunga in maniera inusuale139. Presi uno per uno, questi
elementi rivelano molte, se non moltissime, informazioni su questi guerrieri.
II.4.2 La spada
La lunga spada “degli Shardana”140 che si può osservare –fra gli altri- nei rilievi di Abido
di Ramses II141 ha sempre attratto attenzione da parte degli archeologi. In realtà parlare di
“spada Shardana”, al singolare, è un errore: la spada Shardana non è una sola nel corso
della storia del tardo bronzo, perché quella, leggermente triangolare, che fu usata a Qadesh
venne col tempo sostituita da un modello diverso, evoluzione dell’arma precedente142.
Mentre la prima è di sicuro un’arma asiatica -le spade europee di questo periodo non
avevano una base tanto larga143- la seconda era di origine europea e si diffuse in Asia in un
secondo momento. L’esemplare di spada ritrovata a Boghazkoy, databile al 1400 a.C. e cui
si è già accennato, rappresenta il secondo tipo: è un’arma con un manico a codolo piatto, la
cui lama, assottigliata in prossimità della punta, presenta una robusta costolatura centrale,
che ben supportava una lunghezza di quasi ottanta centimetri144.
Verso la fine del periodo del bronzo si diffuse in tutto il mediterraneo orientale una spada
che poteva efficacemente tagliare e infilzare. Si trattava di un’arma alquanto lunga (dal
pomello alla punta circa 70 centimetri) i cui lati erano lunghi e paralleli, con una punta
affilata, ed in cui manico e lama erano solitamente ottenuti da un solo pezzo di metallo,
alquanto spesso per poter sostenere i colpi145. Ma questa non rappresentò comunque, come
si è pensato, una novità assoluta nel mondo delle lame: non fu la prima e non fu l’ultima ad
essere in grado di agire tanto di punta quanto di taglio. Non era nemmeno nulla più che una
138 R.Drews (1993) p. 152 139 N. Stillman- N. Tallis (1984) p. 106 140 È detta così nonostante non sia un’esclusiva degli Shardana, ma diffusa anche fra altri mercenari fra i
popoli del mare, come i Peleset. A.G. Wainwright (1962) p. 94 141 Tavola II 142 R. Maxwell-Hyslop (1946) p.57 143 R. Maxwell-Hyslop (1946) p.57 144M. Salvini-L.Vagnetti (1992) p. 216 145 R.Drews (1993) p.194
59
variante leggermente diversa di altre spade europee146. È vero che era tipicamente più
lunga delle altre spade contemporanee (10-20 cm circa147), ma non fu la sua lunghezza,
bensì la sua durezza ad causare la sua diffusione: un suo colpo ben assestato avrebbe
potuto tagliare un braccio umano148(difficilmente però uno spadaccino dell’epoca avrebbe
tentato un colpo simile, perché il rischio di esporsi ad un contrattacco nemico, o di rompere
la propria arma sarebbe stato elevato). È più probabile quindi che i colpi fossero dati in
rapida successione, indirizzati ai tessuti molli di gambe e braccia mentre l’attaccante si
muoveva verso il nemico, o lateralmente149. I primi colpi avrebbero potuto far sanguinare
l’avversario, ma non lo avrebbero fermato immediatamente, perché difficilmente sarebbero
stati abbastanza profondi da tagliare tendini o arterie. Usata poi di punta, una spada
avrebbe facilmente potuto perforare zone molli -come l’addome o la gola- con colpi che
sarebbero stati letali.
Nel contesto bellico dell’epoca spade dalla lama lunga come quella degli Shardana erano
alquanto rare. Pochi uomini le avrebbero utilizzate in battaglia, forse solo gli skirmisher e i
corridori150. È probabile che la ragione sia più che altro economica: anche se i regni del
Vicino Oriente Antico avessero avuto a disposizione il know-how necessario a produrle, la
quantità di materiale necessaria a fondere una spada, e soprattutto il lungo apprendistato
per imparare i movimenti necessari all’utilizzo ottimale dell’arma avrebbero reso la spada
troppo costosa. Imparare ad utilizzarla propriamente era un processo lungo, costoso, e che
sarebbe andato perduto qualora l’apprendista non fosse stato un soldato di professione. È
facile infatti ipotizzare che in quei paesi dove la coscrizione era in vigore –come l’Egitto,
dove un servitore del tempio su dieci poteva essere arruolato151- i soldati “di leva”
difficilmente sarebbero andati in guerra più volte. Un mercenario proveniente dal
mediterraneo occidentale invece, uso al mestiere delle armi, sarebbe stato un “prodotto
finito” perfettamente a suo agio con una tale arma a doppio taglio, con la quale, con ogni
probabilità, aveva dimestichezza dalla nascita.
II.4.3 Lo scudo
Gli scudi che si era soliti vedere sui campi di battaglia del tardo bronzo tendevano a coprire
l’intera figura per riparare il guerriero dalle frecce. Mentre, come si è visto, la maggioranza
146 B.Molloy (2009) p.420 147 B.Molloy (2009) p.421 148 B.Molloy (2009) p.422 149 B.Molloy (2009) p.416 150 R.Drews (1993) p.199 151 R.Drews (1993), p.149.
60
delle popolazioni del Vicino Oriente usavano protezioni troppo grandi perché i combattenti
godessero di appropriata mobilità, i mercenari Shardana portavano un piccolo scudo
rotondo, composto probabilmente da una struttura lignea di forma arrotondata ricoperta di
uno strato di cuoio e di borchie metalliche; lo strumento era tenuto assieme da un sostegno
centrale sul quale era ricavata l’impugnatura del fante152 (Questo fattore spingerebbe
ancora per una provenienza anatolica degli Shardana, dato che Erodoto sosteneva che
l’impugnatura centrale dello scudo fosse un’invenzione dei Carii153). Anche in questo caso,
si tratta di un oggetto che diventerà comune in Medio Oriente dopo il 1200, (nella battaglia
navale di Ramses III tutti gli invasori, dagli Shekelesh ai Tjekker, passando per i Peleset, lo
portano154) ma che nei precedenti 60-70 anni era stato –per quanto ne sappiamo-
appannaggio di questi guerrieri155.
Nel valutare la sua importanza, è necessario considerare che uno scudo non era un pezzo
dell’armatura, ma un pezzo dell’arma, e come tale parte integrante del modo di combattere
di chi lo portava. Era necessario adoperarlo in una determinata maniera per far sì che
servisse al suo scopo: Mentre infatti uno scudo di grandi dimensioni avrebbe offerto una
altrettanto grande copertura “statica”, soprattutto se combinato con altri scudi (la tattica
romana della testudo potrebbe essere portata ad esempio del concetto), la scarsa
maneggevolezza, unita al suo grande peso, avrebbe rallentato il soldato aumentando
l’esposizione ai colpi nemici156. Uno scudo di dimensioni e peso ridotti avrebbe permesso
al contrario una grande agilità e maneggevolezza, necessitando però allo stesso tempo di
un utilizzo “attivo”. Uno scudo infatti –e principalmente uno scudo di ridotte dimensioni-
non avrebbe potuto realmente fermare un attacco, soprattutto se usato come impedimento
statico di fronte a un colpo avversario. Con molte probabilità, invece, utilizzando lo scudo
come una vera e propria arma d’attacco, ovvero cercando il contatto con la lama nemica in
maniera tale da ricevere i colpi obliquamente, la forza del colpo sarebbe stata distribuita su
una superficie più ampia157.
Ovviamente l’utilizzo di scudi piccoli, rendendo necessario l’utilizzo di particolari tecniche
di lotta e coordinamento con l’arma offensiva per poter efficacemente coprire la figura a
180°, richiedeva anni di esercizio158. Le caratteristiche dello scudo, quindi, suggeriscono
un comportamento in battaglia che non solo non contraddice quello suggerito dalla spada,
152 N. Stillman- N. Tallis (1984) p. 106, Cavillier (2005) p.41 153 G.A. Wainwright (1959) p.75 154 Tavola II 155 R.Drews (1993) p.179 156 Y. Yadin (1963) p.13 157 B.Molloy (2009) p.1057 158 Ibidem
61
ma anzi lo completa. Infine, le dimensioni dello scudo erano al tempo stesso la più grande
forza e la più grande debolezza di chi lo portava: non coprendo l’intero soldato, lo scudo lo
rendeva particolarmente vulnerabile alle frecce, costringendolo così a movimenti rapidi e
repentini nel tentativo di evitare i dardi.
II.4.4 Le protezioni per il corpo
Prima della crisi del 1200, le tute protettive erano state disegnate appositamente per i
membri dei reparti di carreria: come si è detto, una tunica di cuoio, chiamata sariam,
copriva chi la portava fino alla caviglia, ma rendeva difficili i movimenti. Ma mentre
questo non doveva essere un problema particolare per chi si muoveva a bordo di un carro,
per i fanti sarebbe stato fatale. Con ogni probabilità per questo motivo gli Shardana sono
mostrati sempre senza protezione alcuna per il corpo, a parte nei rilievi di Abu Simbel,
quando, durante il regno di Ramses II, sono mostrati indossare –come le altre guardie del
faraone- una apparentemente rigida protezione che copriva il petto e la spalla destra, quella
della spada, assieme ad una sorta di cintura, forse a coprire la zona lombare159. È però
possibile notare che, nei rilievi della battaglia navale di Medinet Habu, tanto i Peleset e gli
Shekelesh, quanto gli Egiziani, portano un corsaletto ricoperto di scaglie metalliche160.
II.4.4 L’elmo
L’elmo è, fra tutti, l’elemento più distintivo degli Shardana (anche se in alcuni casi è usato
anche dagli Shekelesh161): è presente in tutte le raffigurazioni e rende immediatamente
identificabile questo guerriero. Si tratta di un elmo a calotta, provvisto di corna, con al
centro una protuberanza che regge un disco162. In alcuni casi, è possibile individuare dei
paraguance in cuoio, ed alcune volte sembrano essere stati lavorati in maniera tale da
proteggere anche il collo163. Non è impossibile, poi, che una tale fattura per l’elmo avesse
come scopo l’incutere terrore nel nemico164. Molte discussioni sulla provenienza degli
Shardana si sono basate su quest’elmo cornuto: una statuetta rinvenuta ad Enkomi, a Cipro,
mostra un guerriero con questo tipo di elmo e lo scudo tondo165. Molti sono stati poi i
richiami alla cultura protonuragica, dato che non pochi “bronzetti” nuragici mostrano
159 N. Stillman- N. Tallis (1984) p.106, 160 R.Drews (1993) p.175, G.A. Wainwright (1959) p.80 161 D. O’Connor, in Oren (2000) p.85 162 Tavola III 163 N.K. Sandars (1985) p.106 164 M.P. Speidel (2002) p.286 165Cambridge (2008) p.376
62
guerrieri con spada lunga, scudo tondo, elmo cornuto166. Ma fino a questo momento non
sono state portate prove convincenti a supporto di questa tesi.
II.4.6 Il Giavellotto
Non sono poche le raffigurazioni di guerrieri Shardana che portano armi diverse dalla loro
lunga spada: nei rilievi di Medinet Habu, ad esempio, questi mercenari portano in mano dei
giavellotti167. Non si tratta però di un giavellotto particolare, ma di un normale giavellotto
egiziano, un’arma a lunga gittata. Probabilmente lungo un metro e mezzo per 700 grammi
di peso, con una punta di 11 centimetri, si era rivelato essere indispensabile per l’attacco ai
carri da guerra: strumento nato per l’attività venatoria, deve essere venuto naturale usarlo
per la “caccia” ai cavalli da battaglia, in maniera tale da rallentare, se non proprio fermare,
il mezzo, rendendolo vulnerabile all’attacco della fanteria 168.
II.4.7 La “Turbolenza”
Rimane da definire il bštw, quella parola egiziana tradotta prima come “turbolenza” e
successivamente con la locuzione “ribelli di cuore”. Micheal Spendel, per poter meglio
spiegare le caratteristiche di questi guerrieri169 li avvicina per caratteristiche ai berserker
nordici del medioevo, i quali andavano in guerra senza protezioni, infuriati “like dogs or
wolves. (…) They killed men but neither fire nor iron hurt them. This is called
berserksgangr 170. Questi, basandosi sul fatto che gli Shardana, nei rilievi di Abido,
vestono un abito elaborato quando svolgono il ruolo di guardie del corpo del faraone, ma
siano coperti solo da un elmo e un gonnellino quando in battaglia, arriva a sostenere la tesi
della “nudità eroica”171. La sua argomentazione è che ci siano due motivi per cui un
guerriero dovrebbe combattere privo di protezioni, o di abiti: la ricerca della velocità, ed il
disprezzo del pericolo. Rendendo l’uomo indifeso, lo si porterebbe a combattere molto più
velocemente, costringendolo a correre contro il nemico per poter scampare al morte.
Alla base di tutto ci sarebbe il funzionamento dell’adrenalina, un ormone che "dilates the
airways to improve breathing and narrows blood vessels in the skin and intestine so that
166 Cambridge (2008) p.741, Tavola IV 167 N.K. Sandars (1985) p.34 immagine 14 168 R.Drews (1993) p.187 169 Spendel considera gli Shardana indeuropei, assumendo una loro improvata provenienza dalla Sardegna, e
quindi utilizza per la sua analisi un’impronta quasi Duméziliana con cui chi scrive non concorda. 170 Snorri Sturlusson, Heimskringla, Ynglinga saga 6. Gunter Mller, "Zum Namen Wolf hetan und seinen
Verwandten," in M.P. Speidel (2002) p. 253-254 171 Ibidem p. 262
63
an increased flow of blood reaches the muscles, allowing them to cope with the demands of
the exercise.. .. During surgery, it is injected into tissues to reduce bleeding."172. In altre
parole, in situazioni di pericolo (come nel mezzo di una battaglia e senza alcuna
protezione) un guerriero –come un animale in trappola- sarebbe stato capace di attaccare
senza curarsi delle conseguenze, perché sarebbe più forte, più veloce, e più sordo al dolore
che non i suoi avversari173. In sostanza, la “turbolenza” degli Shardana sarebbe stata una –
voluta e ricercata- tattica di guerra.
II.6.8 Conclusione: il guerriero Shardana
La tattica di guerra –anche se si farebbe meglio a parlar di guerriglia- che i Popoli del Mare
prediligevano era quella, piratesca, della toccata e fuga174. Il fatto –se non certo, alquanto
probabile- che gli Shardana siano stati per lungo tempo pirati lungo le coste del Levante175
fa presumere che il loro armamento rispondesse alle richieste di velocità, richiedendo loro
di essere armati “alla leggera”, e di evitare il più possibile e il confronto diretto con
l’esercito nemico176. Ed oggettivamente dalla descrizione delle armi si ottiene un quadro
coerente con quanto detto: lo Shardana era un fante armato “alla leggera” che puntava tutto
o quasi tutto sulla velocità di esecuzione. La spada indica un soldato che combatte “in
solitaria”: lunga e tagliente da ambo le parti, per poter essere usata aveva necessità di ampi
spazi “di manovra” che il combattimento in linea con altre unità di fanteria non avrebbe
potuto offrire. La conformazione dello scudo suggerisce una tattica militare aggressiva,
tesa alla sopraffazione dell’avversario piuttosto che non alla difesa. La descrizione offerta
da Robert Drews pare perfetta: “The barbarian skirmisher, on the other hand, fights on his
own; with no comrade to right or left, he depends on his own round shield. Mobility rather
than solidarity was essential. (…)ferocious in his horned or feathered helmet, he used his
long sword to threaten opponents in a wide perimeter”177
172 Charles B. Clayman (ed.), The American Medical Association Encyclopedia of Medicine, New York,
1998, 414. In M.P. Speidel (2002) p. 276 173 Ibidem p. 276 174 Wachsmann in Oren(2000), p.105 175A.J. Spalinger (2005) p.181. A supporto si ricorda anche la già citata “Stele degli Shardana”: “Gli
Shardana ribelli di cuore, che nessuno aveva saputo combattere fin da sempre, essi vennero prepotenti
navigando sulle loro navi da guerra dal mezzo del mare e nessuno poteva opporsi a loro”. KRI II, 290.1-4 in
G.Cavillier (2002) p.68 176 N.K.Sandars (1985) p. 177 R.Drews (1993) p.152
64
II.7 Conclusione: Gli Shardana e la guerra nel tardo Bronzo
Si è cominciato questo capitolo dicendo che si sarebbe cercato di descrivere, nella misura
in cui le nostre conoscenze lo possano permettere, il funzionamento della guerra nel Vicino
Oriente nel Tardo Bronzo. Si è detto che si sarebbe cercato di identificare le caratteristiche
del guerriero Shardana, con l’intento di individuare la ragione per la quale vi sarebbe stata
una necessità pratica nello schierarli. Che gli Shardana fossero diffusi è infatti innegabile,
ma manca il perché di questo fatto.
Forse si può azzardare una spiegazione di tipo teosofico: agli occhi dell’uomo del Tardo
Bronzo –ed anche a quelli dell’occidentale moderno, ricordando il tedesco “Gott mit uns”-
le battaglie si vincevano con l’aiuto divino: secondo tutte le popolazioni, accanto al re
combattevano gli dei178. Nella visione dei rapporti fra paesi considerati “civili” –ovvero
quelli dei grandi e piccoli re- questo concetto avrebbe portato come si è detto alla visione
della battaglia come un’ordalia: dal momento che le due parti erano grosso modo
equivalenti in abilità umana e risorse tecniche, la vittoria avrebbe significato essere stati
sostenuti dagli dei. La distanza fra la concezione teologica della guerra come ordalia e la
conduzione pratica delle operazioni belliche portò alla definizione di regole comunemente
accettate, in maniera tale da mantenere l’ordine politico internazionale179. La guerra
modello doveva essere una guerra giusta, corretta, e vittoriosa, col suo culmine in una
battaglia campale decisa precedentemente, in uno spazio delimitato, in un momento
prefissato, con possibilità equilibrate, in modo da dare a tutti i contendenti le medesime
possibilità di vittoria e rendere la sconfitta della popolazione scorretta come determinata
dalla giustizia e dal valore degli eserciti in campo180.
Combattere contro il nemico significava mettere in campo il meglio possibile, ovvero
utilizzare i propri maryannu, guerrieri dal costo elevato che erano mantenuti in previsione
di questi momenti. Ma non solo: i maryannu, in quanto arcieri, necessitavano di qualcuno
che combattesse al loro fianco e ne completasse le caratteristiche. In battaglie contro
predominanti masse di fanti, la forza del numero e il limitato numero di frecce li avrebbero
portati alla sconfitta, e in battaglie contro altri carri, avrebbero potuto al massimo colpire
gli avversari o i loro cavalli, ma non si sarebbero mai potuto ottenere una grande vittoria
con l’annientamento della carreria nemica. Necessitavano quindi di qualcuno che svolgesse
178 M.Liverani (1994) p.134 179 M.Liverani (1994) p.138 180 M.Liverani (1994) p.140
65
i compiti cui loro non potevano adempire: qualcuno che li seguisse, ma senza salire sul
carro; qualcuno che si scontrasse con altri fanti, ma senza aver bisogno di una formazione
chiusa; qualcuno che, velocemente, finisse i maryannu caduti, in maniera tale che non
potessero tornare a combattere in un secondo momento. In breve, servivano loro degli
skirmisher che fossero armati alla leggera, e questo ruolo è riservato agli Shardana in
maniera esplicita, nei già citati testi del quinto anno di regno del faraone Merneptah:“Il
misero capo libico Meryw, figlio di Ded, è sceso nel paese di Tehenw con i battaglioni di
Shardana, Shekelesh, Ekwesh, Lukka, Teresh, i migliori di ogni guerriero e di ogni
corridore nel suo paese”181.
Ma se le regole potevano e dovevano essere rispettate con le popolazioni civilizzate, non
era necessario che lo fossero con delle popolazioni nomadi che, barbare e fuori dal
consesso civile, erano abituate a non seguire le regole per ottenere vantaggi personali, ad
attaccare di notte, di spalle, di sorpresa182, per questi motivi –oltre che per quelli pratici,
dato che si trattava di popolazioni esterne al mondo palatino ed abitanti nelle montagne,
dove i carri da guerra non avrebbero avuto modo di dispiegare la loro velocità - contro di
loro la guerra –anche se si farebbe meglio a parlar di guerriglia- era diversa. Nel papiro
Anastasi, scritto sotto il regno di Ramses II, un’ipotetica spedizione contro una
popolazione di Canaan, i ne’arim, viene descritta così: “Le truppe (regolari) che sono
dinanzi a te ammontano a 1900; Shardana 520, Kehek 1600, Meshwesh 620, Nubiani 880,
in totale 5000”183. Siccome non sono nominati dei cavalli da alcuna parte, si assume che le
truppe regolari siano arcieri a piedi, e che le forze mercenarie siano una fanteria di mischia,
skirmisher professionisti184. Di fronte a popolazioni che facevano della guerriglia la loro
arma di combattimento prediletta, gli stati cercavano mercenari in grado di combattere
quelle battaglie che loro non erano capaci di vincere. La velocità dello scontro e
dell’inseguimento, la capacità nella mischia e nella battaglia corpo a corpo erano qualità
preziose che non potevano essere acquisite dall’oggi al domani. Non era solo una tattica
egiziana, questa: secondo Mario Liverani, Ugarit aveva assunto un corpo di mercenari fra i
Kashka, oltre che gli stessi shardana185. Probabilmente per lo stesso motivo.
Il barbaro mercenario Shardana portava con sé quel bštw, quella turbolenza, che non si
poteva imparare che con l’esperienza, o con la costante applicazione. La vita dell’uomo
181 KRI IV 3.15-4.2 in Cavillier (2005) p. 17 182M.Liverani (1994) p.142 183Papiro Anastasi I, 17.4, in G.Cavillier (2005) p.12 184 R.Drews (1993) p.139 185 M.Liverani, (1962) p. 154 in Drews (1993) p.155
66
medio nei paesi del Vicino Oriente Antico era generalmente pacifica. La presenza di un
ordine sociale e la relativa scarsità delle guerre faceva si che non si fosse, generalmente,
abituati alla lotta corpo a corpo. Non sembra un caso se l’arma tipica dell’esercito egiziano
–ovverosia il paese più sicuro, da questo punto di vista- fosse l’arco. Nei rilievi regali quei
pochi Egiziani che combattono come fanti sembrano infatti cercare la sicurezza
dell’organizzazione nel mezzo di una battaglia186: combattono ordinati, a gruppi di quattro,
affiancati, gli scudi uniti a formare un’unica protezione; la loro arma, la lancia, è perfetta
per questo tipo di guerra, perché con essa non è possibile colpire, per sbaglio, il compagno.
Individui cresciuti in situazioni diverse, al contrario, erano molto più abituati – o forse
bisognerebbe dire “capaci”- a combattere un tipo diverso di guerra. Le caratteristiche delle
armi risalenti al periodo trovate nel mondo ellenico e balcanico187 dimostrano che la guerra
civile non era figlia di un malfunzionamento sociale –come al contrario sarebbe stata
all’interno di ogni paese medio-orientale- ma un elemento strutturale della società188. La
violenza era in qualche misura attesa, le società si strutturarono di conseguenza e la
tecnologia creò gli oggetti necessari, selezionando I guerrieri migliori e più abili189. Non è
difficile pensare che –se il fosco quadro dipinto da Molloy corrisponde al vero-, per una
sorta di darwiniana selezione naturale, gli spadaccini capaci di arrivare all’età adulta
fossero i migliori, e che, partiti da chissà dove in cerca di bottino e scontratisi con le
società palatine del Mediterraneo, fossero stati scelti per fare, a pagamento, quello che
avevano fatto tutta la vita gratuitamente: Combattere.
186 R.Drews (1993) p.138 187 B. Molloy (2010) p.425 188 B.Molloy (2009) p.422 189 B. Molloy (2010) p.422
67
Capitolo III: Gli Shardana nelle fonti storiche
III.1 Introduzione
Nel primo capitolo sono stati introdotti i principi del mondo politico dell’epoca, cercando
di individuare le ragioni per le quali i vari stati del tardo bronzo sarebbero potuti andare in
guerra. Nel secondo si è analizzata la tecnica militare, alla ricerca del motivo per il quale
Paesi grandi e importanti come l’Egitto o Ugarit avessero avuto bisogno di arruolare
guerrieri stranieri per compiere una funzione –quella militare- che la popolazione
autoctona era numericamente in grado di svolgere. Una risposta possibile –assumendo la
precisione dei rilievi egiziani nel mostrare l’armamento di soldati alleati e nemici, e
presumendo che le spade ritrovate ad Ugarit e Hattusa corrispondono tipologicamente a
quelle dei rilievi- è che i guerrieri Shardana fossero un tipo di skirmisher molto particolare
per la zona Vicino Orientale, le cui peculiari capacità sarebbero state utilizzate nel ruolo di
pḥrr nelle guerre con i paesi “civili”, e nel ruolo di guerrieri di mischia per quanto riguarda
le lotte con popolazioni esterne al mondo palaziale. Questo terzo capitolo sarà quindi
improntato all’esposizione degli elementi storici ed archeologici che possano sostenere e
supportare questa teoria verificandola sul piano storico ed evenemenziale.
Inizialmente saranno quindi esaminate le attestazioni storiche provenienti dall’Egitto, da
Ugarit e da Biblo, cercando di verificare la loro effettiva presenza ed il loro ruolo militare e
sociale. In seguito, verranno descritte alcune delle battaglie in cui i faraoni d’Egitto hanno
impiegato questi mercenari, con l’obbiettivo di verificare la fondatezza delle precedenti
descrizioni del loro impiego sul campo. Per quanto riguardala guerra fra civiltà palaziali,
verrà analizzata la battaglia di Qadesh, svoltasi fra le forze egiziane di Ramses II e gli
Hittiti di Muwatalli, mentre per mostrare quello contro le popolazioni estranee al mondo
considerato “civile” dai contemporanei si descriverà la battaglia di terra contro i Popoli del
Mare .
68
III.2 Gli Shardana e l’Egitto
Si è già detto come il primo incontro certo fra gli Shardana e l’Egitto sia stato, più che un
incontro, uno scontro: la già citata “stele degli Shardana, infatti, li ricorda come guerrieri e
invasori “dal mezzo del mare”. È possibile però che anche la stele di Assuan, datata al
secondo anno di regno di Ramses II e quindi precedente, li citi: “Egli ha distrutto i
guerrieri del grande verde, il grande lago del Basso Egitto, sicché essi (gli egiziani)
possono dormire tranquilli”1. A seguito del loro asservimento, gli Shardana entrano in
pianta stabile nell’esercito egiziano, nel quale sono rappresentati dalla battaglia di Qadesh2
in poi. In totale, gli studiosi hanno a disposizione 32 citazioni da testi egiziani riguardanti
gli Shardana, ed anche se cinque di queste li mostrano come nemici della terra d’Egitto, le
restanti ventisette li presentano come membri dell’esercito o addirittura come inseriti nel
contesto civile34.
Gli Shardana in Egitto entrarono a far parte dell’esercito in pianta stabile, avendo quale
forma di retribuzione degli appezzamenti di terreno da coltivare in prima persona o da far
lavorare da terzi. Nel papiro Wilbur (datato al tempo di Ramses V) è attestata la presenza
di militari possessori di appezzamenti di terra nel paese. Il documento è diviso in varie
zone, nelle quali la percentuale degli Shardana è sempre pari o superiore al 4% del totale,
comprendente combattenti e dipendenti “civili” dell’esercito5. È interessante notare come,
a dimostrazione del fatto che l’utilità degli Shardana doveva essere legata alle guerre
contro i nomadi, la presenza Shardana sia maggiore al nord che non al sud6.
Il papiro Harris testimonia come esistessero delle fortezze le cui guarnigioni erano
composte da questi mercenari: “Gli Shardana ed i Weshesh del mare furono annientati,
catturati assieme e portati in egitto come prigionieri (numerosi) come la sabbia della
spiaggia, io li acquartierai in fortezze, sottomessi nel mio nome”. 7 e ancora “Io permisi ai
carristi, ai fanti di ritornare alle loro dimore durante il mio regno, agli Shardana e ai
Kehek di riposare nelle loro città poiché non era più necessario combattere i ribelli di
1KRI II 335,3 in G.Cavillier (2005) p. 12 2 Vedi paragrafo III.4 3 Nel papiro dell’adozione, databile all’inizio del regno di Ramses XI, due Shardana sono segnati come
testimoni dell’adozione, da parte di un egiziana, di due giovani schiavi. Gardiner (1941) p.24 4 J.Kahl in O. Loretz (1995) p.137-140 5 A.J.Spalinger (2005) p.264 6 A.J.Spalinger (2005) p.266 7 Papiro Harris I, 76.5-10, traduzione di G.Cavillier (2005) p.18
69
Kush e i nemici di Kharu 8. Altra conferma è fornita dalla stele funeraria di Sth-m-3b,
“comandante della fortezza degli Shardana”9. La sola esistenza di questa stele testimonia
ancora una volta l’esistenza di una fortezza riservata agli Shardana, oltre che la tendenza,
da parte dell’esercito faraonico, a mantenere una distinzione etnica fra l’esercito egiziano e
questi mercenari tanto caratteristici10. Per quanto riguarda le fortezze Shardana, a parte le
molte ed importanti locate nel medio Egitto e nel Fayyum, è altamente probabile che
militari Shardana fossero presenti anche in Canaan, come personale militare o come
specialisti dell’industria11. È provato infatti come la fortezza di Tell Es- Sa'idiyeh -al centro
della valle del Giordano12- fosse controllata direttamente dagli egiziani durante la fase
finale del nuovo regno13, e secondo i risultati degli scavi è possibile che gli egiziani si
fossero portati con sé gruppi di mercenari. I costumi di seppellimento sono sempre
considerati un importante rivelatore etnico, dato che sono uno degli elementi che un popolo
maggiormente conserva nel tempo, e quelli che sono attestati nella necropoli di Tell Es-
Sa'idiyeh sono quantomeno ambigui: 37 tombe di adulti, e 52 di infanti sono al tempo
stesso nuove e completamente estranee alla tradizione Cananea14 (si tratta infatti di due
giare i cui colli sono attaccati l’uno contro l’altro, fino a formare una sorta di bara di
terracotta15) ma al tempo stesso connesse strettamente alla tradizione egiziana, dato che i
corredi funerari comprendono scarabei e gioielleria16. L’insieme suggerisce fortemente che
si tratti di componenti del contingente egiziano in città, i quali non sarebbero però
sufficientemente integrati da condividere i costumi funebri del paese del Nilo. E siccome i
filistei non sono attestati nei testi egiziani prima dell’anno ottavo di Ramses III17 è
alquanto probabile, quantomeno per esclusione, che questi mercenari siano gli Shardana.
Per quanto riguarda invece la rigida separazione interna all’esercito, stabilita su base
etnica, occorre considerare che l’elemento Shardana nella diciannovesima dinastia era
diventato fondamentale per la sopravvivenza dell’esercito egiziano, ed il fatto che fossero
costituiti in delle unità separate lo conferma18: è probabile fossero tenuti a parte per
8 Papiro Harris I, 78.9-10, traduzione di G.Cavillier (2005) p.18 9 J.Kahl in O. Loretz (1995) p.138 10 A.J.Spalinger (2005) p.264 11 J.N. Tubb in Oren (2000) p. 186 12 J.N. Tubb (1988) p.3 13 J.N. Tubb in Oren (2000) p. 186 14 Ibidem 15 Ibidem 16 J.N.Tubb in Oren (2000) p. 188 17 Ibidem 18 A.J.Spalinger (2005) p.273
70
mantenerli interamente “Shardana” e non “egittizzarli” nella tecnica militare. Nonostante
la crescente dimensione dell’esercito in quegli anni, la quantità di menzioni relative agli
Shardana pare aumentare 19, facendo pensare (anche se correlazione non significa causa),
ad una crescita del numero degli Shardana al servizio del faraone. È anche probabile che
gli Egiziani li stessero armando direttamente: nel corso della diciassettesima campagna di
scavi ad Ugarit, infatti, fu rinvenuta una spada nuova, mai utilizzata, forse ancora in
fabbricazione. L’arma- trovata in un contesto “miceneo”- è lunga 74 cm, adatta a colpire
tanto di taglio quanto di punta, e porta il cartiglio di Merneptah.20La spada non è di tipo
egiziano ed è possibile che Merneptah –date le condizioni dell’oggetto- la avesse ordinata
per le sue truppe ausiliarie. Una conferma di tale comportamento può essere trovata nel
fatto che l’iscrizione di Karnak riguardante la battaglia contro i Libu combattuta da
Merneptah, si apra con la descrizione dell’armamento delle truppe da parte del faraone21,
ed allo stesso modo si apre la descrizione della battaglia contro i Popoli del Mare di
Ramses III22.
Infine, occorre mostrare e considerare un ruolo peculiare assunto dagli Shardana in Egitto:
quello di guardie del corpo. I mercenari sono sempre state guardie del corpo alquanto
apprezzate, ma raramente tanto fidate da esser lasciate sole con il proprio protetto. Ramses
II non fa eccezione, dato che –si vede nei rilievi di Abu Simbel- affiancava ai suoi
Shardana alcune guardie regolari 23. È interessante poi notare come, nei rilievi di Abido, gli
Shardana al servizio diretto del faraone siano differenziati da quelli dell’esercito: quando
servono quali guardie del corpo, infatti, vestono un abito elaborato, ma quando in battaglia
sono coperti solo da un elmo e un gonnellino24.
III.3 Gli Shardana e Biblo
Le più antiche testimonianze storiche sugli Shardana si hanno in epoca amarniana, in
alcune fra le numerosissime lettere al faraone da parte di Rib-Addi di Biblo: le EA 81, 122
e 123. Queste attestazioni sono state ampiamente discusse, e ci si è chiesti se sia davvero
possibile affiancare e correlare fra loro i Še-ri-da-nu di El Amarna, gli Šrdn egiziani ed i
trtnm di Ugarit. In EA 81 Rib Addi attesta come uno dei suoi Še-ri-da-nu sia fuggito verso
19 A.J.Spalinger (2005) p.197 20 C.F.A. Schaeffer (1955) p.226 21 C.F.A. Schaeffer (1955) p.228 22 A.J. Spalinger (2005) p.253 23 M.P. Speidel (2002) p. 279, N. Stillman- N. Tallis (1984) p.9 24 M.P. Speidel (2002) p. 262
71
il nemico Abdi-Ashirta dopo aver cercato di ucciderlo. In EA 122 e 123 lamenta invece di
come il comandante egiziano Pahura abbia mandato dei Sutei ed essi abbiano ucciso un
altro dei suoi Še-ri-da-nu e rapito tre abitanti di Biblo. Sulla base di queste attestazioni
sono state fatte numerosissime proposte di identificazione per i Še-ri-da-nu, ma l’unica
cosa della quale si può essere ragionevolmente sicuri è che fossero dei soldati di stanza a
Biblo. Oltre a questo, non si è nemmeno in grado di precisare se siano soldati di Rib-Addi
o della guarnigione egiziana25.
Assumendo comunque l’identità fra Še-ri-da-nu e Šrdn, ciò che risulta utile ai fini di
questa tesi è come siano stati proprio dei Sutei ad essere mandati contro i tre biblioti e lo
Shardana che era con loro. I sutei sono la popolazione nomadica più nominata nelle lettere
amarniane, ed in quanto nomadi erano molto differenti dal punto di vista economico e
sociale dalle popolazioni urbane del levante26, caratterizzati da una arretratezza economica
e militare. Le lettere di El Amarna non ci forniscono alcun dettaglio sul loro modo di
combattere, ma si può supporre fosse simile a quello dei beduini Shasu, che abitavano più
a sud nel Levante27. Questi ultimi sono mostrati nei rilievi egiziani usare le armi tipiche
dello scontro corpo a corpo (spade, asce, spade, mazze), armi da lancio come il giavellotto
e diversi tipi di scudo, ma, data la loro arretratezza economica, sono privi di qualsiasi
elemento della guerra palatina, come i costosissimi carri da guerra e gli archi compositi28.
Al contrario, sembrano essere legati alla guerriglia, più che alla guerra vera e propria. Non
era però raro vederli impiegati come mercenari, come skirmisher e come combattenti di
linea. Nel caso specifico lamentato da Rib Addi nella sua lettera al faraone, è stato
ipotizzato che il comandante egiziano Pahura avesse inviato i Sutei in qualità di
“poliziotti”- un compito inusuale per loro-, per arrestare i tre biblioti, e che avessero ucciso
lo Še-ri-da-nu per aver fatto resistenza. Secondo Vidal, invece, i Sutei sarebbero stati scelti
per compiere un’azione che avrebbe avuto molto più della guerriglia, che non dello scontro
militare puro o dell’azione di polizia29. Sulla dinamica dell’evento è possibile solamente
speculare, ipotizzando che –conoscendo Pahura le caratteristiche degli Sherden- il
comandante egiziano abbia inviato qualcuno in grado di affrontarli sullo stesso terreno.
25 O.Loretz(1995) p. 128 26 J.Vidal (2010) p.95 27 Ibidem 28 J.Vidal (2010) p.97 29 J.Vidal (2010) p.102
72
III.4 Gli Shardana e Ugarit
III.4.1 L’esercito di Ugarit
L’esercito di Ugarit pare esser stato di dimensioni sufficienti (Heltzer parla di 7000 unità,
Liverani di 4000) a garantire l’importanza della città nello scenario vicino orientale e a
proteggerne confini e commerci30. Dal punto di vista organizzativo, pare che vi fossero
notevoli somiglianze fra le armate siriane e le truppe dei faraoni egiziani31: in entrambi i
casi si trattava di un esercito solitamente arruolato per coscrizione, (pare che i vari villaggi
dovessero inviare uomini a far parte dell’esercito, in un numero probabilmente
proporzionale alla grandezza del villaggio stesso32), e che in caso di necessità di
contingenti di grandi dimensioni le autorità regali di Ugarit usassero proclamare una
mobilitazione (ḫrd33) parziale o generale del regno, convocando tutti i dipendenti regali
(militari e non militari) e gli abitanti della costa, da impiegare nella marina militare34.
Si è già osservato nel capitolo II come anche i re di Ugarit avessero a disposizione dei
maryannu. Dai documenti amministrativi, pare che il loro ordine di grandezza che dovesse
aggirarsi attorno alle 230 unità35, ma si pensa anche che non tutti i combattenti su carro
fossero indicati con questo nome (o addirittura che il termine non indicasse
necessariamente lo status di guerriero sul carro, almeno nel regno siriano36), dato che il
numero di cavalli nelle scuderie del re era alquanto più alto, e che quindi i carri ugaritici
dovrebbero essere stati circa 700-100037. Nel capitolo precedente si è rilevato come,
secondo R. Drews, non ci sarebbe alcuna sicurezza nella presenza di i pḥrr nei testi di
Ugarit. È, questa, una affermazione che pare sia il caso di indagare più approfonditamente,
perché negata dalla presenza, nei testi, dei mlsm mrkbt, “corridori del carro”38, e dalla
possibile identificazione di altri corridori: i mdrlm. Secondo l’analisi di Juan Pablo Vita,
infatti, il termine ugaritico mdrlm, tradotto solitamente come “sentinella” perché
considerato provenire dal sostantivo accadico “massaru” indicherebbe in realtà –
discendendo dall’accadico namsaru, un tipo di spada dalle grandi dimensioni- uno
30 J.P. Vita (1995) p.135 31 M.Heltzer (1982) p.103 32 KTU 4.68 in M.Heltzer (1982) p.104 33 M.Heltzer (1982) p.106 34 M.Heltzer (1982) p.111 35 M.Heltzer (1982) p.112 36 J.P. Vita (1995) p.104 37 M.Heltzer (1982) p.194 38 J.P. Vita (1995) p.128
73
spadaccino39. In aggiunta, nel documento amministrativo 00-4.67 le spade mdr fanno parte
dell’armamento previsto per i carri40, e il documento 00.-4.53. ha come oggetto “mdrlm
che non possiedono cuoio”41 una definizione che J. Sanmartin considera come pellicce o
protezioni distribuite dallo stato per difendersi dal freddo42. Il numero di questi soldati è
più grande di quello dei maryannu e pare godessero di non pochi privilegi43, e nel
complesso sembrano rientrare nella descrizione data riguard i pḥrr.
Non pare che vi sia, nei testi ugarititici, un termine che possa essere direttamente
traducibile con “fanteria” cosa che invece accade con l’accadico Sabu šepe44, nonostante vi
siano, fra i testi amministrativi, notizie di armi messe a disposizione dei soldati di leva:
archi, scudi, lance e kepesh45. Erano poi presenti i tnnm, o sananu, guerrieri identificati
individualmente col proprio nome, o con quello del padre, e che in determinati momenti
raggiunsero anche la cifra di 80 individui46. Sappiamo molto poco di loro, che ricevevano
grandi somme –più dei maryannu-, e quindi che dovevano essere di particolare fiducia dal
punto di vista militare, forse guardie del corpo del re. Non è poi impossibile che l’esercito
ugaritico facesse ampio uso i mercenari stranieri, come i trtnm47.
III.4.2 Presenza degli Shardana ad Ugarit
La fonte principale per lo studio dell’esercito del regno di Ugarit proviene dai testi
amministrativi ritrovati -in accadico e ugaritico- a Ras Sharma. Data la loro natura assai
peculiare, il loro è un linguaggio tecnico e abbreviato, fitto di termini che nel corso del
tempo hanno mutato, lentamente accezione e significato, e che quindi non sarebbe di
immediata comprensione e necessiterebbe di grande attenzione e contestualizzazione per
essere compreso appieno48.
Per quanto riguarda gli Shardana ad Ugarit, si è molto dibattuto persino sulla loro stessa
presenza nella città siriana. La questione è particolare: nei testi alfabetici compaiono dei
39 “El termino mdrlm, por lo tanto, podria analizarse de la siguiente manera: mdr (raiz msr) + gl (sufijo
hurrita)+ m (sufijo plural ugaritico) y su traduccion seria “el que utiliza la espada mdr” J.P. Vita (19950)
p.111 40 J.P. Vita (1995) p.46 41 J.P. Vita (1995) p.112 42 Ibidem 43 M.Heltzer (1982) p.116 44 J.P. Vita (1995) p.135 45 J.P. Vita (1995) p.153 46 M.Heltzer (1982) p.122 47 J.P. Vita (1995) p.136 48 J.P.Vita (1995) p.5
74
trtnm, e i quelli accadici dei se-ri-da-nu49, e ci si è chiesti se sia possibile operare un
parallelismo fra questi e gli Šrdn egiziani. W.F Albright infatti rifiutava con decisione
questo accostamento50, ma non sono pochi gli studiosi che l’hanno invece –e con buone
ragioni- portato avanti. L’identificazione regge innanzitutto dal punto di vista ortografico,
in primo luogo perché la s sorda, soprattutto in parole d’origine straniera e all’inizio della
parola, veniva generalmente riprodotta nella scrittura cuneiforme come t o come d
(un’alternanza da attribuire all’incertezza nella rappresentazione delle dentali per parole di
una lingua aliena allo scriba)51, ed in secondo luogo perché, nella tavoletta KTU 4.173:4,
sotto la r di trtnm è stato aggiunto il segno cuneiforme sillabico “a”, portando così ad una
lettura “tarta numa”52. In aggiunta, la contestualizzazione storica –pur non essendo di per
se decisiva- supporta quest’idea: i trtnm compaiono per la prima volta in alcune lettere
databili ai regni di Niqmepa e Ammistamru53, poco tempo prima, quindi, dell’attacco al
Delta egiziano ricordato da Ramses il grande.
III.4.3 Il ruolo degli Shardana ad Ugarit
Anche assumendo l’identità fra Šrdn, trtnm e se-ri-da-nu, comunque, rimane il dubbio sul
loro ruolo all’interno del mondo siriano. Che fossero dei militari pare sicuro: nelle liste che
dividono la popolazione in gruppi o categorie di professionisti, i trtnm sono inseriti nel
paragrafo “tgmr hrd”, “l’intero ammontare dei soldati”54 e che comprende: tnnm, i
‘combattenti’; i mrjnm, i ‘possessori di armi o soldati armati’; il già discusso mdrglm. A
voler ulteriormente specificare, poi, si considerino ancora le già citate lettere PRU
III.16.251 e PRU IV.15.118: queste attestano che “lo Shardana Allan” ricevette dal re delle
terre suscettibili di redistribuzione coatta55. Si è già ricordato nel secondo capitolo come
l’economia ugaritica (come tutte le altre economie pre-monetarie) prevedesse il pagamento
dei servigi allo stato tramite le rendite di campi coltivati, e quindi queste lettere
certificherebbero per Allan un ruolo al servizio del re. Inoltre - anche se, in questo caso, si
rasenta la pura speculazione- il fatto che a concedere i campi sia Niqmepa in persona ha
fatto pensare che il Signore stesso della città avesse convocato questi soldati, “Doubtlessy
as mercenaries”56. I documenti PRU II dal 28 al 3157 e KTU 4 17458, attestano un totale di
49 M.Heltzer (1982) p.125 50 Dietrich M. – Loretz O. (1972) p. 39 51 Dietrich M. – Loretz O. (1972) p. 40 52O.Loretz (1995) p. 130 53 PRU III.16.251 e PRU IV.15.118 54 Dietrich M. – Loretz O. (1972) p. 41 55 J.P. Vita (1995) p.135 56 M.Heltzer (1982) p.126
75
circa 60 Shardana come guardie di palazzo59.Pare poi possibile affermare che, nel corso del
tempo, abbiano perso il proprio carattere straniero e si siano integrati nella vita sociale ed
economica della città, nella stessa maniera di quanto fecero in Egitto60. In sostanza, pur
senza poter avere l’assoluta certezza che degli Shardana fossero impiegati come mercenari
dalla corte Ugaritica, questa affermazione pare poggiare su basi abbastanza solide61.
Dopo aver stabilito, con una ragionevole fiducia, la presenza di Shardana ad Ugarit ed il
ruolo che ricoprivano nella città siriana, è necessario individuare le ragioni che avrebbero
portato Ugarit ad assumere dei mercenari. In primo luogo, occorre considerare il fatto che
gli episodi principali in cui abbiamo notizia di un coinvolgimento militare di Ugarit ci
mostrano un paese tanto ricco quanto relativamente disarmato, poco desideroso e capace di
combattere le proprie guerre62 (si ricordi come esempio la già citata decisione di
Ammistamru II di pagare il tributo a Tudhaliya IV in cambio dell’esenzione dall’invio di
un contingente di armati, ma anche il trattato fra i re Niqmaddu di Ugarit e Aziru di
Amurru, ad esempio, nel quale il primo paga 5000 sicli al secondo affinché lo difenda
dagli ‘Apiru), rendendolo così bisognoso di specialisti della guerra. In secondo luogo,
occorre poi ricordare il ruolo commerciale della città: durante la stagione degli scambi,
carovane di asini traversavano una rete di strade e piste attraverso la steppa e i passaggi
montani. Dalla loro sicurezza dipendeva il benessere dello stato, e per questo motivo molte
sembrano essere state sotto il controllo diretto del palazzo, e i mercanti erano agenti del
governo che viaggiavano per contro del re. Ciò nonostante, rapine ed assalti erano
frequenti sulle strade, portando i mercanti ad unirsi per mutua protezione, o per poterla
ottenere dallo stato63. Analizzando una serie di tavolette sono state trovate delle liste di
persone (sempre attorno alle 155), chiamate al servizio del re e “stabilite nel palazzo
regale”, che contano tanto figure militari -i trtnm, i mrynm-maryannu, i tnnm, i mdrglm-
quanto civili -come i mkrm, “mercanti”-64. È possibile speculare che in questo caso si tratti
–soprattutto tenendo in conto che paiono convocazioni regolari, di un mese circa
ciascuna65- di vere e proprie spedizioni commerciali protette dallo stato attraverso
l’utilizzo di mercenari. E, se così fosse, il carattere composito di queste spedizioni -quello
57 M.Liverani (1969) p. 191 58 M.Heltzer (1979) p.13 59 M.Heltzer (1982) p.126 60 O.Loretz (1995) p. 132 61 O.Loretz (1995) p. 130, M. Liverani (1969) p. 195, M.Heltzer (1979) p.13 62 J.P.Vita (1995) p.11-12 63 Cambridge (2008) p 507 64 KTU. 4.137, 4.163, 4.173, 4.179, 4.174 in Heltzer (1982) p.106-107 65 M.Heltzer (1982) p.107
76
di un corpo ben assortito di diversi generi di militari e di skirmisher- sarebbe
innegabilmente simile a quello del papiro Anastasi. Allo stato attuale, comunque,
affermazioni simili non possono che essere mere supposizioni.
III.4 Gli Shardana in battaglia: Qadesh
Già si è detto come, per il mondo palaziale del tardo bronzo, la guerra corretta e giusta, la
guerra “civile”, fosse un’ordalia. Combattersi significava, agli occhi dei regnanti del
secondo millennio, chiedere giustizia agli dei, certi che chi fosse uscito a testa alta dalla
battaglia sarebbe stato colui che era giusto vincesse. Ma perché la giustizia divina avesse il
suo corso, era necessario che la battaglia fosse combattuta nel modo giusto: doveva essere
una battaglia campale; doveva avere luogo in un momento prestabilito ed in luogo
delimitato e adatto; doveva svolgersi secondo mosse paritetiche e possibilità equilibrate.
Iniziare una battaglia di sorpresa o all’improvviso sarebbe stato ritenuto sconveniente66. È,
questa, una cosa da tenere a mente nel momento in cui ci si approcci alla battaglia di
Qadesh. Perché molte – la grandissima parte- fra le battaglie del mondo antico non hanno
avuto eco alle orecchie di noi contemporanei. A volte viene ritrovata la notizia della
battaglia, magari vaga citazione immersa in un discorso che non riguarda la battaglia e che
nulla ha del racconto storiografico (come la riconquista d’Egitto da parte di Ahmosis, di
cui l’unico documento è un’autobiografia di un semplice fante), ma sono poche le battaglie
di cui gli studiosi contemporanei sappiano più che di quella di Qadesh. Certamente il
materiale a disposizione non ha la qualità di un testo di Tucidide, o la precisione di un
Commentario Cesariano, ma è comunque in grado di rendere chiaro lo svolgimento dello
scontro. Di questa battaglia, di fondamentale importanza per gli equilibri del Levante del
tredicesimo secolo, quasi non si hanno fonti per uno dei due contendenti: gli Hittiti. Questo
potrebbe dipendere dal fatto che i documenti che sono arrivati fino all’epoca moderna
siano tutti del successore di Muwatallish, il fratello Hattushili, usurpatore del regno del
nipote Urkhi-Teshub, il quale non aveva alcun interesse a ricordare le imprese vittoriose
del sovrano, di cui non aveva rispettato le scelte in tema di successione, di alleanze
politiche interne ed internazionali, od in ambito religioso67. Un poco per questo motivo, un
poco per il caso legato ai rinvenimenti -la capitale di Muwatallish non è ancora stata
identificata- non vi è un racconto della battaglia da parte Hittita, e l’unica tavoletta
cuneiforme che ne fa menzione, una breve lettera rinvenuta ad Hattusa, è una lettera di
66 M. Liverani (1994) p.168 67 Pecchioli in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p. 168
77
Ramses II che porta, quindi, ancora una volta il punto di vista egiziano68. Il fatto che anche
il testo cuneiforme sia firmato dal figlio di Sethi I porta ad una sorta di ridondanza delle
fonti: dal paese del Nilo sono infatti giunte fino ai nostri giorni altre copie: 13 papiri ed
innumerevoli sculture. Ramses II la considerò l’evento militare più importante del proprio
regno, e la fece riprodurre ovunque: sul muro di cinta di Abido; nei due piloni del suo
“Ramesseo”; ad Abu Simbel; a Luxor; a Karnak. Ramses II fece di tutto per rendere i suoi
sudditi edotti su come lui, il loro faraone, avesse “vinto l’asiatico”. Anche se aveva
“giocato sporco”. Soprattutto, anche se non lo aveva vinto affatto: gli studiosi ancora
discutono su chi, nei fatti, sia uscito vincitore, quel giorno di maggio dell’anno 1275 a.C.69.
Ovviamente, soprattutto considerando la spererequazione quantitativa fra i due
contendenti, è necessario leggere le fonti egiziane cum grano salis: aldilà dell’eventualità
di una vittoria egiziana, sono infatti completamente deformate dalla propaganda regale:
alcune di esse arrivano a raccontare di come, gettatosi nella mischia, il faraone non si fosse
reso conto che i suoi uomini non erano riusciti a stargli dietro. Ritrovatosi circondato da
ogni parte, chiese aiuto al dio Amon “la mia voce fu udita in Heliopolis del Sud. Mi
accorsi che Amon rispondeva ai miei appelli: mi tese la mano, e me rallegrai”70, e con il
suo aiuto, vinse da solo battaglia: “Improvvisamente mi accorgo che i 2500 carri giacciono
riversi davanti ai miei cavalli. Nessuno di loro ha trovato la forza di combattere e i loro
cuori, nel loro corpi, si sono indeboliti, a causa del timore che ispiro”71. Appare più
probabile che le cose siano andate in maniera diversa, e che il faraone avesse avuto
bisogno di giustificare un insuccesso innegabile, e che lo abbia fatto puntando il dito sugli
Hittiti, che si sarebbero comportati in maniera scorretta72, e sul fatto che le truppe non
avessero fatto quello che avrebbero dovuto fare per sostenere il valore del Faraone73.
L’apparato celebrativo della battaglia di Qadesh, messo in opera da Ramses II mentre
negoziava prima il trattato e poi l’alleanza con gli hittiti mise gli inviati anatolici a contatto
con la propaganda Ramesside74In un momento successivo alla battaglia, quando già il
trattato di pace era stato siglato e i rapporti erano diventati più semplici, la ricostruzione
Ramesside dello scontro fu contestata da Hattushili, che –generale del fratello Muwatalli-
aveva combattuto la battaglia. Gli studiosi hanno infatti a disposizione alcuni frammenti
68 Pecchioli in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p. 168 69 Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.18 70 KRI II, 39, 13-44, in Grimal (1988) p. 332 71 KU, 131-137 in Alberto Rovetta in Pecchioli (2005) p.317 72 Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.19 73 Ibidem 74 Liverani (1990/2) p.212
78
della corrispondenza scambiata fra i due re in cui Hattushili contesta il racconto Ramesside
arrivando a chiedere, ironico: “Ma davvero eri solo tu (sul campo di battaglia)?”75.
Di sicuro, la battaglia di Qadesh fu decisiva: arrestò il tentativo egiziano di sottrarre la
Siria al controllo Hittita76; convinse le due potenze della loro sostanziale parità tecnica e
militare; produsse, a distanza di anni, il primo trattato di pace paritetico di cui si abbia
traccia. Motivo scatenante della guerra fu la decisione del Re di Amurru, Benteshina, di
sottrarsi alla dipendenza Hittita e scegliere come suo grande re il faraone d’Egitto. La
mossa, dato che Amurru era posto esattamente al confine fra i due regni, aveva avuto come
risultato quello di spostare il confine di settanta chilometri verso nord, ponendo Hatti e
l’Egitto in competizione per il controllo del paese. Muwatallish aveva già riconquistato e
risottomesso il paese, lasciando quindi a Ramses II il ruolo dell’invasore di un territorio in
mano al nemico77.
Ramses II preparò il suo esercito in anticipo: “his infantry and his chariotry, and the
Sherden of his Majesty’s capturing whom he had brought back by the victory of his strong
arm”78. Lasciò la fortezza di Sile, a nord-est del delta, all’inizio di aprile/maggio del 1275
con un esercito che è stato stimato essere di 20,000 soldati, divisi in quattro legioni: Amon,
Ptah, Ra, Seth, ognuna delle quali proveniva da una diversa città79 ed era guidata da un
principe di sangue regale80. In aggiunta vi era una divisione, forse di alleati o mercenari
cananei, forse una guardia scelta del faraone81, chiamata nei testi “Naharina”. Sul versante
Hittita, invece, Muwatallish aveva ammassato un grande esercito in Siria, composto da un
corpo di truppe regolari hittite, forze mercenarie e contingenti da un gran numero di stati
vassalli. Era un esercito che comprendeva fra gli altri anche i Lukka, l’armata di Ugarit e
quella del re di Qadesh (che evidentemente era tornata agli hittiti in qualche momento dopo
le campagne di Sethi I) per un totale di 47.500 uomini, di cui 3.500 carristi e 37.000 fanti82.
La grandezza esercito con cui il faraone era partito da Pi-Ramesse, composto da più di
20,000 soldati, era fuori dal comune, e se a questo numero vengono aggiunti gli aiutanti di
campo, si capisce come per poterlo organizzare fosse necessario che le divisioni
procedessero ad una certa distanza l’una dall’altra: una linea del “poema” infatti parla di un
75 Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.20 76 Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.18 77 Liverani in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.18 78 Dal “Poema” di Qadesh, KU 25-26 in A.Gardiner (1960) p.7 79 A. Gardiner (1960) p.5 80 R.O.Faulkner (1953) p.42 81 M.C. Guidotti in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.173 82 T.Bryce (2005) p. 235
79
iter di distanza. Un iter poteva avere due misure: 10,5 o 2,65 chilometri83, e poiché è
difficile che un’armata venga disposta in ampiezza per 30 chilometri (ovvero un giorno e
mezzo di marcia), è probabile che in questo caso debba essere usata la seconda misura. Fu
poi distaccata la divisione Naharina, probabilmente con l’intenzione di coprire il fianco
sinistro dell’esercito del Faraone ed evitare agguati, tanto che fu ordinato che percorresse
la valle che passa fra il mare ed i monti del Libano e quella del fiume Eleutero, mentre il
grosso dell’esercito passava dalla valle dell’Oronte84. L’esercito guidato da Ramses deve
essere arrivato a Qadesh dopo circa quaranta giorni di marcia, quindi a maggio/giugno
dello stesso anno. L’obbiettivo doveva essere la presa della città, fondamentale dal punto
di vista strategico (dominava, come si è detto, la valle dell’Oronte, quella dell’Eleutero, ed
era la porta d’accesso al nord della Siria), tattico (mantenere una roccaforte nemica alle
proprie spalle sarebbe stato fatale, in caso di ritirata), politico (la città, un tempo alleata
d’Egitto, si era schierata con gli Hittiti). La cattura di due supposti disertori dell’esercito
Hittita, e l’aver saputo da loro che Muwatallish era molto a nord, instillò in Ramses un
senso di sicurezza che si sarebbe rivelato fatale: gli uomini dell’esercito Hittita erano
invece “nascosti” alle spalle di Qadesh. Arrivato in vista della città, Ramses passò il canale
di El-Mudakyia, ponendo il campo di Amon a nord-ovest della città, mentre le divisioni
Ptah e Seth erano ancora nella foresta di Labwi, troppo a sud e di là dell’Oronte per poter
essere d’aiuto nella battaglia che sarebbe scoppiata di lì a poco. Mentre infatti Ra era in
marcia –e quindi assolutamente impreparata- per raggiungere l’accampamento di Amon,
2500 carri dell’esercito Hittita le piombarono improvvisamente addosso. L’attacco a
sorpresa85 sbaragliò completamente la seconda divisione egiziana, puntando poi
immediatamente sul campo di Amon. Poiché la fanteria Hittita –benché presente- non
prese parte allo scontro, è possibile ipotizzare che si puntasse sulla velocità dell’azione, e
che quindi l’idea di Muwatallish fosse quella di eliminare Ramses mentre era a capo solo
di un quarto del suo esercito, in modo tale da decapitare l’esercito nemico ed averne poi
facilmente ragione. I carristi accerchiarono l’impreparato campo di Amon, e, penetrati,
furono affrontati dagli Shardana della guardia reale86, che tennero il campo fino all’arrivo,
davvero provvidenziale, della divisione Naharina da est, con la quale Ramses poté lanciare
il contrattacco. Da questo momento in poi, la battaglia deve esser stata quasi
83 A.J. Spalinger, (2005) p.212 84 G.Cavillier in F. Pecchioli- M.C. Guidotti (2002) p.184 85 A. .J. Spalinger (2005) basandosi sul fatto che “the topography of the region indicates that west of the city
and around the Orontes there was relatively level plain, one suitable for chariot warfare” suggerisce però
che l’attacco potrebbe non essere stata una sorpresa. In ossequio alla teoria di Liverani sulla “guerra giusta”,
la battaglia sarebbe stata, secondo lui, preordinata (p.213). 86 S. Santosuosso (1996) p.439
80
esclusivamente combattuta dai reparti di carreria. I fanti in campo dovevano essere
solamente i “corridori” Shardana per gli egiziani (che nei rilievi di Abido sono mostrati
mentre tagliano gola e mani ai carristi appiedati87) e presumibilmente i “terzi uomini” dei
carri hittiti, che sono detti essere equipaggiati “con tutte le armi della battaglia”88. È
presumibile che Ramses avesse con sé nella divisione di Amon 2500 carri89, che quindi
fronteggiarono numericamente alla pari i 2500 della prima ondata. Per rispondere all’arrivo
della divisione Naharina, immediatamente dispiegata, Muwatallish mandò un rinforzo di
1000 carri. È molto probabile che sia stata la superiorità dell’arco composito degli egiziani
a determinare l’esito della battaglia. L’opinione di Yadin è che il carro hittita, armato di
giavellotto, sia stato fin troppo esposto al contrattacco micidiale dell’esercito egiziano con
le sue armi a lungo raggio, lasciando Ramses padrone del campo90. Secondo Bryce, inoltre,
l’armata hittita non era un corpo unico, ma un insieme “disparato” di forze diverse fra loro,
e che quindi sia stato impossibile per Muwatallish mantenere la disciplina nel momento
della reazione del faraone91.
Il “Bollettino di Guerra” afferma l’esistenza di una battaglia anche il secondo giorno
(“All’alba S.M. è pronto a combattere”), ma riferisce solo che si è combattuto, e che un
messaggero degli Hittiti ha portato un messaggio92. Anche il “Poema” lascia intendere che
si combatté il giorno successivo, ma il brano è scritto in maniera tanto retorica da non
avere alcuna utilità ai fini della ricostruzione militare dello scontro. Agli occhi di
Spalinger, la battaglia “preorganizzata” e “civile” sarebbe stata questa, e l’attacco del
giorno prima un riuscito “colpo di mano”93.
Ci si chiede chi abbia vinto la battaglia: le fonti egiziane, come si è visto, riferiscono di una
abbacinante vittoria da parte del faraone, ma nei documenti anatolici lo scontro, pur non
raccontato, è riferito essere una vittoria di Muwatallish94. Entrambi i contendenti con ogni
probabilità sostennero perdite significative, e la battaglia si concluse con una sorta di
pareggio. Nel lungo termine, comunque, Muwatallish fu il vincitore. Dopo lo scontro,
87 Tavola 5 88 Y. Yadin (1963) p. 104 89 A. .J. Spalinger (2005) p.216 90 Y. Yadin (1963) p.109 91 T.Bryce (2005) p.239 92 Cavillier in F. Pecchioli- M.C. Guidotti p.93 93 A.J. Spalinger, (2005) p.217 94 T.Bryce (2005) p.239
81
infatti, Ramses ritirò le sue truppe verso sud, verso la regione di Aba (Damasco), che
venne conquistata dall’esercito Hittita95.
È già stata fatto notare come, all’inizio del “Poema” della battaglia, Ramses II indichi il
suo esercito citando a parte gli Shardana96. Quello che non è stato detto è che alla fine,
quando dice di essere stato tradito dai suoi uomini, gli Shardana non siano, al contrario,
nominati97, probabilmente così indicando un ruolo attivo nella seconda fase della battaglia.
Il loro ruolo pare confermare la descrizione data nel secondo capitolo a proposito della
battaglia con “popoli civili”: corridori, impiegati nello scontro fra carri per finire i nemici. I
rilievi di Abydos e Karnak li mostrano collaborare da vicino con i carristi, finendo i
maryannu hittiti98 i cui veicoli erano stati immobilizzati, e tagliando loro la mano per la
conta successiva99100.
III.6 Gli Shardana in battaglia: i Popoli del Mare
Contro le popolazioni “ribelli” che non avevano sviluppato una struttura palatina –e con
essa un’economia in grado di sostenere le ingenti spese legate ai carri da guerra- il tipo di
combattimento era –doveva essere- diverso. La guerra è intesa come eliminazione dei
ribelli, di nemici sono rappresentati come privi di dei, armi e valore. Sono esseri inferiori la
cui impotenza è pari alla malvagità e alla folle insubordinazione, e come tali vanno
sottomessi o sterminati101. Non è un caso, quindi, se la maggiore insistenza sullo sterminio
si incontri nei testi di Ramses III relativi all’invasione dei popoli del mare102.
Le fonti per questa guerra difensiva sono il papiro Harris, ed il grande tempio mortuario di
Ramses III a ovest di Tebe, a Medinet Habu. Sulle mura del tempio possiamo leggere le
descrizioni e vedere le raffigurazioni di questa guerra, o meglio, di queste due battaglie:
una di terra e una di mare. A voler dar credito alla descrizione di Ramses III, dopo la
distruzione degli imperi e delle città del nord:
95 T.Bryce (2005) p.240 96 “His infantry and his chariotry, and the Sherden of his Majesty’s capturing whom he had brought back by
the victory of his strong arm”96 KU 25-26 A.Gardiner (1960) p.7 97 “The crime which my infantry and my chariotry have done is greater than can be told. Behold, Amun has
given me his victory, no infantry being with me and no chariotry” KU 198-200 A.Gardiner (1960) p.14 98 Tavola 4 99 Tavola 5 100 R.Drews (1993) p. 144 101 M. Liverani (1994) p.109 102 M. Liverani (1994) p.110
82
“A camp was set in one place in Amor. They desolated its people and its land was
like that which has never come into being. They were advancing on Egypt while the
flame was prepared before them103 (…) I organized my frontier in Djahi. I prepared
before them: princes, commanders of garrisons, maryannu, I caused the river
mouth to be prepared like a strong wall with warships, transports and merchant-
men, they were manned entirely from bow to stern with brave fighting men, and
their weapons. The troops consisted on every picked men, and their weapons. They
were like lions roaring on the mountain tops. The chariotry consisted of runners, of
picked men, of every good and capable chariot-fighter (…) as for those who
reached my frontier their seed is not, their heart and their soul are finished forever.
104
I popoli del mare si sono raggruppati, forse stabiliti per qualche tempo, in Amurru105. Da lì,
sono discesi verso la Palestina. Possiamo presumere che questo attacco sia stato diretto
lungo la costa, dato che la flotta appare poi sul Delta. Sembra che la minaccia fosse
abbastanza seria da poter essere affrontata con le sole forze dell’amministrazione egiziana
in Palestina. Le scene di Medinet Habu mostrano Ramses III sul suo carro, che marcia
verso i nemici alla testa delle sue truppe, fra cui gli Shardana. Il fatto che i popoli del mare
siano arrivati con donne, bambini e bagagli, su carri tirati da buoi ha fatto pensare che
stessero, più che invadendo, cercando una nuova casa, e che quindi desiderassero stabilirsi
in Palestina, o nelle regioni del delta del Nilo. Per qualsiasi motivo fossero arrivati,
comunque, Ramses III incontrò i nemici alla frontiera e li massacrò106. La guerra non era
però finita: in uno dei rami del delta del Nilo erano riuscite a penetrare alcune navi dei
popoli del mare. Un secondo combattimento aspettava gli uomini di Ramses. Di fronte al
loro arrivo, il faraone schierò la fanteria sulla battigia, in maniera tale da evitarne lo sbarco,
mentre da altre navi e dalla costa li bersagliava di frecce, essendo loro un bersaglio
immobile e indifeso.107 Nonostante la straordinaria importanza di questa battaglia per tutti
gli studi sulla guerra navale, ai fini di questa tesi solo due elementi possono essere
103J.H. Breasted Ancient Records of Egypt (1906) Vol IV paras 59-82 in N.K. Sandars (1978) p. 119 104 W.F. Edgerton- J.A. Wilson Historical records of Ramesses III, The texts of Medinet Habu (1936) in N.K.
Sandars (1978) p. 119 105 I rilievi della battaglia di terra includono figure delle donne e bambini che gli invasori portano con sé: 5
vagoni con dentro dei bambini nudi, probabilmente un modo per indicarne la giovanissima età. La presenza
dei bambini in mezzo alla battaglia, ed il fatto che almeno una donna dei rilievi di Medinet Habu sia una siro
caananea ha fatto pensare che si fossero stabiliti per qualche tempo, forse 6-7 anni, prima di continuare il
cammino verso sud. (D.Sweeney –A. Yasur-Landau (1999) p.139) 106 A.J.Spalinger (2005) p. 254 107 A.J.Spalinger (2005) p. 255
83
importanti: in primo luogo, il fatto che gli shardana vengano usati dagli egiziani per
abbordare le navi nemiche108109, mostrando così la loro abilità nel corpo a corpo, ed in
secondo luogo la facilità con la quale vengono eliminati i popoli del mare, protetti solo da
piccoli scudi rotondi, una volta a tiro degli archi egiziani.
Ci si è chiesti, comunque, se questo racconto corrisponda alla verità storica o se non sia
invece frutto della propaganda faraonica. Ramses III, infatti, non fornisce date o luoghi
precisi, e non offre alcun contenuto storico chiaramente definibile. Addirittura è stato
pensato che si tratti di copie di immagini del passato, eventi occorsi durante il regno di uno
fra Merneptah e Sethnakht110, oppure che si siano copiati eventi dal vicino Ramesseo111.
Per questo motivo sono stati avviati diversi studi, fra cui quello di Barbara Cifola, che
sostiene che la natura del testo sia altamente retorica e stereotipata, quasi un composto di
topos letterari che riflettono ideologie e motivi culturali tipici dell’Egitto del nuovo
regno112. La coalizione di popoli nemici, in primis, sarebbe ricorrente nella letteratura
egiziana113, essendo utile a ritrarre il nemico come un codardo che ha necessità di allearsi
con altri per poter attaccare il solitario Egitto con la forza del numero114. Cifola sostiene
che la “filosofia” Egiziana, aveva la necessità di categorizzare le situazioni sconosciute e
difficili inserendole ed adattandole ad un precostrutto culturale coerente115. Per questo
motivo un sistema espressivo nato per descrivere le imprese di un Egitto potente ed in
espansione, è utilizzato per descriverne uno arroccato in difesa della propria posizione, un
paese in declino, assediato e necessitato a difendersi, adattando la realtà alle propria
mentalità116. Così, il topos della coalizione è, per quanto riguarda i popoli del mare,
particolarmente enfatizzato ed inaccettabile: è difficile credere che un insieme di popoli
lontani si siano alleati per distruggere l’Egitto passando per Hatti117, appare difficile
credere ad un arrivo di massa, coordinato, unitario e contemporaneo di un insieme di
popoli ostili. E quindi non solo il successo rimane dubbio (soprattutto se si considera il
108 A.J.Spalinger (2005) p. 256, ma è discusso. Secondo altri infatti, gli Shardana della battaglia navale
sarebbero gli aggressori (A.Yasur Landau (2010) p.399), o sarebbero qualche altro popolo aggressore con in
testa l’elmo Shardana. (N.K.Sandars (1985) p.127 ). IN ogni caso, ai fini della dimostrazione della loro
abilità in spazi ristretti, non fa differenza. 109 Tavola 4 110 P. Maynor-Bikai in Ward and Jukowsky (1989) p. 134 111 L. Lesko in Ward and Jukowsky (1989) p. 152 112 B. Cifola (1988) p.277 113 Lo si trova anche nella battagllia di Qadesh: "See, the wretched chief of Khatti is come together with the
many foreign countries who are with him, whom he has brought with him as allies..." da A.Gardiner (1960)
p29 114 B. Cifola (1988) p.297 115 B. Cifola (1988) p. 301 116 Ibidem 117 B. Cifola (1988) p.303
84
successivo insediamento di popoli del mare in Palestina118), ma addirittura pare che una
vera e propria battaglia non sia mai stata combattuta, o, almeno, non una della quale
Ramses III potesse vantarsi contando le spoglie di un nemico sconfitto e catturato119. È
invece molto più probabile che si sia trattato della condensazione narrativa di un lungo
processo di infiltrazione di popoli stranieri respinti attraverso tante piccole schermaglie120.
Partendo da questa convincente posizione, considerando come il faraone metta in allerta le
fortezze lungo i confini -fortezze che ospitano non pochi mercenari Shardana, come si è
visto- e considerando come l’immagine della battaglia a Medinet Habu presenti solo una
schermaglia confusa di carristi e di fanti che combattono vicini121, si può intendere meglio
il ruolo del mercenario nella guerra non “civile”. Nel tempio infatti sono mostrate delle
famiglie trasportate dai carri, prive della protezione della cavalleria o di un gran
contingente di fanti, vulnerabili ed indifese122. L’attacco diventa quindi semplice, quasi un
massacro su una popolazione sparsa ed inerme: in uno dei carri, una donna alza la mano
sinistra a protezione, mentre con la mano destra prova a fermare l’avambraccio di uno
Shardana, che la sta per attaccare123. In un’altra immagine, uno Shardana attacca, con lo
spadone in pugno, un Peleset124, pronto a finirlo con un colpo alla gola.
Il ruolo dei mercenari Shardana nella “guerra” contro i Popoli del Mare pare quindi
confermare le idee e la descrizione formulate nel secondo capitolo, a proposito della
battaglia con “popoli civili”: fanti armati alla leggera per poter colpire con rapidità, in una
mischia, i nemici, e particolarmente efficaci contro nemici armati alla leggera. Ma, al
tempo stesso, la loro mancanza di protezioni, che tanto concede loro in termini di velocità,
li rende straordinariamente deboli alle frecce nemiche.
118 Vedi appendice 119 B. Cifola (1988) p.p. 303-304 120 B. Cifola (1988) p.303, P. Maynor-Bikai in Ward and Jukowsky (1989) p. 137 121 N.K.Sandars (1985) p. 121 122 N.K.Sandars (1985) p. 124 123 D.Sweeney –A. Yasur-Landau (1999) p.118, Tavola 6 124 D.Sweeney –A. Yasur-Landau (1999) p.118, Tavola 5
85
III.7 Conclusioni
Alla fine dello scorso capitolo si descriveva come il mercenario Shardana fosse stato utile
su un doppio piano: quello della guerra contro i paesi “civili”, e quello della guerra contro i
nomadi. Nella guerra contro i paesi civili, nel ruolo di pḥrr, il mercenario Shardana
avrebbe potuto sfruttare le sue doti di velocità e abilità nello scontro corpo a corpo per
appoggiare e difendere gli importantissimi maryannu. Al contrario, nella guerra contro i
nomadi, attuata laddove i carri non potevano andare, avrebbe potuto contrastare altri
skirmisher dotati pressappoco delle stesse qualità, supplendo con la sua ferinità
all’eccessiva calma o poca adattabilità dei soldati egiziani, ugaritici e biblioti.
L’analisi delle fonti storiche pare confermare la teoria. Le pochissime indicazioni che ci
sono offerte dalle lettere amarniane di Rib-Addi di Biblo e l’impiego, ad Ugarit, dei trtnm
quali scorte di quelle che sembrano essere spedizioni commerciali non solo non
smentiscono il loro ruolo di soldati da schermaglia, ma anzi, il fatto che lo Še-ri-da-nu
abbia trovato la morte combattendo contro dei Sutei, e che le carovane passassero
attraverso zone controllate da nomadi e briganti potrebbe suggerirlo. Gli Šrdn egiziani
sono infine quelli sui quali si ha la maggiore quantità di materiale, e sono quindi quelli sui
quali maggiormente si è indagato in questa tesi. Nel loro impiego presso il faraone, si è
documentato, combattono entrambi i tipi ruoli mostrando, soprattutto nella battaglia di
Qadesh, le loro doti nel combattimento di mischia -al momento della difesa del campo- e di
velocità –al momento del contrattacco-. Il combattimento di mischia è mostrato anche nei
rilievi per la battaglia contro i popoli del mare, dove combattono –o forse sarebbe meglio
dire “massacrano”- piccoli gruppi di nomadi in viaggio verso il Nilo.
86
Conclusione
L’intero periodo fra il 1500 ed il 1200 a.C., quello conosciuto dagli storici come “Il Tardo
Bronzo” sembra sia stato climaticamente alquanto favorevole –in quanto più fresco e
umido- per la zona intera del Vicino Oriente, per poi diventare, nel periodo
immediatamente successivo, fra il 1200 ed il 900 a.C., più caldo e secco1. Questo lasso di
tempo coincise con quella catena di eventi che influenzò in maniera sensibile il destino dei
grandi imperi. Alcuni studi sostengono che anche solo un leggero ribasso del volume delle
precipitazioni avrebbe avuto conseguenze devastanti per la produzione agricola, ma anche
e soprattutto nella vegetazione delle steppe sulle quali si basava l’allevamento – ed il
sostentamento- dei nomadi2, che si sarebbero quindi riversati a cercare cibo e salvezza
nelle zone più fertili. L’origine della crisi del 1200 sembra quindi dover essere ricercata
nell’incapacità, da parte delle società palaziali, di contenere la pressione esercitata da
popoli e gruppi sociali esterni, fossero essi i popoli del mare o popolazioni nomadiche.
Quelli che potrebbero essere i primi sintomi di questa crisi, ovvero i primi raid dei popoli
del mare nel Levante, portarono alcuni stati ad arruolare questi guerrieri per utilizzarli
contro popolazioni con simili tecniche di guerra. La prima menzione degli Shardana è
infatti un raid pirata nel quale Ramses II “ li catturò con la forza del suo valido braccio e li
portò in Egitto” 3. Il solo fatto –privo di precedenti- che un invasore non solo non venga
sterminato, ma venga anzi accolto nel paese, inserito nella struttura statale ed impiegato a
difesa dell’’Egitto testimonia l’importanza di questi guerrieri, e scopo di questa tesi è stato
quello di identificare le peculiarità che lo facevano valere tanto. La strada scelta è stata
quella della contestualizzazione, dapprima del periodo storico, ed in secondo luogo quella -
più ristretta e centrata sull’argomento- della tecnica militare. Infine, si è andato ad
analizzare le fonti dirette riguardanti il ruolo dello Shardana nel mondo del tardo Bronzo.
1R.L.Gorny (1989) p. 91 2 Ibidem 3 KRI II, 290.1-4 in G.Cavillier (2002) p.68
87
Il primo capitolo ha offerto quindi una descrizione schematica dello sviluppo storico del
mondo levantino del tardo Bronzo, cercando di individuare le cause economiche e sociali
delle guerre che ogni paese ha combattuto: per quanto riguarda l’Egitto, è affascinante il
parallelismo offerto, per la nascita dell’impero, da A.J. Spalinger fra la nascita dell’impero
Egiziano nel nuovo regno, e la Spagna dei Reyes Catolicos: “In many ways it is as if we
were seeing the sudden alteration of the military arm of Spain far later in AD 1492. In that
year the last remnant of Moorish control ended in the Iberian Peninsula. With the conquest
of Granada, what could the two Catholic rulers of Spain do? Originally, they planned to
attack and subdue Morocco. Suddenly, a grand vista of gold and land opened their eyes to
the possibility of a new direction, the west.(…) Equally, what could the Pharaoh
accomplish with his resilient and bellicose army after the fall of Avaris? “4. Dopo la
conquista di Avaris, sostiene, l’unico modo in cui il faraone avrebbe potuto utilizzare il
proprio esercito era continuare le guerre. Una volta creato l’impero per poter sostenere
l’esercito, divenne necessario mantenere le armate per garantire l’esistenza dei
possedimenti asiatici. Si rese inevitabile la presenza massiccia in loco di soldati in grado di
controllare i vassalli, pacificarne le lotte intestine, e respingere le mire delle altre potenze.
Gli Hittiti erano il grande avversario degli Egiziani, anch’essi un regno regionale assurto
ad impero e fornito di velleità di conquista. Come e più degli egiziani, però, avevano il
problema dei nomadi: i monti a nord della piana dell’Halys, infatti, per secoli pullularono
di Kashka, una popolazione seminomade dedita alla razzia. Ugarit, invece, aveva delle
necessità militari che dovevano essere legate tanto alla sua relazione con gli Hittiti, quanto
alla difesa delle proprie rotte ed interessi commerciali. Un grande problema dovevano
essere le bande di nomadi e transfughi che si erano stabilite nelle zone di confine e che
minacciavano i commerci, necessitando di un costante utilizzo di forze di “polizia”5 per
essere contenute.
Il secondo capitolo è stato incentrato sull’analisi della guerra, con l’obbiettivo di
individuare il ruolo degli Shardana nell’ars pugnandi dell’epoca. I rapporti –in primis
quelli bellici- che intercorrevano fra le popolazioni vicino-orientali rispondevano infatti a
delle codificazioni precise e determinate, alle quale un re, per poter essere considerato
“civile”, doveva attenersi. La guerra fra stati sviluppati era dunque tecnologicamente
avanzata, combattuta principalmente fra reparti di carreria la cui creazione era tanto
4 A.J. Spalinger (2005) p.48 5 Oren (2000) p. 7
88
costosa quanto conveniente: sulle grandi pianure del Levante, un esercito - anche uno di
notevoli dimensioni- composto da fanti ma privo di carri sarebbe stato infatti alla mercé
delle frecce nemiche, colpito da lontano da nemici troppo rapidi per poter essere
efficacemente combattuti. Uno scontro fra carri, invece, doveva essere la norma: cariche in
cui dei maryannu, gli uni contro gli altri, cercavano di trafiggere l’auriga o l’arciere
nemico è probabile che non fossero uno spettacolo inusuale. Ma poiché raramente la
freccia uccideva al primo colpo, e molto più spesso fermava o faceva cadere dal carro i
guerrieri, era necessario l’utilizzo di pḥrr, “corridori”, fanti che li uccidessero, o li
prendessero prigionieri. Questi uomini dovevano essere veloci –per cercare di tenere il
passo coi carri- e dotati di capacità belliche fuori dal comune, soprattutto per quanto
riguardava la guerra di mischia e lo scontro corpo a corpo. Lo Shardana, privo di armature
a parte il suo elmo a calotta, fornito della sua spada –insolita nel mondo vicino-orientale- e
il suo piccolo scudo rotondo aveva le caratteristiche necessarie a svolgere questo ruolo.
Le guerre contro i nomadi e le popolazioni esterne al mondo palaziale necessitavano però
di un tipo di combattimento diverso: privi dei mezzi economici per mantenere delle armate
di maryannu, è probabile che popolazioni come i Sutei e gli Shasu combattessero in
piccole bande di guerrieri basate, più che sulla tattica militare, sul valore del singolo6. Ma
mentre, come già affermato, in pianura gruppi di fanti sarebbero stati inermi di fronte ai
carri, simili combattenti sarebbero stati difficilmente sconfiggibili su terreni –come quelli
montuosi- dove i maryannu non avrebbero potuto spingersi. E, di nuovo, lo Shardana
avrebbe potuto sfruttare le proprie capacità per combattere questi nemici sul terreno della
valentia personale. Il termine egiziano bštw infatti indicherebbe una sorta di ferocia nello
scontro fisico, una “turbolenza” che sarebbe stata alquanto utile nell’ambito di questi
scontri.
Il terzo capitolo infine è stato incentrato sulle notizie storicamente a nostra disposizione
riguardo gli Shardana, cercando una conferma alla teoria precedentemente formulata. Si
può affermare che le fonti, nel peggiore dei casi, non smentiscano questa teoria. A Biblo –
dove sono attestati dalle lettere amarniane- abbiamo notizia di uno Shardana combattere e
morire contro dei Sutei. Ad Ugarit è possibile che fossero impiegati come scorta per le
carovane commerciali, preda di continui attacchi da parte di bande di predoni. Infine, in
Egitto, gli Shardana erano uno dei corpi di mercenari più importanti: ricordati
6 J.Vidal (2010) p.95
89
continuamente dalle fonti, presentati –soprattutto a Qadesh- come pḥrr, inseriti nella
guardia personale del faraone, erano una parte importante dell’esercito egiziano.
In conclusione, è possibile dire che gli Shardana fossero una necessità tattica per I paesi del
Levante. La loro particolare tecnica bellica era sconosciuta al mondo siro-palestinese ed
egiziano, i quali non sembra possedessero nulla di simile alla loro “turbolenza”. La lunga
spada, il piccolo scudo, erano le parti principali dell’armatura di un guerriero dalle rare
abilità nella guerra di mischia e nella velocità, abilità che sarebbe stato difficile e costoso
ottenere dal popolo egiziano, e che era più semplice ed economico reperire nei mercenari.
In combinazione con i carristi e gli archi compositi, gli Shardana erano l’arma perfetta per
la guerra del tardo bronzo. Non è senza ragione che, nel papiro Harrys, Ramses III si vantò
di avere “Sherden and Kehek without number””7.
7 Traduzione da A.Gardiner (Egypt 293 4.10) In Drews (1993) p. 154
90
Appendice:
Gli Shardana in Medio Oriente a seguito della catastrofe
Le rovine di Akko si trovano a circa 13 chilometri a nord della moderna città di Haifa8. In
Egitto la città è già menzionata nei testi di esecrazione del XIX e XVIII secolo9, e
sappiamo che fu fortificata la prima volta – la prima di molte altre- nel Medio Bronzo10.
Nel periodo successivo fu un centro di media grandezza -fra i trenta e i cinquanta acri di
estensione11- ed un importante centro economico e militare. Sita su di un colle a 700 metri
dalla battigia, l’altezza del luogo -35 metri sul livello del mare- le concedeva il controllo
visivo a 360 gradi sul Mediterraneo e sull’entroterra12. La posizione felice -vicina alla
costa, in un golfo naturale, terminale di diverse strade commerciali per l’entroterra13 ed
inserita nella via commerciale che dall’Egitto portava alla Siria14- giocò un importante
apporto nella crescita economica della città, tanto che si pensa avesse un’intera colonia di
agenti commerciali nel porto di Ugarit15. Akko compare poi fra le conquiste elencate da
Thutmosis III a Karnak16 ed è menzionata tredici volte nelle lettere Amarniane, dove
appare come base navale egiziana e centro di raccolta scorte dell’esercito del faraone17.
Nel Tardo Bronzo, la città, pur mantenendo rapporti commerciali col resto del mondo
mediterraneo, visse un declino che si si concluse solo fra il 1200 e 100018, quando fu
distrutta dall’ondata degli invasori.
Gli scavi archeologici condotti dal 1973 al 1983 dai ricercatori dell’Università di Haifa,
sotto la guida del professor Moshe Dothan, hanno portato a pensare che la città, nella
prima età del ferro, fosse dimora degli Shardana (anche se alcuni studi recenti, più cauti,
non si spingono fino a dire di quale popolo del mare si tratti19). Subito dopo la fine della
8 J.C.H. Laughlin (2006) P. 9 9 M.Dothan, (1976) p.1 10 J.C.H Laughlin (2006) P. 11 11 J.C.H. Laughlin (2006) P. 9 12M.Dothan, (1976) p.1 13 T. Dothan- M. Dothan(1992) p. 211 14 M. Dothan (1986) p.105 15 T. Dothan- M. Dothan(1992) p. 211 16 M.Dothan, (1976) p.1 17 T. Dothan- M. Dothan(1992) p. 211 18 J.C.H Laughlin (2006) P. 12 19 J.C.H Laughlin (2006) P. 12
91
città dell’età del bronzo, una nuova popolazione arrivò ad Akko ed utilizzò molti fra gli
edifici preesistenti 20.Vi è stato trovato infatti, in un’area non fortificata (con ogni
probabilità dedicata alla produzione del ferro), un gran numero di pezzi di ceramica di tipo
Miceneo IIIC:1b. È, questo, un tipo di ceramica che è stato trovato ovunque nel
mediterraneo, e soprattutto negli strati successivi ai livelli di distruzione attribuiti a questi
invasori21. Nel Levante queste ceramiche sono state ritrovate in un’area alquanto estesa
che va dalla Cilicia, con la città di Tarso, alle città palestinesi all’interno dei confini
egiziani ed a Cipro. È stata trovata – in strati che potrebbero essere attribuibili a un periodo
antecedente all’invasione dei Popoli del Mare- anche nelle vicine città di Ashdod e di
Dor22.
Concorde con i ritrovamenti ceramici è l’interpretazione che è stata data ad un altare della
stessa epoca, su cui era stata incisa, con tecniche e sistemi diversi, la sagoma di alcune
navi. Il professor M. Artzy ha tentato di operare un confronto fra questa rozza
raffigurazione e quelle di imbarcazioni coeve provenienti da tutto il mediterraneo
occidentale, senza trovare nessuna corrispondenza certa, a parte una somiglianza – la
curvatura della poppa- con alcuni modellini conservati al museo di Nicosia23, provenienti
da un periodo –a cavallo fra XII ed XI secolo- in cui l’isola con tutta probabilità era in
mano ai popoli del mare24 (si ricordi come il sito di Larnaca (l’antica Kition) presenta
evidenze di una invasione e distruzione alla fine del XIII secolo da parte di popolazioni di
origine egea, stabilitesi subito dopo25). Appare quindi possibile pensare, seppur con poche
prove a supporto, che la nave diversa da tutte le altre sia una delle imbarcazioni dei popoli
del mare, ulteriore indizio ad uno stabilirsi Shardana nella zona di Akko a seguito della
catastrofe.
Dal punto di vista delle fonti storiografiche invece, mentre la Bibbia non sembra conoscere
nessun popolo del mare eccettuati i Peleset-Filistei, sappiamo –anche se pochi documenti
sono arrivati ad essere a disposizione degli studiosi moderni- che gli egiziani distinguevano
le varie etnie stanziatesi in Palestina. Uno di questi è l’Onomasticon di Amenope, una
elencazione di stampo enciclopedico di –fra le altre cose- elementi naturali, popoli stranieri
e città26. Il secondo è il rapporto di Wenamun (forse scritto dalla stessa mano di una copia
20 Stern in Oren (2000) p. 204 21 M.Dothan (1986) p.105 22 M.Dothan (1986) p.107 23 M.Artzy (1987) p. 81 24 M.Artzy (1987) p. 82 25 Cambridge (2008) p. 370 26 T. Dothan- M. Dothan(1992) p. 210
92
dell’Onomasticon 27) un documento in ieratico databile alla fine della XX dinastia, unica
attestazione dell’XI secolo che riguardi i rapporti fra l’Egitto e il Levante28.
L’Onomasticon indica i Peleset quali abitanti di Gaza, Ascalona ed Ashdod, e, in una lista
separata di comunità etniche, dice che Shardana, Shekelesh e Filistei erano stanziati in
territori della costa Caananea. Il rapporto di Wenamun, invece, racconta il viaggio di un
sacerdote di Amon verso Biblo, presentando gli Shekelesh come abitanti nella città di
Dor29. Ergo, poiché nell’Onomasticon i popoli sono elencati da Nord a Sud (Shardana-
Shekelesh-Peleset) 30, e poiché possiamo indicare con certezza che i Filistei abitavano
Ashdod ed i Shekelesh Dor, è ragionevole dedurre che gli abitanti di Akko fossero gli
Shardana.
Ci si è chiesti però come mai Shekelesh e Shardana, se davvero erano presenti nella costa
di Canaan nella prima età del bronzo, non siano nominati per nome nella Bibbia. Sono
state date diverse spiegazioni: secondo alcuni potrebbero essere stati assorbiti dalla
popolazione preesistente in poche generazioni, secondo altri invece dovremmo ricercarne
la ragione nel fatto che la Bibbia sarebbe una descrizione del mondo così come si
presentava agli occhi degli israeliti, e quindi nell’ambito di uno scontro con i filistei, altri
popoli numericamente meno importanti sarebbero stati “marginali” e quindi “coperti” dal
nome del gruppo egemone31.
27 C.F. Nims (1950) p.254 28 M. Weinstein 1977 p.78 29 Machinist in Oren (2000) p.65, T. Dothan- M. Dothan(1992) p. 210 30 M.Dothan (1986) p.108, Stern in Oren (2000) p. 198 31 Machinist i in Oren (2000) p. 66
94
Tavola 2: Guerrieri Shardana a Medinet Habu.
Tavola 3: Un pḥrr Shardana taglia la mano a un nemico caduto a Qadesh.
96
Tavola 5, Shardana al servizio del re egiziano attacca i donne e bambini filistei
Tavola 6: Shardana al servizio del re egiziano attacca un carro di Peleset.
97
Bibliografia
1. AA.VV., The Cambridge Ancient History Cambridge 2008
2. Artzy M., On boats and Sea Peoples, in BASOR 266 (1987) pp.75-84
3. Artzy M., The Carmel Coast during the Second Part of the Late Bronze Age: A
Center for Eastern Mediterranean Transshipping, in BASOR 343 (2006) pp.45-64
4. Astour M.C., New evidence on the Last Days of Ugarit, in AJA, (1965), pp. 253-
258
5. Beal R.H., The Organization of the Hittite Military, Heidelberg 1992
6. Bemporad A., Considerazioni sulla fine dell’impero ittita, in Kaskal 3 (2006)
pp.69-80
7. Bryce T., Life and Society in the Hittite World Oxford 2002
8. Bryce T., Lukka Revisited, in JNES 51, 2 (1992), pp.121-130
9. Bryce T., The Kingdoms of the Hittites Oxford 2005
10. Bunnens G., I Filistei e le invasioni dei Popoli del Mare, in “Le origini dei Greci:
Dori e Mondo Egeo” a cura di D. Musti, Roma-Bari 1985
11. Cavillier G., Gli Shardana dell’Egitto o l’Egitto degli Shardana? La visione del
mercenario nell’Egitto ramesside, in Aegyptus anno 82, 1/2 (2002) pp.67-90
12. Cavillier G., Gli Shardana nell’Egitto Ramesside Oxford 2005
13. Cifola B. Ramses III and the Sea Peoples: A structural analysis of the Medinet
Habu inscriptions, in Orientalia 57 (1988) pp.275-306
14. Cifola B., The terminology of Ramses III’s historical records, with a formal
analysis of the war Scenes, in Orientalia 60 (1991) pp.9-57
15. Cross, F. M., Phoenicians in the west: the early epigraphic evidence in Studies in
Sardinian Archaeology II: Sardinia in the Mediterranean (1986) pp.117
16. Darnell J.C. - Manassa C., Tutankhamun’s Armies Hobokey, NJ, 2007
17. Dawson D., The origins of War, Biological and Anthropological Theories in
History and Theory 35 N. 1 (1996)
18. De Martino S., Gli Hittiti Roma 2009
19. Del Monte, G. F., L’annalistica Hittita, Brescia 1993
98
20. Dietrich M. – Loretz O., Die Shardana in den Texten von Ugarit, in Antike und
Universalgeschichte: Festchrift Hans Erich Stier pp. 39-42 Munster, 1972
21. Dothan M., Akko: Interim Excavation Report First Season, 1973/4 in BASOR 224
(1976) pp.1-48
22. Dothan M., Shardina at Akko?, in Studies in Sardinian Archaeology Vol.II:
Sardinia in the Mediterranean (1986) pp. 105-116
23. Dothan T. –Dothan M, People of the Sea, The Search for the Philistines New York
1992
24. Dothan T., Archaeological Evidence for Movements of the Early “Sea People in
Canaan” in Seymour Gitin and William G. Dever Recent Excavations in Israel:
Studies in Iron Age Archaeology( 1989), pp. 59-70
25. Drews R., Medinet Habu: Oxcarts, Ships, and Migration Theories, in JNES, 59,
(2000) pp.161-190
26. Drews R., The end of the Bronze Age: Changes in warfare and the Catastrophe AC.
1200 B.C. Princeton 1993
27. Faulkner R.O., Egyptian Military Organization, in JEA, 39 (1953) pp. 32-47
28. Frank A.G., Bronze Age World System Cycles, in “Current Anthropology” 34
(1993), pp.539-567
29. Gardiner A. Adoption Extraordinary, in JEA 26 (1941) pp.23-29
30. Gardiner A. The Kadesh inscriptions of Ramesses II Oxford 1960
31. Garr W.R., A Population Estimate of Ancient Ugarit, in BASOR, 266 (1987) pp.
31-43
32. Gilboa A., Sea Peoples and Phoenicians along the Southern Phoenician Coast: a
Reconciliation. An interpretation of Sikila (SKL) material culture, in BASOR 337
(2005) pp. 47-78
33. Gordon D.H., Swords, Rapiers and Horse-riders in Antiquity, 27 (1953) pp. 67-78
34. Gorny, R.L. Environment, Archaeology, and History in Hittite Anatolia in “The
Biblical Archaeologist” 52, (1989), pp. 78-96
35. Grimal N., Storia dell’antico Egitto Paris 1988
36. Heltzer M., Some questions concerning the Sherdana in Ugarit, in Israel Oriental
Studies 9 (1979) pp.9-16
37. Heltzer M., The Internal Organization of the Kingdom of Ugarit, Wiesbaden 1982
99
38. Hiller S., È esistita una cultura dorica nella tarda età del Bronzo? Il problema
delle testimonianze archeologiche, in “Le origini dei Greci: Dori e Mondo Egeo” a
cura di D. Musti, Roma-Bari 1985
39. Keegan J., La grande storia della guerra, Mondadori, Milano 1994
40. Kilian K., La caduta dei palazzi micenei continentali: aspetti archeologici, in “Le
origini dei Greci: Dori e Mondo Egeo” a cura di D. Musti, Roma-Bari 1985
41. Knapp B., The Archaeology of Late Bronze Age Cypriot Society Glasgow 1997
42. Laughlin J.C.H., Fifty Major Cities in the Bible, From Dan to Beersheba, New
York 2006
43. Lilliu G., La civiltà nuragica, Sassari 1982
44. Littauer M. A., The military Use of the Chariot in the Aegean in the Late Bronze
Age, in AJA, 76 (1972) pp. 145-157
45. Liverani M, il corpo di guardia del palazzo di Ugarit, in Rivista Degli Studi
Orientali 44 (1969) pp.191-198
46. Liverani M., Antico Oriente: Storia, Società Economia Roma-Bari 1991
47. Liverani M., Guerra e diplomazia nell’antico Oriente, 1600 – 1100 A.C.Roma-Bari
1994
48. Liverani M., Guerra santa e guerra giusta nel Vicino Oriente antico Circa 1600-
600 a.C., in Studi Storici Anno 43, (2002) pp.639-659
49. Liverani M., La chêne de Sherdanu, in Vetus Testamentum 277, (1977) pp. 212-
216
50. Liverani M., Le Lettere di el-Amarna, 1: Le lettere dei “Piccoli Re” Brescia 1999
51. Liverani M., Le Lettere di el-Amarna, 2: Le lettere dei “Grandi Re” Brescia 1999
52. Liverani M., Hattushili alle prese con la propaganda ramesside, in Orientalia 59
(1990) pp.207-217
53. Loretz, O., Les Serdanu et la fin d’Ougarit, in M.Yon – M. Szinycer- P.Bordreuil
“Le pays d’Ougarit- Actes du Colloque international Paris 28 juin-1er juillet 1993”,
Paris 1995
54. Maxwell –Hyslop R., Dagger and Swords in Western Asia: A Study from
Prehistoric Times to 600 B.C., in Iraq, 8 (1946) pp.1-65
55. Mc Leod W., Composite Bows from the tomb of Tuthankamon in Harris J.R.
Tuthankamun’s Tomb Series Oxford 1970
56. Miller J.L., Amarna Age Chronology and the Identity of Nibhururiya in the Light of
a Newly Reconstructed Hittite Text, in Altoriental. Forsch. 34 (2007), 252–293
100
57. Molloy B.P.C., For Gods or Men? A Reappraisal of the Function of European
Bronze Age Shields. In Antiquity 83 (2009) pp. 1052-64.
58. Molloy B.P.C., Swords and Swordsmanship in the Aegean Bronze Age in American
Journal of Archaeology, 114, (2010) pp. 403-428
59. Nims C.F., Egyptian Catalogues of Things, in JNES 9 (1950) pp. 253-262
60. Oren E.D., The Sea People and Their World: A Reassessment Philadelphia 2000
61. Pecchioli Daddi F. –Guidotti M.C., La Battaglia di Qadesh, Ramesse II contro gli
Hittiti alla conquista della Siria Livorno 2002
62. Pecchioli Daddi F. –Guidotti M.C., Narrare gli Eventi, Atti del convegno degli
Egittologi e degli orientalisti italiani Roma 2005
63. Rainey A.F., The Kingdom of Ugarit, in “The Biblical Archaeologist”, 28, (1965)
pp.101-125
64. Rainey A.F., The Military Personnel of Ugarit in JNES 24, (1965) pp.17-27
65. Salvini M.–Vagnetti L., Una spade di tipo Egeo da Bogazkoy, in “La Parola del
Passato”, XLIX (1994) pp.215-236
66. Sandars N.K., Later Aegean Bronze Swords, in AJA 67 (1963) pp.117-153
67. Sandars N.K., The First Aegean Swords and their Ancestry, in AJA 65 (1961) pp.
17-29
68. Sandars N.K., The Sea Peoples: Warriors of the Ancient Mediterranean London
1985
69. Santosuosso A., Kadesh Revisited: Reconstructing the Battle between the Egyptians
and the Hittites, in “The Journal of Military History”, 60 (1996), pp. 423-444
70. Schaeffer C.F.A A Bronze Sword from Ugarit with Cartouche of Mineptah (Ras
Shamra, Syria) in Antiquity 29 (1955) pp.226-229
71. Schulman A.R., Some Observations on the Military Background of the Amarna
Period, in JARCE 3 (1964) pp.51-69
72. Schulman A.R., The Egyptian Chariotry: A Reexamination, in JARCE 2 (1963),
pp.75-98
73. Shaw I., Egyptian Warfare and Weapons Haverfordwest 1991
74. Singer I. Western Anatolia in the Thirteenth Century B.C. According to the Hittite
Sources in “Anatolian Studies” 33 (1983) pp. 205-217
75. Spalinger A.J., War in Ancient Egypt Oxford 2005
76. Speidel M.P. Berserks: A Histyory of Indo-european “Mad Warriors” in JWH 13
(2002), pp.253-290
101
77. Stillman N.-Tallis N., Armies of the Ancient Near East- 3000 BC to 539 BC
Worthing, Sussex, 1984
78. Sweeney D. – Yasur-Landau A., Following the path of the Sea Persons: The
women in the Medinet Habu Reliefs,in Tel Aviv 26, (1999) pp.116-145
79. Tirard H.M., The soldiers of Ancient Egypt, in JEA, 2 (1915) pp. 229-233
80. Tubb J.N. The role of the Sea Peoples in the bronze industry of
Palestine/TranJordan in the Late Bronze Age – Early Iron Age transition in
“Bronzeworking centers of Western Asia c.1000-539 B.C.” a cura di J. Curtis,
London 1988
81. Tubb J.N., An Aegean presence in Egypto-Canaan, in “Egypt, the Aegean and the
Levant” a cura di W.V. Davies e L.Schofield, London 1995
82. Van De Mieroop M., A history of the Ancient Near East ca.3000-323 BC London
2007
83. Vidal J. Sutean warfare in the Amarna Letters in “Studies on War in the Ancient
Near East” (AOAT 372) a cura di Vidal J., Munster 2010
84. Vita J.P. El Ejército de Ugarit, Madrid 1995
85. Wainwright G.A Merneptah’s Aid to the Hittites, in JEA, 46 (1960) pp. 24-28
86. Wainwright G.A Some Early Philistine History, in Vetus Testamentum, 9, (1959)
pp. 73-84
87. Wainwright G.A Some Sea Peoples, in JEA, 47 (1961) pp. 71-90
88. Wainwright G.A The Meshwesh, in JEA, 48 (1962), pp. 89-99
89. Wainwright G.A The Teresh, the Etruscans and Asia Minor, in Anatolian studies 9
(1959) pp. 197-213
90. Wainwright G.A., Some Sea Peoples and Others in the Hittite Archives, in JEA, 25,
(1939) pp.148-153
91. Ward W.A. – Joukowsky M.S., The Crisis Years: The 12th century B.C. From
beyond the Danube to the Tigris, Dubuque 1989
92. Watson W.G.E. –Wyatt N., Handbook of Ugaritic Studies, Boston 1999
93. Weinstein J.M., Review to Goedicke H., The Report of Wenamun, in BASOR 225
(1977) pp. 78-80
94. Yadin Y., The art of Warfare in Biblical Lands Jerusalem 1963
95. Yalichev S., Mercenaries of Ancient World London 1997
102
96. Yasur-Landau A., On Birds and Dragons: A note on the Sea Peoples and
Mycenaean Ships, in Pax Hethitica, Studies in Honor of Itamar Singer, Wiesbaden
2010
97. Yasur-Landau A., The Philistines and the Aegean Migration at the end of the Late
Bronze Age Cambridge (2010)
Fonti delle Tavole:
Tavola 1: N.K.Sandars (1985)p. 15
Tavola 2: N.K.Sandars (1985)p. 34 (foto 14)
Tavola 3: N.K.Sandars (1985)p. 35 (foto 15)
Tavola 4: N.K.Sandars (1985)p. 126-127 Tavola 80
Tavola 5: Sweeney D. – Yasur-Landau A. (1999) p.119 tavola 1
Tavola 6: Sweeney D. – Yasur-Landau A. (1999) p.119 tavola 2
Lista delle Abbreviazioni di Giornali, Periodici e Serie
AJA: American Journal of Archaeology
BASOR: Bulletin of the American Schools of Oriental Research
JARCE: Journal of the American Research Center in Egypt
JEA: Journal of Egyptian Archaeology
JNES: Journal of Near Eastern Studies
JWH: Journal of World History