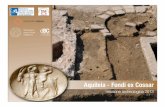LA VIA DELLA "PIETRA VERDE". ll territorio di Piadena tra Neolitico ed Età del Bronzo
F. BENENTE, San Nicolao di Pietra Colice. Introduzione allo scavo e all’area archeologica,...
Transcript of F. BENENTE, San Nicolao di Pietra Colice. Introduzione allo scavo e all’area archeologica,...
Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione TigulliaSoprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
Comune di Castiglione Chiavarese
San Nicolao di Pietra Colice
Introduzione agli scavi e all’area archeologica
Fabrizio Benente
Chiavari 2008
Testi diF. Benente
N. Campana - C. Pittera
RedazioneFabrizio BenenteDaniela OlceseRenato Lagomarsino
Progetto grafico e impaginazioneFabrizio Benente
Referenze iconograficheArchivio Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Tigullia;Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria;Nadia Campana, Fabrizio Benente.Fig. 40 da Ad Mensam, Udine 1994, p.442; fig. 51: da “Medioevo”, n.1 (36),2000, p.8; fig. 53: da QUIRÒS-CASTILLO 2000, p.175. Immagine di copertinarielaborata da: Pellegrini in cammino. Madonna del Parto - Sutri (VT).
Le riproduzioni delle immagini di scavo e dei reperti sono state effettuatesu concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprinten-denza per i Beni Archeologici della Liguria.
Il presente lavoro è stato elaborato nel quadro di un progetto di ricerca,quale strumento didattico e divulgativo. Esso non configura fini di lucro.Si rimane a disposizione per gli eventuali diritti sulle immagini.
Il volume è edito con il contributo diRegione LiguriaProvincia di GenovaProvincia della SpeziaComunità Montana Val PetronioComuni di: Carro, Casarza Ligure,Deiva Marina, Moneglia, Carrodano.
StampaGrafica Piemme - Via Parma 356 - 16043 Chiavari© 2008 - Istituto Internazionale di Studi Liguri - Bordighera
Ascendendo da Lagorara sulla strada romea, sidà nel pericoloso passo nominato Pietra Crosora,ossia Pietra Collica, e poi si dà in una regione no-minata Vasa piena di castagneti e alberi silvestri.
*Agostino Giustiniani
Le condizioni ambientali sono decisamente pocofavorevoli, sia per l’abbondanza delle macerie, checostringono ad un pesante lavoro preparatorio disgombero, sia perchè tutta la zona è coperta daun fitto bosco di giovani castagni selvatici e da unintricato sottobosco. Unico elemento positivo e diindiscutibile evidenza, i resti delle tre curveabsidali della chiesa...
**Leopoldo Cimaschi
Comunque si avviò nella piccola gelida chiesa disassi, piccola, dodici passi per giungere ai piedidel piccolo altare di quella specie di crocetriabsidale, e s’inginocchiò, ed era sola in quelmeraviglioso profumo di resine dei pini e soprat-tutto del loro miracoloso incenso, certamente rac-colto per le funzioni liturgiche. Rimase a lungoinginocchiata e forse pregò nel suo silenzio, o for-se continuò a peccare nel pensiero...
***Mario Dentone
*Castigatissimi Annalidella Repubblica di Genova,
Descrittione della Lyguria, 1537.
** Introduzione ai problemi archeologici etopografici di Pietra Colice, in “Giornale Storicodella Lunigiana”, n.s. Anno VIII, nn.1/2, 1957.
*** La Badessa di Chiavari, Genova 2007.
PRESENTAZIONI
FABIO MORCHIO, Assessorealla Cultura Regione Liguria........................................
GIOVANNA MARIA BACCI, Soprintendenteper i Beni Archeologici della Liguria..........................
FAUSTO FIGONE,Sindaco di Castiglione Chiavarese.............................
TESTI
FABRIZIO BENENTE
San Nicolao di Pietra Colice: introduzione al progetto diricerca...........................................................................
FABRIZIO BENENTE
Il sito archeologico di San Nicolao: evidenze archeolo-giche e architettoniche..................................................
FABRIZIO BENENTE
Fonti scritte e memoria orale...........................................
FABRIZIO BENENTE
Le indagini di Leopoldo Cimaschi e le ricerche degli anni‘80 e ‘90........................................................................
FABRIZIO BENENTE
Le campagne di scavo 2001-2008................................
NADIA CAMPANA
La frequentazione preistorica.......................................
FABRIZIO BENENTE
Lo scavo dell’ospedale..................................................
FABRIZIO BENENTE
Rileggendo lo scavo Cimaschi: le nuove indagini nellachiesa...........................................................................
FABRIZIO BENENTE
Sotto la protezione di San Nicolao: l’uso cimiteriale del-l’area...........................................................................
INDICE
6
7
9
10
14
18
23
27
29
35
39
41
Pag.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
4
CATERINA PITTERA
La tavola medievale: suppellettili da cucina, da mensae da dispensa...............................................................
FABRIZIO BENENTE
L’alimentazione: minestre e focaccette............................
FABRIZIO BENENTE
Utensili d’uso domestico, elementi d’abbigliamento,armi e monete...............................................................
FABRIZIO BENENTE
Viaggiare nel Medioevo: ospedali e locande, pellegrini,mercanti e soldati...........................................................
FABRIZIO BENENTE
I pellegrinaggi: archeologia e storia della mentalità me-dievale........................................................................
FABRIZIO BENENTE
Archeologia degli hospitalia in Liguria..........................
Bibliografia e approfondimenti.....................................
44
47
48
50
53
56
59
Pag.
»
»
»
»
»
»
5
Ragioni differenti, seppure fra loro strettamente correlate, hannoorientato la scelta operata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Li-guria di concedere il proprio sostegno al progetto di recupero e valorizzazionedell’area di scavo archeologico dell’ospedale medievale di San Nicolao diPietra Colice, destinato a costituire una delle emergenze più significativedell’Ecomuseo dell’Alta Val Petronio.
Innanzitutto la rilevanza scientifica di una indagine che ha radicilontane nel tempo e che riporta oggi in evidenza un’area considerata, neisecoli passati, un importante riferimento nella viabilità medievale per lapresenza di strutture di assistenza - fisica e spirituale - che ancora oggipossono testimoniare, nel recupero delle tracce sulla loro ragion d’essere,un diffuso ed incondizionato senso di cooperazione e di accoglienza, lungouna direttrice che conduceva gli individui ad una meta comune.Reminescenze di quella che, per molti, poteva rappresentare, allora, unametafora dell’esistenza. Per i nostri tempi, una proposta sospesa fra unaffascinante ma austero monito ed una invitante quanto inconsueta sug-gestione.
L’approfondimento e l’analisi sulle emergenze riportate alla luce,insieme con la riproposizione delle loro correlazioni, riaccendono poi, inun percorso virtuoso di reciproca alimentazione, le ragioni dell’interesseintorno ai manufatti mentre, d’altro canto, raccolgono la fisiologica preoc-cupazione sia sulla fruibilità dello scavo e sulla sua lettura, sia sulla di-vulgazione dei risultati raggiunti. In questo senso la visita del sito puòtrasformarsi in una occasione per catturare l’attenzione sul territorio efavorire la comprensione degli aspetti meno noti, anche perché più remoti,della storia locale.
San Nicolao ha già dimostrato, infatti, di poter ampiamentecatalizzare questa attenzione per avere ispirato una straordinaria e sinergicaazione di valorizzazione ai differenti soggetti che hanno partecipato al suorecupero, ognuno dei quali ha saputo contribuire, con un appropriatolivello istituzionale o scientifico - e grazie al partecipe e determinato coor-dinamento dell’Amministrazione locale - a raccogliere gli entusiasmi econcretizzarli, attraverso le differenti e particolari sensibilità, in una sti-molante, comune prospettiva.
Dr. Fabio MorchioAssessore alla Cultura, Sport, Spettacolo
Regione Liguria
PRESENTAZIONE
66
Il caso del sito archeologico di San Nicolao è un ottimo esempio di cor-retta applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio1 che harecentemente innovato, senza stravolgerla, la legislazione sul patrimonioarcheologico, architettonico, storico artistico e paesaggistico2. Recita l’ar-ticolo 3 del Codice che:“La tutela del patrimonio culturale consiste nell’eser-cizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di unaadeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonioculturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubbli-ca fruizione”.
Da questo accurato volume emerge chiaramente come il “Progetto SanNicolao”3 abbia messo in pratica il dettato di Legge in tempi brevi e a costicontenuti: fatto se non unico, certamente raro e, perciò, ancor più merite-vole. E’ stata condotta una (più che) adeguata attività conoscitiva, che haconsentito di individuare con precisione e dovizia di contenuti il patrimonioculturale del sito, e si sono elaborate azioni consone a garantirne (per quantorealisticamente consentito dalla particolare ubicazione geografica) la pro-tezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Non è pertanto casuale che la presentazione del libro che rende pubbli-ci gli esiti dello scavo archeologico di San Nicolao di Pietra Colice coincidacon l’inaugurazione dell’allestimento per la fruizione pubblica. Ed è stra-ordinario, felicemente straordinario, annotare che ciò avviene pochi mesidopo la conclusione dell’ultima campagna di scavo. Complimenti vivissi-mi, dunque, a Fabrizio Benente, ideatore e promotore dell’operazione, al-l’Istituto Internazionale di Studi Liguri che - con la sua tradizione e la suacapillare struttura territoriale - costruisce premesse grazie alle quali in-terventi “locali” vengono svolti con qualità assolutamente professionale.
Complimenti al Comune di Castiglione Chiavarese ed al suo Sindaco,che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto al massimo consentito dallerisorse di un Comune interno di ca. 1500 abitanti, ai quali i complimentivanno estesi per aver consentito tanta lungimiranza del loro rappresen-tante. Il “Progetto San Nicolao” non sarebbe diventato realtà senza gliinterventi dei competenti assessorati della Regione Liguria e delle Provin-ce di Genova e di La Spezia, della Comunità Montana Val Petronio e deiComuni di Carro, Carrodano, Casarza Ligure, Deiva e Moneglia; realtàamministrative odierne il cui territorio suggestivamente converge verso lalocalità del Monte San Nicolao, che da cinquemila anni svolge le specialifunzioni di luogo di sosta e di accampamento, di bivacco, di accoglienza edi ospitalità rivolte a genti anche molto lontane. Cito per ultimo l’Ufficioche ho l’onore di dirigere, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dellaLiguria, che fin dall’inizio ha sostenuto l’iniziativa, proponendo al superio-re Ministero la concessione delle autorizzazioni di scavo, ed ha altresì par-tecipato alle ricerche sul terreno con proprio personale tecnico.
L’azione che Enti pubblici e privati hanno svolto a San Nicolao ha difatto attuato anche altri principi del Codice, quali quelli espressi dall’arti-colo 5: Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali inmateria di tutela del patrimonio culturale e dal comma 2 dell’articolo 7: Il
PRESENTAZIONE
77
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordina-mento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione deibeni pubblici.
Qualche vena di preoccupazione è forse legata alle prospettive future.L’entusiasmo di molti e la consapevolezza di tutti hanno prodotto i risulta-ti che felicemente si celebrano, ma il giorno successivo alla festa inizia lagestione: impegno costante, quotidiano, talora meno gratificante. E’ ne-cessario che i soggetti coinvolti continuino ad operare con non minoreenergia e coesione. E’ necessario l’impegno costante e unitario di tuttiaffinché il molto lavoro che presto e bene è stato fatto eviti il rischio diirrimediabili perdite.
Genova, 19 agosto 2008
Giovanna Maria BacciSoprintendente per i beni archeologici
della Liguria
1Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive integrazioni D.Lgs 24
marzo 2006, n. 156 e D.Lgs 24 marzo 2006, n. 1572 Già oggetto di due famose leggi del 1939, la n. 1089 del 1° giugno: Tutela dellecose di interesse artistico e storico, e la n. 1497 del 29 giugno: Sulla protezionedelle bellezze naturali e panoramiche.3 Si intende qui il “progetto culturale” che ha guidato l’intera operazione.
8
Il recupero e la valorizzazione delle emergenze storico - culturalicostituisce un momento fondamentale nel percorso di una politica ammi-nistrativa attenta alla promozione del patrimonio territoriale, anche nel-la prospettiva di uno sviluppo dell’offerta turistica. Il sito di S. Nicolao diPietra Colice rappresenta una delle emergenze più importanti in questaprospettiva, e un’azione di recupero e valorizzazione è stata per il Comu-ne di Castiglione Chiavarese, fino dagli inizi delle campagne di scavo chesi sono succedute a partire dal 2001, un obiettivo da conseguire. La col-locazione del sito - situato al convergere di una serie di confini ammini-strativi e punto di confluenza di importanti percorsi viari, ma anche pun-to di riferimento nella viabilità medievale e quindi luogo di incontro digenti diverse in qualche modo legate da obiettivi e sensibilità comuni – hasuggerito e supportato l’idea di attualizzare questo suo ruolo attraversouna azione di recupero e valorizzazione intrapresa in sinergia con tutti isoggetti pubblici che a vario titolo fossero interessati al tema.
L’idea di raccogliere attorno al “ progetto S. Nicolao” l’azione di tuttauna serie di attori, che vanno dall’Assessorato alla Cultura della RegioneLiguria, agli Assessorati alla Cultura e Turismo delle Province di Genovae La Spezia, alla Comunità Montana Val Petronio, ai comuni limitrofi diCarro, Carrodano, Deiva Marina, Moneglia e Casarza Ligure, per la parteamministrativa (convinti del fatto che i confini culturali travalicano quelliamministrativi); alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguriaper la competenza istituzionale di tutela, e a settori del mondo universi-tario per il supporto scientifico - oltre, ovviamente, all’Istituto di StudiLiguri che aveva condotto le campagne di scavi- per verificare la fattibilitàdi un progetto di valorizzazione del sito, ha rappresentato per il Comunedi Castiglione Chiavarese una scommessa sulla possibilità di dar vita aduna sinergia virtuosa che consentisse la realizzazione del progetto.
Ritengo che questo percorso possa rappresentare un metodo di la-voro esportabile ed applicabile a tutta una serie di casi che si incontranonel multiforme panorama del recupero delle emergenze storico-culturalipresenti nell’ambito di un più vasto territorio, avendo dimostrato come lacollaborazione fra attori diversi e la sinergia fra diverse competenze ecapacità possano conseguire risultati altrimenti impensabili in un ap-proccio particolaristico. Il sito così ricuperato e “ musealizzato” va adinserirsi in un percorso eco-museale che lo colloca al fianco di una seriedi emergenze, quali il sito archeominerario di Monte Loreto, le grotte se-polcrali della Val Frascarese, il Museo Etnografico della Cultura Contadi-na di Velva, antichi mulini ad acqua, ecc., tutte collegate da una retesentieristica attrezzata che ne assicura una completa fruizione, consen-tendo una visione completa del paesaggio culturale del comprensorio,riproponendo così S. Nicolao di Pietra Colice, dopo svariati secoli di oblio,come punto di incontro di nuovi ma sempre suggestivi percorsi.
Fausto FigoneSindaco di Castiglione Chiavarese
PRESENTAZIONE
9
1. SAN NICOLAO DI PIETRA COLICE
INTRODUZIONE AL PROGETTO DI RICERCA
La scelta di condur-re un progetto di inda-gine storico archeologi-ca, che si è protrattoper ben otto anni, hacomportato un’attentavalutazione delle fina-lità e del contributo chela ricerca stessa avreb-be potuto portare allastoria del territorio e aiparticolari tematismiche la contraddistin-guono. Nell’archeologia“di ricerca” - voluta-mente distinta dall’ar-cheologia “di tutela” eda quella “di emergen-za” e “di salvataggio” -deve essere innanzitut-to ben motivata la scel-ta del sito da indagare;una scelta che devepartire da caratteristi-che peculiari di unici-tà, oppure di rappre-sentatività del sitostesso.
Nel percorso di ana-lisi archeologica terri-toriale non potremo,infatti, scavare tutti isiti individuati o indi-viduabili (tutte le chie-se, tutti i castelli, tuttii villaggi abbandonati,ecc.), ma dovremo ne-cessariamente optareper l’analisi di queicontesti che hanno ca-ratteristiche di unicitàrispetto agli altri, o perquelli che possono es-sere rappresentativi diuna globalità di atte-stazioni. Il quadro del-
le tematiche storiogra-fiche che vengono af-frontate con lo scavo diun sito archeologiconon è statico e immu-tabile, ma si sviluppacontinuamente con ilprogredire del lavoro diricerca.Valga propriol’esempio di San Nico-lao, dove l’imponentefase di occupazionemedievale - a cui sonostati dedicati i primi 6anni di ricerche - cela-va le stratigrafie di unafase di frequentazionepreistorica non menoimportante e ancorapotenzialmente ricca di
aspettative per i ricer-catori.
In questo tipo discenario operativo, idati ricavati dall’inda-gine di un sito archeo-logico dovranno esserecontinuamente con-frontati criticamentecon la griglia tematicadi riferimento, e po-tranno portare confer-me e contributi alla re-visione e alla ristruttu-razione dei percorsistessi della ricerca.
Nell’archeologia diricerca si investono ri-sorse umane ed econo-miche con un’opzione
Fig.1 - L’abside della chiesa di San Nicolao in una fotodei primi decenni del secolo scorso.
10
precisa per l’acquisizio-ne di dati scientifici,spendibili in un percor-so di ricostruzione sto-rica del passato. Sitratta della ricerca diuna conoscenza rica-vata “per via di tracce”- utilizzando l’espres-sione dello storico MarcBloch2 - tramite l’appli-cazione del metodoanalitico-deduttivo.Non si scava per cerca-re “oggetti” ma, in ter-mini più diretti, si uti-lizzano risorse econo-miche per ricavare “sa-pere”, tramite l’inter-pretazione di dati ma-teriali lasciati sul ter-reno da attività preva-lentemente antropiche,ossia di quelle tracceche una civiltà produ-ce e lascia poi dietro disè3. In questo percorsodi acquisizione di dati,devono, tuttavia, esse-re ben presenti i pro-blemi di conservazione,valorizzazione e tuteladel bene su cui si ope-ra e degli oggetti che siriportano alla luce.
L’indagine archeolo-gica è un’operazioneculturale che deve in-teressare il territorionella maniera più am-pia, con un ritorno im-mediato in termini diinformazioni e di datispendibili nella divul-gazione del sapere enella ricomposizionedella memoria storicadella collettività. Si do-vrebbe, quindi, opera-re partendo dal pre-supposto che il “sito”oggetto di indagine èinnanzitutto un beneculturale e - in quanto
tale - è patrimonio del-la collettività e non delsingolo ricercatore odella sola comunitàscientifica che ne curalo studio e la tutela.
Il percorso di ricer-ca che ha interessatol’ospedale di San Nico-lao di Pietra Colice par-te da lontano: dalleprime segnalazioni de-gli eruditi locali e dagliscavi in qualche modopionieristici condottida Leopoldo Cimaschinegli anni ’50. La co-
noscenza di questo sito(fig. 1) e la sua presen-za nella memoria sto-rica locale è legata aduna ben radicata tra-dizione devozionale4,ma è anche il risultatodelle operazioni di re-cupero e valorizzazionecondotte negli anni ’90.La scelta di avviare unanuova e ampia opera-zione d’indagine scien-tifica del sito dell’ospe-dale medievale di SanNicolao è stata già mo-tivata in altre sedi5,
Fig.2 - Attività di scavo e documentazione nel corso dellacampagna di indagini del 2006.
11
così come sono statedelineate le scelte me-todologiche e operativeche hanno cadenzato lediverse campagne discavo6. Ricordo, traqueste, l’opzione perl’utilizzo del sito di SanNicolao come cantieredidattico e laboratoriodi formazione per glistudenti di archeologiamedievale dell’ateneogenovese e di altre sediuniversitarie (figg. 2-3).
Nel 2005, a chiusu-ra di un articolo di sin-tesi sui i primi cinqueanni di ricerche, sotto-lineavo la necessità diavviare un dibattito sul“destino” del sito ar-cheologico, al terminedel progetto di indagi-ne e all’esito della ricer-ca stratigrafica7.
Proprio tenendopresenti questi elemen-
ti di riflessione, tra il2006 e il 2007, e gra-zie alla volontà dell’Amministrazione co-munale di CastiglioneChiavarese, sono stateposte le basi progettua-li per il percorso di va-lorizzazione del sito ar-cheologico.
Nel 2008, medianteil contributo economi-co di diversi Enti, si èdata concretezza alprogetto di musealizza-zione, con il consolida-mento delle strutturemurarie messe in lucedagli scavi, con la cre-azione di un percorsodi visita attrezzato, conl’avvio di un’opera didivulgazione e valoriz-zazione turistico-cultu-rale di cui questo volu-metto è una delle tap-pe.
Nella redazione del
presente lavoro, pro-prio per il carattere di-vulgativo che lo carat-terizza, si è scelto dipresentare un quadrogenerale e riassuntivodello stato della ricer-che, arricchito da alcu-ni approfondimenti te-matici.
Il testo può essereletto senza l’apportodell’apparato critico,ma l’ampia bibliografiaposta a chiusura delvolume e i rimandi con-fluiti nelle note offronoil corretto supporto,consentendo la possi-bilità di approfondi-menti di dettaglio. Ilcapitolo dedicato al-l’analisi della frequen-tazione preistorica delsito, condotta da NadiaCampana, costituiscel’ideale premessa alladescrizione delle fasi di
Fig.3 - Un momento dell’attività didattica nel corso della campagna di scavo 2006.
12
occupazione che - apartire dal III millennioa.C. - hanno interessa-to il sito di San Nico-lao.
Ampio spazio vienepoi dedicato agli aspettipiù rilevanti dell’occu-pazione medievale: lacostruzione della chie-sa e dell’ospedale e letecniche adottate; gliaspetti della vita quo-tidiana e le tracce ma-teriali lasciate daquanti hanno vissuto outilizzato il sito tra XIIIe XVI secolo; il temadella viabilità e dellestrutture di assistenzaai viandanti.
Ritengo doverosochiudere questa intro-duzione con alcuniringraziamenti. Nonposso, infatti, dimen-ticare l’impegno profu-so da quanti hannocollaborato al progettod’indagine, con preciseresponsabilità nellaconduzione della ricer-ca scientifica e, in par-ticolare: Gian BattistaGarbarino, DanielaConti, Roberto Codo-villa, Marzia Dentone,Alexander Parise, Fa-brizio Pastorino, NadiaPiombo, Sara Lassa(scavi 2001 - 2006);Nadia Campana, ElenaBesana e CaterinaPittera (scavi 2007-2008). Una parte dellavoro di elaborazionedei dati di scavo è sta-to svolto presso il Di-partimento di Scienzedell’Antichità, del Me-dioevo e Geografico-Ambientali (Disam)dell’Università degli
Studi di Genova,fruendo delle strutturee delle dotazioni infor-matiche a disposizionedella Cattedra di Arche-ologia Medievale.
La collaborazionedegli Autori, l’aiuto diDaniela e la tranquilli-tà della mia casa di Na-scio hanno contribuitoancora una volta a ren-dere celere il lavoro re-dazionale che sta allabase di questo volume;lavoro a cui ha parte-cipato con impegnoRenato Lagomarsino.
L’Istituto Interna-zionale di Studi Liguri- in particolare la Se-zione Tigullia ed il suopresidente GiovanniMennellla - ha soste-nuto l’intero progetto,curando gli aspettiscientifici dell’operazio-ne di valorizzazione delsito. La Soprintenden-za per i Beni Archeolo-gici della Liguria, conla dott.ssa Spadea e inparticolare il dott. Ro-berto Maggi e la dott.ssa Nadia Campana -hanno fornito un con-tributo fondamentaledi indirizzo che ha resopiù agevole e sicuro losvolgimento del lavoro.
Vittorio Allegri e Pa-ola Valdata con le re-dazioni del Secolo XIXe di Entella Tv hannoofferto ampio spazioinformativo agli scavi.
L’Amministrazionecomunale di Castiglio-ne Chiavarese, con ilsindaco Fausto Figoneha sostenuto il proget-to fin dal suo avvio e -come mi auguro - con-tinuerà a sostenere il
futuro del sito di SanNicolao, nel quadrodella costruzione e del-la gestione di un per-corso ecomuseale com-prensoriale che certa-mente restituisce aSan Nicolao e all’areadi Pietra Colice unacentralità “antica” e -insieme - un valore“moderno” di risorsaculturale per il territo-rio e per la collettività.
F. Benente
NOTE
1 Questo lavoro introdu-ce ai risultati delle cam-pagne di scavo 2001-2008. Le foto sono del-l’Archivio della Sez. Tigul-lia dell’Istituto Internazio-nale di Studi Liguri e sonostate realizzate principal-mente da F. Benente, R.Codovilla, F. Pastorino,D. Conti. Le piante e i di-segni originali o digitalisono stati elaborati da F.Benente, N. Piombo, A.Parise, F. Pastorino esono dell’Archivio dellaSez. Tigullia dell’IstitutoInternazionale di StudiLiguri.2 BLOCH 1969, p.63.3 Su questi temi, cfr.MANACORDA 2004, pp. 43-96.4 Prevalentemente con-servata tra gli abitanti deiComuni di CastiglioneChiavarese, di Carro e diCarrodano e delle frazio-ni di Mattarana ePavareto.5 BENENTE 2001a; BENENTE
2005.6 BENENTE ET ALII 2003a,BENENTE ET ALII 2003b.7 BENENTE 2005, pp.91-92.
13
2. IL SITO ARCHEOLOGICO DI SAN NICOLAO
EVIDENZE ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE
Le strutture super-stiti del complessoospitaliero di San Nico-lao di Pietra Colicesono ubicate sul ver-sante settentrionaledel Monte San Nicolao(847 m.), in vista dellaVal Petronio, su unpianoro ben riparato(792 m. slm.), prossi-mo alla “Foce” del SanNicolao e poco discostodalla sommità delmonte (figg. 4-5). L’in-sediamento è prossimoal Monte Pietra di Va-sca che, per la morfo-logia, per la parzialecontinuità toponimicae per il dettaglio pitto-rico scelto dai cartogra-
fi del XVIII secolo, po-trebbe essere indivi-duato come parte del-l’antica Petra Corice,menzionata nelle fontiscritte, a partire dal-l’VIII secolo. Il sito ri-sulta anche centralerispetto ad una viabili-tà di crinale “antica”,ancora ben leggibile ericostruibile sulla basedella cartografia stori-ca. Gli scavi archeolo-gici condotti da Leopol-do Cimaschi (1956-1959), gli interventicondotti dalla Soprin-tendenza per i BeniArcheologici della Ligu-ria e le campagne discavo condotte dal-
l’Istituto Internaziona-le di Studi Liguri(2001-2008) hanno po-sto in luce un comples-so (fig. 6) costituito dauna chiesa, da alcunivani ad essa appoggia-ti, da un’area cimiteria-le (ora interrata) e daun grande edificio/ospedale.
La chiesa di San Ni-colao (fig.6, Cf.1), limi-tatamente conservatain elevato, presentapianta “a tau”, costitu-ita da una navata uni-ca (m. 7,10 x 3,35) e daun transetto triabsida-to (m. 7,85). Le mura-ture sono in conci didifferenti litotipi (pre-
Fig.4 - L’area di San Nicolao e l’attuale rete viaria di accesso al sito.
14
valentemente calcare) ediverse dimensioni,squadrati e spianati.L’edificio disponeva didue accessi. Dell’in-gresso principale, po-sto in facciata, si con-servano alcuni deglielementi costitutivi (al-cuni conci e due men-sole) del portale origi-nale, rinvenuti nel ma-teriale di crollo duran-te gli scavi condotti daLeopoldo Cimaschi.
Un secondo e piùstretto accesso era po-sto nel lato nord dellanavata, in prossimitàdella congiunzione conil transetto. Un terzoaccesso si apriva nellato sud del transetto.Gli studi finora condot-ti sull’edificio di cultohanno proposto data-zioni al XII-XIII secolo,suggerendo confronti
planimetrici con edifi-ci regionali ed extrare-gionali e sottolineandola particolarità delloschema planimetrico -appunto la pianta “atau” - non molto diffu-sa e di solito adottatada ben precisi ordinireligiosi1.
L’analisi archeologi-ca delle strutture mu-rarie può portare ulte-riori contributi. Diffe-renze nella tecnica co-struttiva e nella mate-ria prima adottata sonoben leggibili tra la par-te nord del transetto(costruita con bloc-chetti regolari proba-bilmente prefabbricatiin cava e poi traspor-tati sul sito a dorso dimulo) e l’abside piùmeridionale, che im-piega anche un litoti-po scuro presente nel-
l’area come roccia dibase (serpentinite). Al-tre distinzioni si ri-scontrano nel para-mento esterno sud del-la navata, nel fronte enell’angolo n-w, che ri-sultano frutto di unaricostruzione. In so-stanza la “forma” at-tuale dell’edificio è ilfrutto di diversi inter-venti costruttivi succe-dutisi nel tempo.
Leopoldo Cimaschiha ipotizzato che unaconsistente fase di ri-strutturazione dellachiesa sia avvenutatra XVII e XVIII secolo(cfr. infra par. 4) e in-dicava anche una data- il 1754 - come annodi definitivo abbando-no della chiesa.
I dati degli scavi piùrecenti suggerisconoperò una certa caute-
Fig.5 - Ricostruzione della viabilità antica tra la Foce di Vasca e la Foce della Laggia(da LAGOMARSINO 2005).
15
Fig.6 - Schema planimetrico delle fasi costruttive degli edifici (corpi di fabbrica) per-tinenti alla fase di occupazione medievale del sito.
la, anche per la gene-rale mancanza di stra-tigrafie e di reperti as-sociabili ad una fre-quentazione di XVI-XVIII secolo. Nell’atte-sa del completamentodello studio archeologi-co sembra - piuttosto -che si debba prestareattenzione alla fase diutilizzo tardomedieva-le del complesso, ancheper il suo utilizzo cimi-teriale.
Al fianco nord deltransetto della chiesa,si appoggia un vano apianta rettangolare(fig.6, Cf. 4), costruitosopra ad un massicciobasamento, che reca alcentro un loculo sepol-crale (fig. 6, Cf. 5). Sitratta di strutture rea-lizzate in tempi diver-si. Il basamento è pre-esistente alla costru-
zione della chiesa è puòessere interpretatocome struttura di fon-dazione di un piccoloambiente a navata uni-ca, absidato. Questastruttura, forse un pri-mo oratorio, fu succes-sivamente spoliata eprivata dei conci delparamento. Il basa-mento conserva, infat-ti, soltanto il sacco del-la muratura (cfr. infra).
Il vano rettangolare,realizzato sopra al ba-samento (fig. 6, Cf.4)ha un paramento mu-rario simile a quellodella chiesa, ma risul-ta “posteriore” alla co-struzione del transetto.Si avanza l’ipotesi chesi tratti di un piccolocampanile, costruito intempi successivi ri-spetto alla chiesa. Que-sta struttura avrebbe
aumentato la visibilitàe la possibilità di “ri-chiamo” della chiesa edel complesso ospita-liero.
Al fianco sud del-l’edificio di culto si ad-dossa un locale di ca.30 mq. (fig. 6, Cf. 2)che, per rapporti stra-tigrafici e tecnica co-struttiva, è da ritenerepiù tardo della chiesaed è, quindi, pertinen-te alle fasi finali di vitadel complesso (XV-XVIsecolo). Nell’area a suddella chiesa e del loca-le annesso, le ricerchedi Leopoldo Cimaschiavevano già posto inluce alcuni muri peri-metrali pertinenti adun grande edificio/ospedale. La strutturaè stata l’oggetto princi-pale degli scavi 2001/2006 e il suo sviluppo
16
planimetrico è oggi benleggibile (fig. 6, Cf. 3).
La struttura conser-va una fase costrutti-va originale del XIV se-colo che presenta unapianta quadrangolare(ca. 120 mq) ed è leggi-bile nei muri nord, este sud e nella fondazio-ne del muro ovest. Gliscavi hanno permessodi comprendere chel‘attuale divisione in treampi locali di formarettangolare allungatae in un più limitato am-biente posto sul latosud è frutto di progres-sive riduzioni dello spa-zio interno originale(vedi infra, p. 36).
Le aree esterne po-ste ad est e ad ovestdegli edifici finora indi-viduati si configuranocome pianori di proba-bile formazione artifi-ciale, in parte interes-sati da apporti collu-viali provenienti dalversante che sovrastal’area. Gli scavi avviati
nell’area est hanno evi-denziato che durante lavita del complesso que-sta zona era adibita adun uso di tipo cimite-riale.
Nell’area ovest, am-pia e in leggerissimopendio, sono riconosci-bili diversi apporti dipietrame e di terreno dirisulta, accantonati
Figg.7 e 8 - Esempi di ricostruzioni tridimensionali del complesso. Si tratta di un lavoroin fase di continuo aggiornamento, sulla base dell’elaborazione dei dati di scavo.
durante gli scavi di Le-opoldo Cimaschi e nelcorso di successivi la-vori di sistemazionedell’area.
F. BENENTE
NOTE
1 CIMASCHI 1959, pp. 61-
62; CESCHI 1954; CAVANA
2005, pp.123-125.
17
A partire dal XIIIsecolo, l’ospitale di SanNicolao risulta menzio-nato nelle fonti scritteed è costantemente as-sociato al toponimoPietra Colice; localitàprossima al Passo delBracco, ampiamentecitata in documenticronologicamente an-teriori che ne testimo-niano un ruolo di cen-tralità rispetto alla via-bilità di origine roma-na e altomedievale1 .
Il toponimo PietraCorice è citato - per laprima volta - nel 774,quando compare nellacarta di donazione concui Carlo Magno con-cede al monastero diSan Colombano diBobbio l’Alpe Adra, os-sia un ampio possessofondiario ubicato nellaLiguria costiera (in Ma-rittima)2. Il diploma ca-rolingio testimonia iltransito di una via pu-blica nei pressi di que-sta località3 e tale pre-senza troverebbe con-ferma negli itineraristradali di epoca tardoimperiale e nella Tabu-la Peutingeriana4.
Leopoldo Cimaschie altri autori hannoipotizzato la presenzain zona di una mansiogià a partire dall’età ro-mana, facendo coinci-dere la menzione di inalpe Pennino e Apenni-
na con l’area poi occu-pata dall’ospedale diSan Nicolao5. Nel 1019,la “strada qui pergit aPorta Calese” è menzio-nata come limite con-finario in una conces-sione di terre dell’Ab-bazia di Santa Maria diPatrania6.
A partire dalla finedell’VIII secolo, quindi,l’esistenza di un itine-rario stradale di prima-ria importanza nellarete di collegamentodella Liguria orientaleinnescò strategie diriorganizzazione delpatrimonio fondiario edi controllo stradaleatte a garantire una ef-ficace gestione territo-riale.
Il primo documentoche - secondo alcuniautori - testimoniereb-be la presenza nei pres-si della località PietraColice di un insedia-mento a carattere reli-gioso risale all’anno1160. Nel documentosi menzionano terreposte nella pieve di La-vagna che erano ap-partenute a Gisle mo-nache de Petra Colexi7.
La menzione dellamonaca Gisla ha fattosupporre che nella lo-calità di Pietra Colicegià a partire dal XII se-colo esistesse un mo-nastero femminile, oun semplice romitorio,
ma alla luce del carat-tere laconico della cita-zione, si deve mantene-re una certa cautela8.
Le prime menzionidirette dell’ospedale diSan Nicolao risalgonoal XIII secolo e offronoinformazioni riguardoal nome di un rettore eal possesso di alcuneterre ubicate nel terri-torio di Mezzema. Unatto del 17 marzo 1222registra una vendita diterre effettuata dai co-niugi Dolce ed Arde-manno de Ave. Le ter-re oggetto della transa-zione sono site nel ter-ritorio di Mezzema econfinano con alcunifondi di proprietà del-l’ospedale di San Nico-lao “de Petra Colexi”9.
Nel 1225, troviamoprete Oberto, rettoredell’ospedale e dellachiesa di Pietra Colice,in grave dissidio conAdamo da Lemeglio,arciprete di Moneglia10.Lo stesso prete Obertorisulta attestato in al-tri documenti del1261-1262, proprio inqualità di rettore dellachiesa di San Nicolao11.A partire dal 1256 esino alla metà del XVIsecolo la gestione del-l’ospitale di San Nico-lao viene esercitatadalla chiesa di San Sal-vatore di Lavagna, sot-to il patronato della fa-
3. FONTI SCRITTE E MEMORIA ORALE
18
miglia dei Conti di La-vagna12. Il 16 agosto1256, papa AlessandroIV comunica al prepo-sito e ai canonici dellachiesa di San Salvato-re di Lavagna l’asse-gnazione dell’ospedaledi Pietra Colice, conl’oratorio annesso e contutti i diritti ad essopertinenti, inclusal’autorità di nominareil rettore e con l’obbli-go di pagare un censoannuo alla Sede Apo-stolica13.
Nel XIII secolo, laRepubblica genovesefortifica la sommità diPietra Colice e procedeall’allestimento di unpresidio militare, postoa poca distanza dalcomplesso ospedalieroe finalizzato al control-lo territoriale e viario.Tra le fortezze fatteispezionare dal gover-
no genovese nel 1245viene infatti censita larocca Petrecodicis e nel1250 il castrum Petre-colices14. Documentipiù tardi, databili tra il1426 e il 1464, testi-moniano la gestione eil continuo presidio delcastello di Pietra Coli-ce che - nello scenariopolitico militare del XVsecolo - sembra man-tenere la propria fun-zione strategica15.
Le ricognizioni ar-cheologiche condotte apartire dal 2001 han-no consentito di indi-viduare le tracce mate-riali di un fortilizio tar-do medievale sullasommità orientale delMonte Pietra di Va-sca16. Non risulta, in-vece, possibile verifica-re l’ipotesi formulatadal Cimaschi riguardoall’esistenza di una for-
tificazione sul MonteSan Nicolao17.
La sommità di que-st’ultimo rilievo è oggipesantemente occupa-ta da ripetitori televisi-vi, da una ex casermadi presidio e da altrestrutture che ne han-no limitato e forse an-nullato la leggibilitàarcheologica.
Tornando all’ospe-dale di San Nicolao, lefonti scritte del XIV edel XV secolo fornisco-no testimonianza di al-cuni provvedimentipresi da diversi rappre-sentanti della famigliaFieschi nella gestione enell’amministrazionedell’istituzione ospita-liera. Il riparto dellatassa imposta da PapaUrbano VI nel 1387 re-gistra un tributo di 6denari per l’ospitale dePetra Colice, per cui
Fig.9 - La vetta del monte Pietra di Vasca vista dal San Nicolao.
19
vengono confermatel’esenzione dalla giuri-sdizione pievana e ladiretta dipendenza dal-la Santa Sede18. Nelsettembre del 1446,Ludovico Fieschi e Spi-netto Malaspina - pro-curatori del capitolo edei patroni della chie-sa di San Salvatore diLavagna - revocano aprete Cristoforo de Bic-ci di Val di Taro la curadell’ospedale di SanMichele delle CentoCroci e dell’ospedale di
San Nicolao di PietraColice, sostituendoviprete Andrea di Coster-bosa di Val di Taro19.
Dal documento siricava anche che “procerta tempora dictumospitale (di San Nico-lao) fuerit a nonnullispersonis detentum etoccupatum”, ossia chele strutture erano ri-maste lungamente inabbandono20 .
Da questo e da suc-cessivi documenti, ri-sulta evidente che
ospedali e chiese inquesta fase non sonopiù attivi e vengonopiuttosto ceduti conpassaggi da un rettoreall’altro, probabilmen-te con il valore di sem-plici benefici ecclesia-stici. Il 22 luglio 1502,infatti, Napoleone edAgostino Fieschi, cano-nici della chiesa di SanSalvatore di Lavagna,dopo la morte di preteGiacomo Berici, asse-gnano a prete Antoniode Martinis le chiese edospedali di San Nicolaodi Pietra Colice, di SanMichele delle CentoCroci e di San Benedet-to di Aveno (Missano)21.
Nella seconda metàdel XVI secolo la chie-sa di San Salvatore diLavagna perse i propridiritti sull’ospedale diSan Nicolao; con attorisalente al 4 luglio del1577 l’Arcivescovo Ci-priano Pallavicino,dopo la morte di Cristo-foro Mottini, chiericodella diocesi di Luni-Sarzana e ultimo retto-re dell’ospedale di SanNicolao “de Petra Colo-sia, sive ut vulgo diciturdi Petra Crozia, situmiuxta viam publicam,nel territorio della po-desteria di CastiglioneChiavarese, decretache per sovvenire allenecessità del Semina-rio genovese l’ospedalevenga sottoposto conogni suo diritto e per-tinenza alla giurisdizio-ne economica del Se-minario stesso22.
Le fonti documenta-rie risalenti agli ultimianni del XVI secolo e
Fig.10 - La navata della chiesa durante la campagna discavo 2006. Si confronti l’immagine con quella di fig.11.
20
agli inizi del XVII testi-moniano come - su-bentrata la nuova am-ministrazione - l’ospi-tale di San Nicolao,nell’arco di appena tre-dici anni, dal 1577 al1590, cada in disuso ein rovina, oppure piùsemplicemente attesta-no uno stato di pro-gressivo degrado ormaiavviato da tempo23.
Da questo momen-to, la menzione dellachiesa è difficilmentereperibile nelle fonti ec-clesiastiche24, ma i re-sti del complesso - perla loro particolare po-sizione - diventano unatraccia topografica bendocumentata dalle fon-ti civili e laiche. Unadescrizione dei confinidella podesteria di Ca-stiglione Chiavaresedocumenta lo stato diconservazione del com-plesso nel 1590: “iltempio di San Nicolao…posto sopra la stra-da romea, a Levantedella sommità di PietraCrosa rispetto a dettastrada…nella giurisdi-zione di Framura ...di-strutto dalle antiquità…il quale ha il solo corointegro…”25.
La struttura, in se-guito alla sua decaden-za, si era anche trasfor-mata in un “…ricetacu-lo di uomini scellera-ti…”, nel quadro degliepisodi di brigantaggioche interessano l’areadi strada tra XVI e XVIIsecolo26.
La strada pubblica“romana” che collegaGenova a Sarzana è ri-cordata in una descri-
zione dei confini dellapodesteria di Castiglio-ne Chiavarese datataal 1601, in cui si pre-cisa che il confine ter-ritoriale è presso “..det-to Monte di Pietra Cro-sa sopra il vertice vici-no alla ruinata chiesadi Santo Nicherosio delVasco...”27. Nella rela-zione sullo stato dellecomunaglie della pode-steria di CastiglioneChiavarese, risalenteal 1611 e riportata neiregistri della Magistra-tura di Comunità isti-tuita nel 1623, leggia-mo “…il Monte PietraColva, sino alla chiesadi Sancto Nicolao”28.
Secondo LeopoldoCimaschi, che basavale sue ipotesi su alcu-ne fonti orali29, nel cor-so del XVIII secolo lachiesa conobbe unanuova fase d’uso. Du-rante i mesi in cui lapopolazione locale eraimpegnata nell’attivitàdi raccolta delle casta-gne, le funzioni liturgi-che a beneficio dei co-glitori sarebbero statecelebrate nella ripristi-nata chiesa di San Ni-colao. Quest’uso sta-gionale avrebbe com-portato - secondo Ci-maschi - la ristruttura-zione della navata del-la chiesa, ma in segui-to alle ripetute omissio-ni da parte dei proprie-tari dei castagneti diVasca nel versamentodei canoni dovuti, l’au-torità ecclesiastica nedispose l’abbandono30.Dopo l’ipotizzato utiliz-zo stagionale del XVIIIsecolo, il sito di San Ni-
colao - occasionalemeta di escursionisti eben presente nella me-moria storica locale -rimase in abbandonofino all’avvio delle ricer-che di Leopoldo Cima-schi, nel 1956.
F. Benente
NOTE
1 Per la ricostruzione del-
la viabilità antica e lamenzione di Pietra Colicecfr.: LAGOMARSINO 1997,fig, 1; GAMBARO 2001, pp.75-85; REDOANO COPPEDÉ
2002, pp. 1-31; LAGOMAR-SINO 2005.2 CIPOLLA – BUZZI 1918, pp.130-131.3 Si tratta, appunto dellavia que educit ad PetramCorici.4 Nell’ampia bibliografiadisponibile sul tema, cfr.FORMENTINI 1938, pp. 66-71; CIMASCHI 1957, p. 9;POLONIO 1962, pp. 53-55;PAVONI 1992; CHIAPPE
1996, pp. 126-131; GAR-BARINO 1998, pp. 13; BE-NENTE 2000c, pp. 43-63;DESTEFANIS 2002, pp.69-70.5 CIMASCHI 1957, p. 9; CI-MASCHI 1959, p. 59; LAGO-MARSINO 1997, pp. 67-76;FRONDONI 2001a, p. 31;LAGOMARSINO 2005, pp. 57-66.6 GABOTTO-LEGÈ 1905, doc.XIV, p. 22-24; CIMASCHI
1957, p.5.7 BELGRANO 1862, p. 344;CIMASCHI 1957, pp. 5-6.8Cfr. BOSONI 2003, p.112,nota 56.9 FERRETTO 1906, p. 54;CIMASCHI 1957, p. 6; CAL-CAGNO 2001, p. 33.10 Cfr. TOMAINI 1980, p.
21
149; Notizie sull’attività diAdamo da Lemeglio an-che in: CENTI 1899, pp.146-14811 Ringrazio il dott. CarloMoggia per aver fornitopreziose informazioni sualcuni documenti in cor-so di studio.12 SISTO 1978, pp. 317-331.13 CIMASCHI 1957, p. 18;FERRETTO 1908, p. 769;CALCAGNO 2001, p. 3314 CIMASCHI 1957, p. 615 BUONGIORNO 1973, tavv.V, VI; CHIAPPE 2002, p.146.16 La fortificazione eraubicata sul primo pinna-colo orientale del Pietra diVasca. Ricognizioni con-dotte a partire dal 2001hanno evidenziato la pre-senza di numerosi fram-menti ceramici di XIV eXV secolo.17 CIMASCHI 1957, p. 19,nota 15.18 BELGRANO 1862, p. 395;CIMASCHI 1957, pp. 6-7;CALCAGNO 2001, p. 34.19 FERRETTO 1908, p. 612;CIMASCHI 1957, pp. 17-18;CALCAGNO 2001, p. 34.20 Con quest’ultimo atto,rogato dal notaio Andreade Cairo il 14 maggio1484, Bartolomeo Pa-moul, vescovo di Aiaccioe preposito della chiesa diSan Salvatore di Lava-gna, e diversi membri del-la famiglia Fieschi, patro-ni della chiesa di SanSalvatore di Lavagna co-stituiscono loro procura-tore prete Fabiano daVarese, cappellano dellapieve di Santa Croce diMoneglia. FERRETTO 1908,p. 612; CALCAGNO 2001, p.3421 CALCAGNO 2001, pp. 34-
35.22 FERRETTO 1908, p. 613;CIMASCHI 1957, p. 20; CAL-CAGNO 2001, p. 35.23 Un’efficace descrizionedell’asperità orograficadell’area è rintracciabiletra le pagine degli Annalidel Giustiniani, in unpasso viene infatti men-zionata la rocca di PietraColice: “Ascendendo daLagorara sulla stradaromea, si dà nel pericolo-so passo nominato PietraCrosora, ossia PietraCollica, e poi si dà in unaregione nominata Vasapiena di castagneti e al-beri silvestri” (BELGRANO
1862, p. 742).24 Nella relazione del visi-tatore apostolico Bossio(Relazione Bossio) - risa-lente agli ultimi decennidel XVI secolo - non ven-gono compresi la chiesae l’ospitale di San Nicolao;al contrario vengono de-scritti altri edifici eccle-siastici della zona qualiSan Bernardo e SantaMaria di Piazza, SanMartino di Framura. Nel1593, in una memoriadella pieve di Framura, simenziona la chiesa, ossia“l’oratorio distrutto diSan Nicolao”. Cfr.CIMASCHI 1957, p. 7; CAL-CAGNO 2001, p. 35.25 FERRETTO 1928, p. 32;CIMASCHI 1957, p. 7; CAL-CAGNO 2001, p. 35.26 La fonte prosegue poiprecisando “…si arrivasino al piano ma non sula sommità del monte diPietra Crosta, et andan-do drito di detta ruinatachiesa di SantoNicherosio …e da questastrada pubblica romanavicina a detto tempio di
San Nicolao comincia lastrada che calca il monteper il vertice delle Taglie-rete dividente il territoriodi Castiglione col suo ver-tice dal territorio e giuri-sdizione di Pavareto, Car-ro e Castello abbraccian-do tutto ciò che è tra lastrada romana che va daSanto Nicolao a Mataranae detto vertice delle Ta-glierete”. Cfr. F IGONE
1995, pp. 80-82.27 FERRETTO 1928, p. 27;C IMASCHI 1957, p. 7;FIGONE 1995, pp. 110-116; CALCAGNO 2001, p.35.28 FIGONE 1995, p. 14729 Si tratta della testimo-nianza fornita da Fausti-no Ferrari di Carro, sullabase di documenti di suaproprietà: documenti cheCimaschi si riservava diverificare. Cfr. CIMASCHI
1957, p.19, nota 13.30 CIMASCHI 1957, pp. 12;FIGONE 1995, p. 82.
22
La prima campagnadi scavo, condotta nel1956, interessò princi-palmente l’area dellachiesa. Le indagini ri-portarono in luce il pe-rimetro interno del-l’edificio, mettendo inluce il livello di pavi-mentazione in battutodi calce. Furono inoltreindagate alcune inu-mazioni entro loculo inmuratura1, individuatenel basamento posto aldi sotto del piccolovano rettangolare chesi appoggia al fianconord del transetto ab-sidale (fig. 6, Cf. 4). Inalcune zone del tran-setto, in prossimità de-gli angoli interni, Ci-maschi realizzò deisaggi in approfondi-mento, ma alla luce deidati scaturiti dallacampagna di scavo2005, non esaurì il de-posito archeologico, la-sciando in situ due se-polture e alcuni stratidi frequentazione.
Nel corso della se-conda campagna (1957- 1958), Cimaschi misein luce completamentel’edificio di culto, lavo-rando nell’area imme-diatamente esterna al-l’abside, al fianco norddella navata (fig. 6, Cf.2)2 e alla facciata. Dopol’individuazione del lo-cale addossato al fian-co sud della chiesa
decise di procedere alloscavo estensivo, chevenne condotto persuccessive trincee di
approfondimento. L’ul-tima campagna di in-dagini, rimasta inedi-ta, si svolse in periodi
4. LE INDAGINI DI LEOPOLDO CIMASCHI E LE RICERCHE
DEGLI ANNI ‘80 E ‘90
Fig.11 - Veduta della navata della chiesa.
Fig.12 - L’abside di destra, con piccolo altare in concisquadrati ancora conservato in situ.
23
non continuativi tra ilmese di settembre del1958 e gennaio dell’an-no successivo. Nellefasi iniziali, si continuòa scavare nell’edificio 2(fig. 14), individuandouna porzione di mura-tura probabilmente an-teriore ad esso3. Venne,inoltre, condotto unsondaggio nell’areaesterna all’abside sud(fig.16), interrotto inseguito al ritrovamen-to di resti osteologiciumani4. Si passò poi adindagare l’area esternaall’edificio 2, indivi-duando due tratti dimuratura precedentialla costruzione del-l’ambiente. Con la pro-secuzione dello scavo,fu poi individuato il
Fig.13 e 14 - L’abside di sinistra con l’altare ancora con-servato. Sotto, particolare dello scavo dell’edificio 2.
24
lato nord di un nuovoedificio (fig.6, Cf.3) e sicercò di delimitarne ilperimetro con trinceeche seguivano l’anda-mento dei muri peri-metrali ovest e nord(fig.15).
Lo scavo, anche seostacolato dal rigoreinvernale, portò all’in-dividuazione dei latinord, ovest e sud del-l’Edificio 3. Al momen-to della sospensionedelle indagini, risulta-vano chiari i rapportidiacronici tra la chiesa(fig. 6, Cf.1) di XII-XIIIsecolo, il locale tardomedievale o d’età mo-derna ad essa appog-giato (fig.6, Cf.2), maper Leopoldo Cimaschi
rimaneva aperta l’in-terpretazione dellestrutture dell’edificio/ospedale (Cf. 3) che egliipotizzava riferibili aduno xenodochium alto-medievale, mentre lestrutture venute inluce nell’area compre-sa tra l’edificio 2 e l’edi-ficio 3 erano datate ipo-teticamente tra XII eXV secolo5. Lo studio-so, per diversi motivi,non ebbe occasione diportare a compimentola ricerca avviata, an-che se in molte occa-sioni progettò di ri-prendere le indagini aSan Nicolao6.
Negli anni ’80 furo-no condotti alcuni la-vori preliminari di pu-
litura e documentazio-ne del sito, a cura del-la Soprintendenza Ar-cheologica della Ligu-ria7. Durante i lavori direstauro del complessodi San Nicolao, condot-ti nel 1998 e promossidalla Comunità Monta-na Val Petronio, la So-printendenza per i BeniArcheologici della Ligu-ria ha condotto unabreve indagine che hapermesso di mettere inluce le fondazioni del-l’edificio adiacente allachiesa di San Nicolao,assegnato in base allastratigrafia e all’esamedelle tecniche murarieal tardo medioevo. Lericerche, per cui dispo-niamo solo di brevi no-
Fig.15 - Veduta generale degli scavi Cimaschi del 1957/58, con l’individuazione deimuri perimetrali nord e ovest dell’edificio 3 (fig.6, Cf.3).
25
tizie preliminari8, han-no quindi prevalente-mente interessatol’ambiente già scavato,seppure parzialmentein tre successivi stratidi approfondimento,nel corso della campa-gna di scavo condottada Cimaschi nel 1958/59. Nel corso dei lavo-ri, sono anche state ri-portate in luce le rasa-ture delle strutturemurarie dell’edificio/ospedale (Edificio 3)che è poi diventato og-getto di scavo nel 2001.
F. Benente
NOTE
1 Giornale di Scavo I, 18settembre 1956. Lo sca-vo del loculo venne di-rettamente condotto daCimaschi e da Tiragalloche impiegarono ca. 4 orelavorative. Nel loculo ven-nero trovati: “due chiodiatipici, due cerchietti diferro con fermaglio e al-cuni frammenti di vaset-ti a pareti dipinte e inter-no con tracce di invetria-tura che …dovrebberoappartenere a ceramicamedievale” (si tratta dimaiolica arcaica). Dalcomputo dei femori sicu-ramente identificabili sidedusse che “..nel depo-sito si trovano resti osseidi almeno sei individui;più probabilmente otto.Sullo strato più basso,quasi a contatto con ilterreno vergine, vertebredorsali e ossa dei piedi inconnessione anatomicadimostrano che la cavità,almeno in origine, ebbe
funzione di vera e propriatomba. Lo stato di estre-ma confusione delle ossasoprastanti fa pensareche il luogo sia stato suc-cessivamente destinatoad ossario”. Oggi potrem-mo anche pensare all’ipo-tesi di una sepoltura pri-maria, con scheletro an-cora in connessione e diuna serie di “riduzioni” disepolture cronologica-mente anteriori, oppureall’esito di interventi discavo precedenti a quel-lo di Cimaschi.2 Giornale di scavo II, 9settembre 1957. “Resti disepolture sussistono lun-go la metà superiore del-la fiancata nord e nell’an-golo formato da questacon il lato ovest dell’absi-diola”.3 Giornale di scavo III, 5settembre 1958: “dueoperai hanno completatosino alla roccia lo sban-camento dell’estremitàest dell’ospizio [edificio 2]
sul livello più basso restidi muro orientato est/ovest che giungono, comel’asta di una T sin sottolo scalino, piegano a sud,sembrano proseguire ol-tre la fiancata sud del-l’ospizio, ma poi scompa-iono”.4 Giornale di scavo III, 5settembre 1958. Unatrincea di scavo realizza-ta all’esterno dell’absidio-la sud, pose in luce nu-merosi resti osteologici:“moltissime ossa subitoricoperte”.5 CIMASCHI 1959, p. 59
6 Leopoldo Cimaschi èdeceduto nel luglio del1999.7 Devo l’informazione allacortesia della dott.ssaAlessandra Frondoni, Di-rettore della Soprinten-denza per i Beni Archeo-logici della Liguria.8 FRONDONI 2001a, pp.31-32; FRONDONI 2001b,pp.136-137.
Fig.16 - Particolare dell’area esterna alle abisidi dellachiesa.
26
5. LE CAMPAGNE DI SCAVO 2001-2008
Le campagne di sca-vo 2001-2008 sonostate articolate in duedistinte fasi. La primafase (2001-2006) è sta-ta dedicata allo studiodel complesso medie-vale. Le ricerche sonostate condotte su con-cessione ministerialedalla Sezione Tigulliadell’Istituto Internazio-nale di Studi Liguri ehanno visto il coinvol-gimento di ricercatoriche collaborano alleindagini condotte dal-la Cattedra di Archeo-logia Medievale del-l’Università di Genova.
La direzione dei la-vori è stata coordinatadallo scrivente, coadiu-vato per gli aspetti lo-gistico organizzativi dalprof. Giovanni Mennel-la (Università degliStudi di Genova) e daRenato Lagomarsino(Ispettore Onorario del-la Soprintendenza peri Beni Archeologici del-la Liguria).
Nel corso delle di-verse campagne di in-dagine, hanno collabo-rato alla direzione del-lo scavo con responsa-bilità e competenzespecifiche: Nadia Piom-bo (area 800), MarziaDentone (area 800),Sara Lassa (area 100),Mirko Peripimeno (area500, vano I), RobertoCodovilla (area 500,
vano 2), Gian Battista.Garbarino (area 500,vano 3), Fabrizio Pasto-rino (area 500 ext.),Alexander Parise (area2000), Andrea Polla-stro (Area 3000), Ele-na Besana (area 4000)Federico Andreazzoli eMatteo Galeazzo (ar-cheologia dell’architet-tura), cui si sono ag-giunte - nella fase distudio post-scavo -Daniela Marrazzo eAlessandra Spinetti (la-boratorio reperti arche-ozoologici) e MonicaBaldassarri (studio re-perti numismatici).
Gli scavi 2007-2008- la seconda fase dedi-cata all’analisi dellafrequentazione preisto-rica del sito - sono sta-ti diretti dalla Soprin-tendenza per i Beni Ar-cheologici della Ligu-ria, coordinati da Na-dia Campana e condot-ti dallo scrivente e daricercatori della Sez.Tigullia dell’Istituto In-ternazionale di StudiLiguri.
Lo scavo ha finorainteressato sette di-stinte aree d’indagine(fig.17), per una super-ficie complessiva di ca.300 mq. L’area 500coincide con l’area oc-cupata dall’Edificio 3,già individuato nel cor-so delle ricerche di Le-opoldo Cimaschi e in-
terpretabile comestruttura dell’ospedalemenzionato nelle fontidi XIV-XV secolo.
Due settori di scavosono stati ubicati nel-l’ampio pianoro posto asud est del transettoabsidato della chiesa diSan Nicolao, indagan-do la sequenza strati-grafica esterna al peri-metrale est dell’ospe-dale (area 100) e ana-lizzando una parte del-l’area cimiteriale ester-na all’abside della chie-sa di San Nicolao (area800).
Un ampio settore diindagine ha interessa-to l’area esterna al pe-rimetrale ovest del-l’Edificio 3 (area 500ext). A partire dallacampagna di scavo2005 si è deciso di pro-cedere ad una verificastratigrafica nell’areadella chiesa (area2000), già oggetto de-gli scavi di Leopoldo Ci-maschi e si è condottoun saggio nell’areaesterna nord, compre-sa fra il transetto e lanavata.
Nel 2006 sono statecondotte verifiche stra-tigrafiche nell’areaesterna est e sud dellachiesa e dell’edificio 2(area 3000). Semprenel 2006 è stato con-dotto un saggio di sca-vo nell’estremità est del
27
pianoro artificiale cheospita il complesso diSan Nicolao (area4000).
La fase finale dellacampagna di scavo2006 ha indicato lapresenza di stratigrafiepreistoriche nell’area100 e nell’area 500.Nella parte sud di que-st’ultima area, le fasimedievali coprivano unconsistente depositopreistorico che è statoindagato tramite unsaggio di scavo condot-to in due campagne diindagine, tra 2007 e2008.
Di seguito, senzaentrare nel dettagliospecifico dei dati ana-
litici di scavo, si propo-ne una sintesi degli ele-menti più importantifinora emersi da ottoanni di ricerche ar-cheologiche.
Il quadro interpreta-tivo generale dello sca-vo e della sequenza in-sediativa sembra suffi-cientemente consolida-to, ma è bene premet-tere che questi dati -presentati a scavo ap-pena terminato - sonoin parte passibili di fu-ture modifiche e picco-li aggiustamenti, manoa mano che il dettagliointerpretativo si faràpiù raffinato e lo stu-dio delle sequenze stra-tigrafiche e dei reperti
Fig.17 - Ubicazione delle diverse aree di indagine. Non è localizzata in questa piantal’area di scavo 4000, più esterna e posta ad ovest rispetto al complesso formatodalla chiesa e dall’ospedale.
sarà supportato da in-dagini di tipo archeo-metrico.
Il lettore interessa-to potrà trovare appro-fondimenti e ulterioridettagli nell’apparatobibliografico posto inchiusura di questo vo-lume, che rimanda alleedizioni preliminaridelle diverse campagnedi scavo, pubblicateprevalentemente su ri-viste scientifiche.
F. Benente
NOTE
1 Cfr. ad es. BENENTE etal. 2003a; BENENTE et al.2003b.
28
La campagna discavo condotta nel2006 ha appurato chealcune delle strutturemedievali erano statecostruite direttamentesul substrato roccio-so, mentre altre si ap-poggiavano su lembi diun deposito antropiz-zato più antico, chiara-mente precedente al-l’insediamento medie-vale.
Due brevi indaginiarcheologiche, una ef-fettuata nell’autunno2007 e l’altra tra apri-le e luglio 2008, hannoesplorato un’area di 18metri quadrati nelvano nord dell’ospeda-le, rinvenendo resti difrequentazione e usodell’area risalenti ingran parte al III millen-nio avanti Cristo.
Sono in procinto diessere avviate le ana-lisi geoarcheologiche,paleobotaniche, radio-carboniche di campio-ni del sedimento, ed èin corso l’assemblaggiodei frammenti cerami-ci: si tratta di attivitàe studi “post scavo”che integreranno i datiraccolti sul terreno eprodurranno prezioseinformazioni scientifi-che sulla modalità diformazione dei deposi-ti, sulla loro cronologia,sull’uso della zona e delterritorio circostante.
Al di sotto della fon-dazione dell’ospitale èemerso uno strato ric-co di frustuli di carbo-ne di legna, caratteriz-zato alla base dalla pre-senza di chiazze di ter-reno combusto e pietrealterate dal contattocon il fuoco. È l’esito,probabilmente, di unincendio precedente lacostruzione dell’ospita-le, che il rinvenimentodi un frammento di in-gobbiata monocromadel XII-XIII secolo col-loca in epoca già me-dievale; potrebbe sug-gestivamente trattarsidella testimonianza deldisboscamento e del-la “bonifica” del suolopreliminari alla co-struzione dell’ospitalestesso.
Frequentazioni diepoca romana (vedi in-fra p. 35) sono attesta-te da alcuni minutiframmenti ceramicirinvenuti nello stratosottostante insieme areperti che, al momen-to, non possiamo chedefinire genericamentepre/protostorici e adaltri, come una puntadi freccia in diasprorosso (fig. 18), attribu-ibili all’Età del Rame oal Bronzo Antico.
La disomogeneitàcronologica dei mate-riali rinvenuti in que-sto strato è con ogni
probabilità da imputa-re a rimescolamenticonnessi alla cotruzio-ne dell’ospitale. Risul-ta disturbata da taleattività edilizia anchel’unità stratigraficasottostante, dove tut-tavia si sono conserva-te alcune buche di paloe alcune fossette, la cuifunzione potrà essereverificata sulla basedelle informazioni for-nite dalle analisi deisedimenti che le riem-pivano (fig. 19).
Da questa unitàstratigrafica provengo-no manufatti scheggia-ti in diaspro, selce equarzo insieme a di-versi frammenti cera-mici, tra cui uno per-tinente ad un recipien-te decorato con una se-quenza di punzonatu-re; altri due frammen-ti, riferibili probabil-
Fig.18 - Punta di frecciaa ritocco bifacciale.
6. LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA
29
mente allo stesso vaso,sono stati recuperati indifferenti unità strati-grafiche (fig. 20).
Una decorazione si-mile, che si estende sututta la superficie delvaso, trova riscontrosu boccali campanifor-mi provenienti dall’Eu-ropa centrale (Worms,Rheinhessen, Germa-nia)1. Fasce o triangolidecorati a punzonatu-re sono attestati in Ita-lia settentrionale ecentrale in contesticampaniformi o gene-ricamente di Età delRame (III millennioa.C.)2.
Nello strato sotto-stante allineamenti dipietre affiancati a bu-che di palo indicano lapresenza di una strut-tura complessa conbasamento di pietra e
alzato di legno; ester-namente ad essa sonostate portate alla lucedue fosse di combu-stione (figg. 21-22-23),una a profilo circolare,l’altra ovalare; la primaha un diametro di cir-ca 85 cm ed è profon-da al massimo 25 cm,la seconda è più gran-de: il suo asse maggio-re è lungo quasi unmetro e mezzo ed èprofonda 30 cm.
Il riempimento del-le due strutture era co-stituito da un livello dipietre, alterate e frat-turate dall’azione delfuoco, che poggiavanosu un terreno di colorereso nerastro dall’ele-vata componente orga-nica combusta e dallapresenza di carboni.
Tale stratigrafia in-dica che il fuoco, all’in-
terno di queste fosse, èstato acceso al di sot-to di una copertura dipietre. Strutture diquesto tipo, chiamateanche “forni polinesia-ni”, hanno la caratte-ristica di immagazzina-re il calore e di disper-derlo lentamente, per-mettendo una combu-stione prolungata e auna temperatura co-stante.
Le fosse di combu-stione di San Nicolaosono giunte a noi in unottimo stato di conser-vazione e le analisi deisedimenti e dei carbo-ni di legna daranno in-dicazioni affidabili sul-la loro funzione. Almomento ci limitiamoa riferire che strutturesimili sono ben attesta-te in contesti preisto-rici, soprattutto neoli-
Fig.19 - Piano d’uso caratterizzato dalla presenza di buche di palo e fossette.
30
tici3, e a suggerire peresse generiche inter-pretazioni legate allapreparazione dei cibi:la cottura di grossiquarti di animali, l’af-fumicazione o essicca-zione delle carni o, in-fine, la torrefazione deicereali (fig.24).
A questa fase di fre-quentazione del sitosembrerebbero perti-nenti, insieme a variframmenti ceramici e amanufatti di selce e didiaspro, alcuni reperticeramici particolari,contraddistinti da unadecorazione molto rico-noscibile che permettedi attribuirli a un tipodi vasi, finemente de-corati e di buona fat-tura, spesso a formadi campana rovesciatae perciò chiamati cam-paniformi.
Si tratta di dueframmenti caratteriz-zati da un impastomolto fine, da superfi-ci lisciate di color aran-cio e da una decorazio-ne costituita da fascedi una o più banderiempite di trattini, se-parate da bande a ri-sparmio (fig.25).
In Liguria frammen-ti di vasi campanifor-mi provengono da varisiti della Liguria di Po-nente4, mentre in Ligu-ria orientale sono pre-senti nel non lontanoinsediamento di Suve-ro (Rocchetta VaraSP), un sito artigiana-le dedicato alla produ-zione di monili di stea-tite5.
La datazione deicarboni di legna recu-
perati nel corso dell’in-dagine permetterà didefinire la cronologiadegli eventi portati allaluce nel sito di San Ni-colao. Per ora, soffer-mandoci a trattare bre-vemente della sola fre-quentazione collegataall’uso delle fosse dicombustione, rileviamoche essa è riferibile auna successione di oc-cupazioni avvenuteprobabilmente nell’ar-co di anni - lo scavo haevidenziato che le fos-se hanno avuto più fasid’uso - la più recentedelle quali si colloche-rebbe, come indica lapresenza di ceramicacampaniforme, tra il2500 e il 2200 a.C.
E’ in questo periodo,infatti, che in Italiasettentrionale si dif-fonde il “vaso campa-niforme”, un recipien-te che, tra la fine del-l’Età del Rame e l’ini-zio dell’Età del Bronzo,risulta presente su unterritorio vastissimocorrispondente a qua-
si tutta l’Europa, dal-la Scozia alla Sicilia,dal Portogallo alla Po-lonia, fino alle costedell’Africa settentrio-nale.
Molti studiosi sisono cimentati nellostudio del fenomenocampaniforme e hannofornito per esso diver-se interpretazioni,spiegandolo con lo spo-stamento di una popo-lazione o, in alternati-va, di gruppi o addi-rittura di individui, ericonoscendo nei “por-tatori del campanifor-me” dei mercanti o deicercatori di metallo odei fabbri o, ancora, deiguerrieri armati diarco. Infine, l’analisidel contenuto conser-vatosi in alcuni vasisuggerisce che essofosse il recipiente dibevande fermentate(idromele o birra).
Molti interpretano ilpossesso del vaso cam-paniforme quale sim-bolo di prestigio, di ap-partenenza ad una ri-
Fig.20 - Frammenti ceramici decorati con punzonature.
31
Fig. 21 - La fossa di com-bustione più piccola incorso di scavo; si vedonole pietre che costituisconola parte più superficialedel riempimento.
Fig.22 - La fossa di com-bustione, con il terrenocarbonioso su cui poggia-vano le pietre.
32
stretta élite, capace diconferire alla societàuna struttura gerar-chica. Il dibattito è piùche mai aperto6.
Il fenomeno campa-niforme è uno degliaspetti innovativi chesi sviluppano nell’Etàdel Rame; un altro - ilcui impatto nel nostroterritorio risulta più ri-levante - è quello lega-to all’attività minera-ria: a Monte Loreto(Masso, CastiglioneChiavarese - GE) è sta-ta riconosciuta e stu-diata quella che al mo-
mento è la più anticaminiera di rame del-l’Europa occidentale, lacui coltivazione si af-fiancava a quella di Li-biola (Sestri Levante -GE)7.
La coltivazione del-la risorsa mineraria èstata uno degli esitidell’incremento demo-grafico che si registrain Liguria nell’Età delRame nel IV e III mil-lennio a.C., il cui mo-tore è individuato nel-la elaborazione di pra-tiche di pastorizia. Te-stimonianze di attivitàdi apertura del boscocol fuoco controllatoper ampliare gli spazidi pascolo, meta del-l’alpeggio, sono statestudiate a Prato Mollopresso Monte Aiona8, aquota 1500 m s.l.m. ein altri siti (Fig. 26).
L’aumento di popo-lazione ha altresì resonecessario ricorrere afonti di approvvigiona-mento della materiaprima litica fino a quel
Fig. 23 - Particolare della fossa di combustione didimensioni maggiori, in corso di scavo e vista da sud.
Fig.24 - Ipotesi d’uso della fossa di combustione per lacottura della carne (da LACQUIN, MARCH 2003: 128, fig.1).
Fig.25 - Frammenti di ceramica campaniforme.
33
momento non sfrutta-te.
Risale a poco dopoil 4000 a.C. l’attivazio-ne di una vera e pro-pria cava di diaspro inValle Lagorara (Mais-sana-SP), dove sonotuttora riconoscibili leprofonde nicchie diestrazione generatedalla coltivazione del-l’Età del Rame9.
N. Campana
NOTE
1 SANGMEISTER 1984: 93,fig.4.2 Ad esempio: Velturno-Tanzgasse-BZ: TECCHIATI
1998: 71; Grotta del Fon-tino-GR: VIGLIARDI 1998:178 e 192: scheda 45;Volpaia a Sesto Fiorenti-no-FI: SARTI, CARLINI, MAR-TINI 1999-2000: 199,fig.4.4).
Fig.26 - Siti menzionati nel testo.
3 FRÈRE-SOUTOUT 2003;SARTI et alii 1991.4 MAGGI 1998: 26; DEL LUC-CHESE, ODETTI 2001.5 MAGGI et alii 1987 (fig.11.6 NICOLIS, MOTTES 1998.7 CAMPANA et alii 2006.8 BAFFICO et alii 1987.9 CAMPANA, MAGGI 2002.
34
7. LO SCAVO DELL’OSPEDALE
L’indagine stratigra-fica condotta nell’area500 ha permesso ditracciare una primaserie di punti chiavenella lettura planime-trica dell’edificio 3 esulla sua cronologiad’uso e di abbandono,ma ha anche fornitoindicazioni sulla pree-sistenza di alcunestrutture nella medesi-ma area (fig. 31). Duelunghe trincee di spo-liazione e le relativestratigrafie d’uso indi-viduate nell’area ester-na suggeriscono, infat-ti, l’ipotesi della pre-senza di una strutturapiù antica, anteriore
alla costruzione del-l’Edificio 3 (XIV secolo).La datazione di questafase potrà essere pre-cisata con il completa-mento dello studio deireperti di scavo.
La costruzione del-l’edificio è preceduta dauna sistemazione ge-nerale dell’area che hacomportato un proba-bile disbosco ed una re-golarizzazione del-l’area. Queste attivitàhanno lasciato tracciaarcheologica soprattut-to nel vano centrale enel vano sud, e hannoin parte intaccato stra-tigrafie pertinenti allafase di frequentazione
preistorica e ad unaprobabile fase di fre-quentazione d’età ro-mana (cfr. supra, par.6). Quest’ultima fase èdocumentata solo dalabili tracce stratigra-fiche e dalla presenzadi alcuni reperti, tracui due frammenti diceramica a vernicenera e una monetad’età repubblicana,trovata in giacitura se-condaria.
L’edificio è stato co-struito con blocchi dipietra di provenienzalocale, solamente spac-cati e posti in opera conmalta di terra. La tec-nica costruttiva è più
Fig.27 - Veduta dell’area di scavo 500 con i tre ambienti dell’ospedale.
35
accurata in prossimitàdelle due aperture pre-senti nell’ambiente po-sto a sud (vano 3). Lastruttura conserva unafase originale del XIVsecolo, che presentauna pianta quadrango-lare (ca. 120 mq) ed èleggibile nei muri nord,est e sud.
Gli scavi hanno per-messo di comprendereche l’attuale divisionein tre ampi locali di for-ma rettangolare allun-gata e su un più limi-tato ambiente posto sullato sud è frutto di pro-gressive riduzioni e ri-pensamenti dello spa-zio interno originale. Lacopertura era fornitada un tetto a doppiospiovente, con intelaia-tura lignea e copertu-ra in lastre di calcareargilloso.
Il vano 3, posto asud, costituisce l’unicoambiente che ha con-servato traccia delleaperture di accesso e diredistribuzione degliutenti nei diversi vanidell’ospedale e fu pro-
babilmente l’ultimovano a rimanere inuso. L’ambiente pre-senta, infatti, un in-gresso sul fronte oveste un’apertura di colle-
gamento con il piccolovano posto a sud. Nel-l’area esterna ovestsono emersi indizi re-lativi alla presenza diuna struttura di ripa-ro o di una semplicetettoia realizzata in tec-nica mista, con alme-no il perimetrale sud inmuratura.
Lo sviluppo plani-metrico dell’ospedale(ca.120 mq.) richiamaal precipuo scopo fun-zionale della struttura,ossia quello di ricove-ro/dormitorio per vian-danti e pellegrini. Pos-siamo stimare la capa-cità di accoglienza del-l’edificio in una qua-rantina di posti-letto.Allargando l’analisi ad
Fig.28 - Il crollo del tetto (parzialmente spoliato) all’in-terno del vano 1.
Fig.29 - Veduta dell’area di scavo 500 con traccia delcrollo del tetto all’interno del vano centrale (vano 2).
36
altri ospedali indagatiarcheologicamente,questo sviluppo plani-metrico è decisamentepiù ridotto rispetto aquello documentato daigrandi ospedali postisui valichi alpini o pi-renaici (ad esempioospedale del Gran SanBernardo, 243 mq;ospedale di S. Cristinadi Somport, 325 mq)1,ma trova confronti conle dimensioni degliospedali di passo postiin area appenninica(ospedale di San Nico-lao di Tea, 128 mq). Idati finora desunti dal-lo scavo dei tre vanisuggeriscono un ab-
bandono pianificato,con il recupero di even-tuali oggetti d’arredo,reperti mobili e vasel-lame dai piani d’uso,progressivo collassodelle strutture portan-ti, fino al crollo defini-tivo del tetto. I pianid’uso erano in sempli-ce terra battuta (fig.30).
L’analisi dei repertidi scavo, ceramici e nu-mismatici, offre ele-menti di datazione perle fasi d’uso. Un utileelemento di datazionepost quem è offerto dal-la presenza di un de-naro della zecca di Fer-rara - databile al 1344-
1352 - rinvenuto nellostrato di terreno di ri-porto per la preparazio-ne del piano pavimen-tale dell’ambiente 1.
Il crollo del tetto deivani 1 e 2 (figg. 28-29)ha restituito sei mone-te, e almeno due diqueste forniscono ele-menti probanti per unadatazione post quem.Un denaro minuto dizecca genovese a nomedi Filippo Maria Vi-sconti (1421-1435) eun denaro minuto delperiodo dei dogi bien-nali suggeriscono unadatazione entro la metàdel XV secolo. Le mo-nete, infatti, possonoessere state perse nel-le ultime fasi di fre-quentazione dei pianid’uso interni ai vani.
Dopo il crollo deltetto non cessa la fre-quentazione dell’edifi-cio e, all’interno degliambienti 2 e 3, si al-ternano episodi di fre-quentazione e di accen-sione di fuochi, ed epi-sodi di caduta delle“ciappe” di coperturadel tetto e di spoliazio-ne dei materiali di crol-lo riutilizzabili. Da que-ste attività provengononumerosi reperti ricon-ducibili ad armi. Loscavo ha restituito nu-merose punte di frec-cia e di dardo da bale-stra, puntali di armi dalancio e da taglio, oltrea una noce da balestrain osso2 . Anche allaluce della vicinanzacon il castello genove-se di Pietra Colice, sipotrebbe ipotizzare chela presenza di questi
Fig.30 - Piano d’uso del vano centrale.
37
oggetti sia l’esito di unepisodio di acquartie-ramento di truppe, av-venuto dopo la metàdel XV secolo, nel com-plesso quadro dei di-sordini e delle attivitàbelliche che contraddi-stinguono l’area del Ti-gullio nel Quattrocen-to. Una frequentazionedi questo tipo non co-stituisce un esempioisolato, ma rientra inuna casistica già notaagli archeologi3.
L’abbandono defini-tivo dell’Edificio 3 è se-gnato dalla tampona-tura con pietre dellaporta d’accesso ovest alvano 3 e dal generalecrollo dei perimetrali. Ilritrovamento dei fram-menti ricomponibili diun piccolo catino dimaiolica arcaica condecorazione e morfolo-gia comuni nella pro-duzione ligure quattro-centesca4 contribui-scono a datare questefasi nell’ambito dellaseconda metà del XVsecolo.
Guardando più ingenerale alla cronolo-gia dell’intera area 500,il reperto più recenterinvenuto nei contestiche si sono formatidopo l’abbandono degliedifici è rappresentatoda un frammento digraffita a punta e stec-ca pisana, databile alXVI secolo. Non sonoemersi indizi che pos-sano confermare unafrequentazione o un’oc-cupazione dell’area nelXVII-XVIII secolo.
F. Benente
NOTE
1 Cfr. quanto esposto inQUIRÒS CASTILLO 2000, pp.39-45.2 Questo tipo di repertirisulta segnalato rara-mente tra i materiali discavo, anche nei contestimilitari. Cfr. DE LUCA -FARINELLI 2002, pp.456,478, tav. III,1.3 Nella seconda metà delXV secolo una guarnigio-ne fiorentina si acquartie-ra nelle strutture abban-donate del monastero diSan Michele della Verru-ca, lasciando ampie trac-ce materiali. Cfr. GELICHI
et al. 2003, p. 22.4 La diffusione nel corsodel XV secolo di catini dimaiolica arcaica di ridot-te dimensioni è testimo-niata da contesti d’usodel Castrum Rapallini, delcastello di Andora e degliscavi urbani savonesi, giàstudiati e presentati inaltre sedi. Cfr.BENENTE
1991.
Fig.31 - L’area esterna ovest con (evidenziate in rosso)le due trincee di spoliazione pertinenti ad un edificioprecedente all’ospedale di XIV-XV secolo.
38
8. RILEGGENDO LO SCAVO CIMASCHI
LE NUOVE INDAGINI NELLA CHIESA
“Sull’intera area sca-vata, il terreno imme-diatamente sottopostoai piani di fondazione èapparso di colore gial-lastro, uniformementearido e del tutto sterile,rotto da filoni affiorantidi roccia viva”.
Con queste paroleLeopoldo Cimaschichiudeva la sua primarelazione dedicata alloscavo della chiesa diSan Nicolao1 e - teori-camente - poneva unasorta di pietra tombalesulle possibilità di ac-quisire con lo scavostratigrafico ulterioridati sulla cronologia esulle fasi costruttivedell’edificio di culto.
L’esame dei giornalidi scavo originali e al-cune valutazioni di op-portunità e di metodoche hanno accompa-gnato l’avvio dello stu-dio delle tecniche e del-le fasi costruttive dellachiesa hanno suggeri-to di avviare nel 2005una prima lettura ar-cheologica delle super-fici stratigrafiche la-sciate in situ dagli sca-vi del 1956/57.
L’indagine condot-ta nell’area 2000 haavuto, quindi, un limi-te preciso e alcune fi-nalità. Il limite era datodall’effettiva portatadelle ricerche condotte
da Leopoldo Cimaschi:la documentazione fo-tografica e soprattuttoi giornali di scavo nonoffrivano certezza chelo scavo avesse esauri-to la sequenza strati-grafica. La nuova in-dagine ha avuto anchelo scopo di procederead una verifica e aduna rilettura delle fasi
di fondazione dellestrutture murarie del-la chiesa. Lo scavo con-dotto nel transetto hapermesso di rilevareche il piano raggiuntodagli scavi Cimaschiera - in realtà - unasuperficie orizzontalearbitraria. La correttalettura della sequenzastratigrafica ancora in
Fig.32 - Area del transetto della chiesa durante lo sca-vo 2005. Le frecce indicano la posizione della sepol-tura, di cui è ancora visibile il riempimento.
39
situ ha consentito didocumentare un suolod’uso, tagliato da tresepolture.
Due inumazionierano già state in par-te intaccate da prece-denti operazioni di sca-vo. Una terza sepol-tura era ubicata all’in-terno dell’abside late-rale sud, orientatanord - sud, parallela alpiccolo altare ancoravisibile nella documen-tazione degli scavi Ci-maschi, conservavaancora lo scheletro diun inumato. Nel ter-reno di riempimento adimmediato contatto
con lo scheletro, inprossimità delle ossadel bacino è stata rin-venuta una moneta. Sitratta di un ulterioreesempio di una prati-ca non casuale, ma ri-tuale o “tradizionale”,già documentata in di-versi scavi medievali enella stessa area cimi-teriale di San Nicolao2.
La moneta è unquattrino di Pisa perl’imperatore Carlo VIII,emesso nel solo anno1494. Il rinvenimentooffre un fondamentaleelemento post quem (ladata di coniazione del-la moneta ) per la da-
tazione delle fasi di uti-lizzo terminali dellachiesa di San Nicolao.
Al di sotto di questefasi, il substrato roccio-so in disfacimento pre-sentava limitate traccelasciate dall’accensionedi fuochi, testimonian-do una frequentazionedell’area precedentealla costruzione del-l’edificio di culto.
Nell’area della nava-ta, la rilettura strati-grafica ha rivelatol’uniforme presenza delpiano roccioso. Un li-mitato deposito ar-cheologico era conser-vato nell’angolo sudovest dell’edificio e deveessere correlato ad unrifacimento di questaparte della muraturadella chiesa.
Lo scavo dell’areaesterna nord, compre-sa tra transetto e na-vata, con il ritrovamen-to di due inumazionisovrapposte, ha con-fermato l’utilizzo cimi-teriale delle zone im-mediatamente adia-centi ai muri perime-trali della chiesa.
F. Benente
NOTE
1 CIMASCHI 1957, p.16.2 La pratica di inseriremonete nelle sepoltureviene diversamente inter-pretata dagli studiosicome continuità della tra-dizione dell’ “obolo di Ca-ronte”, generica offertafunebre, o amuleto apo-tropaico. Cfr.Trouvaillesmonétaires de tombes,1999.
Fig.33 - Lo scheletro ancora in situ in una delle sepoltureposte all’interno del transetto della chiesa (area 2000).
40
L’analisi dell’area800, avviata con lacampagna di scavo2004, ha avuto comeobiettivo l’indagine del-la sequenza stratigra-fica esterna all’area ab-sidale della chiesa diSan Nicolao, dove alcu-ne brevi annotazioniregistrate nei giornalidi scavo di Cimaschisuggerivano la presen-za di un’area funeraria.Le sepolture indagatesono riferibili ad alme-no quattro fasi di uti-lizzo cimiteriale del-l’area e sono prelimi-narmente databili traXIII e XV secolo.
La presenza dellastruttura a pianta ret-tangolare (fig. 6, Cf. 4),con loculo interno -scavato nel 1956 da Le-opoldo Cimaschi - e al-cune indicazioni de-sunte dall’analisi stra-tigrafica suggerisconoche la fase delle sepol-ture entro fossa terra-gna - relative alla vitadell’edificio di culto -sia preceduta da unaprima fase di inuma-zioni, forse relative alsottostante basamento(fig. 6, Cf. 5). Quest’ul-timo, come detto inprecedenza, sembra ri-feribile ad un primoedificio mononavata,forse una piccola cap-pella absidata, preesi-stente alla chiesa di
San Nicolao (fig. 38).Le sepolture analiz-
zate nel corso dellecampagne di scavo2004/06 sono tutteentro terra, sono postein prossimità dellastruttura dell’abside
della chiesa e sembra-no avere una distribu-zione di tipo radiale ri-spetto alle absidi stes-se (figg. 34-35). In al-cuni casi si è evidenzia-to un fenomeno di dop-pia deposizione entro il
9. SOTTO LA PROTEZIONE DI SAN NICOLAO
L’USO CIMITERIALE DELL’AREA
Fig.34 e 35 - Due fasi successive dello scavo dell’areacimiteriale posta a est delle absidi.
41
medesimo spazio se-polcrale. Il rinvenimen-to di rari chiodi nellaterra di riempimento dialcune fosse di inuma-zione non è un sicuroindizio della presenzadi una cassa lignea.
Le modalità di con-servazione delle ossa eil generale manteni-mento delle connessio-ni anatomiche suggeri-rebbero piuttosto chele sepolture siano av-venute in “piena terra”,ma lo studio deve es-sere completato conun’accurata analisi ta-fonomica1.
I dati registrati du-rante lo scavo hannofornito elementi infor-mativi sulle modalità dideposizione e sulle pra-tiche rituali. Per quan-to riguarda l’orienta-mento, la maggior par-te delle inumazionipresentano il consuetoasse ovest-est, con te-sta collocata ad oveste i piedi a est2.
L ’ o r i e n t a m e n t onord-sud di alcuneinumazioni sembra es-sere stato condiziona-to dalla presenza delbasamento Cf.5, oppu-re dalla volontà di de-porre l’inumato a im-mediato contatto conl’abside centrale. Tuttigli inumati sono statideposti a decubito dor-sale, con diverse va-rianti della posizionedegli arti superiori:braccia distese lungo ilcorpo, braccia conver-genti sull’addome, unbraccio disteso lungo ilcorpo e uno dispostodiagonalmente sul pet-
Fig.36 - Particolare delle modalità di deposizione degliinumati.
Fig.37 - Particolare di sepoltura che ha restituito ele-menti dell’abbigliamento dell’inumato. Le frecce indi-cano la posizione delle fibbie della cintura e - a destrasul fianco - di un piccolo pugnale.
42
to, braccia raccolte sulpetto, parallele tra loroe perpendicolari all’as-se del corpo, bracciaincrociate sul petto.
Secondo una prassigià ben analizzata daaltri autori, la posizio-ne degli arti superioridegli inumati può esse-re legata a una sceltarituale, mentre quelladegli arti inferiori puòdipendere dalle moda-lità di deposizione edalla presenza di unlenzuolo o di un suda-rio3.
Diverse sepolturehanno restituito ele-menti dell’abbiglia-
mento personale degliinumati: fibbie da cin-tura circolari in bron-zo, con ardiglione inbronzo o, in alternati-va, in ferro. Un soloindividuo presentavaun corredo personalepiù articolato, formatodai diversi elementi diuna cintura (fig. 37).Due fibbie ad anello inbronzo erano poste ailati del bacino dell’inu-mato, mentre una fib-bia centrale, ad anelloe placchetta decorata a“dente di sega” ha con-servato un frammentodel cinturone in cuoio.Ad una delle due fibbie
laterali era collegato -tramite un fodero chenon si è conservato -un piccolo pugnale concodolo e pomolo in fer-ro, rinvenuto sul fian-co dell’inumato.
L’utilizzo nell’abbi-gliamento maschilebasso medievale diquesto tipo particolaredi cinturoni con fibbiemultiple (solitamenteerano tre), fodero late-rale e arma trova unimmediato riscontronella bibliografia ar-cheologica. In almenoun caso è stata ipotiz-zata la pertinenza auna dotazione di tipomilitare4.
F. Benente
NOTE
1 COLARDELLE et alii 1996,p. 291.2 La scelta di questoorientamento, trova spie-gazione con la precisa vo-lontà di deporre il defun-to con lo sguardo verso ilsorgere del sole, in modoche possa intraprenderela strada verso est, dalmondo terreno a quelloceleste. Cfr. SBARRA 2003,pp.34-36; COLARDELLE
1983, p. 379.3 Cfr. quanto espresso in:GRILLETTO - LAMBERT 1989,p. 347, nota 35; GELICHI
2001, p.83; SBARRA 2003,p.36; DADÀ- FORNACIARI
2006, pp.17-18.4 Cfr. i precisi riscontriediti in REDI - MALANDRA
2003, pp. 397-400, e inparticolare: fig.5; DE
VINGO 2000, p.283, fig.23.
Fig.38 - Sepoltura che presenta il cranio dell’inumatoappoggiato alla rasatura del basamento CF. 5.
43
Lo studio dei reper-ti ceramici provenientidal sito archeologico diSan Nicolao ha fornitoinformazioni sulle do-tazioni da cucina, damensa e da dispensadell’ospitale e interes-santi indicazioni suquali fossero le abitu-dini alimentari dei suoiabitanti e dei suoi fre-quentatori1.
La ceramica comu-ne “grezza” (ossia pri-va di rivestimento e adimpasto non depurato),ha un ruolo quantita-tivo preponderante trai manufatti destinatiagli usi della cucina eadoperati nella prepa-razione e nella cotturadei cibi. Sono presenticinque forme principa-li: testelli, olle, bocca-
li, fornetti-coperchio etegami.
La forma più atte-stata è quella del “te-stello” (fig. 39), un di-sco, con un piccolobordo più o meno rial-zato e diametro com-preso tra 16-20 cm.Questo tipo di manu-fatto, piuttosto diffusonella Liguria orientalee in Lunigiana, era uti-lizzato per la cottura dipiccole focaccine di fa-rina di cereali e casta-gne2.
L’impasto dei testel-li era piuttosto grosso-lano e per la loro pro-duzione venivano uti-lizzate argille locali ric-che di inclusi gabbrici(granuli rocciosi di co-lore chiaro) che con-sentono una migliore
conservazione del calo-re. L’analisi morfologi-ca e l’esame degli im-pasti hanno fatto ipo-tizzare l’esistenza dialmeno due distintemanifatture cerami-che, attive a livello lo-cale o sub regionale.
Alla famiglia delleceramiche grezze devo-no essere ricondotte leolle a corpo globularee orlo estroflesso e iboccali a bocca triloba-ta con ansa a nastro,entrambi lavorati altornio e caratterizzatida un impasto più de-purato rispetto a quel-lo dei testelli.
Le olle (fig. 41) era-no utilizzate per cuoce-re, o semplicementeper riscaldare a river-bero (fig.40) cibi liqui-di o semiliquidi (zuppe,minestre e polente difarina di castagne). Iboccali, presenti in mi-nor quantità rispettoalle olle, erano utilizza-ti probabilmente comecontenitori di liquidi.
Significativa è l’atte-stazione del testo dapane (o fornetto-coper-chio) di forma tronco-conica, con anse late-rali e fondo piano3.Questo tipo di oggettiveniva utilizzato diret-tamente sul focolarepiano, per la cottura dipani e focacce, secon-do un uso domestico
10. LA TAVOLA MEDIEVALE
SUPPELLETTILI DA CUCINA, DA MENSA E DA DISPENSA
Fig.39 - Frammenti di testelli utilizzati per la cottura diimpasti di farinacei.
44
documentato nelle vallidel Tigullio fino aglianni ‘70 del secoloscorso4.
La presenza delleceramiche invetriateda fuoco è documenta-ta quasi esclusivamen-te dai tegami con bas-sa parete inclinata econ presa laterale a bu-gnetta, tipici della pro-duzione ligure del XIVsecolo. Tra i contenito-ri da dispensa, ossiadestinati alla conserva-zione delle derrate ali-mentari, sono attesta-ti alcuni frammenti digiara caratterizzati daun impasto chiaro.
Le ceramiche fini damensa, presenti in mi-nor quantità rispetto aquelle da cucina sonorappresentate quasiesclusivamente dallemaioliche arcaiche(figg. 42-43) di produ-zione toscana e savo-nese5. Si tratta di ce-ramiche rivestite dasmalto bianco e deco-rate in verde e bruno.
Le maioliche arcai-che rinvenute a SanNicolao presentano imotivi decorativi tipicidella produzione delXIV e XV secolo. Oltrealla produzione decora-ta in verde e bruno,sono attestati piatti inmonocromia bianca,scodelle con breve tesae piccoli recipienti persalse anch’essi sempli-cemente smaltati inbianco.
Decisamente menoattestate, le graffite ar-caiche tirreniche e legraffite policrome diproduzione savonese.
Fig.40 - Cucina medievale: si osservi l’utilizzo delle olle,affiancate al fuoco, o poste a sospensione.
Fig.41 - Esemplificazione della morfologia delle olle edel testo da pane/fornetto documentati a San Nicolao.
45
Si tratta, in questocaso, di ceramiche chepresentano decorazionigraffite su un ingobbiodi colore chiaro e poidipinte in giallo e ver-de prodotte a Savonatra XIII e XV secolo6.
Le importazionisono documentate daalcuni frammenti di ce-ramica smaltata di pro-duzione spagnola rife-ribili al XIV-XV secolo.Del tutto assenti lemaioliche liguri e ita-liane del XVI secolo. La
frequentazione più tar-da del sito è documen-tata da un frammentodi ceramica “graffita astecca” di produzionepisana7.
Le forme delle cera-miche da tavola rinve-nute, sono prevalente-mente testimonianzadi una dotazione di tipoindividuale, mentresono scarsi i recipientiadatti ad un uso collet-tivo, quali grandi piat-ti o catini da portata .
Oltre ai manufatti
Figg.42-43 - Catino di maiolica arcaica di produzionesavonese (XIV- XV secolo).
ceramici, sono venutialla luce anche reci-pienti da cucina in pie-tra ollare. Si tratta direcipienti in pietra, la-vorati al tornio, prodot-ti nelle valli alpine eutilizzati prevalente-mente per la cotturadei cibi. Il numero diframmenti di pietra ol-lare rinvenuti è piut-tosto esiguo, tutti ri-conducibili al tipo (tal-coscistico) diffuso inmolti contesti bassomedievali liguri8.
C. Pittera
NOTE
1 Tra le relazioni prelimi-nari dedicate all’esamedei reperti di San Nicolao,si veda: BENENTE - CODO-VILLA - PASTORINO 2004 eBENENTE 2005, con prece-dente bibliografia.2 CFR. QUIRÒS CASTILLO
1998 e PRUNO 2003, pp.75-76; DADÀ-FORNACIARI
2006, pp. 7-8.3 BENENTE - CODOVILLA - PA-STORINO 2004, p.69.4 BENENTE - CODOVILLA - PA-STORINO 2004, p.72.5 BENENTE 2001c, pp. 206-228.6 VARALDO 2001b, pp.167-198; RAMAGLI 2001, pp.252-253.7 L’attestazione confermala diffusione della cerami-ca graffita a stecca neicontesti urbani e ruralidella Liguria orientale.cfr. BERTI 2005, pp.173-174.8 Confronti con i repertidel villaggio abbandonatodi Zignago e numerse at-testazioni negli scavi ur-bani di Genova e Savona.
46
11. L’ALIMENTAZIONE: MINESTRE E FOCACCETTE
L’analisi dei dati ar-cheologici fornisce al-cuni indizi sulle ten-denze e sulla tipologiadel “consumo” alimen-tare. La presenza di te-stelli, testi da pane (for-netti) e olle costituisceun chiaro indicatorearcheologico della pa-nificazione domestica,della produzione disemplici focaccette edell’elaborazione dizuppe, minestre o po-lente di farina di cere-ali poveri; elementi cheandrebbero inquadratinella funzione specifi-ca del complesso, de-stinato all’accoglienzadei pellegrini e dei vian-danti e legato ai doveristabiliti dall’ospitalitàreligiosa. Il consumo dicarne è indirizzato pre-valentemente all’alle-vamento in posto o al-l’acquisto di fauna do-mestica e sono scarsele tracce di selvagginae prodotti di attivitàvenatoria. L’elementopreponderante delladieta è costituito daicaprovini, ma è signi-ficativa l’attestazionedel consumo di carnesuina e di minori per-centuali di pollame.Questi elementi vannotenuti in considerazio-ne per l’interpretazionedelle tracce di struttu-re esterne destinate alricovero degli animali.
Fig.44 - Cucina di una casa rurale. Tacuinum Sanitatis(XIV secolo) della Biblioteca Casanatese.
Fig.45 - Il ciclo di produzione delle focaccette (testaõ)tramite i testelli a Nascio, in Val Graveglia.
47
12. UTENSILI D’USO DOMESTICO, ELEMENTI
D’ABBIGLIAMENTO, ARMI E MONETE
I reperti metallici-rinvenuti nello scavo,quando non sono per-tinenti all’edilizia, ri-mandano alla dotazio-ne della cucina e dellatavola del complesso, oall’abbigliamento deisuoi frequentatori (fig.49). Risulta interes-sante la presenza didue punte di freccia daarco, a corpo lungo esottile, con cuspide pi-ramidale distinta dalcorpo1, di una “noce”da balestra in osso (fig.50), di punte di verret-tone da balestra e diuna punta di giavellot-to (fig. 47), oltre che dialcune lame di coltelloe di pugnale (fig. 46).
La maggior parte deireperti di armi provie-ne dalle fasi di frequen-tazione dell’area suc-cessive alla perdita difunzione dell’Edificio 3.Si tratta di una serie diattività legate a un epi-sodio di frequentazionetemporanea per cui siè ipotizzato l’acquartie-ramento di militari nel-l’area (vedi supra pp.37-38).
Significativa - inquesta direzione - è lapresenza delle frecceda arco. L’uso di que-st’arma sembra affievo-lirsi a partire dagli ini-zi del XIII secolo, purnon essendo mai deltutto abbandonato, e
torna ad imporsi nelXIV secolo, grazie al-l’influenza della pre-senza in Italia di nume-rosi mercenari inglesiarmati di arco lungo2.
Le due punte di frecciapotevano far parte del-la dotazione bellica del-la guarnigione genove-se attestata nella roc-ca Petrecolicis, oppure
Fig.47 - Punte di dardi di balestra e punte di freccia
Fig.46 - Piccolo pugnale proveniente da una dellesepolture e lama di coltello da cucina.
48
appartenere a truppeprovvisoriamente ac-quartierate nell’areadell’ospedale. La pre-senza di un paio di for-bici in ferro e di alcu-ne fusaiole in terracot-ta rimanda alle attivi-tà artigianali e di fila-tura della lana che sisvolgevano nel com-plesso.
Risulta significativala mancanza di repertiimmediatamente riferi-bili al pellegrinaggio(insegne di pellegrinag-gio, conchiglie, oggettidevozionali, puntalimetallici di bastone dapellegrino). L’assenzadi reperti che offronouna precisa connota-zione “pellegrinale” alsito di San Nicolao devetenere conto di alcuneconsiderazioni. Nellacasistica ligure, le at-testazioni di reperti di-rettamente riferibilialla pratica del pellegri-naggio provengonoquasi esclusivamenteda sepolture3, rara-mente da contesti discavo “aperti”4 o da ri-cognizioni di superfi-cie5 .
La circolazione nu-mismatica sembrereb-be attestare una varie-tà di provenienze dazecche non regionalinella prima metà delXIV secolo (Pavia, Pisa,Ferrara, Firenze, Bolo-gna) ed una riduzionead attestazioni di no-minali di zecca esclu-sivamente genovese trametà XIV e metà XVsecolo6.
Questi dati potreb-bero fornire utili ele-
Fig. 50 - Dado da gioco inosso e “noce” del mecca-nismo di scatto della ba-lestra.
Fig.49 - Fibbia da cintura che conserva una piccola partedel cinturone in cuoio. La fibbia proviene da una sepol-tura.
49
menti di analisi sullavitalità dell’arteria via-ria transitante per Pie-tra Colice, con flussidifferenziati che po-trebbero trovare corri-spondenze nelle fasi divita dell’ospedale, nelsuo utilizzo da parte dipellegrini e di viandan-ti, in una generale cir-colazione di uomini,mercanzie tra l’areapadana, la Toscana el’area costiera ligure.
F. Benente
NOTE
1 DE LUCA-FARINELLI 2002,tipo H, tav. I, n.4),2 DE LUCA-FARINELLI 2002,p. 458.3 BULGARELLI 2001, pp. 93-97; pp. 110-113; GIROD
2001, pp. 44-48; GANDOLFI
2001, p.105, MURIALDO
2001, p.108, GARDINI
2001b, p.134.4 VARALDO 2001C, pp. 114-115.5 MURIALDO-LENA 2001, pp.447-504.6 Le relazioni preliminarisullo studio dei repertinumismatici di San Nico-lao sono edite in: BALDAS-SARRI 2003a, pp.128-130.BALDASSARRI 2003b,pp.86-90.
13. VIAGGIARE NEL MEDIOEVO
OSPEDALI E LOCANDE
PELLEGRINI, MERCANTI E SOLDATI
Lo studio archeolo-gico degli hospitalia edelle strutture di acco-glienza per i viandantie per i pellegrini puòessere inquadrato inambiti di ricerca piùampi, quali ad esempiol’archeologia delle stra-de e la storia dellamentalità medievale.
A partire dal IV se-colo, la necessità di for-nire assistenza ai pove-ri, ai malati e ai vian-danti viene codificatacon specifiche norme,di cui abbiamo notiziasoprattutto per quan-to riguarda gli ambitiurbani1. A Roma mo-nasteri, xenodochia,ospizi e diaconie escholae peregrinorumassumono un ruolo si-gnificativo nell’organiz-zazione dello spaziourbano, quali struttu-re di assistenza allaplebe, ai viandanti e aipellegrini giunti permotivi devozionali adlimina Petri2.
Con le prime atte-stazioni della peregri-natio religiosa verso i“luoghi santi”, ma an-che di viaggi compiuticon intenti non devo-zionali3, i santuari co-stituiscono le tappe delviaggio del pellegrino,sono spesso localizzatiin punti nodali dellaviabilità e appaiono or-ganizzati per l’acco-
glienza con appositestrutture di servizio4.
Nell’altomedioevo leprime forme di assi-stenza organizzata lun-go le strade sono testi-moniate dalle istituzio-ni religiose, e in parti-colare dai monasteri,che mettevano a dispo-sizione strutture desti-nate all’ospitalità deiforestieri, secondo iprecetti della regola5.
Nella prima metàdel IX secolo, il ceno-bio bobbiese era dota-to di un’infermeria e diuna foresteria capacedi accogliere separata-mente ospiti religiosi elaici. La presenza di vi-sitatori e di ospiti ester-ni a Bobbio doveva es-sere ampia, se è veroche richiedeva l’operadistinta di due sovrin-tendenti6.
Nei secoli centralidel medioevo monaste-ri e pievi costituironouna rete di luoghi disosta distribuiti lungole principali direttriciviarie italiane ed euro-pee, spesso disposti adistanze cadenzate ri-spetto ai tempi di per-correnza7.
A partire dall’XI-XIIsecolo, la progressivaaffermazione sul terri-torio degli hospitaliacontribuisce a costrui-re lo scheletro dell’or-ganizzazione viaria me-
dievale, insieme ad unavaria tipologia di strut-ture “laiche”, propriedell’ospitalità a paga-mento8.
L’ondata di nuovefondazioni ospedalieresi diffuse lungo le viecommerciali e di pelle-grinaggio tra Italia eSpagna e si estese poia tutta l’Europa. La let-teratura d’argomentodistingue abitualmen-te tre fasi di espansio-ne: tra X e XII secolo,sulla scia del riformi-smo cluniacense e ci-stercense, la nascita diospedali per pellegriniè sostenuta dai sovra-ni, dalle aristocrazielocali e dai monasteri.
A partire dal XII se-colo, si segnalano mol-te fondazioni di ospe-dali ad opera di laici ca-ritatevoli, che ne affi-davano la gestione aordini religioso/caval-lereschi, a canoniciagostiniani o a confra-ternite religiose.
Tra XIV e XV seco-lo, l’assistenza si indi-rizza maggiormente afavore dei ceti poveri ebisognosi e degli am-malati e, sovente, gliospedali vengono gesti-ti dalle autorità citta-dine o comunali9.
Secondo una teoriadi tipo evolutivo del-l’ospitalità, le forme diaccoglienza religiosa
50
gratuita e caritativa -prevalenti nell’altome-dioevo - sono sostitui-te nel basso medioevodal passaggio all’ospi-talità di tipo commer-ciale fornita dalle lo-cande10. La crisi del-l’ospitalità medievale -in ambiente urbano - èsicuramente legata allosviluppo degli ospedalimaggiori e all’avvio del-la tradizione ospedalie-ra rinascimentale11 .
Nelle aree rurali,tale crisi sembra inve-ce legata allo stato di“sicurezza” delle stradee di pericolo per i via-tores, a contingentimotivi politico econo-mici, al passaggio dal-le forme di devozione epellegrinaggio di lungotragitto alla devozionedi tipo locale e dome-stico, sub regionale, le-gata soprattutto allanascita e allo sviluppo
dei santuari mariani12.Diversi contributi di
indirizzo metodologicosono stati dedicati allastoria della viabilitàmedievale, spesso sot-to il profilo storico/eco-nomico e giuridico, piùraramente sotto il pro-filo storico-topograficoed archeologico13.
Un recente lavorodi Stella Patitucci Ug-geri ha delineato gli in-dirizzi e i problemi del-lo studio delle vie diterra e d’acqua nell’Ita-lia medievale, sottoli-neando l’attenzioneche l’analisi della via-bilità storica deve rivol-gere al preciso contestogeomorfologico, ai datidelle fonti scritte, alletracce materiali (ma-nufatti, tracciati e in-frastrutture) legate allavia, al tessuto demico/insediativo connessoalla strada, alla topo-nomastica14.
L’archeologia dellestrade - in Liguria - siè occupata principal-mente della ricostru-zione della rete di col-legamento commercia-le tra Genova e la Pia-nura Padana15, conparticolari approfondi-menti mirati alla cono-scenza delle “volte”stradali, ossia dei cara-vanserragli e/o magaz-zini commerciali dispo-sti lungo le principalidirettrici viarie di co-municazione16.
La presenza sul ter-ritorio di strutture “lai-che”, legate all’ospita-lità “a pagamento”,connesse agli utilizzicommerciali, mercanti-
li - e militari - dellestrade, ed estranee al-l’organizzazione religio-sa dell’assistenza aiviandanti non costitu-isce, comunque, un in-dicatore esclusivo perla ricostruzione storicadella viabilità. Quandole direttrici viarie coin-cidono, difficilmente sipuò teorizzare una di-stinzione tra i percorsidei pellegrini, i percor-si dei mercanti e le viedegli armati.
Si potrà piuttostooperare una distinzio-ne fra strutture di as-sistenza e servizi stra-dali con scopi e naturadiversificati. In questomodo, lo studio dei luo-ghi di culto e dellestrutture di assistenza- correlato allo studiodella viabilità e dei ser-vizi di strada - può con-tribuire ad una rico-struzione storica glo-bale delle strade per-corse dall’uomo medie-vale: dal mercante e dalcavaliere, così come dalpellegrino.
F. Benente
NOTE
1 Nel canone 75 del Con-cilio di Nicea (325) simenziona l’esigenza dicostruire ospizi per i po-veri, per gli ammalati eper i viandanti. Nel VIsecolo, il primo libro delCodex Justinianus affron-ta in alcune norme la giu-risprudenza su orphana-tròphia, ptocotròphia egerontocòmia, ossia distrutture appositamentepensate per sopperire albisogno di alloggio e rico-
51
Fig.51 - San Giacomo raf-figurato in abiti da pelle-grino. Portale dell’Oratoriodei SS. Giacomo e Filippo,Borzonasca.
vero degli orfani, dei po-veri e degli anziani.2 Gli xenodochia e gli ospi-zi si diffusero in Italia siasotto forma di case indi-pendenti, sia come an-nessi di sedi vescovili omonasteri. PEYER 2000, p.128-129; Per l’organizza-zione assistenziale dellaRoma altomedievalecfr.GIUNTELLA 2001, pp.639-641, GIUNTELLA 2003,pp.41-50.3 Si devono qui ricordarei resoconti di viaggio dilaici ed ecclesiastici: ilviaggio a Roma e in Ter-rasanta ricordato nell’Iti-nerarium Sancti Willibaldi(VIII secolo), le annotazio-ni itinerarie nel Liber pon-tificalis della chiesa ro-mana e nell’opera raven-nate di Andrea Agnello (IXsecolo), il ritorno daRoma all’Inghilterra del-l’arcivescovo Sigerico (Xsecolo), l’opera di Guido-ne ( XI-XII secolo), quelladi Edrisi e altri e nume-rosi resoconti di viaggiodel XII-XIII secolo.Cfr.PATITUCCI UGGERI 2002,p.4.4 La nascita e lo sviluppodi un santuario sonospesso accompagnate daepisodi di fervore edilizioe da forme di aggregazio-ne insediativa, contri-buendo alla formazione dipiccoli nuclei, spesso in-dividuati con un agioto-ponimo. Cfr. PANI ERMINI
1998, pp. 837-877; CAN-TINO WATAGHIN 1998a, pp.624-625.5 Le regole del monache-simo occidentale, in ac-cordo con i modelli orien-tali, attribuirono grandeimportanza all’ospitalità eall’organizzazione di al-
loggi per ospiti, separatidal corpo del convento.La Regula magistri, elabo-rata in Italia meridionaletra V e VI secolo organiz-zò la materia dell’ospita-lità e dell’accoglienza conuna serie di norme bendettagliate. Dopo il ritua-le dell’accoglienza, il rico-vero degli ospiti - per ilconsueto periodo massi-mo di tre giorni - avveni-va in un locale dormito-rio, sorvegliato da mona-ci e dotato soltanto di let-ti, in modo da ovviare allapossibilità di furti. Que-ste norme furono ripresenel VI secolo dalla regolabenedettina che però spi-ritualizzò particolarmen-te il rituale dell’accoglien-za. Successivi commentialla regola benedettina, apartire dal IX secolo, fu-rono mirati a graduare lemodalità di ricezione del-l’ospite e a limitare la pos-sibilità di accoglienza, inmodo che i doveri di ospi-talità non dovessero an-dare a detrimento deglialtri doveri del monaste-ro. Cfr. Regula S. Benedic-ti, LIII; CANTARELLA 1997,pp. 25-27; CANTINO WATA-GHIN 1998a, pp. 625-629;PEYER 2000, pp.128-132.6 Cfr. POLONIO 2003, pp.109-112.7 Luoghi di sosta che sonoben testimoniati dai reso-conti di viaggio che cisono stati lasciati dai pel-legrini. SUMPTION 1981;SETTIA 1996b, p. 27; AIRAL-DI 2001, pp. 26-33.8 PEYER 2000, pp.233-294; CAGNANA 1996, p. 73,fig. 1; QUIRÒS CASTILLO
2000.9 PEYER 2000, p. 139; MAR-CHESANI-SPERATI 1981, pp.
55-56.10 Secondo altre tesi,l’ospitalità a pagamentodelle persone abbientifece già il suo ingressonegli ospedali e nei mo-nasteri tra IX e X secolo.Da questo periodo in poil’ospitalità caritativa sa-rebbe stata a solo appan-naggio dei poveri e dei bi-sognosi. Cfr. PEYER 2000,pp. 26-147.11 MARCHESANI - SPERATI
1981, pp. 55-56.12 Per un quadro “ligure”del fenomeno, cfr. MERIA-NA 1993, pp.9-5613 Cfr. come riferimentogenerale ai problemi trat-tati nel testo: PLESNER
1938; STOPANI 1988; SZA-BÒ 1992; SETTIA 1996a,pp. 75-92; UGGERI 2000;PATITUCCI UGGERI 2002,pp.1-72.14 Cfr. soprattutto PATITUC-CI UGGERI 2002, pp.1-19.15 CAGNANA 1996, pp. 71-74; MANNONI 2001, pp. 58-61.16 Si tratta di strutturechiuse, talora protette datorri, articolate su cortiliinterni con porticato estalle per il ricovero deimuli, con magazzini de-stinati alle merci e allog-gi per i proprietari e i mer-canti posti ai piani supe-riori. Cfr.QUIRÒS CASTILLO
2000, p.37.
52
Il pellegrinaggio ri-veste un ruolo ben pre-ciso nella spiritualità enell’esperienza quoti-diana dell’uomo medie-vale. Affrontare il viag-gio del pellegrino, as-sumerne le vesti inmaniera rituale, signi-ficava per l’uomo me-dievale abbandonaretemporaneamente lospazio consueto dellaquotidianità, per av-viarsi verso una metaben precisa: un san-tuario, uno spazio sa-cro in cui la potenzadivina aveva scelto dimanifestarsi mediantedei miracoli o tramitela presenza di reliquie1.
Tra VIII e X secolo,la pratica del pellegri-naggio si definisce sul-la base dei santuari“nazionali” e dei culti“episcopali”, nuovetappe di sperimenta-zione di una “sacralità”crescente2. Lungo iprincipali percorsi via-ri si sviluppano tappeintercalari, veri e pro-pri “segnali toponoma-stici” che preparanoalla meta finale e chenascono alla luce del-l’esigenza di “sacraliz-zare” luoghi, ambientie regioni connessi allapratica del pellegrinag-gio e al culto delle reli-quie3. La presenza di
xenodochia, di hospitiae, successivamente, lafondazione degli hospi-talia e soprattutto leloro dedicazioni santo-riali avevano lo scopodi orientare e suppor-tare spiritualmente ilcammino del pellegrinonel quadro della “pro-tezione” offerta dalSanto4, costituendotappe intermedie versouna meta lontana.
Le intitolazioni de-gli hospitalia costitui-vano, quindi, gli ele-menti connotativi, latraccia di un itinerariopreciso verso la metadella peregrinatio. Pro-prio tenendo presente
14. I PELLEGRINAGGI: ARCHEOLOGIA
E STORIA DELLA MENTALITÀ MEDIEVALE
Fig.52 - Pellegrini a Roma per il Giubileo del 1350. Da un ’illustrazione delle Croni-che di Giovanni Sercambi.
53
questo elemento, deveessere studiata tutta laserie di fattori e causelegati alla fondazione ealla dedicazione deisingoli hospitalia. Leintitolazioni documen-tate lungo una direttri-ce viaria andrebberolette in rapporto allameta del pellegrino (leintitolazioni a San Gia-como, ad esempio), adepisodi di marcata de-vozione locale, alla pre-senza di ben precisiordini religiosi ed ospi-talieri, alla diffusionedi culti determinati, alpassaggio di reliquie5.
Nel caso dell’ospe-dale di Pietra Colice -ma anche per l’analo-go esempio di Tea - l’in-titolazione a San Nico-lao trova riscontro nel-la diffusione del cultoin Liguria tra XII e XIIIsecolo, testimoniatadalla dedicazione di al-cune chiese del Tigul-lio, ma anche dalla suadiffusione nella religio-sità popolare duecente-sca, documentata dal-le rime dell’Anonimogenovese6. Un altroaspetto proprio dellastoria della mentalitàmedievale è legato allapresenza di aree cimi-teriali annesse ai com-plessi ospitalieri, comenel caso di San Nico-lao di Pietra Colice.Secondo il diritto cano-nico, gli ospedali reli-giosi - distinguendosidagli hospitalia privatae prophana - fruivanodelle immunità e deibenefici propri dei locasacra7.
Questo tipo di strut-
ture aveva, quindi, lafacoltà di avere campa-nile, cappella e cimite-ro e vi si officiavano lefunzioni sacre. La giu-risdizione religiosa pre-vedeva che pellegrini,viandanti o personaledell’ospedale potesserotrovare sepoltura apudecclesiam, sotto la pro-tezione offerta dal san-to pellegrino cui era de-dicato il luogo di cul-to8.
Un secondo ed im-portante elementod’analisi è offerto dallefondazioni religiose nelquadro dell’organizza-zione delle “aree distrada”9 e dei poteri -signorili e comunali -che venivano esercita-ti sulle strade.
Nel medioevo, fermarestando la scelta diuna precisa direttriceviaria, la preferenzaaccordata ad un itine-rario piuttosto che adun altro poteva esserecondizionata dalla si-tuazione politica, dagliequilibri di potere, epoteva variare con ilvariare delle alleanze edelle particolari condi-zioni di sicurezza10.
Soltanto le zone dipassaggio obbligatoimpongono percorsiprecisi e, in questocaso, la presenza difondazioni religiose, diponti, di hospitalia,come ovviamente quel-la di fortificazioni, puòessere l’indizio di unpotere forte esercitatosulla strada stessa osul comprensorio terri-toriale.
La fondazione e la
gestione di una strut-tura ospitaliera da par-te di un ente, di un or-dine religioso, di unvescovo, di un privato,di un membro delle ari-stocrazie detentrici delpotere locale sono,inoltre, portatori di in-formazioni, di “messag-gi” che possono essereanalizzati e compresinel quadro della storiareligiosa e sociale di unterritorio e delle formedella “propaganda” fa-miliare e personale.
Uno studio di ampiorespiro - che prenda inconsiderazione con-giuntamente viabilità eospedali - dovrà com-portare una valutazio-ne delle dinamiche dipotere, pubbliche o pri-vate, e delle strutturedi controllo che - neidiversi momenti stori-ci - sono state attivenell’ambito di un’areadi strada11.
Entrando in meritoal caso qui oggetto distudio, emergono conforza alcuni quesiti. Cisi deve, infatti, chiede-re chi siano i promoto-ri e quali strategie sia-no alla base della fon-dazione dell’ospedale diSan Nicolao di PietraColice (ma anche degliospedali di San Miche-le di Centocroci, delPasso del Bocco, di SanBenedetto di Missano edell’ospedale e del pon-te di Lavagna) e soprat-tutto della costruzionedel grande edificioospitaliero qui esami-nato12.
È, infatti, importan-
54
te chiarire il ruolo spe-cifico svolto dai mem-bri della famiglia deiconti di Lavagna ecomprendere l’impor-tanza del compito as-solto dalla gestione diospedali “di passo” e diospedali di ponte nelquadro delle politicheterritoriali e propagan-distiche attivate daiFieschi nell’area com-presa tra la Val di Taro,la Val di Vara, la costadel Tigullio e la Luni-giana13.
Allo stesso tempo,proiettando l’attenzio-ne sull’area di stradadel Passo del Bracco/Pietra di Vasca devonoessere considerate lestrategie politiche po-ste in atto dal comunedi Genova nel XIII se-colo, con la costruzio-ne e la gestione delcastrum Petrecolices,posto al vertice diun’arteria “storica” dicomunicazione, inun’area a fitta densitàdi castelli (ad es. ca-stelli di Frascati,Lagneto, Passano,Celasco, Salino, Lago),dove sono attestati po-teri signorili capaci dicostituire distretti ter-ritoriali autonomi14.
F. Benente
NOTE
1 VAUCHEZ 1993, pp.144-160.2 CARDINI 1988, pp. 1027-1028.3 Le tappe intercalari de-gli itinerari religiosi sonospesso materializzate daedifici di culto. Questi
luoghi sono sacralizzatidalla presenza di reliquie,da monumenti che ripro-ducono edifici dei luoghisanti, dalla presenza dielementi figurativi colle-gati alle mete del pellegri-naggio, o di simboli pro-pri del mondo dei pelle-grini (il labirinto, la con-chiglia, ecc.). Cfr. PATITUC-CI UGGERI 2002, pp.7-10.Per l’area della Liguria diLevante, si veda BASSO
20014 Data la vastità della bi-bliografia d’argomento, sirimanda genericamenteai contributi editi in: Santie demoni nell’Alto Medio-evo occidentale e per laLiguria BULGARELLI – GAR-DINI – MELLI 2001; cfr. an-che BASSO 1999.5 CARDINI 1988, p. 1032.6 Cfr. ad esempio, la riman. X, intitolata “De San-cto Nicolao”: San Niche-roso confesor/Chi sei pinde pietate/e aprestao se-correor/en ogni necessi-tae/a mi, malvale pecca-or,/tuto pin de iniquitae/semper seai consolaor/inognuncana aversitae” daLe Rime volgari dell’ano-nimo genovese, X. Devo lasegnalazione alla cortesiadell’amico e scrittore Ma-rio Dentone.7 MARCHESANI - SPERATI
1981, pp.29-368 ARIÉS 1980, pp.52-71. epp. 88-949 SERGI 1981; QUIRÒS
CASTILLO 2000, pp. 16-22.10 SETTIA 1996a, p. 27.11 Grazie ad un’analisi diquesto tipo, ad esempio,è stata avanzata l’ipotesiche i proventi signorili inLunigiana derivassero dalcontrollo dei servizi distrada, piuttosto che dal-
l’imposizione di pedaggiarbitrari e dalla gestionedi “castelli stradali” e cheil controllo stradale costi-tuisse una forma di do-minazione sociale sumercanti e contadini. Cfr.QUIRÒS CASTILLO 2000, pp.16-22.12 Ospedali che, a partiredal XIII secolo risultanotutti dipendere dalla chie-sa fliscana di San Salva-tore di Lavagna (SISTO
1978; CALCAGNO 2001,pp.33-35; Il cammino del-la Chiesa genovese, p.201)13 CALCAGNO 2002, pp. 33-64.14 Questo è il caso - adesempio - dei domini diLagneto e di CelascoCAGNANA-QUIRÒS CASTILLO
2000; BENENTE-PERIPIMENO
2002.
55
15. ARCHEOLOGIA DEGLI HOSPITALIA IN LIGURIA
Alcuni progetti dicensimento delle strut-ture legate all’ospitali-tà religiosa e all’ospe-dalità sono stati svilup-pati per Genova, il Ge-novesato e per la Ligu-ria orientale1 ed hannoaccompagnato unafruttuosa stagione distudi storici sulla via-bilità e sugli ordiniospitalieri collegati al-l’assistenza ai viandan-ti e ai pellegrini2. Risul-ta però difficile, allaluce dei dati finora editiin Liguria, parlare diuna ricerca archeologi-ca appositamente pro-gettata per uno studioglobale dei luoghi diculto (chiese, cappelle,santuari) e dei luoghi diassistenza (hospitalia)legati alla viabilità dipellegrinaggio, o piùgeneralmente collegatiai percorsi terrestri checonsentivano il transi-to di uomini e merci trala Liguria e le aree ge-ografiche contermini.
Lo scavo degli ospe-dali di San Nicolao diPietra Colice3, di SanGiacomo di Possuolo4
e di Pian delle Reste5
costituiscono operazio-ni di scavo condotte nelmomento di formazio-ne e prima definizionedegli ambiti disciplina-ri dell’archeologia me-dievale. Questi scavihanno avuto revisioni
ed edizioni dei dati con-dotte in tempi recenti6.Non prendendo qui inconsiderazione i validilavori condotti sullegrandi istituzioni ospi-taliere urbane genove-si7, si può affermareche una stagione distudi archeologici sultema degli ospedalimedievali e sulla lororelazione con la viabi-lità nelle aree extra ur-bane e rurali è ancorain fase di definizione8.
In particolare, ac-canto all’analisi dellestrutture materiali,dell’organizzazione de-gli spazi, della diacro-nia di utilizzo e dellacultura materiale checaratterizza gli ospeda-li posti nelle aree extraurbane e rurali, an-drebbe approfondito ilruolo svolto dalle strut-ture ospitaliere in rap-porto alla rete viaria ealla gestione comuna-le o signorile delle areedi strada (fig. 55).
Ulteriori aspetti cheandrebbero chiaritisono la progressiva ac-quisizione da parte de-gli hospitalia di unaprecisa connotazionereligiosa e i tempi del-l’affermazione di unaben definita specializ-zazione d’uso. Esami-nando la documenta-zione d’archivio, si os-serva come - nella
maggior parte dei casi- la prima menzionedocumentaria degliospedali (tra XII ed ini-zi XIII secolo) è quasisempre legata all’indi-cazione della sua ubi-cazione geografica, se-condo la formula hospi-talis + toponimo, men-tre solo in un momen-to successivo troviamoattestate le intitolazio-ni ad un ben precisosanto protettore e/o lapertinenza ad un enteecclesiastico.
Allo stesso modo,andrebbe ben valutatala tempistica di acqui-sizione di una specia-lizzazione verso l’acco-glienza di pauperes,pellegrini e infermi, te-nendo anche conto chela presenza di un nu-cleo stabile di residen-ti (rettore, fratres, con-versi, donati ecc.) dove-va comportare nucleiinsediativi di maggiorestensione, con edificistudiati per diverse de-stinazioni d’uso.
Gli scavi finora con-dotti in Liguria e inaree contermini contri-buiscono solo in partead offrire indicazionisulla definizione plani-metrica delle struttureospitaliere (fig. 53). Lapresenza iniziale di unedificio di culto (SanNicolao di Pietra Coli-ce, San Giacomo di
56
Fig.53 - Sviluppo planimetrico degli ospedali di SanNicolao di Pietra Colice, di San Nicolao di Tea, di S.Giacomo di Possuolo e dell’ospedale di Cian de Reste.
Possuolo) - con un ipo-tizzabile locale annes-so, destinato all’ospita-lità9 - si accompagna,in una seconda fased’uso genericamentecollocata tra XIII e XIVsecolo, alle tracce distrutture a pianta ret-tangolare allungata,del tipo “a sala” (SanNicolao, Pian delle Re-ste), con sviluppi pla-nimetrici non semprecomputabili.
Lo scavo di San Ni-colao di Pietra Coliceha posto in luce unastruttura a pianta ret-tangolare di ca. 120mq, con alcune parti-zioni interne. L’ospeda-le di Pian delle Reste,nella sua seconda fased’uso, è articolato inalmeno due distintestrutture. Uno degliedifici, a pianta rettan-golare, presenterebbeuno sviluppo internosuperiore ai 90 mq10.
È possibile riscon-trare qualche coinci-denza tra i dati ancoraframmentari fornitidall’evidenza ligure e idati emersi dalle inda-gine condotte in Luni-giana. Nel caso del-l’ospedale di San Nico-lao di Tea (fig.54),un’esaustiva indaginearcheologica ha chiari-to come, alla fase di XIsecolo, articolata suedificio di culto e pic-colo locale annesso,faccia seguito nel XIIIsecolo (2a fase d’uso) lacostruzione di un edi-ficio a pianta rettango-lare, distinto in dueambienti posti a quotedifferenziate, con uno
sviluppo complessivodi ca. 128 mq. A que-sta struttura si aggiun-gono progressivamen-te, tra XIII e XVI seco-lo, ulteriori annessicon funzioni specifi-che11.
Il recente scavo del-l’ospedale suburbanodi S. Giovanni a Pon-tremoli, pur nella ridot-ta conservazione delleevidenze, ha consenti-to di documentarestrutture murarie econtesti d’uso di XIII-XIV e una successivafase cimiteriale di fineXIV - inizi XV secolo12.
Tenendo presente ilrischio di una perico-losa generalizzazione,operando sulla base didati che sono ancorascarsi e frammentari,sembrerebbe che a fasiiniziali articolate sul bi-nomio chiesa + piccolo
locale con funzioni diospitalità, faccia spes-so seguito la realizza-zione di strutture piùcomplesse, articolatesu un edificio a piantarettangolare, anche digrandi dimensioni (80- 120 mq e oltre) chepuò successivamenteessere ingrandito conl’aggiunta di annessi edi ulteriori vani.
Risulta comunqueevidente che soltanto laconduzione di scaviestensivi ed un atten-to lavoro di censimen-to ed analisi territoria-le potranno consentireuna maggiore definizio-ne delle tipologie e del-le diverse scelte plani-metriche adottate daifondatori e dai gestoridegli ospedali ligurimedievali.
F. Benente
57
NOTE
1 Cfr. MARCHESANI - SPERATI
1981; BRUZZONE-SANTAMA-RIA 2002; SALVATORI 1999.Per un progetto di censi-mento e localizzazionecartografica dei luoghi dipellegrinaggio della Ligu-ria orientale, cfr. Le vie ei segni del pellegrinaggio.2 Cfr. ad esempio i con-tributi raccolti in Rivieradi Levante tra Emilia e To-scana 2001.3 CIMASCHI 1957; CIMASCHI
1959.4 CAGNANA et al. 1992.5 TORRAZZA 1974, p. 10.6 CAGNANA 2001; BRUZZO-NE-SANTAMARIA 2000; GIAN-NICHEDDA 2001.7 GARDINI 2001a, pp. 79-105.8 I progetti di studio in-centrati sugli ospedalidella Val Polcevera sem-brano ancora attestati suuna fase di generale revi-sione dei dati di passatericerche, mentre nonsembrano ancora espres-se con chiarezza le lineemetodologiche e gli indi-rizzi tematici che dovreb-bero essere alla base diuna nuova stagione distudi. Cfr. BRUZZONE-SAN-TAMARIA 2000.9 Nel caso di San Nicolaopotrebbe trattarsi dellestrutture murarie rinve-nute da Leopoldo Cima-schi nell’area posta tral’ospedale del XIII-XIVsecolo (edificio 3) e lastruttura più tarda ad-dossata alla chiesa (edi-ficio 2)10 CAGNANA 2001, p. 13011 QUIRÒS CASTILLO 2000,pp. 162-183.12 DADÀ -FORNACIARI 2006,pp.143-167.
Fig.54 - Ipotesi ricostrittiva dell’ ospedale di San Nicolaodi Tea, nella sua fase di XIII secolo. (QUIRÒS CASTILLO
2000, p.175).
58
Fig.55 - Carta di distribuzione degli edifici di culto e deiprincipali ospedali del Tigullio.
16. BIBLIOGRAFIA E APPROFONDIMENTI
AIRALDI G. 2001, Il raccon-to del pellegrino, in BUL-GARELLI - GARDINI - MELLI
2001, Genova, pp. 26-35.ARIÈS P. 1980, L’uomo ela morte dal medioevo aoggi, Roma - Bari.BAFFICO O., CRUISE G. M.,MACPHAIL R. I., MAGGI R.,NISBET R. 1987. Monte Aio-na - Prato Mollo, in P. MEL-LI E A. DEL LUCCHESE (acura di), Archeologia inLiguria III.1. Scavi e sco-perte 1982-86. Preistoriae Protostoria, Genova, So-printendenza Archeolo-gica della Liguria 1987,pp. 57-66BALDASSARRI M. 2003a, Ireperti numismatici di SanNicolao, in BENENTE F. etalii 2003a, pp.128-130.BALDASSARRI M. 2003b, Ireperti numismatici, inBENENTE F. et alii 2003b,pp.86-90.BASSO V. 1999, Vie e se-gni del pellegrinaggio nel-la zona orientale del Ge-novesato, in “Compostel-la”, n. 25, (1999), Pisto-ia.BASSO V. 2001, Per unamicrostoria del pellegri-naggio. Presenze di pelle-grinaggio tra Levanto eGenova, in BULGARELLI -GARDINI - MELLI, 2001, pp.87-92.BELGRANO L. T. 1862, Il re-gistro della curia arcive-scovile di Genova, in “Attidella Società Ligure diStoria Patria”, II (1862),Genova.
BENENTE F. 1991, Notesulla maiolica arcaica aSavona e in Liguria tra XVe XVI secolo, in “Atti delXXIV Convegno Interna-zionale della Ceramica”,Albisola (1991), pp. 91-108.BENENTE F. 2000a, Bilan-cio e destini di un temastoriografico, in L’incastel-lamento in Liguria (X-XIIIsec.) (Atti della Giornata diStudio), a cura di F. BE-NENTE, Rapallo 26 aprile1997, Bordighera 2000,pp. 17-69.BENENTE F. 2000b,Premessa…sotto forma diriflessione metodologica,in Incastellamento, popo-lamento e signoria ruraletra Piemonte Meridionalee Liguria, Volume 1 - Te-sti Preliminari del Semi-nario di Studi, Acqui Ter-me, 17-19 novembre2000, a cura di BENENTE
F. e GARBARINO G.B., Bor-dighera, pp. 7-12.BENENTE F. 2000c, Inse-diamenti urbani, strutturedel territorio e viabilità inLiguria tra tarda antichitàe XI secolo: Genova, il Ge-novesato e l’area del Ti-gullio, Tesi di Dottorato diRicerca, Università degliStudi di Roma “La Sa-pienza”, 2000.BENENTE F. 2001a, Il pro-getto di scavo dell’ospeda-le di San Nicolao di PietraColice, in L’ospedale diSan Nicolao di Pietra Coli-ce, “Quaderni della Tigul-
lia”, 1, Chiavari, pp. 36-43.BENENTE F. 2001b, Arche-ologia delle chiese, dellecappelle, dei santuari edegli ospitali. Archeologiadei “percorsi materiali” edei “percorsi spirituali”, inBULGARELLI - GARDINI - MEL-LI 2001, Genova, pp. 83-86.BENENTE F. 2001c = F. BE-NENTE, Maiolica Arcaica, inVARALDO C. 2000, pp. 206-228.BENENTE F. 2005, Indagi-ne archeologica di unospedale di passo dellaLiguria medievale: SanNicolao di Pietra Colice., inF. BENENTE, Progetto Dei-va. Studi e risorse biblio-grafiche per la storia delterritorio di Deiva, 1, Qua-derni della Tigullia, 3,Chiavari, pp. 91-116.BENENTE F. 2005b, Proget-to Deiva. Studi e risorse bi-bliografiche per la storiadel territorio di Deiva, 1,Quaderni della Tigullia,3, Chiavari.BENENTE F. - CODOVILLA R.- PASTORINO F. 2004, Nuo-vi dati su produzione e cir-colazione delle ceramichecomuni grezze nella Ligu-ria orientale, in “Atti delXXVII Convegno Interna-zionale della Ceramica”,Albisola (2004), pp. 63-80.BENENTE F. et al. 2002, Ar-cheologia medievale nellaLiguria di Levante: gli sca-vi di Pian dei Costi, Monte
59
Loreto e San Nicolao. No-tizie preliminari delle cam-pagne 2000-2002, “Qua-derni della Tigullia”, 2,Chiavari, pp. 43-52.BENENTE F. et al. 2003a, Loscavo dell’ospedale diSan Nicolao di Pietra Coli-ce (Castiglione Chiavare-se), in “Ligures”, I, (2003),Bordighera, pp.97-136.BENENTE et al. 2003b, SanNicolao II. Lo scavo del-l’ospedale di San Nicolaodi Pietra Colice (Castiglio-ne Chiavarese) Relazionepreliminare avanzata del-le campagne di scavo2001,2003,2004, in“Giornale Storico dellaLunigiana”, n.s. AnnoLIV, Gennaio-Dicembre2003 (2005), pp.25-113.BENENTE F. – PERIPIMENO M.2002, Archeologia e storiadegli insediamenti fortifi-cati della Liguria. Rifles-sioni su problemi di ricer-ca e informatizzazione deidati, in D. Calcagno (acura di), Pietre disposte aseguir cammino, Atti delConvegno di Rezzoaglio,2001, pp.43-51.BERTI G. 2005, Pisa. Le ce-ramiche ingobbiate “graf-fite a stecca”. Secc. XV-XVII, (Museo Nazionale diSan Matteo), Firenze.BLOCH M.1969, Apologiadella Storia, Torino.BOSONI L. 2003, Fontiscritte, in BENENTE F. et al2003, pp.111-114.BRUZZONE L. – SANTAMARIA
R. 2002, Gli ospedali me-dievali della Val Polceve-ra e dell’Oltregiogo: osser-vazioni preliminari sulleproblematiche poste dallaricerca sul terreno, in“Studi Genuensi”, n.s.,16, (2000-02), pp.43-55.BULGARELLI F. – GARDINI A.
- MELLI P. 2001, Archeo-logia dei pellegrinaggi, inLiguria, Savona.BULGARELLI F. 2001, Arche-ologia del pellegrinaggio,in BULGARELLI - GARDINI -MELLI 2001, pp. 93-97.BUONGIORNO M. 1973, Il bi-lancio di uno stato medie-vale. Genova 1340-1359,in “Collana Storica diFonti e Studi”, 16, Geno-va.CAGNANA A.1996, Archeo-logia delle strade: finalitàdi ricerca e metodi d’inda-gine, in “Archeologia del-l’Architettura”, I (1996),pp. 71-74.CAGNANA A. 2001, Ospita-le di “Cian de Reste”, inBULGARELLI - GARDINI - MEL-LI 2001, pp. 129-130.CAGNANA A. et al. 1992,San Giacomo di Possuolo,in Archeologia preventivalungo il percorso di unmetanodotto, a cura diMAGGI R., “Quaderni del-la Soprintendenza Ar-cheologica della Liguria”,4, 1992, pp. 123-144.CAGNANA A. et al. 2001, Gliscavi nel castello di Cela-sco (Monte Bardellone, LaSpezia). Relazione prelimi-nare sulle campagne1996-1999, in “Archeolo-gia Medievale”, XXVIII,(2001), pp. 127-147.CAGNANA A. - QUIRÒS CASTIL-LO J. A. 2000, Incastella-mento e popolamento nel-l’area di Ceula - Levanto(SP), in L’incastellamentoin Liguria (X-XIII sec.), (Attidella Giornata di Studio,Rapallo 26 aprile 1997), acura di BENENTE F., Bor-dighera, pp. 217-239.CALCAGNO D. 2001, Docu-menti relativi all’ospedaledi San Nicolao di PietraColice (1222-1601), in
L’ospedale di San Nicolaodi Pietra Colice, pp. 33-35.CALCAGNO D. 2002, I contidi Lavagna ed il controllodel territorio, in D. CALCA-GNO (a cura di), La monta-gna tosco-ligure-emilianae le vie di commercio epellegrinaggio. Borgo Valdi Taro e i Fieschi, BorgoVal di Taro, pp.33-64.CAMPANA N., MAGGI R. (acura di) 2002, Archeolo-gia in valle Lagorara. Die-cimila anni di storia intor-no a una cava di diaspro,Origines, Firenze, Istitu-to Italiano di Preistoria eProtostoria 2002.CAMPANA N., MAGGI R., PE-ARCE M., OTTOMANO C.2006, Quanto rame? Sti-ma della produzione mi-neraria del distretto diSestri Levante fra IV e IIImillennio BC, in Atti dellaXXXIX Riunione Scienti-fica IIPP, Firenze 2006:1339-1348.CANTARELLA G. M. 1993, IMonaci di Cluny, Torino.CANTINO WATAGHIN G.1998a, I percorsi stradalidi età tardoantica, i nuoviitinerari altomedievali e ipercorsi dei pellegrini finoalla via Francigena, inTesori della Postumia, pp.623-629.CANTINO WATAGHIN G.1998b, Rete urbana e si-stema di comunicazioninegli equilibri tardoantichidell’Italia annonaria, inOptima Via, (Atti del Con-vegno Internazionale diStudi “Postumia. Storia eArcheologia di una gran-de strada romana alleradici dell’Europa”, Cre-mona 13-15 giugno1996), pp. 383-392.CARDINI F. 1988, Reliquie
60
e pellegrinaggi, in Santi edemoni nell’alto medioevooccidentale (secoli V-VI),Settimane di Studio delC.I.S.A.M., XXXVI, Spole-to 7-13 aprile 1988, Spo-leto (1989), pp. 981-1036.CAVANA M. 2005, Un’areadi sosta per pellegrini eviaggiatori, in “Guida agliitinerari fliscani nel Tigul-lio”, Recco.CENTI A.1899, Cenni sto-rici di Moneglia, Genova,ristampa anastatica, Bo-logna 2002.CESCHI C. 1954, Architet-tura romanica genovese,Milano.CHIAPPE M. 1996, Il Tigul-lio ed il suo entroterra nel-l’Alto Medioevo, Lavagna.CHIAPPE M. 2002, Vie di co-municazione e controllodel territorio dell’entroter-ra del Tigullio tra Medioe-vo ed Età Moderna: la Val-le Sturla nel XV secolo, inCALCAGNO 2002, pp.97-176.CIMASCHI L. 1957, Introdu-zione ai problemi archeo-logici e topografici di Pie-tra Colice, in “GiornaleStorico della Lunigiana”,n.s. VIII, n. 1-2, (1957);ora ristampato in “Qua-derni della Tigullia”, 1,(2001), Chiavari, pp. 11-20.CIMASCHI L. 1959, Unachiesa romanica a crocecommissa in un ospitalemedievale presso il passodel Bracco, in “Palladio”,1-2, 1959; ora ristampa-to in “Quaderni della Ti-gullia”, 1, (2001), Chiava-ri, pp. 21- 26.CIPOLLA C. - BUZZI G. 1918(a cura di), Codice Diplo-matico del Monastero diSan Colombano di Bobbio,
in Fonti per la Storia d’Ita-lia, Roma 1918.COLARDELLE M. 1983, Sè-pulture et traditionsfunéraires du Ve au XIIIesiècle ap. J.C. dans lecampagnes des Alpesfrançaises du nord,Grenoble, pp.136-137.COLARDELLE M. et alii 1996,Typo-cronologie des sé-pultures du Bas-Empire àla fin du Moyen Age dansle sud est de la Gaule, inH. GALINIÈ, E. ZADORA-RIO
(a cura di), Archéologie ducimetiére chrétien, Actesdu 2e colloque ARCHEA,Tour, pp.271-303.GABOTTO F. - LEGÉ V. 1905,Le carte dell’archivio capi-tolare di Tortona (Sec IX-1220), in Biblioteca dellaSocietà Storica Subalpina,XXIX, Pinerolo, pp. 22-24.GAMBARO L. 1999, La Ligu-ria costiera tra III e I seco-lo a.C., in “Documenti diArcheologia”, 18, Manto-va.GAMBARO L. 2001, Dall’al-ta Val di Vara verso Ge-nova, in Vie Romane inLiguria, a cura di R. LUC-CARDINI, Genova, pp. 75-83.GANDOLFI D. 2001, Alben-ga. S. Maria in fontibus, inBULGARELLI - GARDINI - MEL-LI 2001, pp.104-106.GARBARINO O. 1998, Il pro-blema storico dell’AlpeAdra e dei suoi confinisecondo la tesi del diplo-ma interpolato, in “Grup-po Ricerche Civiltà Ligu-re - I Quaderni di Ivo, 2”,pp.13-43.GARDINI A. 2001a, Le ricer-che archeologiche nelcomplesso ospitaliero del-la Commenda di Prè aGenova, in La Riviera di
Levante tra Emilia e To-scana, Bordighera, pp.79-105.GARDINI A. 2001b, Camo-gli. Abbazia di San Frut-tuoso di Capodimonte, inBULGARELLI - GARDINI - MEL-LI 2001, pp. 133-134.GELICHI S. 2001, Le sepol-ture: tipologia e organizza-zione degli spazi, in S.GELICHI, I. NOBILE (a curadi), Il battistero di San Gio-vanni di Incino, Erba,pp.50-93.GELICHI S. et alii 2003, SanMichele alla Verruca: lasequenza, lo scavo dellachiesa e delle aree cimite-riali, in R. FRANCOVICH, S.GELICHI (a cura di), Mona-steri e castelli tra X e XIIsecolo, Biblioteca del Di-partimento di Archeologiae Storia delle Arti, 7, Fi-renze 2003 pp.11-38GIANNICHEDDA E. 2001,Sori. San Giacomo di Pos-suolo, in BULGARELLI - GAR-DINI - MELLI 2001, pp. 131-132.GIROD A. 2001, Le conchi-glie. Studio malacologico,in BULGARELLI - GARDINI -MELLI 2001, pp. 44-49.GIUNTELLA A. M. 1998,“Note su alcuni aspettidella ritualità funerarianell’alto medioevo. Con-suetudini e innovazioni”,in BROGIOLO, CANTINO WA-TAGHIN 1998, pp. 65-70.GIUNTELLA A. M. 2001, Glispazi dell’assistenza edella meditazione, inRoma nell’Alto Medioevo,Settimane di Studio delC.I.S.A.M., XLVIII, Spole-to (2001), pp. 639-691.GIUNTELLA A. M. 2003, Or-ganizzazione monastica eassistenziale nella Romaaltomedievale, in MARCE-NARO 2003, pp.41-50.
61
GRILLETTO R. - LAMBERT C.1989, Le sepolture e il ci-mitero della chiesa abba-ziale della Novalesa, in“Archeologia Medievale”,XVI, (1989), pp. 329-356.Il cammino della chiesagenovese dalle origini ainostri giorni, a cura di D.PUNCUH, Genova 1999.LACQUIN A. - MARCH R.J.2003. Méthodes de cuis-son pré et proto-histori-ques: le cas du Bouilli, inapproche expérimentale,in M.-C. Frère-Sautot (acura di), Le feu domesti-que et ses structures auNéolithique et aux Âgesdes metaux, Montagnac2003: 127-142.LAGOMARSINO R. 1997,Strade e fortificazioni me-dioevali di crinale tra Ra-pallo e la Fontanabuona,Rapallo.LAGOMARSINO R. 2001, Unricordo di Leopoldo Cima-schi, in L’ospedale di SanNicolao di Pietra Colice,“Quaderni della Tigullia”,1, pp. 8-10.LAGOMARSINO R. 2005, Laviabilità antica nella valledi Deiva e nella zona delBracco. Il discusso proble-ma della via Aurelia,inBENENTE 2005, pp. 57-66.Le vie e i segni del pelle-grinaggio, Cartoguida acura R. Lagomarsino, V.Basso e G. Pesce (senzadata).MAGGI R. 1992 (a cura di),Archeologia preventivalungo il percorso di un me-tanodotto, “Quaderni del-la Soprintendenza Ar-cheologica della Liguria”,4, Genova.MAGGI R. 1998. Storia del-la Liguria tra 3600 e 2300anni avanti Cristo (Età del
Rame), in A. DEL DEL LUC-CHESE, R. MAGGI (a curadi), Dal diaspro al bronzo.L’Età del Rame e l’Età delBronzo in Liguria: 26 se-coli di storia fra 3600 e1000 anni avanti Cristo,Quaderni della Soprin-tendenza Archeologicadella Liguria 5, La Spezia1998: 7-28.MAGGI R., MACPHAIL R.I.,N ISBET R., TISCORNIA I.1987. Pianaccia di Suve-ro. Il sito campaniforme, inP. MELLI, A. DEL LUCCHESE
(a cura di), Archeologia inLiguria III.1. Scavi e sco-perte 1982-1986, Preisto-ria e Protostoria, Genova,Soprintendenza Archeo-logica della Liguria 1987:33-3.MANACORDA D. 2004, Primalezione di archeologia,Roma-Bari.MANNONI T.1996, Archeo-logia dei collegamentistradali di Genova, in Lacittà ritrovata. Archeologiaurbana a Genova 1984-1994, a cura di P. MELLI,Genova 1996.MANNONI T. 2001, Le stra-de medievali della Liguria,in BULGARELLI - GARDINI -.MELLI 2001, pp. 58-61.MARCHESANI C. - SPERATI G.1981, Ospedali genovesinel medioevo, in Atti del-la Società Ligure di StoriaPatria, n.s., Vol. XXI(XCV), Fasc.I, (1981), Ge-nova.MOTTES E. (a cura di), Sim-bolo ed enigma. Il bicchie-re campaniforme e l’Italianella preistoria europeadel III millennio (Catalogodella mostra: La Rocca diRiva del Garda, 12 mag-gio – 30 settembre 1998),Trento 1998: 174-179.MURIALDO G. – LENA A.
2001, Un’insegna pelle-grinale a Perti - Finale Li-gure, in “Archeologia Me-dievale”, XXVIII (2001),pp. 497-504.MURIALDO G. 2001, S. Eu-sebio di Perti, in BULGAREL-LI - GARDINI - MELLI 2001,pp.107-109.NICOLIS F., MOTTES E. (acura di) 1998, Simbolo edenigma. Il bicchiere cam-paniforme e l’Italia nellapreistoria europea del IIImillennio (Catalogo dellamostra: La Rocca di Rivadel Garda, 12 maggio –30 settembre 1998),Trento 1998.ORLIAC C. 2003. Étudeexpérimentale du fon-ctionnement de fourspolynésiens à Tahiti, inM.-C. Frère-Sautot (acura di), Le feu domesti-que et ses structures auNéolithique et aux Âgesdes metaux, Montagnac2003: 209-214PANI ERMINI L. 1988, San-tuario e città fra tarda an-tichità e altomedioevo, inSanti e demoni nell’altomedioevo occidentale (se-coli V-VI), Settimane diStudio del C.I.S.A.M.,XXXVI, Spoleto 7-13 apri-le 1988, Spoleto (1989),pp. 837-877.PATITUCCI UGGERI S. 2002,La viabilità di terra e d’ac-qua nell’Italia medievale,in La viabilità medievalein Italia, a cura di S. PATI-TUCCI UGGERI, “Quaderni diArcheologia Medievale,IV”, Firenze, pp. 1-72.PAVONI R. 1992, LiguriaMedievale, Genova.PEYER H. C. 2000, Viaggia-re nel Medioevo. Dall’ospi-talità alla locanda, Bari.PLESNER J. 1938, Una ri-voluzione stradale del
62
Dugento, in Acta Jutlan-dica, X, 1, Kobenavn.POLONIO V. 1962, Il Mona-stero di San Colombano diBobbio dalla fondazioneall’epoca carolingia, Ge-nova.POLONIO V. 2003, Mona-chesimo altomedievale inLiguria, in MARCENARO
2003, pp.101-106.PRUNO E. 2003, La diffu-sione dei testelli nell’AltoTirreno tra XI e XIV seco-lo, in Atti III CongressoNazionale di ArcheologiaMedievale, Salerno, pp.71-77.QUIRÒS CASTILLO J.A.,1998, Cambios y tran-sformaciones en el pai-saje del Apenino toscanoentre la Antiguedad Tar-da y la Edad Media. Elcastaño, in “ArcheologiaMedievale”, XXV, Firenze,pp. 177-197.QUIRÒS CASTILLO J. A. 2000(a cura di), L’ospedale diTea e l’archeologia dellestrade nella Valle del Ser-chio, Firenze.RAMAGLI P. 2001, Graffitapolicroma savonese, inVARALDO 2001, pp. 252-253.REDI F. - MALANDRA C.2003, S. Potito di Ovindo-li. Lo scavo medievale nel-l’area della villa romana.Rapporto preliminare,anni 2001-2003, in “Ar-cheologia Medievale”,XXX (2003), pp.391-427.REDOANO COPPEDÈ G. 2001,L’estrema Liguria di Le-vante ed il suo entroterranella storia delle comuni-cazioni dal Basso Medio-evo alla metà del XIX se-colo, in CALCAGNO 2001,pp.29-152.REDOANO COPPEDÈ G. 2002,Le vie di comunicazione
dell’Appennino tosco-ligu-re-emiliano, in CALCAGNO
2002, pp. 1-31.Riviera di Levante tra Emi-lia e Toscana 2001. Uncrocevia per l’ordine diSan Giovanni, (Atti delConvegno, Genova-Chia-vari-Rapallo, 9-12 settem-bre 1999), a cura di J.COSTA RESTAGNO, Bordi-ghera.ROSSINI G. 2001, Da SanGiovanni di Prè a San Laz-zaro di Sarzana: presen-ze degli ordini ospitalierinella Riviera di Levantesulla via per Gerusa-lemme, in Riviera di Le-vante tra Emilia e Tosca-na 2001, pp.107-154.SALVATORI E. 1999, Strut-ture ospedaliere in Luni-giana: dal censimento allamicroanalisi, in Riviera diLevante tra Emilia e To-scana 2001, pp.189-222.SALVATORI E. 2001, Tramalandrini e caravanser-ragli: l’economia della Lu-nigiana medievale allaluce di alcune recenti pub-blicazioni in “BollettinoStorico Pisano”, LXX(2001), pp. 311-322.SANGMEISTER E. 1984. Die“Glockenbecher-kultur”,in SW-Deutschland, in J.GUILAINE (a cura di), L’agedu cuivre européen. Civi-lisations a vases campa-niformes, Parigi 1984:81-93Santi e demoni nell’alto-medioevo occidentale (se-coli V-VI), in Settimane diStudio del C.I.S.A.M.,XXXVI, Spoleto 7-13 apri-le 1988, Spoleto (1989).SARTI L., CARLINI C., MAR-TINI F. 1999-2000. L’ene-olitico di Volpaia a SestoFiorentino: primi dati sul-le produzioni fittili e liti-
che, Rivista di ScienzePreistoriche L, 1999-2000, Firenze: 189-227.SARTI L., CARLINI C., MAR-TINI F., PALLECCHI P. 1991.Mileto: un insedimento ne-olitico della ceramica a li-nee incise, Rivista diScienze Preistoriche XLI-II, 1991, Firenze: 73-154.SBARRA F. 2003, Aree ci-miteriali e pratiche funera-rie, in S. GELICHI et alii2003, pp. 23-36.SERGI G. 1981, Potere eterritorio lungo la strada diFrancia. Da Chambéry aTorino fra X e XIII secolo,Napoli.SERGI G. 1996 (a cura di),Luoghi di strada nel Me-dioevo, Torino.SETTIA A. A.1996a, Traccedi medioevo. Toponoma-stica, archeologia e antichiinsediamenti nell’Italia delnord, Mondovì.SETTIA A. A. 1996b, Ca-stelli e strade del Nord Ita-lia in età comunale. Sicu-rezza, popolamento, stra-tegia, in SERGI 1996, pp.15-40.SILVER I. A. 1969, Theageing of domesticanimals, in D. BROTHWEL,E. S. HIGGS, (Eds), Sciencein Archaeology, London,Thames and Hudson, pp.283-302SISTO A.1978, Chiese con-venti ed ospedali fondatidai Fieschi nel secolo XIII,in Atti del Convegno Inter-nazionale per l’VIII cente-nario dell’urbanizzazionedi Chiavari, (Chiavari, 8-10 novembre 1978), Chia-vari (1980), pp. 317-331.STOPANI R. 1988, La viafrancigena.Una strada eu-ropea nell’Italia del Medio-evo, Firenze.SUMPTION J. 1981, Mona-
63
ci, santuari e pellegrini. Lareligione nel Medioevo,Roma.SZABÒ TH. 1992, La politi-ca stradale dei comunimedievali italiani, in“Quaderni storici”, XXI,1,pp. 77-116.TECCHIATI U. 1998. Veltu-ro – loc. Tanzgasse:un’area megalitica di etàcampaniforme in Vald’Isarco (Bolzano), in F.NICOLIS, E. MOTTES (a curadi), Simbolo ed enigma. Ilbicchiere campaniforme el’Italia nella preistoriaeuropea del III millennio,(Catalogo della mostra:La Rocca di Riva del Gar-da, 12 maggio – 30 set-tembre 1998), Trento1998: 69-72TOMAINI P. 1980, Moneglia.Notizie storiche. Roma.TORRAZZA G. 1974, Campa-gna di scavo nell’ospitaledi Cian de Reste, in “No-tiziario di Archeologia Me-dievale”, 1974, pp. 10-12.Trouvailles Monétaires detombes 1999, Actes duDeuxième Colloque Inter-national du Groupe Suis-se pour le Ètude desTrouvailles Monétaires(Neuchâtel, 3-4 marzo1995), Lousanne.UGGERI G. 2000, Viabilitàantica e viabilità medieva-le. Un esempio di persi-stenza nella lunga dura-ta, in Atti VII Giornate sul-l’età romano-barbarica,Benevento, Napoli,pp.321-336.VARALDO C. 2001a, Arche-ologia urbana a Savona.Scavi e ricerche nel com-plesso monumentale delPriamàr II.2 Palazzo dellaLoggia. I materiali, in “Col-lezione di monografiePreistoriche ed Archeolo-
giche, XI”, Bordighera -Savona.VARALDO C. 2001b, Graffi-ta arcaica tirrenica in VA-RALDO 2001, PP. 167-198.VARALDO C. 2001c, Savo-na. San Domenico, in BUL-GARELLI - GARDINI - MELLI
2001, pp. 114-115.VAUCHEZ A.1993, La spiri-tualità dell’occidente me-dioevale, Milano.VIGLIARDI A. 1998. Il cam-paniforme della Grotta delFontino (Montepescali,Grosseto), in F. NICOLIS -E. MOTTES (a cura di), Sim-bolo ed enigma. Il bicchie-re campaniforme e l’Italianella preistoria europeadel III millennio (Catalogodella mostra: La Rocca diRiva del Garda, 12 mag-gio – 30 settembre 1998),Trento 1998, pp.174-179.
64