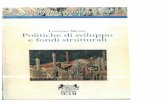Area II, saggio 2 in Aquileia, Fondi ex Cossar - Missione archeologica 2013
Transcript of Area II, saggio 2 in Aquileia, Fondi ex Cossar - Missione archeologica 2013
Aquileia - Fondi ex Cossarmissione archeologica 2013
DIPARTIMENTODEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIADELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA
Contributi di:S. Berto, J. Bonetto, V. Centola, S. Dilaria, D. Dobreva, G. Furlan, A.R. Ghiotto, E. Madrigali, C. Previato, A. Stella, S. Zago
Rilievi di:S. Berto, T. Luongo Progettazione e layout:P. Kirschner, A.R. Ghiotto
DIPARTIMENTODEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIADELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA
Piazza Capitaniato 735139 PADOVA +39 049 8274591/4587fax +39 049 8274613 www.beniculturali.unipd.it [email protected] [email protected]
La ricerca è �inanziata da Arcus S.p.A., Fondazione Aquileia, MIUR e Università degli Studi di Padova, Progetto di Ateneo 2012 “Conoscenza, tutela e valorizzazione. Le ricerche nei fondi ex Cossar di Aquileia come modello innovativo di approccio alle aree archeologiche complesse” (responsabile scienti�ico A. R. Ghiotto; codice progetto GHIOPRAT12).
In copertina: strutture produttive nell’area II, saggio 4 - calco di gemma a soggetto dionisiaco (IG 562481).
ISBN: 9788890842436
Aquileia - Fondi ex CossarMissione archeologica 2013
a cura di Jacopo Bonetto e Andrea Raffaele Ghiotto
Padova 2014
5
Sommario
Premessa Jacopo Bonetto,Andrea Raffaele Ghiotto
p. 7
Area II, saggio 1 Emanuele Madrigali p. 15
Area II, saggio 2 Caterina Previato p. 19
Area II, saggio 3 Caterina Previato p. 23
Area II, saggio 4 Vanessa Centola p. 29
Area II, saggio 5 Caterina Previato p. 37
Area III, saggio 1 - Ambiente 11 Caterina Previato p. 47
Area III, saggio 2 Simone Berto, Simone Dilaria, Guido Furlan, Sabrina Zago
p. 53
Area III, saggio 3 Andrea Raffaele Ghiotto,Emanuele Madrigali
p. 63
Area III, saggio 4 Jacopo Bonetto p. 71
Verso uno studio del paesaggio economico aquileiese. Sintesi dei dati relativi ai ritrovamenti ceramici della campagna 2013
Diana Dobreva p. 77
I rinvenimenti monetali Andrea Stella p. 93
7
Premessa
Dal 20 maggio al 19 luglio 2013, seguita da due settimane di ulteriori verifiche condotte nel mese di settembre, si è svolta la quinta campagna di ricerche archeologiche presso i fondi ex Cossar di Aquileia, conferiti in gestione alla Fondazione Aquileia. Le indagini sono state coordinate e condotte sul campo dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, in co-direzione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia.Le attività sono state dirette da chi scrive, con la collaborazione di Simone Berto, Vanessa Centola, Diana Dobreva, Guido Furlan, Tiziana Luongo, Emanuele Madrigali, Caterina Previato e Andrea Stella. A queste, scandite in tre turni di tre settimane, hanno partecipato nel complesso oltre 30 studenti, specializzandi, borsisti, dottorandi e assegnisti delle Università di Padova, Udine e Brno.Le indagini hanno riguardato due diverse aree di scavo, ubicate all’interno della grande domus che occupa il settore centrale dell’area archeologica. L’abitazione fu parzialmente indagata, a più riprese, durante il secolo scorso, per diventare poi oggetto delle nuove ricerche avviate nella campagna 2009. La prima delle due aree (area II) si estende nel settore centrale e orientale della casa; la seconda (area III) si trova invece nel settore occidentale, acquisito nel 2010 dalla Fondazione Aquileia e sino ad allora mai indagato dal punto di vista archeologico, se si fa eccezione per una lunga trincea esplorativa aperta da Giovanni Battista Brusin nel 1941 (“Aquileia Nostra”, XII, coll. 26-27).Gli scavi nell’area II hanno interessato innanzitutto l’esteso settore sud-est dell’edificio abitativo (saggio 4), in continuità con le indagini avviate nella campagna 2012. Lo scavo ha consentito sia di mettere in luce le tracce di una complessa e articolata sequenza di attività produttive svolte all’interno di un ambiente affacciato sul tratto stradale che fiancheggia il lato est della casa, sia di documentare i resti, seppur estremamente lacunosi, del cordolo di un sottostante e più antico asse viario con il medesimo orientamento nord-sud. Tale settore offre quindi molteplici spunti di interesse non solo per quanto concerne le vicende dell’edificio domestico, ma anche in relazione ad altri aspetti legati all’archeologia della produzione e alla viabilità urbana aquileiese.Nella stessa area II un secondo contesto di particolare rilevanza è stato riconosciuto nel settore settentrionale della casa (saggio 5), al fine di stabilire i limiti dell’edificio domestico in corrispondenza di uno spazio scoperto, già posto in luce lo scorso secolo, la cui lettura appariva però di difficile soluzione. Altri tre sondaggi, molto più contenuti dal punto di vista spaziale, ma di sicuro interesse per la ricostruzione delle fasi di sviluppo planimetrico dell’edificio, hanno interessato poi il settore orientale della casa (saggio 1), quello meridionale (saggio 3) e quello della corte centrale (saggio 2).Vari sondaggi hanno riguardato anche l’opposto settore occidentale dell’abitazione (area III). Le indagini in quest’area, condotte a partire dal 2010, stanno permettendo di comprendere nella loro interezza la planimetria, l’articolazione e i percorsi interni dell’edificio domestico. Ciò riveste un eccezionale interesse scientifico, poiché è questa la
8
prima volta in cui ad Aquileia viene posto in luce e affrontato sistematicamente lo studio di una casa di età romana nel suo complesso.In corrispondenza del settore centrale dell’area III, le indagini archeologiche degli anni scorsi hanno evidenziato l’esistenza di un originario nucleo abitativo caratterizzato da un impianto planimetrico riferibile alla tipologia domestica “ad atrio”, ampiamente diffusa in ambito romano in età repubblicana e alto imperiale, ma sinora mai attestata con sicurezza ad Aquileia.In questo contesto è stato affrontato lo scavo della supposta bottega affiancata all’ingresso della casa (saggio 3), contraddistinta da una complessa sequenza stratigrafica, e sono state condotte alcune verifiche puntuali all’interno dell’atrio e di un secondo spazio attiguo all’ingresso (saggio 2), nonché lungo l’asse stradale nord-sud dal quale si accedeva all’abitazione (saggio 4). Sempre nell’area III, è stata portata a termine l’indagine all’interno di un ambiente già parzialmente scavato lo scorso secolo (saggio 1), individuando una serrata sequenza di piani pavimentali sovrapposti e le successive tracce di un’interessante frequentazione tardo antica legata allo svolgimento di attività metallurgiche.Come di consueto, in parallelo alle indagini di scavo sono stati effettuati e costantemente aggiornati i rilievi planimetrici e strutturali mediante l’utilizzo di una stazione totale.Le ricerche sul campo sono state affiancate dalle operazioni di ripulitura, catalogazione,
classificazione e studio dei reperti ceramici, vitrei e metallici, nonché dalla classificazione dei rinvenimenti monetali presentati nel lavoro che chiude questa relazione.Infine, come da tempo avviene, si sono svolti vari incontri di programmazione tra i responsabili delle ricerche archeologiche e il gruppo di architetti dell’Università IUAV di Venezia incaricati di redigere, su mandato della Fondazione Aquileia, il progetto definitivo di copertura dell’edificio domestico e delle opere di generale valorizzazione dell’area.
Jacopo Bonetto, Andrea Raffaele Ghiotto
Domus dei Fondi ex Cossar. Immagine zenitale dell’area di scavo (Foto LTS, luglio 2011).
9
Gruppo di lavoro
Direttori di scavoJacopo BonettoAndrea Raffaele Ghiotto
Responsabili di scavoVanessa CentolaGuido FurlanEmanuele MadrigaliCaterina Previato
Responsabili dello studio dei repertiDiana DobrevaAndrea Stella
Rilevatori e disegnatoriSimone BertoTiziana Luongo
Operatori di scavoChiara AndreattaVirginia AvogaroGiovanni BettiAlessandro BiselloVittoria CancianiElisa CastellaccioMargherita ColomboMarianna ColussoBeatrice De FaveriValeria De Scarpis Di VianinoSimone DilariaGiulia FiorattoRosa FirettoChiara Gasparini
Tobia GirottoMarco GottardoLucia JiranovaEster LunardonNicolò MaresoFrancesco MasieroIrene MissagliaAlessandro PiazzaIsabella PiovesanLaura PizzolAnna RiccatoMichela RuzzanteElia SaviatestaGaia SinigagliaMartina Trivini BelliniSabrina ZagoValentina Zanus Fortes
19
Area II, saggio 2
Nel corso della campagna 2013 è stato aperto un piccolo saggio di scavo nel giardino della corte orientale della domus, ad est della vasca situata al centro dello spazio scoperto, per raccogliere ulteriori informazioni circa la planimetria dell’area. Il saggio, esteso per m 2,2 x 1,2, è adiacente ai settori già indagati nel 2009 e nel 2010.
Lo scavo
Completata la rimozione dell’humus (1004), nel settore orientale del saggio è stata individuata la prosecuzione ovest della fossa -1134, già scavata nel 2010. La fossa, riempita da uno strato marrone ricco di inclusi (1135), era limitata ad ovest da una struttura muraria di ridotto spessore con orientamento nord-sud, identificabile nella prosecuzione meridionale del muro 1105, già intercettato nel 2009. La rimozione di 1135 ha permesso di rimettere in luce la fronte orientale della struttura, di fattura scadente e realizzata perlopiù con materiale di reimpiego (pietre di medie dimensioni, ciottoli e frammenti di laterizi) legato da malta di calce. Il muretto poggia su uno dei piani in cubetti di cotto già riportati alla luce nel 2009 (1073). Più ad ovest invece, al di là del muro 1105, sotto l’humus è emerso un sottile livello compatto, di colore marrone chiaro (1148), che copriva uno strato a matrice argillo-sabbiosa di colore grigio scuro (1149), caratterizzato dalla presenza di grumi di argilla gialla e da numerosi inclusi, tra cui frammenti laterizi, scapoli lapidei, frammenti ceramici e di intonaco, tessere musive e cubetti di cotto. Fin da subito si è riconosciuto nel livello 1149 il riempimento della vasca al centro della corte, già parzialmente scavata nel 2009. Si è proceduto quindi alla rimozione dello strato 1149. È stato così possibile rimettere in luce anche la fronte occidentale del muro 1105 e verificare che la struttura, in prossimità del limite sud del saggio, piega verso ovest con un angolo di 90°. Alla base del muro 1105, verso ovest, sono state riportate in luce alcune lastre lapidee disposte in senso nord-sud, che costituiscono la prosecuzione meridionale di quelle già individuate nel 2009 (1108). Ad ovest delle lastre e in quota con esse è stato individuato un lacerto di pavimentazione in cubetti di cotto (1150) e, ad una quota superiore, la preparazione del mosaico della vasca, costituita da frammenti di laterizi disposti di taglio (1110), mentre non vi è traccia in questo punto del mosaico soprastante (1111). Sebbene non vi sia una sovrapposizione diretta tra la pavimentazione in cubetti di cotto 1150 e la preparazione 1110, la differenza di quota tra le due sembrerebbe testimoniare l’esistenza di due diverse fasi di pavimentazione della vasca.
Conclusioni e prima interpretazione
I nuovi dati raccolti nel corso della campagna 2013 si sono rivelati di fondamentale importanza per comprendere le vicende costruttive della corte, e in particolare della vasca
20
parte quadrangolare della vasca era probabilmente pavimentata in cubetti di cotto, come testimonia il lacerto di pavimento (1150) individuato nel corso delle indagini 2013. La presenza delle lastre lapidee (1108) intorno alla porzione quadrangolare della vasca fa ipotizzare che sopra di esse poggiasse una struttura di qualche tipo, di cui non è rimasta traccia, posta a delimitare questa parte della struttura. A questa prima fase sarebbe da riferire anche la canaletta curvilinea 1044, che non a caso inizia esattamente nel punto in cui termina la preparazione 1107. In una seconda fase venne costruito il muro 1105. La parte orientale della vasca, a pianta semicircolare, venne defunzionalizzata, e così anche la canaletta 1044. La parte occidentale della vasca, a pianta quadrangolare2, venne invece ripavimentata con un tessellato bianco (1111), di cui si conservano alcuni lacerti e la relativa preparazione (1110). Il ridimensionamento della vasca avvenne forse al momento della costruzione del muro 1010, riportato alla luce nel 2009, che comportò una riduzione dell’estensione della corte verso nord. Lo studio dei materiali e dei contesti permetterà di verificare tale ipotesi, e di collocare nel tempo questi cambiamenti nell’assetto planimetrico della corte.
Caterina Previato
2 Le vasche quadrangolari semplici sono ampiamente diffuse nelle domus della Cisalpina (cfr. Anni-baletto 2012, pp. 181-182).
posta al centro dello spazio scoperto (Fig. 1). Sulla base delle informazioni raccolte, è possibile rivedere quanto già osservato nelle precedenti campagne di scavo e distinguere tre diverse fasi edilizie. In una prima fase la vasca aveva una pianta rettangolare absidata1; era cioè caratterizzata da una parte quadrangolare, addossata al braccio ovest del peristilio, e da una parte semicircolare, in asse con l’accesso all’oecus, di cui rimane traccia nell’andamento curvilineo dei pavimenti in cubetti di cotto 1075 (con il rifacimento 1073) e della relativa preparazione (1107), oltre che in quello del taglio -1104. In questa prima fase anche la
1 Analoga planimetria presenta una vasca di una domus di Rimini (Annibaletto 2012, p. 183; si tratta della vasca g della domus Ariminum 7). Vasche con la stessa planimetria, corrispondente al tipo B nella classificazione di L. Farrar (Farrar 1998, p. 74), sono state individuate anche in alcune case pompeiane, ad Ostia e nella “maison des Dieux Oceans” a Saint-Romain-en-Gal (Farrar 1996, p. 22), oltre che nella casa di Bacco e nella casa della Caccia al Cinghiale a Cartagine e nella casa della pesca ad Althiburos (Ghiotto 2003, tabella p. 239 e p. 244, nota 36).
Fig. 1. La parte orientale della vasca al centro della corte, vista da nord.