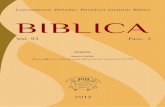Un gentiluomo fra le carte dell'Ambrosiana: Prospero Visconti, in Tra i fondi dell’Ambrosiana,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Un gentiluomo fra le carte dell'Ambrosiana: Prospero Visconti, in Tra i fondi dell’Ambrosiana,...
UN GENTILUOMO TRA LE CARTE DELL’AMBROSIANA: PROSPERO VISCONTI
(E UN MANOSCRITTO INEDITO DI FRANCESCO COPPETTA DE’ BECCUTI)
di Mauro Pavesi
Seppure poco noto al di fuori dello stretto giro di studiosi delCinquecento milanese, Prospero Visconti, signore di Breme (1543-1592),1
Questo contributo nasce da un più vasto studio condotto da chi scrive durante lascuola di specializzazione in Storia dell’arte dell’Università Cattolica di Milano (ProsperoVisconti mecenate e collezionista d’arte nella Milano di fine Cinquecento, a.a. 2004-2005), rea-lizzato grazie anche alla guida e ai numerosi consigli di Luigi Spezzaferro, che, a unanno dalla scomparsa, colgo qui l’occasione per ricordare. I risultati di quel lavoro, giàin parte editi (MAURO PAVESI, L’orgoglio di un nobile “internazionale”: Prospero Visconti, inAA.VV., La nobiltà lombarda: questioni storiche e artistiche, Atti del convegno, BrignanoGera d’Adda 2005, a cura di Andrea Spiriti e Gianvittorio Signorotto, in corso di stam-pa) saranno, a breve, oggetto anche di un altro, più vasto contributo. Ringrazio per gliaiuti e i suggerimenti anche Alessandro Rovetta, Andrea Spiriti, Francesco Frangi,Stefania Buganza, Alex Valota, Francesco Repishti, Cristina Vergani, Laura Aldovini,Laura Mauri, Jessica Gritti, Federico Riccobono, Elisabetta Crema.
1 Su Prospero Visconti si vedano anche BARTOLOMEO TAEGIO, Il Liceo di M.Bartolomeo Taegio, dove si ragiona dell’ordine delle academie e della nobiltà e del poetico figmen-to delle Muse. Libro secondo, Milano, apresso Paolo Gottardo Pontio, 1571, pp. 41-43 e46; PAOLO MORIGIA, Historia dell’antichità di Milano, Venezia, appresso i Guerra, 1592(rist. anast. Bologna, Forni, 1967), pp. 548-49, 592-605; GIOVANNI PAOLO LOMAZZO,Trattato dell’arte della pittura (1584), in Scritti sulle arti, II, a cura di Roberto PaoloCiardi, Firenze, Marchi & Bertolli, 1974, p. 188; P. MORIGIA, La nobiltà di Milano,Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, 1619 (rist. anast. Bologna, Forni, 1972), p. 164;FILIPPO ARGELATI, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, II, Milano, in aedibus Palatinis,1745, pp. 1650-51; POMPEO LITTA, Famiglie celebri d’Italia, Milano, Paolo EmilioGiusti, 1819, Visconti di Milano, tav. XII; ANTONIO FROVA, A proposito del cosiddettoErcole Santambrosiano, in “Archivio Storico Lombardo”, XX (1903), pp. 543-47; ROSITA
LEVI PISETZKY, La moda spagnola a Milano, in AA.VV., Storia di Milano, X, Milano,1957, pp. 885, 892, 900, 908; PAOLO MEZZANOTTE - GIACOMO CARLO BASCAPÈ,
Mauro Pavesi
è stato senz’altro un grande protagonista della cosiddetta «età deiBorromei». Discendente diretto di un importante letterato come GaspareAmbrogio Visconti2 e noto agli storici dell’architettura per il grande palaz-zo che si era fatto costruire forse su disegni di Pellegrino Tibaldi (di cui,
798
Milano nell’arte e nella storia. Storia dell’edilizia di Milano, guida sistematica della città,Milano, Bestetti, 1968, pp. 328-29; ALESSANDRO MORANDOTTI, Pirro I Visconti Borro-meo di Brebbia mecenate nella Milano del tardo Cinquecento, in “Archivio Storico Lom-bardo”, CVII (1981), pp. 128-29 e 735-36; CLAUDIO FRANZONI, Inter christianorumsacra statua Herculis, in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, XV (1986),pp. 735-36; GIULIO BORA, Da Leonardo all’Accademia della Val di Bregno: Giovan PaoloLomazzo, Aurelio Luini e i disegni degli accademici, in “Raccolta Vinciana”, XXIII (1989),p. 75; A. MORANDOTTI, Il revival leonardesco nell’età di Federico Borromeo, in AA.VV.,Leonardeschi a Milano, fortuna e collezionismo, Atti del Convegno Internazionale (1990), acura di Maria Teresa Fiorio e Pietro Cesare Marani, Milano, Electa-Ente Raccolta Vin-ciana, 1991, pp. 166-67 e n. 13; G.P. LOMAZZO E I FACCHINI DELLA VAL DI BLENIO,Rabisch (1589), a cura di Dante Isella, Torino, Einaudi, 1993 [ISELLA] p. 157, n. 1;CARLA COMPOSTELLA, Ritratti romani e ritratti rinascimentali dalla collezione di ProsperoVisconti. Un contributo alla storia del collezionismo milanese del tardo Cinquecento, in “Notiziedal Chiostro del Monastero Maggiore”, (1993), pp. 207-30; FABRIZIO SLAVAZZI, Notasulla collezione di Antichità di Prospero Visconti, in “Notizie dal Chiostro del MonasteroMaggiore”, LI-LII (1993), pp. 231-32; ERNST HANS GOMBRICH, “My library was duke-dom large enough”: Shakespeare’s Prospero and Prospero Visconti of Milan, in AA.VV., Englandand the Continental Reinassance: Essays in Honour of J.B. Trapp, Woodbridge, BoydellPress, 1994, pp. 185-90; BARBARA AGOSTI, Collezionismo e archeologia cristiana nelSeicento. Federico Borromeo e il medioevo artistico tra Roma e Milano, Milano, Jaca Book,1996, pp. 155-56; PAOLA BARBARA CONTI, Note a margine del Mailänder Briefe di H.Simonsfeld. Gli Scala e altri cristallieri milanesi, in “Archivio Storico Lombardo”, CXXIV-CXXV (1997-1998), pp. 545-62; G. BORA, Milano nell’età di Lomazzo e S. Carlo: riaf-fermazione e difficoltà di sopravvivenza di una cultura, in AA.VV., Rabisch. Il grottesco nel-l’arte del Cinquecento. L’Accademia della Val di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese,Catalogo della mostra, Lugano 1998, a cura di G. Bora - Manuela Kahn-Rossi -Francesco Porzio, Milano, Skira, 1998, pp. 43 e 47; SIMONE ALBONICO, Profilo delle acca-demie letterarie milanesi nel Cinquecento, in AA.VV., Rabisch. Il grottesco nell’arte delCinquecento, pp. 105 e 107; LAURA GIACOMINI, Tre palazzi privati milanesi e l’architettoPellegrino Pellegrini, in “Arte Lombarda”, n.s., 137 (2003), pp. 74-90. La fonte che per-mette la miglior conoscenza del personaggio è tuttavia la monumentale edizione dellesue lettere, integrate con altre di diverse personalità milanesi e tedesche e un nutritocommento finale di tipo storico-critico: HENRY SIMONSFELD, Mailänder Briefe zuer baye-rischen und allgemeinen Gesichte des 16. Jahrhunderts, in “Abhandlungen der historischenKlasse der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften”, XXII Band,München, 1902 (I [1901-2], pp. 231-480; II [1902], pp. 481-575; d’ora in avanti cita-ta semplicemente come SIMONSFELD).
2 LITTA, Famiglie celebri d’Italia, Visconti di Milano, tav. XIII.
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
dopo le ultime distruzioni belliche, resta la sola facciata nell’odierna viaLanzone [fig. 2]),3 Prospero era stato uno dei più raffinati mecenati dellacultura del suo tempo, per l’amicizia e la protezione accordata a musici(Orlando di Lasso gli aveva dedicato un madrigale),4 pittori (Giovan PaoloLomazzo, Aurelio Luini, Antonio Campi),5 poeti6 e scienziati. Proprietario
799
3 Sul palazzo di Prospero si vedano in particolare MEZZANOTTE - BASCAPÈ, Milanonell’arte e nella storia, pp. 640-41; STEFANO DELLA TORRE - RICHARD SCHOFIELD,Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano. Invenzione e costruzione di una chiesa esem-plare, Como-Milano, Nodo Libri - San Fedele Edizioni, 1994, p. 37; e soprattuttoGIACOMINI, Tre palazzi privati milanesi e l’architetto Pellegrino Pellegrini, cui si rimandaper le ampie e ricche note e per una bibliografia completa sull’edificio.
4 Sui rapporti tra Prospero Visconti e Orlando di Lasso (che solitamente non emer-gono dall’ampia letteratura sul compositore fiammingo) si veda il saggio critico allega-to a SIMONSFELD, pp. 487 e 533.
5 Per i rapporti con Aurelio Luini, è forse il caso di segnalare l’inedita nota dell’in-ventario post mortem di Prospero (Archivio di Stato di Milano, Notarile 19119, Corneliode Pasquale, 29 maggio 1592), in cui viene registrato un «quadro messo ad avolio consopra Nostra Signora con il figlio in braccio, Santo Sebastiano et Santo Rocco […] cheè di Gio. Antonio Rampino tortonese, il quale l’ha riposto ivi per mandarlo nel Duomodi Tortona». L’indicazione del committente e la coincidenza del soggetto permettonodi identificare quel dipinto con la pala che Aurelio aveva dipinto per l’altare Rampinidella chiesa maggiore tortonese, che va a questo punto datata ai primi mesi del 1592(l’opera, tuttora in loco, era considerata invece opera giovanile in CARLENRICA SPAN-TIGATI, Per la pittura a Tortona. Considerazioni e proposte, in AA.VV., Storia, arte e restaurinel tortonese. Il palazzetto medievale, dipinti e sculture, Tortona, Cassa di Risparmio di Tor-tona, 1993, p. 98; così anche in AA.VV., Pittura a Milano, rinascimento e manierismo, acura di Mina Gregori, Milano, Cariplo, 1998, p. 265).
6 Tra i poeti e gli uomini di lettere in contatto con Prospero vanno ricordati il friu-lano Erasmo di Valvasone (ERASMO DI VALVASONE, Rime, a cura di Giorgio CerboniBaiardi, Centro culturale Erasmo, Valvasone, 1993, p. 21) e l’artista-letterato GiovanPaolo Lomazzo. Tra gli altri, i cui nomi riflettono il momento non felicissimo della cul-tura milanese del tardo XVI secolo, si possono ricordare il piemontese GherardoBorgogni, amico ed imitatore di Tasso (su di lui si veda B. AGOSTI, Poesie di GherardoBorgogni su due dimenticati artefici milanesi, in AA.VV., Scritti per l’Istituto Germanico diStoria dell’arte di Firenze: settanta studiosi italiani, a cura di Miklós Boskovits - BrunoSanti - PierPaolo Donati, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 325-30), Bernardino Baldini(su cui si vedano P. ZAMBELLI, Baldini, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani,V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, pp. 481-82; e la nota di ISELLA, p.19) e i pavesi Ercole Cimilotti e Girolamo Bossi (studiati in S. ALBONICO e ROSSANO
PESTARINO, L’età di Carlo Borromeo, in AA.VV., Sul Tesin piantàro i tuoi laureti. Poesia evita letteraria nella Lombardia spagnola (1535-1706), Catalogo della Mostra, Pavia,Castello Visconteo, Pavia, Cardano, 2002, pp. XX e 107-11).
Mauro Pavesi
a sua volta di una splendida raccolta d’arte, descritta da Giovan PaoloLomazzo, Paolo Morigia e Giovanni Mazenta,7 Prospero è spesso segnala-to per il suo ricco carteggio con i duchi di Baviera, pubblicato nel 1902 daHenry Simonsfeld,8 da cui emerge il suo ruolo di consigliere di Alberto V
800
7 Lomazzo lo ricorda come proprietario della splendida tavola con il Battesimo di Cristodi Cesare da Sesto e Bernazzano (LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, p. 165), mentreMorigia, oltre alle antichità e alle medaglie, parla, oltre al dipinto di Cesare da Sesto (chesi accompagnava probabilmente ad un altro dipinto dell’artista leonardesco, la Madonnadel bassorilievo oggi all’Hermitage, visto da Morigia presso Galeazzo Visconti, erede diProspero; PAOLO MORIGIA, La nobiltà di Milano, divisa in sei libri, Milano, Nella stampadel quon. Pacifico Ponzio, 1595, p. 277), due opere del Moretto da Brescia (MORIGIA,Historia dell’antichità di Milano, pp. 593-94; solo una è oggi identificabile nella VestaleTuccia di collezione Gallarati Scotti a Roma). Giovanni Ambrogio Mazenta ricorda anche,nelle sue celebri memorie su Leonardo da Vinci, che, nel palazzo di Prospero, «già vi furnomolti disegni suoi [di Leonardo] e molti discepoli del medesmo vi fiorirono» (GIOVANNI
AMBROGIO MAZENTA, Le memorie su Leonardo da Vinci di don Ambrogio Mazenta [1635 circa],a cura di Luigi Gramatica, Milano, Alfieri e Lacroix, 1919, p. 45). Lo stesso Mazenta eracugino di secondo grado di Prospero, essendo figlio di Melchiorre Mazenta e di LuciaVisconti, zia del padre di Prospero e figlia del poeta Gaspare Ambrogio (MARZIA GIULIANI
- ROSANNA SACCHI, Per una lettura dei documenti su Giovan Paolo Lomazzo, “istorito pittor fattopoeta”, in AA.VV., Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, pp. 323-36: 323). Per cono-scere meglio le raccolte d’arte di Prospero sarebbe interessante ritrovare i Versi volgari neiquali si descrive il viaggio di Giulio Cesare Veli da Bologna a Milano, composti da lui medesimoquando era alloggiato nella casa dell’Ill.mo Signore Prospero Visconti, professor grandissimo d’an-tiquaria, dove vide le sue pitture, medaglie, disegni … segnalati in MADDALENA SPAGNOLO,Correggio: geografia e storia della fortuna (1528-1657), Cinisello Balsamo (Mi), Silvana,2005, p. 281, n. 64. Il testo, citato in GIOVANNI FANTUZZI, Notizie degli scrittori bolognesi,VIII, Bologna, nella Stamperia di San Tommaso d’Aquino, 1790, pp. 166-67, era statoredatto dal numismatico bolognese che nel 1600 aveva ospitato il celebre erudito france-se Peiresc in viaggio per Roma. Riguardo alle collezioni d’arte di Prospero, segnalo unospunto inedito per la raccolta numismatica; le didascalie di due ritratti incisi in ANTONIO
CAMPI, Cremona fedelissima …, Cremona, per Hippolito Tromba & Hercoliano Bartoli,1585, li indicano inconfutabilmente come tratti da medaglie di proprietà del Visconti.Sotto l’effigie di Filippo Maria (ivi, libro IV, p. 94) un’iscrizione attesta che il ritratto «ècavato […] da una medaglia di Prospero Visconte nob. milanese»; la medaglia dovevaeffigiare il personaggio di profilo, e, a giudicare dall’incisione, sembra quella di Pisanello,il duca indossa una veste con l’aquila bicipite sulla spalla e la biscia viscontea sul petto.Qualche pagina più avanti, in corrispondenza dell’immagine di Francesco Sforza, si leggeche «la sua effigie armata in questo modo» (cioè con il duca di profilo in armatura, conl’impresa del cane al guinzaglio sul petto) è visibile «in una medaglia che è appressoProspero Visconti nob. milan.» (ivi, p. 96).
8 SIMONSFELD. Se ne veda anche la scheda bibliografica di ETTORE VERGA in“Archivio Storico Lombardo”, XXXV (1902), pp. 172-78.
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
e Guglielmo V Wittelsbach, di cui curava gli interessi italiani, mentre unlato inedito del personaggio è quello che affiora dalle numerose missiveconservate all’Archivio di Stato di Firenze, che testimoniano la sua corri-spondenza con il granduca Ferdinando de’ Medici.9
Le sue lettere ai sovrani bavaresi, un tempo conservate nel ms. 168della Biblioteca Trivulzio, oggi purtroppo irreperibile,10 trattano unvastissimo campionario di argomenti, dalla compravendita di opere d’arte,libri, abiti, stoffe, gioielli, ad alcuni delicati momenti di storia milanese(come la peste del 1572 o il conflitto tra Carlo Borromeo e i governatorispagnoli), ma anche di feste, balli e ricevimenti della nobiltà lombarda. Perintrodurre il personaggio basterebbero le parole con cui lo ricordano i piùnoti memorialisti milanesi, come l’abate Filippo Picinelli (1670), che lo
801
9 Le lettere a due granduchi (Francesco I e Ferdinando I de’ Medici) e ad alcuniimportanti dignitari della corte fiorentina sono già state in parte studiate da chi scrivee saranno commentate analiticamente in un contributo di prossima pubblicazione. Traquelle più interessanti segnalo quelle che testimoniano la presenza di Prospero comemediatore nella vendita di alcuni disegni di importanti autori del Rinascimento di pro-prietà di Ottavio Strada, figlio del celebre Jacopo, che il Visconti propone al segretariodel granduca nonostante affermi di rendersi conto che «portare tali cose a Fiorenza siaportare vasi a Samo, nottole a Attene e coccodrilli a Egitto» (Archivio di Stato diFirenze, Mediceo del Principato 825, ff. 317-18, 6 febbraio 1591). La lettera inviatadallo Strada al Visconti (che testimonia esplicitamente di una passata amicizia diProspero con il celebre Jacopo Strada), allegata a quella che il nobile milanese aveva spe-dito a Firenze, elenca i disegni proposti al granduca, raccolti in due quaderni, conte-nenti «la maggior parte delli disegni stampati di quel valentuomo Alberto Durero[…], pezzi di disegni di […] Michelangelo, Raphael d’Urbino, Francisco Parmesano,Iulio Romano, Luca d’Olanda» e il «Porton d’Alberto Durero, dove suso sonno fatti diMassimiliano I imp.». Nonostante l’estrema rarità di quest’ultima stampa (si tratta evi-dentemente dell’Arco di trionfo di Massimiliano I d’Asburgo), ne è conservata una copiapresso il Gabinetto dei Disegni degli Uffizi (inv. 5062); la si veda riprodotta nel cata-logo di GIOVANNI MARIA FARA, Albrecht Dürer. Originali, copie, derivazioni, Firenze,Olschki, 2007, pp. 369-72. Un’altra copia della lettera dello Strada era peraltro giàstata pubblicata in GIOVANNI GAYE, Carteggio inedito d’artisti, III, Firenze, G. Molini,1840, pp. 512-13 e in JOHN SHEARMAN, Raphael in Early Modern Sources (1483-1602),II, London-New Haven, Yale University Press, 2003, pp. 1364-65, senza però chevenisse riconosciuto in Prospero l’intermediario tra il Medici e lo Strada.
10 Il manoscritto, ancora citato (come «Vicecomes Prosper. Epistolae ab anno 1569ad an. 1579») in GIULIO PORRO LAMBERTENGHI, Catalogo dei codici manoscritti dellaTrivulziana, Torino, Fratelli Bocca, 1884, p. 455 (il repertorio era stato redatto quandola biblioteca era ancora di proprietà della famiglia Trivulzio), non è più reperibile dopola cessione al Comune di Milano.
Mauro Pavesi
celebrava per la sua «felicità nell’ingegno, che a qualsivoglia cosa s’appli-casse, faceva meravigliose riuscite»,11 o il suo contemporaneo Paolo Mo-rigia, che, oltre a definirlo meritevole di «degne lodi perché possessore dimolte scienze, oratore eccellente e versatissimo»,12 ne aveva parlato in ter-mini entusiastici per la raffinatezza di uomo di lettere e per il suo esserepersona «amichevole de la matematica et de la filosofia», «intendente d’ar-chitettura et di pittura», appassionato di storia e di antiquaria ed «eccel-lente musico in diverse sorte di strumenti».13
802
11 FILIPPO PICINELLI, Ateneo dei letterati milanesi […], Milano, Nella stampa diFrancesco Vigone, 1670, p. 477.
12 MORIGIA, Historia dell’antichità di Milano, p. 593.13 Ibid. Sugli interessi musicali di Prospero si veda Morigia 1595, p. 186. Segnalo
anche che il suo inventario post mortem (cit. alla n. 5) registra nelle stanze del suo palazzouna sorta di vero e proprio museo musicale, con strumenti antichi e stranieri, tra cui flau-ti, cornamuse, tromboni, «viole […] lavorate di osso», un liuto d’ebano, un «alpicorno».È probabile che fosse invece l’«organo cromatico» progettato dal celebre compositore eteorico don Nicola Vicentino l’«arcicimbalo» che Giovanni Ambrogio Mazenta avevaattribuito a Leonardo (MAZENTA, Le memorie su Leonardo da Vinci, p. 45). Tale strumento erain grado di eseguire tutte le tonalità intermedie della scala cromatica, con esiti musicaliparticolarmente espressivi e adatti ad una mano virtuosa, per cui è documentato anche unprogetto “architettonico” di Pellegrino Tibaldi (DELLA TORRE - SCHOFIELD, Pellegrino Ti-baldi architetto, p. 37). Su don Nicola si vedano DAVIDE DAOLMI, Don Nicola Vicentino arci-musico in Milano, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1999 (per i rapporti con Prospero, maanche con Guglielmo V, pp. 92-100); HENRY WILLIAM KAUFMANN, The Life and Works ofNicola Vicentino (1511c.-1576), s.l., American Institute of Musicology, 1966; RODOBALDO
TIBALDI, I mottetti a quattro voci (Milano 1599) di Giovanni Paolo Cima e lo stile “osservato”nella Milano di fine ’500: alcune osservazioni, in “Polifonie”, II (2002), 1, pp. 7-41: 9-20.L’organo cromatico è forse quello raffigurato sul retro della medaglia coniata per il musi-cista da Annibale Fontana, con quattro frontoni triangolari e, agli spigoli, quattro piloniche sembrano obelischi. Tra gli altri musici che furono in qualche rapporto con Prospero,oltre al già citato Orlando di Lasso, vanno ricordati il veneziano Vincenzo Bellavere, allie-vo di Andrea Gabrieli (cfr. SIMONSFELD, p. 317; su di lui si veda FABIO FANO, Bell’haver,Vincenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, VII, Roma, Istituto della EnciclopediaItaliana, 1965, pp. 642-43), l’emiliano Girolamo Conversi, già al servizio del cardinalGranvelle (FRANCESCO BUSSI, Conversi, Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani,XXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 569-70 e Conversi Girolamo,in Dizionario della Musica e dei Musicisti, a cura di Alberto Basso, II, Torino, Utet, 1985, p.308), il molfettese Josquino Salepico, che fu anche inviato alla corte di Baviera per qual-che tempo (Salépico, Josquino, in Dizionario della Musica e dei Musicisti, VI, Torino, Utet,1988, p. 542; si veda anche FRANCESCO SAMARELLI, J. Salepico vel Salem da Molfetta liutistae musicista del secolo XVI, in “Note d’Archivio per la Storia Musicale”, [1932]) e soprattut-to l’organista del Duomo milanese Giuseppe Caimo, amico di Lomazzo e affiliato alla Val
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
A confermare l’ampio raggio della sua attività culturale è anche ilprimo manoscritto dell’Ambrosiana scelto per questo breve intervento,14
che è per la verità un codice datato 1740 e composto in gran parte di testilatini, con un’antologia di poeti dal XVI secolo in poi. Il manoscritto(l’attuale X 14 sup.) contiene, fra le altre cose, anche la trascrizione deiCarmina illustrium poetarum italorum raccolti da Matteo Toscano,15 unasilloge pubblicata a Parigi nel 1572, comprendente anche due brevi idil-li latini dello stesso Prospero (Eurydice e Aegle), il quale fra l’altro com-pare tra i dedicatari del volume. Nell’edizione a stampa dell’antologia,curata da quello che era stato uno dei più prestigiosi letterati della cortedi Caterina dei Medici, la poesia indirizzata al Visconti è collocata subi-to dopo le dediche a Pio IV, alla regina madre e al «poeta regius» JeanDorat – «Iohannes Auratus» –, maestro di Ronsard e di altri letteratidella Pléiade (nel manoscritto ambrosiano è riportato il solo carme offer-to a Prospero), inserendo implicitamente il Visconti nel novero degliintellettuali di spicco dell’epoca.
Ma c’è di più: questo breve excursus tra le carte dell’Ambrosianapotrebbe, come vedremo, prestarsi emblematicamente a smentire il pre-giudizio di una troppo netta distinzione tra “Milano sacra” e “Milano
803
di Blenio, su cui si vedano le brevi biografie di MARCO ROSSI, Caimo Giuseppe, in Dizionariodella Chiesa Ambrosiana, I, Milano, Ned, 1987; di IAIN FENLON, Caimo Giuseppe, in NewGrove, Dictionary of Music and Musicians, IV, London, Macmillan, 2001, pp. 608-09; ISELLA,pp. 335-36 e soprattutto lo studio monografico di PATRICIA BRAUNER, Gioseppe Caimo“nobile milanese” (ca. 1540-1586), Ph.D. Diss., Yale University, 1970. Il Secondo libro di can-zonette a quattro voci di Caimo, dedicato proprio a Prospero, è stato recentemente oggettodi un’edizione critica: GIUSEPPE CAIMO, Secondo libro di canzonette a quattro voci, a cura diLaura Mauri Vigevani, Milano, Rugginenti, 2003.
14 Ms. X 14 sup., codice cartaceo, con legatura in pelle; sul dorso la scritta ILLUS.| POET. | CARM.; ff. 1-158: Illustrium poetarum italorum carmina selecta, ParraviciniAugustini selevit et recensuit ex collectione Io. Matthei Toscani, Mediolani anno 1740; ff. 159-76: Scelta di italiani componimenti de’ migliori poeti, con una serie di poesie, peraltro giànote, di personaggi del Seicento e del Settecento come Carlo Maria Maggi, ApostoloZeno, Ludovico Antonio Muratori. La silloge di Matteo Toscano comprende poesie lati-ne di Castiglione, Della Casa, Bembo, Navagero, Molza.
15 IO. MATTHAEUS TOSCANUS, Carmina illustrium poetarum Italorum, I, Lutetiae,apud Aegidium Gorbinum, 1572. Su Matteo Toscano, che apparteneva probabilmentealla famiglia da cui proveniva anche il Lorenzo Toscano affiliato come compà Toscagnall’Accademia della Val di Blenio (ISELLA, p. 21) si veda ARGELATI, Bibliotheca Scriptorummediolanensium, II, p. 1507. Secondo Argelati sia il Toscano sia Prospero Visconti eranodotti anche nelle lingue greca ed ebraica, segno forse di interessi cabalistici.
Mauro Pavesi
profana”, mostrando come un personaggio dalle molteplici cariche pub-bliche potesse dimostrare un carattere molto più sfumato di quanto sipossa pensare, con una gamma di interessi assolutamente non classifica-bili in modo schematico o semplicistico nell’uno o nell’altro senso.Questi spunti “ambrosiani” su Prospero, che comprenderanno infattialcune sue lettere nei carteggi di Carlo e Federico Borromeo e un mano-scritto con una redazione del Canzoniere del poeta perugino FrancescoCoppetta de’ Beccuti, saranno forse utili a portare un piccolo contributoalla conoscenza di un momento, come quello del tardo Cinquecento lom-bardo, a lungo dimenticato dalla critica e ora oggetto di numerose pub-blicazioni storiche e storico-artistiche, anche alla luce del recente dibat-tito storiografico sulla cultura dominante nella Milano dell’epoca.16
804
16 La netta prevalenza, fin dalle fonti antiche, della letteratura sulla “Milano sacra”di Carlo Borromeo ha fatto sì che la scoperta di un filone alternativo di committenzalaica e nobiliare assumesse quasi il significato di un’agguerritissima e sovversiva fron-da antiborromaica. Vale qui la pena di riassumere per sommi capi questo complessonodo critico: grazie agli studi imprescindibili di Dante Isella (Per una lettura dei Rabisch,in ISELLA, pp. IX-LXII; recentemente ripubblicato in D. ISELLA, Lombardia stravagante.Testi e studi dal Quattrocento al Settecento tra lettere e arti, Torino, Einaudi, 2006, pp. 75-102), di una delle figure nodali della cultura di quest’età, l’artista e poeta Giovan PaoloLomazzo (che in precedenza era stato spesso scambiato per un trattatista pedante ebigotto, ad esempio in JULIUS VON SCHLOSSER, La letteratura artistica [1924], Firenze,La Nuova Italia, 1967, pp. 448-49), veniva riscoperto il lato tendente al comico, al bef-fardo e al grottesco, oltre che un’infarinatura di letture filosofiche “pericolose” nellaMilano della Controriforma; mentre in precedenza Alessandro Morandotti aveva resonoto un importante focolaio di arte non religiosa sorto intorno a Pirro ViscontiBorromeo (MORANDOTTI, Pirro I Visconti Borromeo di Brebbia mecenate nella Milano deltardo Cinquecento, e ID., Nuove tracce per il tardo Rinascimento italiano: il ninfeo-museo dellavilla Visconti Borromeo, Litta, Toselli di Lainate, in “Annali della Scuola NormaleSuperiore di Pisa”, 15 [1985], pp. 129-86; tutti questi studi sono recentemente statiraccolti dallo stesso Morandotti, insieme ad importanti aggiornamenti, nel ricco emonumentale Milano profana nell’età dei Borromeo, Milano, Electa, 2006); quasi contem-poraneamente anche Barbara Agosti aveva proposto alcune interessanti aperture su unmondo, quello dei fantasiosi e «ghiribizzosi» artigiani milanesi, che si rifaceva allecapricciose invenzioni di Leonardo e Arcimboldi (AGOSTI, Poesie di Gherardo Borgogni).Se l’enorme valore di tali pionieristici contributi, capaci di riscoprire per la prima voltaun mondo fino ad allora mai studiato, sta nel rinvenimento di un nodo artistico chedovette comunque essere complementare (senza una non necessaria opposizione) allacommittenza arcivescovile, va segnalato il rischio di scambiare tutta l’arte profana peril frutto di un’inesistente cultura ribelle e anticlericale. Si deve forse all’esatto ricono-scimento di questo malinteso critico anche qualche incomprensione di segno opposto,
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
Al nome di Prospero Visconti si può infatti arrivare sfogliando le pagi-ne di un libro curioso come quello dei Rabisch di Giovan Paolo Lomazzo, unpersonaggio controverso, ma sicuramente non allineato con le posizioniaustere e rigoriste del cardinal Borromeo.17 Due poesie dialettali di quel-l’antologia (che oggi si legge nella fondamentale edizione del compiantoDante Isella), collocate in una posizione di rilievo, in apertura della secon-
805
presente (a parere di chi scrive) nella pur interessante interpretazione di Danilo Zardin(pubblicata in due recensioni, apparse entrambe in “Studia Borromaica”, XII [1998],pp. 448-56: ad AA.VV., Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, e ad AA.VV.,Latrobio [Giovan Pietro Giussani], Il Brancaleone, a cura di R. Brigantini, Roma, Salerno,1998). Il dibattito storiografico, che in realtà verte su ben altre e più complesse cate-gorie che non quelle di arte e committenza culturale (come quelle di “controriforma” edi “riforma cattolica”) è in parte riassunto in alcune note di MORANDOTTI, Milano pro-fana nell’età dei Borromeo, pp. 93-94 (si veda in part. la n. 443). Una lettura equilibratadella cultura di quel periodo è quella proposta da CESARE MOZZARELLI, Milano secondaRoma. Indagini sulla costruzione dell’identità cittadina nell’età di Filippo II, in AA.VV.,Felipe II. Europa y la Monarquía Católica, Actas del congreso internacional, director JoséMartínez Millán, I.2, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 531-53, che ha guardato alla Milanodel tardo Cinquecento sotto un’altra ottica, diversa da quella della semplice opposizio-ne tra arte sacra e arte profana (con il rischio di individuare erroneamente una commit-tenza sacra in opposizione a una profana), osservando come gli indubbi problemi origi-nati dal forte rigorismo di san Carlo fossero pienamente risolti, allo scoccare del nuovosecolo, grazie alla prudenza e alla cautela del cugino Federico, capace di attirare nuova-mente a sé il patriziato nel nome dell’arte e della cultura (il personaggio emblematicodi questo momento è il già citato Paolo Morigia, alfiere della nuova, orgogliosa auto-coscienza cittadina in cui c’era posto sia per Carlo Borromeo, sia per Lomazzo). Percomprender pienamente questo delicato momento storico e per dare una lettura equi-librata di personaggi come Prospero Visconti o come Pirro Visconti Borromeo,Mozzarelli suggeriva infatti di provare a resistere alla tentazione di «cercare con sensi-bilità novecentesca inquietudini eretiche o psicologiche di questi di solito integratissi-mi personaggi» (MOZZARELLI, Milano seconda Roma, p. 535).
17 Anche alla luce del dibattito storiografico riassunto, per sommi capi, alla n. 14,va segnalato che lo stesso Lomazzo, che pure non si può certo definire un modello didedizione controriformistica, rischia spesso di essere vittima di qualche fraintendimen-to (un esempio di questo tipo di semplificazione è nel pur interessante studio di MARIA
TERESA BINAGHI OLIVARI, Annone Brianza: il polittico anversese nella chiesa di San Giorgio,in AA.VV., Scultori e intagliatori del legno in Lombardia nel Rinascimento, Atti della gior-nata di studi [Milano 2000], a cura di Daniele Pescarmona, Milano, Electa, 2002, pp.201-19, in cui Lomazzo è presentato come il capo di una sorta di società segreta chepromuoveva idee ereticali e un’improbabile fronda antispagnola e filofrancese). Per illato “eversivo” della sfuggente personalità di Lomazzo si vedano il citato saggio di Isellae molti dei contributi editi in AA.VV., Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento.
Mauro Pavesi
da parte della raccolta, in parallelo con la dedica iniziale al più famosoparente Pirro Visconti Borromeo, ricordano infatti Prospero come «padrogne signò» dell’eccentrica ed eversiva brigata della Val di Blenio;18 la secondadi esse invoca addirittura, per tutto il gruppo dei Facchini, l’ala protettricedel potente nobile milanese, cui è infatti dedicato un prolisso «Triglionfdr’Amò» con l’elenco completo dei «Fachign, Consiglié e Savigl dra Vall deBregn» (Facchini, Consiglieri e Savi della Val di Blenio) con lo stessoLomazzo, sotto forma del «Nabad Zavargna», che si dichiara umilmente«sò sarvigliò», suo servitore.19
806
18 ISELLA, p. 157. Gli studi di Isella hanno aperto non poche prospettive sulla cono-scenza di questo congrega di artisti, artigiani, letterati, attori che si riunivano decan-tando poesie dedicate a Bacco, all’ebbrezza del vino, con un sottofondo di filosofia fici-niana e teologia orfica, a forte rischio di sconfinamento nell’eresia (non è certo con qualegrado di consapevolezza). Si veda al proposito il già citato testo introduttivo in ISELLA.
19 ISELLA, pp. 160-69, II, 39.
Figura 1 – TOLOMEO RINALDI, Progetto per la facciata del Duomo di Milano, Milano,Biblioteca Ambrosiana, S. 148 sup., c. XII:
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
A fronte di questa evidente implicazione in un contesto decisamentegoliardico, negli anni di san Carlo, Prospero è direttamente coinvolto,spesso occupando strategiche posizioni di rilievo, in molti enti ecclesia-stici e laici a cui l’arcivescovo era particolarmente attento, come laVeneranda Fabbrica del Duomo, l’Ospedale Maggiore e la confraternitadi S. Giovanni Decollato, appena riformata dallo stesso Borromeo,20 dicui, non ancora trentenne, il Visconti era già priore.21 Dell’attività diProspero presso il cantiere della cattedrale si trova un importante riscon-tro proprio in Ambrosiana: si tratta di un monumentale progetto «allaromana» per una facciata su due ordini classici, visibile in una stampadedicatagli nel 1590 dall’architetto Tolomeo Rinaldi, che oggi fa partedi un gruppo di disegni catalogati con la segnatura S 148 sup. (c. XII;fig. 1)22 e si caratterizza per un austero e imponente prospetto su un dop-
807
20 La confraternita di S. Giovanni, i cui esponenti appartenevano per lo più alle altesfere della nobiltà cittadina, si occupava della sepoltura e della cura spirituale dei condan-nati a morte. Su questo ente la Biblioteca Ambrosiana possiede un vasto numero di mano-scritti documentari, risalenti però ad un’età più tarda – sono quasi tutti del XVIII secolo– e consistenti per lo più in registri di sentenze capitali, elenchi di giustiziati e documen-ti amministrativi (S 175 inf.; B 272 suss.; B 278 suss.; L 11 suss.; e i mss. da S.Q. + I. 6a S.Q. + I. 10). La chiesa era nota come S. Giovanni “alle Case Rotte” per essere statacostruita nei pressi delle rovine delle dimore dei Torriani, distrutte nel XIV secolo.L’edificio, rimaneggiato nel Seicento da Francesco Maria Richini e un tempo collocato neipressi di palazzo Marino, fu demolito nel XX secolo per far posto all’edificio della BancaCommerciale; su di esso si veda, oltre al saggio di ANTONIO CERUTI, La chiesa di S.Giovanni Decollato alle Case Rotte in Milano, in “Archivio Storico Lombardo”, S. I, I (1874),pp. 148-85; e alla scheda in MARIO CACIAGLI - PANTALEO DI MARZIO, Le chiese scomparsedi Milano, Milano, Civica Biblioteca d’Arte, 1997, pp. 206-43; anche la tesi di laurea diMONICA CAPUTO - BARBARA CONCARI - CRISTINA VERGANI, La chiesa di S. Giovanni decol-lato alle Case Rotte, Milano, Facoltà di Architettura, a.a. 1997-98, rel. Amedeo Bellini. Perun aggiornamento bibliografico sulla chiesa e la confraternita si veda (anche se l’argomen-to del saggio è un gruppo di dipinti del XVII secolo) SIMONETTA COPPA, Un ciclo ritrova-to del secondo Seicento milanese. Le “Storie del Battista” per l’oratorio segreto della chiesa di S.Giovanni alle Case Rotte, in “Arte Lombarda”, CXXXVII (2003), pp. 121-24. Sull’im-portanza della confraternita come polo di religiosità laica nella Milano di Carlo Borromeosi veda MOZZARELLI, Milano seconda Roma, pp. 547-48, n. 44.
21 Proprio in quella veste, nel mese di luglio del 1575, il Visconti aveva collabora-to, d’intesa con il cardinale, all’arrivo a Milano dei Gesuiti, concedendo al padre pro-vinciale Francesco Adorno l’uso per un anno di S. Giovanni alle Case Rotte (la chiesadella confraternita) durante i lavori alla vicina S. Fedele (Archivio di Stato di Milano,Notarile 14702, notaio G.F. Pinotini).
22 ERNESTO BRIVIO, La Fabbrica del Duomo, storia e fisionomia, in AA.VV., Il Duomo,
Mauro Pavesi
pio ordine di colonne, racchiuso tra due torri e coronato da un classicheg-giante timpano triangolare sormontato da una folla di statue.
Anche tralasciando tutte le volte in cui l’arcivescovo viene citato nellacorrispondenza tra il Visconti e la corte tedesca,23 questo breve itinera-rio tra le carte dell’Ambrosiana offre altri indizi più concreti del legametra san Carlo e Prospero, attraverso le tre occorrenze del nome di que-st’ultimo tra gli interlocutori epistolari del Borromeo. La prima occasio-ne risale al 1572, quando il Visconti, in veste di priore della già citataconfraternita di S. Giovanni,24 aveva scritto all’arcivescovo chiedendogliuna sovvenzione per dotare e maritare «alcune putte» in occasione dellafestività del Battista (lettera 1);25 di seguito, dopo la morte del fratelloGiovan Paolo (1574),26 aveva inviato al cardinale un’accorata missiva27
in cui lo supplicava di sostenerlo nelle opere di beneficenza richieste dalcongiunto in punto di morte (lettera 2).28 Risale invece al 1584 l’ultimo
808
cuore e simbolo di Milano. IV centenario della dedicazione 1577-1977, in “Archivio Ambrosia-no”, XXXII (1977), pp. 15-155: 134; Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’ori-gine fino al presente, Milano, Brigola, 1881 (vol. IV), pp. 166 ss. Su quest’argomento è suf-ficiente ricordare che negli ultimi anni Settanta c’erano stati momenti di fortissima ten-sione tra i fabbricieri e l’arcivescovo, sfociati nel provvedimento del 1579, con cui ognilaico veniva escluso dal Capitolo; la proibizione era durata fino a quando il Borromeo eratornato sui suoi passi, nel 1582. Proprio in quell’anno il nome di Prospero compare perla prima volta nei registri dell’archivio del Duomo, già con la qualifica di deputatus (il giu-ramento che sanciva ufficialmente l’ingresso di Prospero tra i deputati della VenerandaFabbrica risale all’inizio dell’anno successivo, il 31 gennaio 1583). Da lì in poi il suo ruolonella Veneranda Fabbrica era divenuto sempre più importante, portandolo a seguire inprima persona la conduzione architettonica dell’edificio.
23 Ad esempio quando, nel 1579 Prospero lo aveva messo in contatto con AlbertoV per aiutarlo a far ottenere al figlio l’ambìto vescovato di Colonia e il titolo di GrandeElettore dell’Impero (SIMONSFELD, p. 409).
24 Ambr. F 133 inf., c. 132 (da Prospero a s. Carlo).25 La lettera fa oggi parte di uno dei volumi del Carteggio di S. Carlo (Ambr. F 70 inf.).26 Prospero aveva in precedenza dato notizia della morte del fratello con una lette-
ra a Guglielmo V datata 7 dicembre 1574 (SIMONSFELD, p. 343, n. 180).27 Ambr. S.Q. + II.10, f. 509.28 «S’io son buono a servirla la supplico che si vaglia di me, ch’io l’assicuro che mi
trovarà sempre prontissimo ad obbedirla e servirla in ogni cosa a lei grata a me possi-bile, e lo debbe fare, sì per non lasciare giacere indarno l’autorità ch’io voglio che ellaabbia sopra di me, come per non privare me dil piacere et favore ch’io sento nel obbe-dirla e servirla» (Ambr. G 141 inf., c. 303, n° 75). La beneficenza per cui Prospero chie-deva aiuto all’arcivescovo consisteva nel dotare fanciulle povere; forse non era estraneoa questa istanza il fatto che i due fratelli Visconti fossero stati assolti, in gioventù, da
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
scambio epistolare tra lui e san Carlo, ritiratosi a Varallo poco primadella morte; l’argomento era il recapito al vicario generale di una casset-ta di reliquie mandata in dono da Guglielmo di Baviera29 (lettere 3-5).
A completare e complicare la fisionomia di questo personaggio,goliardico protettore dell’Accademia della Val di Blenio e zelante colla-boratore del Borromeo, possiamo aggiungere un tassello ancora differen-te. È proprio la Biblioteca Ambrosiana a conservare una prova (che è fral’altro uno dei rarissimi cimeli della biblioteca di Prospero)30 che allapubblica adesione all’austero rigorismo morale carliano (perfino neglianni – gli ultimi prima della morte del cardinale – caratterizzati da unpiù acceso zelo religioso) corrispondeva, in privato, una maggiore auto-nomia di interessi e una curiosità per alcuni prodotti intellettuali «difronda» che certo non poteva identificarsi in toto con gli ideali dell’asce-tica cultura del primo Borromeo. Il manoscritto ambrosiano in questio-ne, oggi catalogato come Y 32 sup., contiene una rara copia cinquecen-tesca del Canzoniere del poeta perugino Francesco Coppetta dei Beccuti.A causa di un’antica iscrizione sulla prima pagina («Sonetti canzonimadrigali del signor Prospero Visconti»), la paternità di tali rime è erro-
809
un processo in cui erano accusati di aver sedotto e “disonorato” due giovani donne mila-nesi (Archivio di Stato di Milano, Famiglie 206 e 207; Notarile 14710, Giovan Fran-cesco Pinotini, 9 aprile 1585).
29 Ambr. F 70 inf., c. 262 (da Prospero a s. Carlo) e 292, 272v (da s. Carlo aProspero).
30 Un altro libro sicuramente appartenuto al Visconti è la copia conservata allaTrivulziana di Milano della Cremona fedelissima, il già citato lussuoso volume di AntonioCampi (come testimonia la nota di possesso «Prosperi Vicecomitis» scritta a penna conl’inconfondibile calligrafia). La segnalazione è in Le tavole del Lomazzo (per i settant’annidi Paola Barocchi), a cura di Barbara Agosti e Giovanni Agosti, Brescia, L’obliquo,1997, p. 167. Una seconda nota di proprietà è quella del marchese Vercellino Maria Vi-sconti, che nel XVII secolo possedeva anche l’epistolario oggi irreperibile di Prospero(poi passato anch’esso in proprietà Trivulzio). Da una lettera dell’epistolario con i duchidi Baviera sembra di capire che il Visconti stesse cercando anche un esemplare dei diecilibri della Perspectiva del teorico medievale polacco Vitellione (o Witelo), uno dei testibase dell’ottica fino al XVII secolo (SIMONSFELD, p. 298, lettera n° 90 del 14 gennaio1573); per il resto l’inventario del 1592 segnala in casa di Prospero anche un testocurioso come il De Abditis Rerum Causis del medico parigino Jean Fernel (1548), untesto che si proponeva di classificare e spiegare le funzioni e le disfunzioni degli organidel corpo umano e che può essere letto come il primo vero studio di fisiologia.Purtroppo il già citato inventario si limita a citare in più punti plichi di «libri de diver-se scienzie» senza specificarne i titoli.
Mauro Pavesi
neamente attribuita al Visconti stesso; una semplice nota di possesso èstata evidentemente scambiata per una sorta di firma, a partire dall’in-ventario ottocentesco Ceruti-Cogliati, fino agli altri cataloghi più attua-li.31 Proprio a causa di questo equivoco il manoscritto non è mai statoconsiderato dagli studiosi che si sono occupati del poeta perugino, unautore che, come testimoniano gli studi di Abd-El-Kader Salza,32 EzioChiorboli,33 Armando Balduino34 e Giorgio Petrocchi,35 ha conosciutouna vicenda di trasmissione testuale non proprio lineare. La prima edi-zione a stampa, curata da Ubaldo Bianchi, incompleta e invalidata dadiversi errori, risale infatti al 1580,36 quasi tre decenni dopo la morte
810
31 Il codice Y 32 sup è un manoscritto cartaceo e misura cm. 20,3x15x2. La legatu-ra è stata rifatta, probabilmente nel XIX secolo; anche le ultime due pagine sono staterestaurate con nuova carta. Sul dorso si legge il titolo: VISCONTI | SONETTI | CAN-ZONI | MADRIGALI (poesie: ff. 1-99v). Non ci sono altre scritte o indicazioni, se sieccettua, nella prima pagina, la scritta in corsivo «GB Agnesi», probabilmente un’indi-cazione di proprietà. Il codice è composto di 99 carte, più tre fogli di guardia (probabil-mente ottocenteschi, come si deduce dalla filigrana con la scritta «J. Hon… | & | Zon…»)all’inizio e tre alla fine; in quelli iniziali è ripetuta due volte la segnatura della bibliote-ca. In tutti i fogli originali del codice compaiono quattro linee orizzontali; il disegno dellafiligrana è costituito da due cerchi, seguiti nella pagina successiva da un cerchio sormon-tato dai tre bracci di una croce (simile al disegno della croce di malta) alternati a due foglibianchi. La calligrafia sembra quella, nervosa ed elegante, che si legge nelle lettere dellostesso Prospero (ad esempio quelle al cardinal Borromeo conservate anch’esse inAmbrosiana); solo l’intitolazione iniziale «Sonetti, canzoni et madrigali | del sr ProsperoVisconti» è stata aggiunta da un’altra mano. A c. 90, dopo l’ultima stanza della canzone«O de l’arbor di Giove altiera verga», compare l’indicazione «il Fine»; seguono alcunifogli bianchi, da c. 91 (dove avrebbe dovuto trovar posto una «Tavola» in realtà mai com-pilata) a c. 96, che precedono le ultime rime (cc. 96-99v).
32 ABD-EL-KADER SALZA, Francesco Coppetta de’ Beccuti, poeta perugino del secolo XVI,in GSLL, suppl. n. 3, 1900.
33 Chiorboli ha infatti curato l’edizione moderna delle poesie del Beccuti(GIOVANNI GUIDICCIONI - FRANCESCO COPPETTA BECCUTI, Rime, a cura di Ezio Chior-boli, Bari, Laterza, 1912).
34 ARMANDO BALDUINO, Appunti sulle rime del Coppetta (con una scelta dell’autore ealcuni componimenti inediti), in GSLI, CXLVI (1969), pp. 52-74.
35 GIORGIO PETROCCHI, I fantasmi di Tancredi: saggi sul Tasso e sul Rinascimento,Roma-Caltanissetta, Sciascia, 1972, pp. 313-25. Sul Coppetta si veda anche CLAUDIO
MUTINI, Beccuti, Francesco in Dizionario Biografico degli Italiani, VII, Roma, Istituto dellaEnciclopedia Italiana, 1965, pp. 498-502.
36 Rime di M. Francesco Coppetta de’ Beccuti, in Venezia, appresso Domenico e GiovanBattista Guerra, 1580.
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
dell’autore, che era deceduto a Perugia nel 1553. Di seguito si contanosolo due tirature settecentesche, che ebbero il merito di recuperare diver-so materiale inedito,37 fino ad arrivare all’unica edizione moderna, del1912, a cura di Ezio Chiorboli.38 Gli studi successivi – e mi riferisco inparticolare al saggio di Armando Balduino del 1969 –39 avevano indivi-duato due linee parallele nello stemma codicum, differenziate più che altroda una serie di emendamenti di alcuni lati scabrosi del testo, dettati pro-babilmente da remore moralistiche nei confronti di alcuni componimen-ti di tema scopertamente omosessuale. Una prima analisi del codiceambrosiano, che sembrerebbe collocarlo in una posizione equidistantedalle due tendenze della tradizione manoscritta, porta a segnalare unacuriosa variante, che non sembra comparire in nessuna delle quattro edi-zioni a stampa e nemmeno nei codici più antichi indicati dagli studi. Sitratta dell’incipit del sonetto 11 del manoscritto ambrosiano, che, inluogo dell’usuale «Quel ricco laccio onde m’ha giunto Amore», comin-cia con un apparentemente inspiegabile vocativo:
Varchi, qual laccio ove m’ha giunto AmoreÈ d’un diamante con nuova arte orditoIl più vago, il più terso, il più graditoChe rendesse già mai luce o splendore.40
Pur considerando l’apparente assenza di qualsiasi legame tra ilCoppetta e il celebre intellettuale fiorentino (il fatto che i due personag-gi fossero accomunati dal medesimo orientamento omoerotico non sem-bra al momento significativo), l’inedito manoscritto Y 32 sup. è comun-que meritevole di uno studio approfondito, che potrebbe comprendereanche una collazione con le altre redazioni cinquecentesche del Canzonieredel Beccuti, proprio in virtù della sua datazione precoce, viso che il ter-minus ante quem dato dalla morte di Prospero (marzo 1592) potrebbe esse-re ulteriormente precisato dall’analisi delle filigrane, che sembrerebbecollocare il codice in un lasso di tempo compreso tra il 1560 e il 1580.41
811
37 La prima è a cura di Giacinto Vindioli, Perugia, Ciani e Desideri, 1720; la secon-da di Vincenzo Cavallucci, Venezia, Pitteri, 1751.
38 GUIDICCIONI - COPPETTA, Rime.39 BALDUINO, Appunti sulle rime del Coppetta, pp. 53-64.40 Il componimento è il II VI del manoscritto ambrosiano (f. XX).
Mauro Pavesi
Un altro dato curioso è senz’altro la calligrafia con cui le poesie sono rico-piate, che sembra essere quella, elegante, nervosa e abbastanza inconfon-dibile, dello stesso Visconti, come si può facilmente riscontrare ancheoperando un confronto con le sue citate lettere autografe in Ambrosiana.Se a prima vista può sembrare difficile immaginare uno dei più potentie ricchi nobili milanesi intento a copiare di suo pugno un Canzoniere diquasi cento pagine, il fatto potrebbe essere spiegato con un forte e per-sonale desiderio di appropriarsi dei meccanismi più reconditi dello stilecupo, fantasioso e immaginifico delle composizioni del poeta perugino,talvolta costellate da una serie di oscure, ermetiche visioni. Tale interes-se, che va senz’altro messo in relazione con l’attività poetica di Prospero,ricordata da tutte le fonti coeve ma oggi in gran parte ancora da rico-struire (oltre ai due idilli latini nella citata silloge di Matteo Toscano varicordato uno scambio di sonetti nei Grotteschi di Lomazzo),42 potrebbeessere la testimonianza di una sorta di lunga e paziente applicazione delVisconti sui testi del poeta perugino, nata probabilmente dal desideriodi affinare il suo stile in direzione del particolare petrarchismo delBeccuti, notoriamente affine a quello di Giovanni Della Casa e Galeazzodi Tarsia.43
Senz’altro meno interessanti di quest’ultimo documento, le lettere diProspero a Federico Borromeo sono tutte di carattere analogo a quellescritte a San Carlo; tuttavia, conoscendo, anche alla luce degli studi diCesare Mozzarelli, l’età del secondo Borromeo come decisamente meno“conflittuale”, esse risultano, dal punto di vista storico, un po’ menoemblematiche, proprio per aver perso la loro funzione di spia di unasituazione più articolata e complessa. Si tratta, in ognuno dei casi, dibrevi messaggi d’occasione; nella prima, datata 18 gennaio 1588 (G 141inf., lett. n° 10), il Visconti, congratulandosi per il conseguimento delcappello cardinalizio, offriva anche un’accesa dimostrazione di amicizia,
812
41 Come testimonia il repertorio di Briquet, la data più probabile è la seconda(CHARLES MOÏSE BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier desleur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, II, Genève, Jullien, 1907, n° 3244). Il disegnodella filigrana (due cerchi, seguiti nella pagina successiva da un cerchio sormontato daitre bracci di una croce simile ad una croce di Malta) permette fra l’altro di dedurre chela carta del manoscritto era stata prodotta a Vigevano.
42 G.P. LOMAZZO, Rime ad imitazione dei Grotteschi usati da’ pittori (1587), III, a curadi Alessandra Ruffino, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2006, pp. 170-72, nn. 10-12.
43 SALZA, Francesco Coppetta de’ Beccuti.
Mauro Pavesi
«che se in altro io cedo a molti, in questo solo non cedo ad alcuno, mami presuppongo di precedere tutti dal signor conte Renato [il fratello diFederico] in poi».44 Lo stesso discorso vale per la seconda missiva, risa-lente alla primavera del 1589, in cui il Visconti chiedeva anche al secon-do Borromeo aiuti e favori per la confraternita di S. Giovanni Decollato(G 144 inf., lett. n° 6). Nella terza lettera, inviata da Milano il 20 marzo159145 (G 152 inf., lett. n° 134), Prospero intercedeva presso il cardina-le in favore del convento milanese dei Gesuati, collocato presso la chiesadi S. Gerolamo, il cui priore era il dotto memorialista Paolo Morigia,46
noto come preziosissima fonte per gli studi storici e storico-artistici lom-
814
44 Ambr. G 141 inf., lett. n° 75 e n° 303.45 Ambr. G 152 inf., c. 263, lett. n° 134.46 Sull’importanza di Morigia per la corretta comprensione storiografica di questo
periodo della vita milanese si veda MOZZARELLI, Milano seconda Roma, pp. 538-41.
Figura 3 – GIOVANNI PAOLO LOMAZZO, Orazione nell’arte, Milano, PinacotecaAmbrosiana, inv. 764.
Un gentiluomo tra le carte dell’Ambrosiana
bardi ma anche per il bel ritratto dipinto da madonna Fede Galizia, con-servato proprio in Ambrosiana.47
L’ultimo argomento che lega Prospero Visconti all’Ambrosiana nonriguarda più un testo manoscritto ma un dipinto della Pinacoteca, e cioè labella tavoletta con l’Orazione nell’orto di Gian Paolo Lomazzo (fig. 3), ogget-to dell’interessante scheda di Marco Rosi di recente pubblicata nel catalo-go del Museo.48 L’opera, che Rosi ha correttamente datato al 1565 sullabase del ritrovamento di una vecchia descrizione inventariale del suo pen-dant (una piccola Crocifissione firmata dal medesimo artista, oggi irreperibi-le),49 era stata donata solo nel 1907 dall’ingegner Luigi Danioni, cognatodi Antonio Fogazzaro. L’autore della scheda, sulla base di un memorialeoggi negli archivi dell’Ambrosiana (W 53 inf., cc. 40-44) che attestava laprovenienza dei due dipinti dalle raccolte dei Visconti di Breme (nonBroni, come erroneamente scritto nel catalogo), imparentati col Danioniper via materna, ne ipotizzava un’antica appartenenza proprio alla collezio-ne di Prospero, l’unico Visconti di quel ceppo, insieme al fratello GiovanPaolo, morto, come detto, in giovane età, ad aver avuto contatti significa-tivi con Lomazzo. Tale supposizione, per quanto molto suggestiva, appareperò poco probabile ad un’analisi più approfondita: Prospero era infattimorto senza figli nel 1592, ma fin dal suo primo testamento del 157550
aveva disposto che, in caso di mancanza di prole, tutti i suoi beni sarebbe-ro passati a Galeazzo Visconti di Fontaneto, che apparteneva ad un diversoramo della dinastia, cosa che infatti avvenne.51 Si può quindi dedurre che,se l’Orazione nell’orto, nel XIX secolo, era di proprietà dei Visconti di Breme,questo non implica affatto una provenienza dal palazzo di Prospero, vistoche il suo ramo, senz’altro il più importante di quel ceppo della famiglia,si era malinconicamente estinto proprio con la sua morte.
815
47 Su cui si veda GIACOMO BERRA, in AA.VV., Pinacoteca Ambrosiana, Milano,Electa, 2006 pp. 149-53.
48 MARCO ROSI, in Pinacoteca Ambrosiana, pp. 161-65.49 Chi scrive ha ritrovato in un archivio privato milanese un’inedita immagine del
dipinto perduto, che a breve sarà oggetto di una pubblicazione specifica.50 Archivio di Stato di Milano, Notarile 14702, Gio. Francesco Pinotini,
6.XII.1575.51 L’Archivio di Stato milanese conserva anche (nei faldoni dei notai Gio. Francesco
Pinotini e Antonio Destrieri) tutte le carte della spiacevole vertenza tra l’erede GaleazzoVisconti e Giustina Garofoli, vedova di Prospero, che aveva reclamato invano per séalmeno i beni mobili del marito.
Mauro Pavesi
APPENDICE
4 ottobre 1584, F 70 inf., n° 300
Carlo Borromeo a Prospero Visconti
Al signor Prospero Visconte.Molto illustre Signore. V.S. sarà contenta di consegnare al mio vicariogenerale quella cassa di sante reliquie che gli è stata lasciata da darmidal carissimo S. Duca di Baviera, che ne scrivo parimente a lui. Et nonessendo altro, negli affetti et raccomandazioni fo buon fine. Di Vercelli.
7 ottobre 1584, F 70 inf., n° 258
Prospero Visconti a Carlo Borromeo
[sul retro: «All’Illmo et rsmo sige mio ossmo il sige Cardinale di S.Prassede»]
Illustrissimo e reverendissimo mio signore,Conforme a quello che V.S. Illustrissima mi comandò con la lettera suadelli 4 dil presente, io ho consegnato oggi al m. vicario suo generale lacassetta di sante reliquie che mi mandò il Signor Duca di Baviera miosignore, della quale ne ha trattato con V.S. Illustrissima. […] Credo cheda detto signor Viviani ne avrà parimente avviso, e pregandole Dio daogni bene fo fine, e le bacio la mano con ogni riverenza e affetto. DiMilano alli VII di ottobre MDLXXXIIII.
20 ottobre 1584, F 70 inf., n° 275
Carlo Borromeo a Prospero Visconti
Al signor Prospero Visconte.Molto illustre Signore. Alla ricevuta delle lettere di V.S. già era statoavvisato della essecuzione et consignazione fatta da lui al mio vicario
816
Appendice
generale della cassetta di sante reliquie, conforme a quello che ella mene scrive parimenti. Alla quale non occorrendomi altro, desidero dalSignore ogni suo bene, et cetera.
Dal carteggio di Guglielmo di Baviera e Carlo Borromeo
1. Monaco, 25 novembre 1580 (F 57 inf., n° 260, Guglielmo di Baviera a CarloBorromeo)
2. luogo non disponibile, […] 1579 (F 48 inf., n° 90, Carlo Borromeo aGuglielmo di Baviera)
3. luogo non disponibile, […] 1579, (F 48 inf., n° 25, Carlo Borromeo aGuglielmo di Baviera)
4. luogo non disponibile, […] 1582, (F 65 inf., n° 17, Carlo Borromeo aGuglielmo di Baviera)
25 novembre 1580, F. 57 inf., n. 260
Guglielmo di Baviera a Carlo Borromeo
Reverendissime in Christo pater atque illustrissimo domine […]. Salutem et gratifican-di paratissima studia habet in madato nobilis et generosus consiliarius cubiculariusquenoster sincere dilectus et fidelis Prosper Vicecomes …
Lettere di Prospero Visconti a Federico Borromeo
1. Milano, 18 gennaio 1588 (G 141 inf., c. 303, n° 75)
2. Milano, 15 marzo 1589 (G 144 inf., n° 6)
3. Milano, 20 marzo 1591 (G 152 inf., n° 134)
1. 18 gennaio 1588, G 141 inf., c. 303, n° 75
Prospero Visconti a Federico Borromeo
[sul retro: «All’Illmo et rsmo sige mio ossmo il sige Cardinale Borromeo»]
817
Mauro Pavesi
«Illustrissimo e reverendissimo signor mio,se tardi io scrivo a V.S. Illustrissima rallegrandomi dell’onore e dignitàsua, io mi sono però rallegrato con l’animo molto per tempo. E benchéio sia degl’ultimi che abbiano fatto seco tale officio, io pretendo nondi-meno di essere delli primi in amarla, riverirla e osservarla: che se in altroio cedo a molti, in questo solo non cedo ad alcuno; ma mi presuppongodi precedere tutti dal signor conte Renato in poi. Mi rallegro dunqueseco della promozione fatta da Sua Santità della persona di V.S.Illustrissima, ben che tal grado le fosse debito qualche tempo fa, e mene rallegro tanto di cuore quanto si conviene all’amore et osservanza cheio le tengo, e alla grandezza e dignità dil cardinalato; con la quale digni-tà molto più volentieri mi devo rallegrare dell’onoratissimo et utilissi-mo acquisto fatto da lei, che veramente non si doveva oramai più diffe-rire, e piaccia a Dio che quello che è venuto più tardi di quello che iodesiderava duri più lungamente ad utile di S. ta Chiesa e della patria suae mia et a consolazione de’ suoi parenti e servitori, e quel tempo che èstato tolto per lo adietro a tale dignità, la quale doveva essere onoratadella persona sua, per l’avenire le sia restituito et prorogato a mille dop-pii. S’io son buono a servirla la supplico che si vaglia di me, ch’io l’as-sicuro che mi trovarà sempre prontissimo a ad obbedirla e servirla inogni cosa a lei grata a me possibile, e lo debbe fare, sì per non lasciaregiacere indarno l’autorità ch’io voglio che ella abbia sopra di me, comeper non privare me dil piacere et favore ch’io sento nel obbedirla et ser-virla. E baciandole la mano con ogni riverente affetto, le prego da Dioogni contento. Di Milano alli XVIII di genaro MDLXXXVIII.»
2. 15 marzo 1589, G 144 inf., n° 6
Prospero Visconti a Federico Borromeo
[sul retro: «All’Illmo et rsmo sige mio ossmo il sige Cardinale Borromeo.Roma»]
«Illustrissimo e reverendissimo signor mio, affidato della infinita cortesia e benignità di V.S. Illustrissima, la qualeso quanto tenga a petto e stimi le cose che sono in utilità pubblica diquesta nostra città di Milano, vengo ora a supplicarla che ella sia servi-ta di favorire appresso N. S.re la scola nostra di Santo GiovanniDecollato detto alle Case Rotte, la quale, se l’affezione non m’inganna,sono sicuro che è meritevole di straordinarii favori e grazie, sì perché èla più antica di quante congregazioni siano in queste parti, e così tiene
818
Appendice
il primo loco di dignità e precedenza, come anche perché gli sono den-tro li primi cavaglieri si questo stato e altre persone religiose et pie,come ancora per l’ufficio importantissimo, utilissimo anci necessarioche si è presa a fare, ciò è non solo di seppellire quei miseri che dallagiustizia sono condannati all’ultimo supplicio, ma di assistergli inanciche morano circa doi giorni e due notti continue con essortationi, pre-ghiere, orazioni e fargli amministrare li sacramenti debiti, e più sove-nendogli ancora le cose temporali opportune. Questa benedetta scolaottenne già da N.S. Sisto Quinto una indulgenza, la quale desiderares-simo che fosse ampliata in alcune parti, et in particolare per tutta l’ot-tava del Corpus Domini, sì come era altre volte; nella quale ottava sitiene il Santissimo Sacramento con grandissima riverenza e decoro, etper antichissima usanza gli concorre una frequenza notabile di popolo,il quale, acciocché non resti defraudato di questa solenne indulgenza,che crede certo che gli sia, sarà bene che V.S. Illustrissima sia servitad’impiegare l’autorità sua acciocché otteniamo questo tesoro spirituale;ma perché più amplamente le esporrà il bisogno nostro il presentatoredi questa, che sarà il sig.e Camillo Hettorri, dottore di leggi, al qualemi rimetto; però io non sarò più longo; solo le dico che, oltre l’operabuona et santa, che facendo ella, le farà acquistare grandissimo meritoapresso a Dio; la scola nostra, et io in particolare, comunq’io mi sia, lene terremo obbligo perpetuo e singolare. E pregandole da Dio il com-pimento de soi santi desiderii, fo fine et me ne raccomando di cuore. DiMilano, alli XV di marzo MDLXXXIX.»
3. 20 marzo 1591, G 152 inf., n° 134, c. 263
Prospero Visconti a Federico Borromeo
[sul retro: «All’Illmo et rsmo sige mio col.ssmo il sige CardinaleBorromeo. Roma»]
«Illustrissimo e reverendissimo mio signore, se bene la città di Milano scrive a V.S. Illustrissima in raccomandazio-ne de frati Giesuati dell’ordine di Santo Gieronimo, non ho però potu-to mancare di aggiungere anch’io, comunque io sia, queste due righe,invitato dalla sua buona vita et buoni costumi et quasi sforzato dall’in-finito utile spirituale che tutti noi sentiremo. Questi, già sei annilasciorno di dire li loro soliti Pater nostri et, con l’autorità di papa SistoSanta memoria si misero a dire l’ore canoniche; ora si desidera et sup-plica che, con l’autorità di Sua Santità possano ancora celebrare la san-
819
Mauro Pavesi
tissima messa; e perché questo cederà a gloria di Dio et grandissimoaugumento del culto suo, e portarà grandissima devozione a questacittà, mi pare che sia cosa che da se stessa si raccomanda, senza che iogli aggionga più lunghi né più efficaci prieghi; solo dico che, oltrequello, che tutta la città nostra le terrà, io le terrò obbligo particolareet perpetuo, e pregando a V.S. Illustrissima ogni bene et felicità fo fine,et le bacio la mano con ogni riverente affetto. Di Milano alli XX di marzo MDLXXXXI.»
820