Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali presenti in manoscritti e libri a...
Transcript of Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali presenti in manoscritti e libri a...
Akten des internationalen Symposiums Berlin 16.–18. November 2011
herausgegeben von ulrike peter und bernhard weisser
2013
translatio nummorumrömische kaiser in der renaissance
Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften / Humboldt-Universität zu Berlin),
Winckelmann-Gesellschaft Stendal, Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
translatio nummorumrömische kaiser in der renaissance
cyriacus. studien zur rezeption der antikeband 3
in kommission bei harrassowitz verlag
Zum Geleit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ulrich Pfisterer
›Sinnes-Wissen‹ Jean Siméon Chardin und die Numismatik zwischen Kunst und Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANtIqUARE UNd IHRE SCHRIftEN
Martin Mulsow
Kaisermünzen und Konkurrenten Numismatische diskussionen zwischen Spanheim, Morell und ihren Gegnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Michail Chatzidakis
Auf der Suche nach dem grossen Epikerdie Kenntnis der antiken chiotischen Numismatik in einer Berliner Zeichnung Ciriacos d’Ancona . . . . . . . . . 47
Jonathan Kagan
Notes on the Study of Greek Coins in the Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wilhelm Hollstein
Die Fasti magistratuum et triumphorum Romanorum des Hubert Goltzius Eine Analyse der Münzbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Henning Wrede
Der Nutzen der Numismatik bei Hubert Goltzius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Inhaltsverzeichnis
6
Inhaltsverzeichnis
Ian Campbell
Pirro Ligorio’s Use of Numismatic Evidence Examples from his Oxford Codex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Patrizia Serafin
Pirro Ligorio e le monete tra storia e mitoL’esempio di Nerone (dal Codice Torino 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
ANtIqUARE UNd IHRE SAMMLUNGEN
françois de Callataÿ
The Numismatic Interests of Laevinus Torrentius (1525–1595), one of the Foremost Humanists of his Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
John Cunnally
The Mystery of the Missing CabinetAndrea Loredan’s Coin Collection and Its fate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ursula Kampmann
Die Schellenberg-Briefe Ein wertvolles Zeugnis für den Kenntnisstand eines »normalen« Sammlers zur römischen Antike . . . . . . . . . 149
MüNZEN UNd WISSENStRANSfER
Ulrike Peter
Testimonianza veraErschließung römischer Münzen als historische quelle – das Beispiel Sebastiano Erizzo (1525–1585) . . . . 159
Peter franz Mittag
Die Erforschung der Kontorniaten in der Renaissance und deren Wirkung bis ins frühe 18. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
MüNZEN ALS VORLAGEN
Andrew Burnett
Ancient Coins on Buildings in Northern Italy in the Late Quattrocento . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Alan M. Stahl
Roman Imperial Coins as an Inspiration for Renaissance Numismatic Imagery . . . . . . . . . . . . . 201
dagmar Korbacher
Von der vera imago zur imago viva Zur Rezeption antiker Münzen im Medium der Zeichnung von Pisanello bis Leonardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7
Inhaltsverzeichnis
MüNZEN UNd BILdER
Gian franco Chiai
Imagines verae?die Münzporträts in der antiquarischen forschung der Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ulrike Eydinger
Die Münze als Träger ikonographischen WissensEin Hilfsmittel bei der Identifizierung antiker Götterbilder in der Renaissance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Michele Asolati | Marco Callegari
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali presenti in manoscritti e libri a stampa nella Repubblica di Venezia durante il XVI secolo . . . . . . . . . . 251
Neela Struck
Vergleichendes Sehendie Numismatik als Wurzel der Stilkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
AdAPtIONEN, tRANSfORMAtIONEN UNd fäLSCHUNGEN
federica Missere fontana
Tra aemulatio e frode: storie di monete, storie di falsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Johannes Helmrath
Transformationen antiker Kaisermünzen in der RenaissanceEinige thesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Karsten dahmen
(Um-)Wege der Auseinandersetzung mit der AntikeMedaillenkunst vor Pisanello – Anregungen und Vorbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Vera-Simone Schulz
Vom Tyrannenmörder zum SouveränUmdeutungen des Brutuskultes im 16. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Verzeichnis der antiquarischen Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Personenindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
251
In un terreno già così fertile la lunga permanenza di Petrarca tra Padova e Venezia ebbe effetti ben visibili. La sua convinzione che le monete antiche dovessero essere considerate fonti primarie di notizie e informa-zioni storiche, e che in tale veste tramandassero la grandezza degli imperatori dell’antica Roma, venne recepita immediatamente. Non è infatti da doversi rite-nere un caso se proprio i Carraresi, i signori di Padova che ospitarono il grande poeta, vennero effigiati more antiquo nel 1390 sulle prime medaglie celebrative fino a oggi conosciute. da questo momento in poi la pre-senza di immagini tratte da monete romane divenne sempre più comune in ambienti pubblici e privati. Nelle città venete le facciate dei palazzi più prestigiosi vennero decorati con medaglioni tratti da monete per lo più romane fino a tutto il Cinquecento, ma ancor più indicativo per comprendere appieno la diffusione di questo gusto dell’antico è la presenza di raffigura-zioni monetali all’interno delle chiese. due esempi su tutti: le citazioni di monete imperiali romane nel di-strutto affresco del Mantegna »Giudizio di san Giaco-mo« nella Cappella Ovetari della Chiesa degli Ere-mitani di Padova (1449–57) e la Cappella dell’Arca della Basilica del Santo (1533). qui, in quello che era e che è tuttora il luogo più venerato dalla cristianità veneta, sul soffitto a stucchi – pro gettato da Giovanni Maria falconetto e realizzato da tiziano Aspetti detto Minio – sono stati inseriti sei medaglioni raffiguranti imperatori romani, che richiamano decorazioni simili utilizzate pochi anni prima dal falconetto stesso nella Sala dello Zodiaco nel Palazzo dell’Arco a Mantova.
1. Alessandro Maggi e il Cod. 663 della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova
Marco Callegari
Il grande interesse per il mondo classico presente nel Veneto nel secolo XVI trova le sue origini già nell’ulti-ma parte del medioevo durante il periodo comunale. Alla fine del XIII secolo infatti si era formato in parti-colare a Padova un gruppo di pre-umanisti – i cui esponenti principali erano Lovato de Lovati e Alberti-no Mussato – grazie ai quali era ad esempio avvenuta la riscoperta delle tragedie senechiane in campo lette-rario.
Non a caso nel 1283 il ritrovamento casuale di una tomba di un soldato romano di epoca imperiale, il cui scheletro si era mantenuto in eccezionali condizioni di conservazione insieme a una spada e a due vasi conte-nenti monete d’oro, venne considerato come la sco-perta del corpo del troiano Antenore, mitico fondatore di Patavium, e celebrato con l’innalzamento di un’arca monumentale ancor oggi conservata in centro a Pado-va. Più strettamente legata alla numismatica è però la figura già più volte ricordata del notaio veronese Gio-vanni de Matociis detto il Mansionario. Il manoscritto delle sue Historiae imperiales, Chigi J.VII.259 della Biblioteca Apostolica Vaticana scritto tra il 1312 il 1320, riporta infatti nei margini delle pagine le effigi degli imperatori mediante disegni tratti da monete, probabilmente con la funzione di ausilio per il lettore, consentendogli di individuare con maggiore facilità le diverse sezioni delle Historiae.
Michele Asolati | Marco Callegari
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali presenti in manoscritti e libri a stampa nella Repubblica di Venezia durante il XVI secolo
252
Michele Asolati | Marco Callegari
corso per Enea Vico, la cui abilità di disegnatore e in-cisore gli permise una più stretta vicinanza dell’imma-gine all’originale, sebbene a volte ancora interpretata come elemento decorativo, al punto da poter distin-guere anche i particolari secondari [fig. 2]. La tipolo-gia iconografica di Vico venne sostanzialmente ripresa anche dal senatore veneziano Sebastiano Erizzo, il qua-le nella propria opera si avvalse però di disegnatori e incisori che interpretarono in misura maggiore i ritrat-ti presenti nelle monete rispetto al parmense [fig. 3].
Almeno per il Veneto scarsissime sono le notizie sulla ricezione dei modelli proposti da questi »reper-tori« a stampa da parte di collezionisti e cultori di nu-mismatica dell’epoca. Nell’ambito di una ricerca volta a identificare testimonianze di tali forme di acquisizio-ne di modelli iconografici, sono stati presi in conside-razione due manoscritti cinquecenteschi identificati in biblioteche di Padova e Venezia, che all’esame hanno riservato inaspettate sorprese.
Il primo è opera di Alessandro Maggi, di cui in se-guito tratterà diffusamente federica Missere fontana e a cui si rimanda per le vicende biografiche, oltre che per il legame di amicizia e di interessi comuni che lo
In un tale contesto non può certamente apparire stra-no se alla metà del Cinquecento nel giro di pochi anni apparvero a Venezia le opere numismatiche dei tre au-tori a tutti ben noti: Enea Vico, Jacopo Strada e Sebas-tiano Erizzo. Immediatamente i loro testi acquisirono lo status di repertori visivi e quindi usati dai collezio-nisti, che apprezzarono soprattutto le imma gini delle monete riportate. La tipologia e la qualità delle xilo-grafie e incisioni nei libri dei tre autori sono ovviamen-te differenti e vale la pena visualizzare per sommi capi le diverse forme di translatio dagli originali.
Jacopo Strada, antiquario, collezionista e numisma-tico, fu l’autore o il curatore di due opere – »Epitome thesauri antiquitatum, hoc est, Impp. Rom. orienta-lium & occidentalium iconum, ex antiquis numisma-tibus quàm fidelissimè deliniatarum. Ex musaeo Iaco-bi de Strada Mantuani antiquarij« (Lugduni, apud Iacobum de Strada, et thomam Guerinum, 1553; nel colophon: Lugduni, excudebat Ioannes tornaesius) e »fasti et triumphi Rom. a Romulo rege usque ad Ca-rolum V Cæs. Aug.« (Venetiis, impensis Iacobi Stradæ Mantuani, 1557) – realizzate sulla base della propria collezione numismatica. In entrambi i volumi venne-ro usate le stesse xilografie la cui tipologia è ancora le-gata al fondo nero dell’Illustrium immagines di Andrea fulvio (Impraessum Romae, apud Iacobum Mazo-chium Romanae Achademiae bibliopo., 1517) e carat-terizzate inoltre da disegni scarsamente aderenti alle monete originali [fig. 1]. diverso ovviamente il dis-
1 Jacopo Strada, Epitome Thesauri antiquitatum, 1553, p. 12: Augusto
2 Enea Vico, Ex libris XXIII commentariorum, 1562, tav. I: Cesare
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
253
1 Su Pietro Bembo si veda Carlo dionisotti, s. v. Pietro Bembo, in: dizionario biografico degli Italiani, a cura di Mario Caravale, 75 voll., Roma 1960–(in seguito dBI), vol. 8, 1966, pp. 133–151 (http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bembo_(dizio-nario-Biografico)/).2 Su Alvise Cornaro si veda Giuseppe Gullino, s. v. Alvise Cor-ner, in: dBI, vol. 29, 1983, pp. 142–146 (http://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-corner_(dizionario-Biogra fico)/).3 Su Marco Mantova Benavides si veda franco tomasi, Chris-tian Zendri, s. v. Marco Mantova Benavides, in: dBI, vol. 69, 2007, pp. 214–220 (http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-mantova-benavides_(dizionario-Biografico)/).
porta la sequenza di paginazione 1–21, 1–6, 22–33, 33–41, 1–16, 16–25, 1–26, 1–31, 1–15, 1–6; la se-conda è frutto già di un assemblaggio delle singole parti, riportando la seguente sequenza: 1–21, [1–6], 22–33, 33–41, 40–55, 55–136, 138–143.
dato l’aspetto dell’inchiostro e della calligrafia, l’in-tero testo dell’opera sembra essere stato scritto nell’ar-co di un periodo di tempo piuttosto breve, a eccezione del fascicolo di sei carte in seconda posizione in en-trambe le sequenze e significativamente privo della nu-merazione in basso a destra: probabilmente si tratta di una aggiunta posteriore alla prima redazione dell’ope-ra. Infine le note e le correzioni, sempre opera della stessa mano del testo e presenti sui margini di tutto il volume, testimoniano un lungo lavoro di rifinitura nel tempo, come sembrerebbero indicare i diversi inchio-stri usati e i diversi spessori delle punte dei calami.
unirono per anni a Giovanni da Cavino al punto da farsi ritrarre insieme nella famosa medaglia opera del da Cavino stesso. Maggi fu un erudito esperto di anti-quaria e di storia antica, amico e familiare di Pietro Bembo1 (e quindi conoscitore della sua collezione numismatica), ma anche di Alvise Cornaro2 e Marco Mantova Benavides.3 La sua reputazione era così alta, che nel 1541–1542 venne chiamato dalle autorità della città di Padova per la ideazione del nuovo ciclo di affreschi della Sala dei Giganti (già Sala degli Eroi in epoca carrarese) dopo l’incendio che aveva distrutto la decorazione pittorica precedente e per la ideazione del monumento a tito Livio nel Palazzo della Ragione con un affresco di domenico Campagnola rappresentante due ritratti tratti da monete di Augusto e tiberio.
fu proprio su suggerimento di Pietro Bembo che intraprese tra il 1550 e il 1570 la redazione della »In-terpretatio historiarum ac signorum in numismatibus excussarum excussorumve duodecim primorum Cae-sarum«,4 opera che doveva essere costituita di tre volu-mi, di cui solo il primo è a noi pervenuto [figg. 4–5]. La sua presenza nella Biblioteca del Seminario di Pa-dova è dovuta al dono che ne fece l’anno 1800 alla sua morte l’abate Giuseppe Gennari,5 il quale a sua volta lo aveva ricevuto nel 1778 dal canonico Camillo Stor-ni di Montagnana.6 Già, però, nei primi decenni dell’ Ottocento ne venne dimenticata la presenza e venne dato come perduto, per essere riconosciuto solo nel 1962 da Elda Zorzi.7
Il volume è costituito di 153 carte illustrate con disegni e alcune incisioni, tutti ritagliati e incollati sul-le pagine, secondo una mise en page che già doveva servire da traccia per una stampa che non venne mai effettuata.
A esclusione della prima pagina col titolo, sulle al-tre pagine sono presenti due numerazioni della stessa mano, una sull’angolo in alto a destra e un’altra in bas-so a destra. La prima è sicuramente la più antica e ri-
4 Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, ms. 663.5 Su Giuseppe Gennari si veda Paolo Preto, s. v. Giuseppe Gen-nari, in: dBI, vol. 53, 2000 (http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-gennari_(dizionario_Biografico)/).6 Su Camillo Storni si veda Pietro Giorgio Lombardo: Il proble-ma della canapa nello stato veneto e il canonico Camillo Storni da Montagnana (1747–1802), in: Contributi alla storia della chiesa padovana nell’età moderna e contemporanea, 2 voll., Padova 1984, vol. 2, pp. 185–217.7 Elda Zorzi: Un antiquario padovano del sec. XVI. Alessandro Maggi da Bassano, in: Bollettino del Museo Civico di Padova 51 (1962), n. 1, pp. 41–98, in part. pp. 49–63, 78–83.
3 Sebastiano Erizzo, Discorso sopra le medaglie antiche, 1559, p. 134
254
Michele Asolati | Marco Callegari
10 Cfr. Zander H. Klawans: Imitations and Inventions of Ro-man Coins. Renaissance Medals of Julius Caesar and the Roman Empire, Santa Monica 1977, p. 20 n. 1, p. 21 n. 4, p. 24 n. 4, p. 35 n. 2.
8 Cfr. Giulio Bodon: Studi antiquari fra XV e XVII secolo. La famiglia Maggi da Bassano e la sua collezione di antichità, in: Bol-lettino del Museo Civico di Padova 80 (1991), pp. 23–172, in part. p. 68.9 Cfr. Zorzi 1962 (nota 7), p. 52.
Come si può vedere dalla tabella, è possibile identifi-care un gruppo omogeneo per stile di sette incisioni probalimente xilografiche (Incisioni A: le due incisio-ni a c. 90v sono le stesse presenti poi a c. 95r–v) incol-late all’inizio di ogni capi tolo in uno spazio a loro appositamente dedicato al l’interno del testo [figg. 6–12]. L’argomento trattato nelle pagine successive è strettamente connesso con le monete raffigurate, che anzi si direbbero essere state fonte diretta di ispirazio-ne di quanto svolto nel capitolo stesso. Per tali motivi queste incisioni possono essere considerate le uniche illustrazioni previste – almeno inizialmente – da parte dell’autore e le uniche appositamente realizzate per l’opera. Le incisioni delle figg. 6–8 e 12 sono però tratte da invenzioni caviniane e non da monete roma-ne originali,10 mentre l’incisione della fig. 11 è uguale a un disegno presente in un album, che verrà esamina-to in seguito, in cui comunque sono presenti elementi iconografici che rimandano al medaglista padovano [fig. 13]. Infine le ultime due incisioni raffigurano due monete appartenute alle collezioni di Pietro Bembo e di Alessandro Maggi [figg. 9–10]. La perfetta corris-pondenza delle incisioni con le monete caviniane sin
Elementi significativi a corredo del testo sono inoltre le immagini presenti nel manoscritto, in passato prese poco in considerazione con l’attribuzione ad Alessan-dro Maggi di tutti i disegni,8 mentre le incisioni pre-senti furono segnalate con un semplice accenno in quanto considerate di provenienza sconosciuta.9
In verità tali immagini offrono lo spunto per qual-che precisazione ulteriore.
Una prima caratteristica comune a tutte è di non essere state disegnate direttamente sul testo (e qui è evi-dente la differenza per esempio con i codici di Pirro Ligorio), ma di essere tutte ritagliate e incollate sulle pagine. tale fatto indica almeno due fasi distinte nella preparazione del manoscritto, ossia la fase della scrit-tura e quella della raccolta delle illustrazioni, separate tra loro anche da un punto di vista temporale. A que -s to punto però si apre un’altra questione: prima il testo o prima le immagini? Oppure sono stati realizzati con-temporaneamente?Il principale indizio per cercare di comprendere come venne realizzato il volume viene dalla posizione delle immagini all’interno del manoscritto e dal loro legame col testo scritto.
Prima sequenza Seconda sequenza Incisioni A Incisioni tratte da Zantani-Vico 1548
Disegni mano A Disegni mano B
1–21 1–21 3v 14v; 19r
1–6 [1–6]
22–33 22–33 25v 31r
33–41 33–41
1–16 40–55 40r 42v; 43v; 44r–v 53r–v
16–25 55–64 57v; 58r 58r
1–26 65–90 65r; 90v 76r–v; 86r–v; 87v
1–31 91–121 95r–v 112v; 113v; 115r 108r; 109v; 111v; 117r; 118r
1–15 122–136 122r
1–6 138–143 138r
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
255
4 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 1r 5 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 58r: sopra disegno di mano A, sotto disegno di mano B
11 Per notizie biografiche su Giovanni da Cavino si rimanda in particolare ai testi citati infra, a nota 20.
siano stati aggiunti in un secondo momento. Si distin-guono gruppi di due mani diverse: la prima (corris-pondente nella tabella alla mano A) pur attenta a una riproduzione il più possibile fedele è meno accurata nella resa delle immagini e utilizza un inchiostro color marrone scuro con un tratto piuttosto grosso del di-segno; la seconda (corrispondente nella tabella alla mano B) è invece di qualità decisamente maggiore della precedente e si caratterizza per un inchiostro di colore più chiaro [fig. 5]. In particolare di questo se-condo gruppo il dritto di un sesterzio di domiziano a c. 31r [fig. 33] è molto vicino a un’altra invenzione caviniana e tutto il gruppo sembra attenersi ai modi grafici presenti nei disegni presenti in un album, di cui si tratterà diffusamente nella seconda parte di questo contributo. Potrebbe infatti trattarsi della stessa mano dell’autore dell’album, anche se si riscontra una mino-re attenzione e una resa più veloce nella delineazione delle monete.
A differenza di quanto sostenuto in passato non sono riscontrabili elementi che possano stabilire con certezza che Alessandro Maggi sia stato l’autore di uno
nei minimi particolari fanno supporre che sia stato lo stesso da Cavino a preparare i rami per Alessandro Maggi. Si tratterebbe quindi dell’unico esempio fino a oggi conosciuto della sua opera incisoria, sicuramente secondaria all’attività di medaglista, ma che comun-que contribuisce a fornire un altro tassello per deline-are il quadro ancora lacunoso della sua vita e del suo lavoro.11 Per quanto riguarda le altre cinque incisioni presenti nel manoscritto, si tratta di immagini ritaglia-te dal volume di Antonio Zantani con le tavole di Enea Vico, »Le imagini con tutti i riversi trovati et le vite de gli imperatori tratte dalle medaglie et dalle hi-storie de gli antichi«, uscito a Parma nel 1548 a spese del Vico stesso. tale presenza segnala da parte del Maggi la preferenza per lo stile iconografico del par-mense, come si è visto in precedenza maggiormente attento alla resa dei particolari e quindi più utile per i collezionisti nel riconoscimento degli esemplari.
I disegni delle monete invece sono distribuiti nel volume senza un criterio apparente e tutti incollati sui margini delle pagine. Non pare quindi che la loro pre-senza sia riconducibile al progetto originario, ma che
256
Michele Asolati | Marco Callegari
6 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 3v: Cesare
8 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 65r: Augusto
12 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 138r: Caligola
9 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 95r: moneta della collezione Bembo
11 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 122r: tiberio
10 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 95v: moneta della collezione Maggi
7 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 40r: Cesare
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
257
16 Le misure dei fogli incollati sono le seguenti: c. 3r, cm 9,1 × 15,2; c. 5r, cm 9,1 × 14,4; c. 6r, cm 9,6 × 13,8; c. 7r, cm 10 × 13,2; c. 8r, cm 10 × 13,8; c. 9r, cm 10,1 × 13,8; c. 10r, cm 10 × 13,8; c. 13r, cm 9,9 × 13,8; c. 14r, cm 9,6 × 14,1; c. 15r, cm 10 × 13,8.17 Cfr. a tal proposito le indicazioni disponibili on line presso il sito http://www.querinistampalia.it/museo/monete_medaglie.html.18 Cfr. Biblioteca querini Stampalia, Mss. Cl. III, Cod. 48 (406): »Medagliere quiriniano«; Mss. Cl. III, Cod. 49 (304): »Musaei quiriniani antiqua numismata«; Mss. Cl. III, Cod. 55 (768): »Miscellanea di Numismatica ossia quaderni vari di Me-morie minute […] Studi e scritti di Gerolamo querini […]«.19 Cfr. supra, nota 4.
12 Biblioteca querini Stampalia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399). Il taccuino misura cm 12,6 × 18,2 ed è formato da sedici carte nu-merate a stampa in alto a destra del recto. La coperta è in perga-mena ed è legata con lo stesso materiale alla cucitura del fascicolo. Un sentito ringraziamento va indirizzato alla fondazione querini Stampalia di Venezia per aver consentito lo studio e la pubblicazio-ne del manoscritto. La nostra gratitudine va inoltre al Biblioteca-rio Marcello Busato per la cortesia e la disponibilità.13 Cc. 6v, 16r–16v: alla c. 6v inizio di una lettera »29 8 an […] Cari.mo«; alla carta 16r, »Gio«; alla c. 16v quattro parole mano-scritte.14 Alle carte 10v e 11r ci cono delle somme ma tematiche, proba-bilmente di denaro, scritte con andamento contrario.15 Cm 7,4 × 8.
spondendo a prescrizioni calligrafiche, non è ricono-scibile, per cui l’anno 1783 andrebbe inteso semplice-mente come un terminus post quem per determinare l’ingresso nella biblioteca querini. tuttavia, va ricorda-to che proprio attorno a quella data Gerolamo querini stava dando corpo a una ricca collezione numis matica, fatta prevalentemente di monete greche e romane, di cui ancora oggi sopravvivono numerosissimi esem-plari:17 di Gerolamo, peraltro, la Biblioteca querini Stampalia conserva attualmente alcuni manoscritti con elenchi delle sue monete e alcuni studi numisma-tici.18 Risulta plausibile dunque che il taccuino sia en-trato nel patrimonio querini proprio grazie a Gerola-mo e alla sua passione numismatica e che quell’anno corrisponda grosso modo alla data d’ingresso.
Completamente differente sembra però essere la cronologia dei disegni, in particolare dei dieci ricon-ducibili a una sola mano. questi infatti trovano con-fronto assai stringente con alcuni dei disegni presenti sul manoscritto attualmente conservato presso il Se-minario Vescovile di Padova, attribuibile ad Alessan-dro Maggi e databile nell’ambito del XVI secolo.19 In particolare, i dritti dei disegni presenti sulle carte 14r e 15r del manoscritto veneziano sono caratterizzati in modo del tutto affine a quello presente alla c. 31r del manoscritto patavino [fig. 33], da potersi quasi dire dello stesso artista: in realtà i disegni del manoscritto veneziano sono più raffinati e complessi, ma le simili-tudini con molti tra quelli del manoscritto patavino sono tali e tante da giustificare l’accostamento, o per lo meno da consentire l’ipotesi che quelli veneziani siano appartenuti a un gruppo di prototipi da cui fu-rono tratti quelli patavini.
Appare fondata l’ipotesi, pertanto, che i disegni presenti nel manoscritto conservato a Venezia vadano ascritti al Cinquecento.
tale ipotesi appare avallata anche da un’altra circo-stanza. I dieci disegni del manoscritto veneziano in
dei due gruppi di disegni (eventualmente del solo gruppo A, come si vedrà in seguito), la cui funzione originaria potrebbe essere stata quella di semplici sche-de di segnalazione e solo successivamente impiegate per illustrare il manoscritto.
2. Un manoscritto con disegni di Giovanni da Cavino?
Michele Asolati
tra i manoscritti conservati presso la Biblioteca que-rini Stampalia di Venezia si conserva un taccuino di sedici carte intitolato »Medaglie d’Imperatori, ec. e Consolari. disegnate con la penna e riconosciute 19 Mag.° 1783«.12 forse originariamente doveva essere destinato a un uso differente da quello per cui poi fu effettivamente impiegato, perché alcune carte recano alcune indicazioni manoscritte, come l’incipit di una lettera o un nome abbreviato,13 oppure alcune addi-zioni di cifre probabilmente in lire e soldi.14
L’interesse di questo manoscritto risiede in undici disegni riferibili a »medaglie d’imperatori«, come reci-ta il titolo, mentre mancano illustrazioni di esemplari consolari, o, per dirla altrimenti, romani repubblicani. Il titolo dunque abbraccia argomenti effettivamente non compresi nel taccuino.
Ciascuno dei disegni è incollato sul recto di undici delle sedici carte: fatta eccezione per quello alla c. 4r,15 i fogli che effettivamente sono disegnati corrispondono grosso modo a una misura standard di cm 9/10 × 14.16 questa differenza trova corrispondenza anche nella qualità stessa dei disegni: quello riportato alla c. 4r [fig. 17], benché di ottima qualità, non presenta le ca-ratteristiche di eccellenza che connotano gli altri dise-gni, ascrivibili certamente a una sola mano.
Purtroppo della storia del manoscritto nulla è noto, a parte la data indicata nel titolo. La grafia, però, ri-
258
Michele Asolati | Marco Callegari
e falsario, in: Veneto, ieri, oggi, domani VII, 74 (febbraio 1996), pp. 38–41; Id.: Giovanni da Cavino, in: donatello e il suo tempo, Il bronzetto a Padova nel quattrocento e nel Cinquecento, Mila-no 2001, pp. 289–298; Philip Attwood: Italian Medals c. 1530–1600 in British Public Collections, London 2003, pp. 184–197, in part. pp. 185–186.
20 Giovanni Gorini: Appunti su Giovanni da Cavino, in: La medaglia d’Arte, Atti del I Convegno Internazionale di Studio, Udine, 10–12 ottobre 1970, Udine 1973, pp. 110–120; Id.: New Studies on Giovanni da Cavino, in: Italian Medals, a cura di John Graham Pollard, Washington 1987 (Studies in the History of Art 21), pp. 45–54, in part. p. 46; Id.: Giovanni da Cavino medaglista
glie simili a sesterzi imperiali, ma con piccoli partico-lari modificati, oppure con accoppiamenti di dritti e rovesci sconosciuti alla serie romana imperiale. Stante la precisione e la cura stilistica con cui furono traccia-ti, non sembrano potersi dire disegni preparatori, ma riproduzioni a penna di medaglie finite.
Solo il caso proposto alla c. 3r [fig. 13] pone qual-che ostacolo a questa interpretazione. A differenza de-gli altri simili, illustra tre facce invece di due: la prima con busto imperiale, la seconda con SC al centro e la
effetti non riproducono monete imperiali, bensì opere del medaglista patavino Giovanni da Cavino (1500–1570), ben conosciuto dal XVI secolo in poi, oltre che per le sue medaglie ritraenti personaggi a lui contem-poranei, per le rielaborazioni di prototipi romani im-periali e le invenzioni ispirate all’antico, generalmente delle dimensioni dell’antico sesterzio imperiale, note con il nome corrente di »padovane«:20 tra le rielabora-zioni si contano sia semplici riproduzioni, chiaramente con caratteristiche stilistiche riconoscibili, sia meda-
14 tiberio, sesterzio, 22–23 d. C. (25,51 gr, 35 mm)
16 Giovanni da Cavino, medaglie per l’imperatore tiberio
15 tiberio, asse, 22–23 d. C. (10,18 gr)
13 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 3r: tiberio
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
259
caviniano un sesterzio, conservato presso la Bibliothèque Natio-nale di Parigi, recante al dritto l’imperatore seduto e al rovescio la sigla SC, riportando l’indicazione »an imitation of a genuine se-stertius«. In realtà il pezzo è un originale imperiale che condivide lo stesso conio di dritto con un analogo esemplare conservato presso il British Museum; cfr. Mattingly 1965 (nota 21), tav. 23, n. 16 e RIC, vol. I, tav. 11, n. 48.23 Nell’esemplare qui riprodotto, al rovescio la legenda è suddi-visa in quattro righe (P P / OB / CIVES / SERVAtOS) ed è pre-sente la sigla SC sotto.24 Otone non produsse monete di bronzo: il prototipo fu un aureo o un denaro, chiaramente privo dell’indicazione SC che compare invece nel disegno.25 Cfr. nota precedente.
21 La verifica è stata condotta sui principali cataloghi a stampa disponibili, come Harold Mattingly: Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. I: Augustus to Vitellius, London 1965; Anne S. Robertson: Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet University of Glasgow, vol. I: Augustus to Nerva, Oxford 1962; Sylloge Nummorum Romanorum. Italia, Milano Civiche Raccolte Numismatiche, vol. I: Giulio–Claudi, part 1: Augustus–tiberius, Milano 1990. Inoltre sono state consultate varie risorse disponibili on line, come www.coinarchives.com (versione academic), www.acsearch.com, www.cngcoins.com, www.vcoins.com, www.wildwinds.com.22 Roman Imperial Coinage (RIC), vol. I: from 31 BC to Ad 69, a cura di C. H. V. Sutherland, Revised Edition, London 1984, p. 97, n. 48. Klawans 1977 (nota 10), p. 29, n. 5 propone come
centro simile a RIC, vol. I, p. 97, nn. 48–51 (ti-berio); disegno a destra simile a RIC, vol. I, pp. 95–96, 2J (tiberio); cfr. Klawans 1977, p. 29, n. 4 (per l’abbinamento d / busto e R / imperatore seduto: cfr. fig. 16a) e p. 30, n. 1 (per il R / con sigla SC al centro: fig. 16b);
2) c. 5r [fig. 18]: simile a RIC, vol. I, p. 130, n. 112 (Claudio), ma senza EX S C all’inizio della legen-da del R /; cfr. Klawans 1977, p. 42, n. 5;23
3) c. 6r [fig. 19]: simile a RIC, vol. I, p. 175, n. 398 o p. 178, n. 442 (Nerone); cfr. Klawans 1977, p. 45, n. 4 (per il d /) e p. 48, n. 9 (per il R /);
4) c. 7r [fig. 20]: d / simile a RIC, vol. I, pp. 243–244 n. 9fa (Galba), ma con POt in luogo di P finale di legenda; R / simile a RIC, vol. I, pp. 254–255, nn. 462–468 (Galba), ma con AdLOCVt in luogo di AdLOCVtIO; cfr. francesco Cessi, Bruno Caon: Giovanni da Cavi-no medaglista padovano del Cinquecento, Pado-va 1969, p. 87, n. 65 [fig. 21];
5) c. 8r [fig. 22]: simile a RIC, vol. I, p. 260, nn. 9–10 (Otone),24 ma con tRI POt in luogo di tR P finale di legenda del d /; cfr. Klawans 1977, p. 54, nn. 3–4 (per il d /) e pp. 54–55, nn. 4–6 (per il R /, ma con una suddivisione differente della legenda: SECVRI-tAS P R; fig. 23); cfr. an-che Cesare Johnson, Rodolfo Martini: Milano, Civiche Raccolte Numismatiche. Catalogo delle Medaglie, vol. II: Secolo XVI-Cavino, in: Bollet-tino di Numismatica, monografia 4.II.2, Roma 1989, n. 1482 per una medaglia fusa con un ac-coppiamento di facce simile a quello illustrato nel manoscritto;
6) c. 9r [fig 24]: d / simile a RIC, vol. I, p. 260, 2 (Otone), ma con tRI POt in luogo di tR P finale di legenda;25 R / invenzione caviniana; cfr. Klawans 1977, p. 54, n. 3 [fig. 25];
terza con una figura imperiale seduta a sinistra. Sem-brerebbe indicare l’accoppiamento di uno stesso dritto con due rovesci differenti (v. infra, n. 1). Certamente il dritto è caviniano poiché rispecchia esattamente il trattamento dei capelli delineato sulle medaglie dell’ incisore patavino [cfr. fig. 16]: un’evidente scrimina-tura separa le ciocche della parte superiore del capo da quelle inferiori, suddivise in fasce parallele, secondo un modello che non trova confronti puntuali sulla monetazione di tiberio.21 tuttavia, alcune caratteristi-che delle facce poste rispettivamente al centro e a sini-stra non rispondono a realizzazioni di questo artista, ma dei prototipi romani [cfr. fig. 14]:22 il punto tra le lettere S e C è di forma triangolare, mentre quello del patavino è tondo; il campo ai lati dell’imperatore se-duto è privo di lettere, mentre sulle medaglie »padova-ne« compare la sigla S-C. Potrebbe trattarsi di errori dovuti alla stretta somiglianza con modelli imperiali, ma, come vedremo, non si può escludere anche una sovrapposizione voluta tra realizzazioni antiche e mo-derne. Peraltro va significativamente evidenziato come incisioni molto simili a questi disegni siano raggrup-pate in maniera del tutto simile sul manoscritto già ricordato, conservato presso il Seminario Vescovile di Padova, e come le caratteristiche di queste ultime per-mettano di assimilarle ad altre incisioni applicate allo stesso manoscritto, riproducenti unicamente esempla-ri caviniani e per questo forse ascrivibili allo stesso in-cisore patavino [cfr. fig. 11].Esaminando ora nel dettaglio le singole illustrazioni sulle carte veneziane, si possono verificare le seguen ti corrispondenze:
1) c. 3r [fig. 13]: disegno a sinistra simile a the Ro-man Imperial Coinage, 10 voll. (d’ora in poi cita-to solo RIC), vol. I, p. 96, 15b (tiberio) noto per l’asse [fig. 15], ma non per il sesterzio; disegno al
260
Michele Asolati | Marco Callegari
17 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 4r: Germanico
18 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 5r: Claudio
20 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 7r: Galba
22 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 8r: Otone
23 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore Otone con Securitas Populi Romani
21 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore Galba con Adlocutio
19 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 6r: Nerone
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
261
24 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 9r: Otone
26 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 10r: Vitellio
28 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 13r: tito
30 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 14r: domiziano
29 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore tito con Iudaea Capta
31 Biblioteca querini Stampalia, Venezia, Mss. Cl. III, Cod. 42 (1399), c. 15r: domiziano
27 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore Vitellio con Libertas Restituta
25 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore Otone con Securitas Populi Romani
32 Giovanni da Cavino, medaglia per l’imperatore domiziano con indicazione del Ludi Saeculares
262
Michele Asolati | Marco Callegari
due secoli di collezionismo di antichità 1596–1797, Padova 1997, pp. 132–135, in part. p. 134; id.: Monete antiche a Padova, Pado-va 1972, pp. 25–26; id. 1996 (nota 20), pp. 39–40.
26 Per questi e per altre medaglie caviniani realizzate per com-mittenti coevi cfr. Cessi, Caon 1969 (testo, n. 4), pp. 32–77. 27 Cfr. p. es. Giovanni Gorini: Lo statuario pubblico: il collezio-nismo numismatico, in: Lo statuario pubblico della Serenissima.
Corner, ecc.;26 in altre parole, potevano assecondare le esigenze di più di un committente e avere un mercato molto più ampio, allargato potenzialmente a schiere di collezionisti di monete antiche, allora non sempre attenti e disposti a distinguere prodotti genuini da »creazioni« antiquarie.27 Non è improbabile che prop-rio i raccoglitori fossero interessati a considerare pre-ventivamente le possibili scelte da acquistare e a giudi-care le varietà e gli abbinamenti tipologici: perciò i disegni potrebbero essere stati un mezzo di promozio-ne del prodotto caviniano in risposta a tali interessi, realizzati con una precisione e una raffinatezza tali da rappresentare in modo eccellente le caratteristiche del prodotto finito.
In questa prospettiva forse potrebbero anche essere spiegate le incongruenze segnalate sopra: nel caso di tiberio potrebbe trattarsi del tentativo di accostare medaglia caviniana a moneta antica semplicemente per dimostrare l’accuratezza del lavoro incisorio, spin-ta a tal punto da riprodurre le caratteristiche dell’an-tico modello confondendosi con questo; nei casi di Nerone e di Galba potrebbero essere illustrate sempli-cemente delle possibili combinazioni realizzabili, poi effettivamente mai portate a termine perché di scarso successo.
In buona sostanza, dunque, sembra giustificabile la conclusione che i dieci disegni più raffinati del ma-noscritto conservato presso la Biblioteca querini Stampalia di Venezia siano stati tracciati dallo stesso Giovanni da Cavino e costituiscano dunque una testi-monianza unica della personalità di questo artista e della cultura patavina del Cinquecento.
Conclusioni
Giovanni da Cavino ha avuto un’influenza notevole sullo sviluppo della medaglia nel Cinquecento e, più in generale, del collezionismo numismatico a partire dal XVI secolo e ancora fino ai giorni nostri: delle col-lezioni pubbliche nazionali ed estere che hanno inizia-to a formarsi nel Sei-, Sette- e ancora nell’Ottocento non ve n’è alcuna di una qualche importanza che ac-colga esemplari di età romana imperiale, la quale non sia caratterizzata dalla presenza di esemplari »padova-ni« in quantità più o meno accentuate, entrativi con o
7) c. 10r [fig. 26]: simile a RIC, vol. I, pp. 271–273, nn. 69, 80–81, 104–105 (aurei e denari di Vitel-lio), ma con legenda del d/ A VItELLIVS GER-MAN IMP AVG P M P P in luogo di A VItEL-LIVS GER IMP AVG P M t P P comunque non abbinata al R / su coniazioni antiche; cfr. Klawans 1977, p. 59, n. 3 [fig. 27];
8) c. 13r [fig. 28]: simile a RIC, vol. II, p. 127, n. 93 (tito); cfr. Klawans 1977, p. 67, n. 3 [fig. 29];
9) c. 14r [fig. 30]: d / simile a RIC, vol. II, p. 194 (domiziano); R / simile a RIC, vol. II, p. 201, n. 376 (ma con legenda completamente differente dall’originale COS XIIII LVd SAEC SVf P d e incompatibile con quella del d/); cfr. Klawans 1977, p. 71, n. 4 [fig. 32];
10) c. 15 [fig. 31]: cfr. n. 9.
In definitiva, dunque, una parte significativa della produzione medaglistica ispirata all’antico dell’artista patavino è rappresentata in questi fogli manoscritti, malgrado le minime incongruenze illustrate sopra a proposito di tiberio, di Claudio e di Otone, e gli ac-coppiamenti ignoti indicati ai nn. 1, 3 e forse 8, i qua-li tuttavia non inficiano l’attribuzione caviniana delle singole facce.
Se i soggetti disegnati non riproducono monete ef-fettivamente antiche, ma opere di un solo medaglista operante nel corso del XVI secolo, appare inevitabile chiedersi da chi e perché furono realizzati. A nostro parere, la risposta più semplice e anche più evidente al primo quesito, stante la qualità elevatissima dei dieci disegni del manoscritto conservato a Venezia, induce a considerare la possibilità che sia stato Cavino stesso a tracciarli o comunque qualcuno a lui molto vicino. Purtroppo non disponiamo di disegni certamente a- scrivibili all’artista patavino per poter confermare que-sta eventualità, ma ipotesi differenti sembrerebbero suscitare questioni dalla soluzione ben più complessa. Il motivo, va da sé, è ancora più difficile da indivi-duare, ma non si può escludere che questi abbiano fat-to parte di sorta di »schedario« illustrato delle realizza-zioni ispirate all’antico dell’artista veneto. In effetti, le medaglie di questo genere non erano realizzate su ri-chiesta di uno specifico committente, come quelle prodotte con i ritratti di Marco Mantova Benavides, Marcantonio Passeri, francesco querini, Girolamo
Esempi di modelli iconografici nelle raffigurazioni monetali
263
n. 248. – fig. 15: Auktionshaus H. d. Rauch GmbH, Auktion 85, 26. November 2009, n. 386. – fig. 16a: Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 82, 16 September 2009, n. 974. – fig. 16b: Classical Numismatic Group, Electronic Auction 132, 1 february 2006, n. 291. – fig. 21: Classical Numismatic Group, Electronic Auction 227, 10 february 2010, n. 595. – fig. 23: Baldwin’s Auc-tions Ltd, Auction 67, 28 September 2010, n. 2301. – fig. 25: Classical Numismatic Group, Electronic Auction 227, 10 febru-ary 2010, n. 596. – fig. 27: Classical Numismatic Group, Elec-tronic Auction 249, 9 february 2011, n. 501. – fig. 29: Classical Numismatic Group, Electronic Auction 249, 9 february 2011, n. 504. – fig. 32: Classical Numismatic Group, Electronic Auction 221, 28 October 2009, n. 617.
senza la consapevolezza della loro origine da parte dei primi raccoglitori.
questo personaggio, però, è stato in grado di ispi-rare la cultura degli ambienti eruditi veneti e non solo, fornendo un bagaglio iconografico grazie alle proprie creazioni ispirate all’antico, al pari di altri artisti veneti che poco prima di lui hanno percorso la medesima strada, come Vettor Gambello detto Camelio28 e Vale-rio Belli29.
Ora è evidente come tale bagaglio sia stato diffuso anche attraverso veicoli di rapida divulgazione e molto più »volatili« del metallo coniato, probabilmente già dall’artista stesso in seguito a un’accorta autopro-mozione dei propri prodotti presso i collezionisti e gli antiquari dell’epoca. quest’approccio sembra distin-guere Giovanni da Cavino dai suoi predecessori e con-temporanei che pure sono stati in grado di influenza-re, con prodotti simili ai suoi, l’editoria numismatica e il mondo dell’arte già nel Cinquecento:30 l’artista pa-tavino sembrerebbe aver schiuso l’arte della medaglia a un mercato fatto non solo di specifici committenti per specifiche opere, ma anche di una clientela più ampia che ha impiegato le sue opere per ampliare, abbellire e completare le proprie raccolte, ma anche per illustrare opere erudite di carattere storico-numismatico.
Illustrazioni:fig. 1: Strada 1553, p. 12. – fig. 2: Vico 1562, tav. 1. – fig. 3: Erizzo 1559, p. 134. – figg. 4–12, 33: riproduzioni per conces-sione della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, foto rea-lizzate da Marco Callegari. – figg. 13, 17–20, 22, 24, 26, 28, 30–31: riproduzioni per concessione della fondazione querini Stampalia, Venezia, foto realizzate da Michele Asolati. – fig. 14: Numismatik Lanz München, Auktion 147, 2. November 2009,
1546, a cura di Howard Burns, Marco Collareta, davide Gaspa-rotto, Vicenza 2000, pp. 137–159; Attwood 2003 (nota 20), p. 205–224.30 Cfr. a tal proposito ancora Valerio Belli, del quale alcune medaglie »all’antica« sono riprodotte già nei »Promptuarii iconum insigniorum a seculo hominum«, Lugduni, apud Gulielmum Rouillium, 1553 e sono state più tardi fonte d’ispirazione persino per Rubens: cfr. Gasparotto 2000 (nota 29), p. 141.
28 John Graham Pollard: Renaissance Medals, Vol. I: Italy, Washing ton 2007, pp. 187–196, in part. n. 170–171. Cfr. anche Cristina Crisafulli, Leonardo Mezzaroba: La scuola medaglistica veneziana nel Rinascimento attraverso le collezioni del Museo Correr, in: Bollettino dei Musei Civici Veneziani; s. III, 4 (2009), pp. 6–67, in part. p. 10 e schede 40–43; 50–58.29 davide Gasparotto: Una galleria metallica di personaggi illu-stri: le medaglie all’antica, in: Valerio Belli Vicentino 1468 c.–
33 Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova, Cod. 663, c. 31r: domiziano
































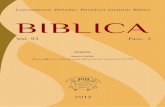




![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)

