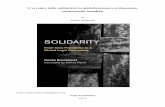La rappresentazione del Minotauro dantesco nei manoscritti trecenteschi della Commedia tra commento...
Transcript of La rappresentazione del Minotauro dantesco nei manoscritti trecenteschi della Commedia tra commento...
44, Nuova Serieluglio-dicembre 2014
anno LV
L’ALIGHIERIRassegna dantesca
Direttori: Saverio Bellomo, Stefano Carrai, Giuseppe Ledda
Angelo Longo EditoreRavenna
DirezioneSaverio Bellomo, Stefano Carrai, Giuseppe Ledda
RedazioneLuca Lombardo, Nicolò Maldina, Anna Pegoretti, Filippo Zanini
Comitato d’onoreRobert Hollander, Mario Marti,John Freccero, Karlheinz Stierle
Comitato scientificoZygmunt G. Barański, Teodolinda Barolini, Lucia Battaglia Ricci,
Simon A. Gilson, Bodo Guthmüller, Emilio Pasquini,Jeffrey T. Schnapp, Luigi Scorrano, John Scott
I collaboratori sono pregati di inviare copia del loro contributo(sia per attachment che per posta) al seguente indirizzo:
Giuseppe Ledda - Università di BolognaDipartimento di Filologia classica e Italianistica
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Italia (e-mail: [email protected])I volumi per eventuali recensioni debbono essere inviati a
Giuseppe Ledda, vedi indirizzo sopra
Abbonamenti e amministrazione: A. Longo Editore - Via Paolo Costa 33 - 48121 RavennaTel. 0544.217026 Fax 0544.217554 www.longo-editore.it
e-mail: [email protected]
Abbonamento 2015 Italia: € 40,00 (due fascicoli annui)Abbonamento 2015 estero: € 60,00 (due fascicoli annui)
I pagamenti vanno effettuati anticipatamente con assegno, vaglia postaleo con versamento sul ccp 14226484
oppure con carta di credito (solo Visa o Mastercard) e intestati a Longo Editore - Ravenna
I contributi pubblicati su «L’Alighieri» sono soggetti al processo di peer review. Ogni contri-buto ricevuto per la pubblicazione viene sottoposto, in forma rigorosamente anonima, alla let-tura e valutazione di due esperti internazionali, esterni alla direzione della rivista.
ISBN 978-88-8063-808-7
© Copyright 2015 A. Longo Editore sncAll rights reserved
Printed in Italy
44, Nuova Serie
luglio-dicembre 2014anno LV
L’ALIGHIERIRassegna dantesca
fondata da Luigi Pietrobonoe diretta da Saverio Bellomo, Stefano Carrai e Giuseppe Ledda
SAGGI
Zygmunt G. Barański 5 Reading the Commedia’s IXs “vertically”: from addresses to the Reader to the crucesignatiand the Ecloga Theoduli
Alessandra Forte 37 La rappresentazione del Minotauro dantesco nei manoscritti trecenteschi della Commediatra commento scritto e commento figurato
Justin Steinberg 59 Dante’s Justice? A reappraisal of the contrapasso
LECTURAE DANTIS
Giuseppe Marrani 75 Purgatorio XXIII
Domenico Cofano 93 Lettura di Paradiso XVIII
NOTE
Paola Allegretti 111 L’ecdotica applicata alla Vita Nova: modelli, concetti e ricerche
Lino Pertile 121 Inf. IV, 36: parte o porta?Nicolò Magnani 129 La terminologia linguistica nel
De la volgare eloquenzia di Giovan Giorgio Trissino: alcuni campioni traduttivi
RECENSIONI
Edoardo Fumagalli 153 Rec. a Luciano Gargan, Dante, la sua bibliotecae lo Studio di Bologna
Antonio Montefusco 157 Rec. a Dante Alighieri, Fiore, Detto d’amore, a c. di Paola Allegretti e Il Fiore e il Detto d’Amore, a c. diLuciano Formisano
Veronica Albi 163 Rec. a Dante Alighieri, Le Quindici Canzoni. Lette da diversi. I, 1-7 e Dante Alighieri, Le Quindici Canzoni. Lette da diversi. II, 8-15 con app. di 16 e 18
Luca Mazzoni 169 Rec. a Mario Apollonio, Dante. Storia della «Commedia», a c. di Carlo Annoni e Corrado Viola
Elisa Maraldi 173 Rec. a Elide Casali, «O gloriose stelle…». L’astrologia cristiana da Barbanera a… Dante
Vera Ribaudo 175 Rec. a Giuseppe Frasso, Massimo Rodella, Pietro Mazzucchelli studioso di Dante
ALESSANDRA FORTE
(Università di Bologna)
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO NEI MANOSCRITTI TRECENTESCHI DELLA COMMEDIATRA COMMENTO SCRITTO E COMMENTO FIGURATO
ABSTRACT
Il presente lavoro si propone di contribuire alla risoluzione di una crux esegetica deltesto dantesco – le sembianze del Minotauro di Inf. XII – attraverso uno spoglio analiticodelle riproposizioni figurate del guardiano nei codici miniati della Commedia. Il ricorsoalla tradizione iconografica dantesca consente di delineare una possibile soluzione defi-nitiva al problema, difficilmente risolto se si limita la ricerca alle sole fonti di ispirazionedel poeta e alla voce dei suoi primi commentatori. In tal modo, si dimostra parimenti chele figure di un commento per imagines – veri e propri appunti esegetici in figura e maimeri ornamenti artistici – si rivelano validi strumenti interpretativi per loci testuali con-troversi.
This paper aims to contribute to the interpretation of a difficult passage in Dante’stext – the aspect of the Minotaur of Inf. XII – through an analytical examination ofguardian’s figurative expressions in the illuminated manuscripts of Dante’s Commedia.The exam of the iconographic tradition helps outline a possible definitive solution to theproblem, that would not be solved if the research exclusively focused on the poet’ssources of inspiration and on the early commentators’ voices. This peculiar casestudy demonstrates how the so-called “pictorial commentaries” – never mere artisticdecorations, but veritable exegetical figurative notes – prove to be precious inter-pretative keys for controversial textual points.
Le fattezze del Minotauro dantesco rappresentano una crux interpretativa ir-risolta, per dirimere la quale si presenta particolarmente efficace il contributodel cosiddetto “commento figurato”1. Si ritiene questo un caso altamente rap-
1 Si fa riferimento principalmente agli studi di L. BATTAGLIA RICCI, della quale si citano soloalcuni titoli esemplificativi: EAD., Testo e immagini in alcuni manoscritti illustrati della «Comme-dia»: le pagine d’apertura, in Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani, a c.di L. Lugnani, M. Santagata, A. Stussi, Lucca, Pacini Fazzi, 1996, pp. 23-49; EAD., Il commento il-lustrato alla «Commedia»: schede di iconografia trecentesca, in *“Per correr miglior acque...”.Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno in-ternazionale di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 601-39;EAD., La tradizione iconografica della «Commedia», in Dante e la fabbrica della «Commedia», ac. di A. Cottignoli, D. Domini, G. Gruppioni, Ravenna, Longo, 2008, pp. 239-54. Cfr. anche L. MI-GLIO, I commenti danteschi: i commenti figurati, in *Intorno al testo. Tipologie del corredo esegeticoe soluzioni editoriali. Atti del Convegno di Urbino, 1-3 ottobre 2001, Roma, Salerno Editrice, 2003,pp. 377-401.
«L’Alighieri», 44 (2014)
ALESSANDRA FORTE38
presentativo di quel ruolo esegetico che la cultura di Dante affida alle immaginie della straordinaria efficacia critica che rivela, in merito a problematiche di que-sto tipo, la scelta dello studioso moderno di interrogare la tradizione iconograficadella Commedia.
Sull’orlo della «rotta lacca» che apre il cerchio dedicato alla violenza, l’anticomostro mitologico si presenta agli occhi dei due viatores. Solo al termine di unaconcitata apparizione, l’«infamïa» viene direttamente nominata e il lettore, risve-gliando i ricordi di un vecchio mito, in quella creatura biforme riconosce facil-mente il Minotauro di Creta. Dante ridisegna questo guardiano pagano, cantatodai più grandi poeti del mondo classico, attraverso il messaggio di una gestualitàrivelatrice, che sin da subito lo integra perfettamente in quell’esercito cristianodi demoni assoggettati al volere divino, impotenti e inutilmente ribelli. Il «savio»Virgilio non indugia, infatti, nel colpirlo, e presto gli ricorda gli ultimi avvenimentidella sua vita terrena, primo su tutti lo scontro fatale con Teseo, «duca d’Atene»,ma non meno doloroso giunge il ricordo di Arianna traditrice. Coerentemente conl’intera operazione di derisione del diabolico messa in atto dal maestro, in questocontesto – come suggerisce Padoan – menzionare Teseo significa menzionare in-nanzitutto la giustizia divina, celata dietro l’immagine di un eroe mitologico nelquale il Medioevo riconosceva tradizionalmente una figura Christi2.
Nei versi introduttivi del canto, la violenza di cui il Minotauro dantesco è rap-presentante si esplica nelle forme di una furia rabbiosa autolesionistica. Così,Dante racconta al suo lettore che quel mostro «quando vide noi, sé stesso morse»e che, in risposta alle provocazioni del maestro si dimena a tal punto che «gir nonsa, ma qua e là saltella», attraverso un gesto totalmente irrazionale che rimandaa un toro di classica memoria3.
Per quanto riguarda la conformazione fisica del nuovo mostro infernale, perla maggior parte degli studiosi resta ancora un interrogativo il modo in cui Danteimmaginasse il suo guardiano.
L’iconografia classica disegna il Minotauro quasi esclusivamente con testa ditoro e corpo di uomo, solitamente raffigurato in coppia con Teseo nel momentoin cui l’eroe armato lo sta uccidendo; i dettagli che possono mutare riguardano lapresenza o l’assenza di sassi tra le mani del mostro, della coda, di un corpo nudo
2 Cfr. G. PADOAN, Teseo “figura Redemptoris” e il cristianesimo di Stazio, in ID., Il pio Enea,l’empio Ulisse, Ravenna, Longo, 1977, pp. 125-50.
3 Il paragone è di derivazione virgiliano-senecana. Si fa riferimento alla celebre similitudine diAen. II, in cui è Laocoonte, stritolato dai serpenti, ad essere associato alla figura di un toro morentesull’altare del sacrificio: «qualis mugitus fugit cum saucius aram taurus / et incertam excussit cervicesecurim» (Aen. II, 223-24); pure virgiliano è il verso «sternitur exanimisque tremens procumbithumi bos» (Aen. V, 481), che vede il toro promesso in palio («donum […] pugnae», Aen. V, 478)in una contesa stramazzare al suolo sotto il colpo del vincitore. Se dell’espressione dantesca si con-sidera, infine, nello specifico, il sintagma «qua e là» (Inf. XII, 24), si individua una puntuale ripresadell’«huc et huc» del senecano «taurus duos perpessus ictus huc et huc dubius ruit» (Oed., 342-43). Cfr. A. TARTARO, Il Minotauro e i Centauri, in *I “monstra” nell’«Inferno» dantesco: tradi-zione e simbologie. Atti del XXXIII Convegno storico internazionale, Spoleto, CISAM, 1997, pp.162-76, a p. 164, e A. MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre dai loro sfrenati e bestiali ap-petiti a usare violenza […] diventon monstri”. Lettura del Canto XII dell'«Inferno», in ID., Tra«Convivio» e «Commedia», Roma, Salerno Editrice, 2004, pp. 73-126, a p. 95.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 39
o di un chitone e di eventuali ulteriori figure a decorazione della scena. Le suesembianze comunque – corpo di uomo e testa di toro – nell’arte della classicitàrestano una costante indiscussa4. Ma com’era, invece, il Minotauro di Dante: unuomo con testa di toro come la classicità insegnava o un essere ribaltato, con cor-poratura taurina e parte superiore umana?
Chiunque si sia accostato a questo canto XII dell’Inferno e ne abbia tentatouna lettura si è imbattuto in questa incertezza interpretativa; quando non si è la-sciato rapire esclusivamente dalla parte centrale del canto, più o meno dettaglia-tamente ha tentato di renderne conto. Pertanto, molto sinteticamente, si puòaffermare che nel corso del tempo la critica si sia divisa tra coloro che hanno sem-plicemente registrato la presenza di un’ambiguità nel testo dantesco e coloro chehanno tentato di sciogliere il dubbio esegetico, ricercando spunti risolutivi all’in-terno della cultura antecedente e contemporanea al poeta.
Le fonti mitologiche ed enciclopediche che Dante poté avere a disposizionehanno potuto fornire poche delucidazioni a riguardo, dal momento che quasi tutterestano ambigue nelle loro allusioni alla conformazione fisica del mostro: parlanodi biforme o misto o duplice, ma non specificano se la parte considerata mostruosa– quella taurina – abiti nel capo o nel corpo dell’uomo-animale. È dato acquisitoche già la ricerca di una verità su queste sembianze nelle fonti classiche di Virgilioe Ovidio si mostra operazione abbastanza complessa, in fin dei conti poco utileperché non risolutiva: tutte le informazioni a disposizione del lettore, infatti, sichiudono in un’affascinante ambiguità di definizioni5. Altrettanto vaga è l’infor-mazione fornita dalla maggior parte delle fonti più tarde6: poche delucidazionifornisce Servio nel suo commento all’Eneide, limitandosi a raccontare lo svolgersidei fatti e rimandando sostanzialmente ad una spiegazione di stampo razionali-stico7; un comportamento analogo si riscontra nei tre Mitografi Vaticani8 e nontroppo distanti appaiono le Etymologiae di Isidoro, nelle quali si informa sullapossibilità che un uomo possieda capo o corpo taurino, ma ancora non si chiariscedi quale dei due casi proposti il mostro di Creta sia la diretta esemplificazionepratica9; più precisi nelle loro indicazioni, invece, le testimonianze dell’Igino delleFabulae, del Liber monstrorum e dell’enciclopedista Giovanni Balbi in cui si
4 Per le varianti iconografiche esistenti, cfr. la voce Minotauros in Lexicon iconographicummythologiae classicae (LIMC), Zurich-München, Aara-Aphlad-Artemis, 1992, vol. VI, pp. 374-81.
5 Cfr. Aen. II, 24-26; Met. VIII, 156 e 169; Ars Am. II, 24.6 Le fonti menzionate, al pari di quelle classiche, sono segnalate da A. TARTARO, Il Minotauro
e i Centauri cit., p. 164 e poi riprese da MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre” cit., p. 99.7 Cfr. SERVIO, ad Aen. VI, 14: «dicendo autem Vergilius ‘ut fama est’ ostendit requirendam esse
veritatem. nam Taurus notarius Minois fuit, quem Pasiphae amavit, cum quo in domo Daedali con-cubuit. et quia geminos peperit, unum de Minoe et alium de Tauro, enixa esse Minotaurum dicitur».Si ha qui la prima introduzione del motivo dell’adulterio di Pasifae non con un toro ma con Tauro,notaio di Minosse, che avrà grande fortuna in tutta la tradizione esegetica successiva, compresaquella dantesca.
8 Cfr. Myth. Vat. I, 43; Myth. Vat. II, 144; Myth. Vat. III, 11, 7. Si fa riferimento a MythographiVaticani I et II, a c. di P. KULCSAR, Turnhout, Brepols, 1987 e Scriptores rerum mythicarum latinitres romae nuper reperti, a c. di G.H. BODE, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968.
9 Cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, Etym., XI.iii, 9. Si cita da ID., Etimologie o Origini, a c. di A. ValastroCanale, Torino, UTET, 2004.
ALESSANDRA FORTE40
menziona un Minotauro classico, con testa di toro su corpo umano10.Per questa specifica conformazione del mostro, gli studiosi hanno individuato
la principale fonte classica di riferimento nella Tebaide di Stazio: un Teseo con-dottiero, ricordato nell’antica vittoria di Creta, stringe l’ispido collo taurino conle mani forzute e indietreggia per evitare il pericolo delle corna11. Simili riferi-menti hanno sempre condotto a immaginare con sicurezza un Minotauro dallatesta di toro, anche se risulterebbe interessante considerare come qualche piccolodettaglio, diversamente discusso, possa aprire la possibilità di pensare questo mo-stro anche in vesti differenti12. Con questo non si vuole naturalmente ribaltarel’immagine che la classicità possedeva dell’opprobrium cretese, forte di tutta unasua ampia, indiscutibile tradizione letterario-iconografica, ma soltanto illustrarequanta ambiguità risiedesse nei testi che Dante aveva a disposizione, se persinoda una fonte classica diveniva possibile per il lettore immaginare un Minotaurodiverso da quello che aveva sempre conosciuto. Menzione esplicita delle cornataurine, comunque, è stata riscontrata anche in un secondo testo classico, le He-roides di Ovidio, che sostanzialmente ricalcano quanto già raccontato altrove dalpoeta, con l’unica differenza – ma secondo Steven Botterill decisiva per l’identi-ficazione della conformazione del mostro – dell’introduzione di questo dettaglio,il quale, come per Stazio, parrebbe affidare al Minotauro un capo taurino13.
Nonostante piccole suggestioni di questo tipo, comunque, solo apparente-mente risolutive, ciò che accomuna tutte o quasi tutte le fonti fin qui considerateè l’incertezza, l’ambiguità dell’informazione. Questa circostanza, pertanto, co-m’era prevedibile, non ha condotto gli studiosi a nessuna risposta certa. Si puòvedere – e si è visto – come, sulla stessa linea, proceda anche tutta l’esegesi tre-centesca della Commedia, la quale ricorre continuamente alla sfera allegorica e,in alcuni casi, rinvia più o meno esplicitamente proprio a Servio14.
10 Balbi, riecheggiando l’informazione del lessicografo Papia, scrive che «Minotaurus monstrumdictum quod ex homine id est Pasiphe et thauro natus fuit. caput taurinum, per caetera homo fuit»;il Liber monstrorum, tra «le mirabili difformità», annovera un «Minotaurum […] Qui taurinum caputhabuit» (Liber monstr. I, 50); Igino informa che «Minotaurum peperit capite bubulo parte inferiorehumana» (Fab. XL, 7-9). Si cita da G. BALBI, Catholicon, Westmead, Gregg International, 1971;Liber monstrorum de diversis generibus, a c. di C. BOLOGNA, Milano, Bompiani, 1977; IGINO, Fa-bulae, a c. di P. K. MARSHALL, Stuttgart-Leipzig, in aedibus B.G. Teubneri 1993.
11 Cfr. STAZIO, Theb. XII, 668-71.12 In Ach. I, 192 si legge che «ruperit Aegides Minoia bracchia tauri»: Teseo, figlio di Egeo,
spezzò le braccia del toro. Come aveva fatto nella Tebaide, anche qui Stazio non pronuncia il nomeproprio del mostro e se prima, per alludere alla bestia cretese, utilizzava il termine taurus, adessosceglie il sostantivo iuvencus. Riferirsi in entrambi i casi alla bestia definendola “toro” potrebbecondurre a immaginare una corporatura animale, magari taurina fino al busto e per il resto umana,sorella della conformazione classica del centauro. L’obiezione, almeno per quanto si legge nellaTebaide, della presenza delle corna potrebbe essere risolta mantenendole, ma ponendole su testaumana; a sostegno di questa conformazione le testimonianze iconografiche nell’arte antica nonsono molte, ma non mancano: il Lexicon iconografico della mitologia classica fornisce almeno treesempi. Cfr. Minotaur in Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC) cit.
13 Cfr. Her. X, 105-07. Cfr. S. BOTTERILL, The form of Dante’s Minotaur, in «Forum Italicum.A quarterly of Italian Studies», XXII/1 (1988), pp. 60-73, a p. 65: «Heroides X supplies all the par-ticulars missing or left implicit in Metamorphoses and Ars Amatoria, but present in Inferno».
14 Cfr. MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre” cit., p. 97.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 41
Quasi tutti i commentatori che scrivono nel tempo immediatamente successivoalla morte del poeta inseriscono, nelle loro analisi, un excursus mitologico e al-ludono agli espedienti realizzati da Dedalo perché Pasifae potesse soddisfare ilsuo bestiale desiderio. Così, Iacopo Alighieri tocca in rapida rassegna tutti i puntipiù significativi del mito15 e Iacomo della Lana si dilunga persino sul graduale,quotidiano generarsi della passione perversa in Pasifae. Premette, però, che Dante«qui introduce una favola poetica»16, precisazione che penserà di recuperare ilButi quando, qualche decennio dopo, vorrà mantenere cauto il suo lettore17. De-cisamente analitico Pietro Alighieri, che ripercorre i sentieri più segreti del mitoe recupera le citazioni dei poeti classici cari a Dante; come lui, Guido da Pisa.Più rapidi nell’esposizione si presentano, invece, l’Ottimo e Andrea Lancia18, leChiose cassinesi e Boccaccio; poche righe ci lascia l’Anonimo fiorentino. Ben-venuto da Imola, infine, contrariamente ai più, tiene a difendere la veridicità delracconto19.
Per quanto riguarda il ricorso all’allegoria, i commentatori si dividono sostan-zialmente tra la vecchia idea risalente al commento serviano (l’adulterio di Pasifaenon con un toro vero e proprio ma con Tauro, notaio di Minosse) e l’allusionealla spiccata ingiustizia del figlio del re di Creta che appare bestia perché, neisuoi comportamenti tirannici, si fa inumano. Pietro Alighieri, il più puntuale, rac-coglie entrambi i filoni esegetici20; allo svelamento razionalistico serviano si ri-fanno solo le Chiose cassinesi21 e Guido da Pisa22; molto più praticata, invece,dai commentatori danteschi la seconda strada esegetica. Questa, infatti, abbrac-ciando un numero maggiore di commentatori, copre l’intervallo dell’intero secolo:da Iacopo Alighieri23 fino all’Anonimo Fiorentino24. Così Iacomo della Lana25,
15 Cfr. IACOPO ALIGHIERI, ad Inf. XII, 12-15. I commenti alla Commedia si citano dal sito Dar-mouth Dante Project, salvo quando diversamente indicato in nota.
16 IACOMO DELLA LANA, ad Inf. XII, 12. Si cita da ID., Commento alla «Commedia», a c. di M.VOLPI, Roma, Salerno Editrice, 2009.
17 Cfr. FRANCESCO DA BUTI, ad Inf. XII, 1-15.18 Si fa riferimento a ANDREA LANCIA, Chiose alla «Commedia», a c. di L. AZZETTA, Roma,
Salerno Editrice, 2012.19 Cfr. BENVENUTO DA IMOLA, ad Inf. XII, 11-13. Cfr. anche ANDREA LANCIA, ad Inf. XII, 1-21,
che parla di «questa favola, o vero che fosse» e informa che ne «scrive Ovidio nell’ottavo libro delMetamorfoseos».
20 PIETRO ALIGHIERI, ad Inf. XII, 4-15. Pietro Alighieri aggiunge anche un ritorno all’interpreta-zione fulgenziana della storia, con il suo punto di partenza sempre nell’adulterio di Pasifae con ilnotaio Tauro, ma questa volta generante un essere detto di duplice natura perché nobile di partematerna e ignobile di parte paterna (ad Inf. XII, 4-15).
21 Cfr. Chiose cassinesi, ad Inf. XII, 12, il cui testo è vicinissimo a quello di Pietro Alighieri. Si-mile anche un accenno di Francesco da Buti a commento di Inf. V, 4-15; il Buti, però, nell’analisisuccessiva di Inf. XII, preferirà seguire e argomentare la spiegazione allegorica di marca boccac-ciana.
22 GUIDO DA PISA, ad Inf. XII, 19-20. Si rimanda a ID., Expositiones et glose. Declaratio super«Comediam» Dantis, a c. di M. RINALDI, Roma, Salerno Editrice, 2013.
23 Cfr. IACOPO ALIGHIERI, ad Inf. XII, 12-15.24 Cfr. ANONIMO FIORENTINO, ad Inf. XII, Nota.25 Cfr. IACOMO DELLA LANA, ad Inf. XII, 12.
ALESSANDRA FORTE42
ancora Guido da Pisa26, l’Ottimo27, poi Benvenuto28, Boccaccio29 e Francesco daButi30 si mostrano tutti coerenti nel ritrarre un Minotauro sia carnefice sia crudele,ma non realmente biforme: se i poeti scelsero il toro per identificarne mezza cor-poratura, questo è dovuto esclusivamente alla ferocia e alla violenza degli atti diun uomo tanto inumano. Unica voce che predilige a tal punto l’allegoria da nonaccennare neanche minimamente alle vicende del mito è Guglielmo Maramauro,il quale quasi divertito afferma: «che non creda alcuno che esso fosse mezo omoe mezo bestia, salvo per lo modo dicto de sopra!», avendo assicurato infatti alsuo lettore che il mostro «se pò bene dire parte omo e parte bestia» soltanto perché«ha effìgie umana e acti bestiali»31.
Anche dall’esegesi trecentesca si ricavano scarse informazioni per quanto con-cerne la discussa iconografia del mostro: salvo due o tre casi, infatti, i commen-tatori si limitano tutti a riconoscere semplicemente che si trattasse di una naturaduplice. Così, a partire da Iacomo della Lana fino all’ultimo commentatore delTrecento, si recuperano solo informazioni generiche32. Soltanto Iacopo Alighieri,l’Anonimo Fiorentino e Francesco da Buti si pronunciano sulla questione, ma ne-anche i loro commenti conducono ad una verità univoca, dal momento che le po-sizioni si presentano contrastanti: i primi due raccontano che da quell’unioneillecita «finalmente una criatura nacque, dal petto in su uomo e l’altro busto d’untoro»33, che il mostro si presentava come «uno il quale era bue dalla cintola ingiù et da indi in su uomo ferocissimo»34; Francesco da Buti, invece, spiega chela stessa creatura «dalla parte di sopra era toro, e da quella di sotto era uomo»35.
Per tentare conclusioni più certe, allora, resta da esplorare un ultimo campod’indagine: quello delle testimonianze illustrate della Commedia che, decorandoi manoscritti trecenteschi, vanno ad affiancarsi all’esegesi verbale e tramandanoun Minotauro, in questo caso, per forza di cose, visibile all’occhio del lettore36.
26 Cfr. GUIDO DA PISA, ad Inf. XII, 11-12.27 Cfr. L’OTTIMO COMMENTO, ad Inf. XII, 11-15, il cui testo segue puntualmente il commento di
Iacomo della Lana.28 Cfr. BENVENUTO DA IMOLA, ad Inf. XII, 11-13.29 Per Boccaccio, il mostro è un «dimonio, discritto in forma di un Minutauro», attraverso il
quale il poeta spiegherebbe al suo lettore «in che consista la bestialità». Cfr. GIOVANNI BOCCACCIO,ad Inf. XII, 11-27.
30 Cfr. FRANCESCO DA BUTI, ad Inf. XII, 1-15.31 GUGLIELMO MARAMAURO, ad Inf. XII, 22-27.32 «Uno animale, lo quale era mezzo uomo e mezzo bue» (Iacomo della Lana), «medius homo
et medius taurus» (Guido da Pisa), «il Minotauro, mezzo bue, e mezzo uomo» e «il Minotauro chefue mezzo huomo et mezo bue» (Ottimo), «questo monstro chiamato Minotauro, mezzo huomo emezzo bue» (Andrea Lancia), «genuit quemdam semihominem et semitaurum», «taurus in parteerat et in parte homo» e «hunc Minotaurum, in parte hominem et in parte taurum» (Pietro Alighieri),«iste mynotaurus in parte homo et in parte thaurus» (Chiose cassinesi), «una creatura la quale eramezza uomo e mezza toro» (Boccaccio), «Minotaurum, qui erat semivir et semitaurus» (Benvenutoda Imola).
33 IACOPO ALIGHIERI, ad Inf. XII, 12-15.34 ANONIMO FIORENTINO, ad Inf. XII, 12.35 FRANCESCO DA BUTI, ad Inf. XII, 1-15.36 Per un’idea complessiva della tradizione illustrata che sarà qui considerata, si rimanda alle
schede specifiche del catalogo Illuminated Manuscripts of the «Divine Comedy», a c. di P. BRIEGER,
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 43
Il XII canto dell’Inferno, nei manoscritti trecenteschi illustrati, è solitamentepresentato attraverso la focalizzazione di tre momenti principali: il primo incon-tro con il Minotauro, il successivo incontro dei due pellegrini con i centauri e inultimo la presentazione dei dannati. Normalmente, questi avvenimenti vengonoscissi dai miniatori in due o tre vignette separate e distribuite, in base al tipo diimpaginazione, tra i versi del canto o sui margini superiore e inferiore della carta.
Il ms. Strozz. 152 della Biblioteca Laurenziana di Firenze e il codice di Ox-ford Canonici It. 108 conservato alla Bodleian Library scelgono una rappresen-tazione su un’unica striscia continua, illustrando in maniera consecutiva losnodarsi dei tre principali incontri del canto. Nella prima raffigurazione, realiz-zata sul margine inferiore di c. 10v, il Minotauro non è una bestia particolarmenteimponente e spaventosa; nel secondo manoscritto, il mostro (e di conseguenza icentauri) cambia totalmente le sue sembianze e si trasforma in un diavolo, comecomunemente se ne immagina l’aspetto, cioè con corpo umano, corna, coda eali di pipistrello; quest’ultima illustrazione rappresenta un unicum tra le modalitàtrecentesche di raffigurazione del guardiano infernale. Esclusi questi due esem-plari, comunque, il resto dei miniatori preferisce distribuire i vari momenti delcanto in un numero maggiore di vignette, permettendo che l’attenzione del frui-tore si focalizzi gradualmente su un episodio alla volta.
Per quanto riguarda la questione insidiosa della conformazione fisica del Mi-notauro, la tradizione figurata è accomunata dalla tendenza a rappresentare ilmostro come toro dalla testa di uomo, presentando, dunque, una versione ribal-tata dell’iconografia classica. Fa eccezione soltanto il manoscritto di Budapest,che riproduce il Minotauro conforme al mito classico: la corporatura del guar-diano si mostra mastodontica, scura e ricoperta di un manto di peluria, ma so-stanzialmente umana; la testa è inequivocabilmente taurina. Il manoscritto riportaesclusivamente il testo della Commedia corredato di illustrazioni, per cui, datal’assenza di un commento o di semplici glosse sparse, non è possibile tentare dispiegare l’immagine attraverso un confronto con l’esegesi scritta. Restano visi-bili, in alcuni punti, poche righe scritte a contorno della vignetta, che svolgonola funzione di istruzioni grafiche per il miniatore, ma purtroppo il testo di questiappunti resta parziale per buona parte del codice e, anche in questo caso speci-fico, quanto si riesce a recuperare non fornisce informazioni utili per l’interpre-tazione iconografica37. Ulteriori singolarità del codice – si pensi all’introduzione
M. MEISS, C.S. SINGLETON, Princeton, Princeton University Press, 1969 e, più in generale, ai con-tributi di L. MIGLIO, Dante Alighieri. Manoscritti miniati, in Enciclopedia dell’Arte Medievale,Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1991-2001, vol. V, pp. 627-35; A.M. CHIAVACCI LEONARDI,Il libro di Dante dalle prime copie manoscritte all’edizione della Crusca e M.G. CIARDI DUPRÉ
DAL POGGETTO, “Narrar Dante” attraverso le immagini: le prime illustrazioni della «Commedia»,entrambi in Pagine di Dante. Le edizioni della «Divina Commedia» dal torchio al computer, a c.di R. Rusconi, Milano-Perugia, Electa-Editori Umbri Associati, 1989, pp. 51-62 e pp. 81-102; perla tradizione napoletana, cfr. in particolare M. ROTILI, I codici danteschi miniati a Napoli, Napoli,Libreria Scientifica Editrice, 1972.
37 Le parole ricostruite sono soltanto due e restano di difficile comprensione: «a[---]/ li apeano[---]». Per la trascrizione integrale delle istruzioni presenti sul codice, cfr. P. PELLEGRINI, Le istru-zioni per il miniatore. Annotazioni linguistiche, in «Commedia». Biblioteca universitaria di Buda-
ALESSANDRA FORTE44
di figure demoniache accanto ai guardiani mitologici espressamente menzionatida Dante, oppure alla colorazione rossa dei dannati38 – inducono sostanzialmentea concludere che questo manoscritto miniato si distingua all’interno della tradi-zione illustrata trecentesca per una sua specifica originalità, che lo rende ecce-zionale non solo nella raffigurazione del suo Minotauro ma nell’intera suaespressione artistica39.
Per il resto, la tradizione figurativa trecentesca si mantiene stabile nella sceltadi un’iconografia ribaltata, attraverso la proposta di un modello di mostro biformeche si presenta umano nella parte superiore e taurino nel corpo. Nonostante questalinea coerente di base, le scelte dei miniatori si presentano comunque abbastanzaoriginali, concentrandosi ognuna su un peculiare aspetto. Le due tendenze prin-cipali riscontrate si scindono nella riduzione della componente umana al solovolto del mostro da un lato – è il caso dell’Egerton 943 e del codice altonense(Altona (Hamburg), Schulbibliotek des Christianeums, n. 2 Aa.5./7) – e nella di-stribuzione delle due nature in modo più bilanciato, facendo sì che il guardianodivenga sostanzialmente somigliante ai compagni centauri, dall’altro.
Il ms. Egerton 943 della British Library, codice di lusso risalente alla secondametà del XIV secolo, corredato di un apparato illustrativo che si estende all’interopoema, inserisce le miniature riquadrate tra i versi stessi, obbligando quasi il let-
pest, Codex Italicus 1. Studi e ricerche, Compagnola di Zevio, Grafiche SiZ, 2006, pp. 85-90. Iltesto di questi appunti, per buona parte del codice, si presenta in parte perduto o cancellato nella ri-pulitura finale del foglio o coperto da una parte di illustrazione; del resto, queste annotazioni mar-ginali avevano una funzione meramente pratica ed erano destinate ad essere cancellate, una voltacompletato il lavoro di decorazione. Cfr. J.J.G. ALEXANDER, I miniatori medievali e il loro metododi lavoro, Modena, Panini, 2003, pp. 83-110, ma anche M. MEISS, The smiling pages, in Illuminatedmanuscripts, cit., pp. 52-70, a p. 45.
38 Le carte 11r e 11v presentano dei grossi demoni simili per struttura e colore al Minotaurodella prima vignetta, ma dotati di corna e volto umano. Se un primo sguardo potrebbe far supporreche si tratti di centauri in forma di diavoli (in un’operazione non molto diversa da quella che si erariscontrata nel Can. it. 108), presto si conclude che si tratta di figure demoniache a tutti gli effetti,poiché i centauri compaiono in una vignetta apposita e nelle vesti umane di semplici arcieri. Moltoprobabilmente il miniatore avrà prima seguito il testo dantesco e poi arricchito l’Inferno dei suoiabitanti usuali, come lui li ha immaginati, secondo un canone iconografico cristiano che concepiscel’esercito del Male esclusivamente nella forma del diabolico. La seconda singolarità del codice –il colore rosso vivo delle anime dei dannati – può essere spiegata attraverso il simbolismo cromaticomedievale, che vede nel rosso un colore associato al tradimento e alla menzogna, più in generalealla sfera del Male. Se la spiegazione dell’operazione artistica risiede in questa simbologia, si chia-risce facilmente anche la scelta di estendere la colorazione agli stessi guardiani. Per la simbologiamedievale del colore rosso, cfr. M. PASTOUREAU, L’uomo rosso. Iconografia medievale di Giuda,in ID., Medioevo simbolico, Roma, Laterza, 2007, pp. 178-90.
39 Gli studi sul codice non sono giunti a conclusioni univoche: c’è chi vi ha intravisto un mi-niatore completamente privo di ogni familiarità con il testo, che è portato a procedere di propriafantasia perché non comprende (cfr. L. VOLKMANN, Iconografia dantesca, Firenze, Olschki, 1898),e chi invece gli attribuisce una grande sensibilità creativa che può solo valorizzarne il lavoro (cfr.I. BERKOVITS, Il codice dantesco di Budapest, in Italia ed Ungheria: Dieci secoli di rapporti lette-rari, a c. di M. Horányi e T. Klaniczay, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, pp. 45-57). Per l’interaquestione, storia, fortuna e stile del codice, cfr. G. FOSSALUZZA, Provenienza del codice, fortunacritica, stile e carattere illustrativo delle miniature, in «Commedia». Biblioteca universitaria diBudapest cit., pp. 51-83.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 45
tore ad interrompere la sua lettura per visionare il mostro del quale si sta parlando;l’illustrazione di questo codice che, come anticipato, presenta il Minotauro conuna testa di uomo barbuta e dotata di folti capelli attaccata direttamente a un corpotaurino, sembra porsi proprio come trasposizione figurata del testo contiguo: «’nsu la punta della rotta lacca / l’infamïa di Creti era distesa» (Inf. XII, 11-12). Dav-vero molto simile la conformazione del Minotauro del codice di Altona, in cui latesta umana, anche qui attaccata al corpo taurino, rivolta all’indietro nel gesto dimordersi, è un’altra trasposizione in immagine di un verso del canto: «e quandovide noi, sé stesso morse» (v. 14). Il commento scritto, purtroppo, non garantisceun supporto interpretativo valido per le illustrazioni di questi due codici, dal mo-mento che, se l’altonense ne è completamente sprovvisto, quello londinese nonfornisce informazioni univoche a riguardo e parrebbe schierarsi al fianco di tuttaquella tradizione esegetica che lascia la questione in sospeso40. Grazie all’illu-strazione, però, incerta non è più la conformazione del mostro, ma resta, al mas-simo, il rapporto che il miniatore può aver instaurato con il testo e con il suocommento. Risulta fondamentale il fatto che, nell’incertezza fornita sia dal testopoetico che dalle glosse dell’Anonimo, si sia scelto di disegnare un Minotaurocon corpo taurino, scelta da non considerarsi casuale, se la parte animale è tal-mente prevalente in questa figura da limitare al solo volto tutto il carattere umano.
Effettivamente mezzo uomo e mezzo toro è il Minotauro degli altri manoscrittiminiati del Trecento: un singolare quadrupede nello Strozz. 15241, un elegantemostro alla moda nel ms. di Chantilly, un bipede più slanciato nel codice napo-letano dei Girolamini. Il ms. 597 del Musée Condée, al pari dello Strozz. 152, ta-glia il corpo del Minotauro in due parti maggiormente equivalenti ma, con minorverosimiglianza, lascia il mostro in una sorta di equilibrio innaturale: a questastrana figura di guardiano l’appoggio al suolo, infatti, non viene garantito da quat-tro zampe animali, come si vede in ogni figura di centauro, ma soltanto da duezampe posteriori; se questa condizione incerta non salta immediatamente all’oc-chio dell’osservatore è grazie al fatto che la veste di moda trecentesca che il Mi-
40 Il codice è corredato di un fitto apparato di glosse, tramandate comunemente sotto il nomedi Anonimo Latino ma, da non troppo recenti studi, scisso in due autonome personalità identificatecon i nomi di Anonimo Lombardo e Anonimo Teologo. Cfr. in proposito M. SPADOTTO, AnonimoLatino (Anonimo Lombardo e Anonimo Teologo), in Censimento dei commenti danteschi. I com-menti di tradizione manoscritta (fino al 1480), a c. di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, SalernoEditrice, 2011, pp. 43-60. Per una trattazione dettagliata dell’apparato esegetico del ms. Egerton943, cfr. A. PEGORETTI, Indagine su un codice dantesco. La «Commedia» Egerton 943 della BritishLibrary, Pisa, Felici, 2014. A proposito del Minotauro di Inf. XII, il commento racconta: «qui taurus,credens vacham esse, concubuit cum ea; ex qua natus est semihomo et semibos qui fuit vocatusMinotaurus» (ANONIMO LATINO, ad Inf. XII, Short Form) e «quo facto thaurus dictus cum reginaconcubuit, unde pregnans peperit Minothaurum, medium hominem et medium bovem» (ANONIMO
LATINO, ad Inf. XII, 12; Expanded Form). Si cita da Anonymous Latin Commentary on Dante’s«Commedia», a c. di V. CIOFFARI, Spoleto, CISAM, 1989. Le due versioni del commento si spieganotenendo presente la scelta di lavoro dello studioso: cfr. ID., Introduction, ivi, pp. 1-5.
41 L’immagine dello Strozz. 152 è quella di una bestia minuta, palesemente più piccola dei duepoeti che la osservano, e dall’aspetto di un quadrupede in movimento molto vicino alla tipologiadi raffigurazione animale dell’Egerton 943, con la sola differenza della cesura a metà corpo – an-ziché all’altezza del collo – che separa l’animale dall’uomo.
ALESSANDRA FORTE46
notauro indossa si allunga in drappeggi sul davanti e realizza un efficace giocodi simmetrie42. Il codice si mostra particolarmente prestigioso per i suoi materiali,per la composizione della pagina e la qualità dei vari componenti, ma soprattuttoper la presenza, tra le sue carte, di un imponente apparato esegetico, le Exposi-tiones et glose super Comediam di Guido da Pisa; il tutto risulta poi notevolmentearricchito da un dettagliatissimo corredo illustrativo. Nel caso specifico di Inf.XII, il commentatore – che, interagendo con l’apparato iconografico, lungo tuttoil percorso si fa portatore di un messaggio didattico-morale43 – non si soffermatroppo sulla conformazione del mostro: concentrandosi prevalentemente sul suosignificato allegorico, lo definisce in breve «vir inhumanus»44. Anche qui è si-gnificativo, però, che nell’incertezza si finisca per scegliere questo tipo di solu-zione iconografica.
Meno innaturale appare il Minotauro del codice Filippino (CF 2.16 della Bi-blioteca dei Girolamini di Napoli)45, che fa la sua comparsa nuovamente concorpo di toro e solo due zampe come nel caso dello Strozz. 152 e del codice diChantilly, ma mostrando una figura costruita maggiormente in altezza, più slan-ciata e, almeno dal punto di vista della postura e dell’equilibrio, più verosimile.Le chiose del codice rimandano al mito di Creta, spiegando in corrispondenzadel sintagma «partiti bestia» che «nota est fabula Minois, regis cretensis», la cuimoglie dai desideri lussuriosi «concubuit cum tauro»46. Ciò che conta maggior-mente per il commentatore di questo manoscritto, però, è che il lettore memorizziil valore allegorico del mito, l’insegnamento celato dietro questo simbolo delMale47. Così, in un manoscritto tanto sapientemente studiato, in cui l’immagine
42 Cfr. C. BALBARINI, L’«Inferno» di Chantilly. Cultura artistica e letteraria a Pisa nella primametà del Trecento, Roma, Salerno Editrice, 2011, p. 104. La studiosa parla di «qualche incoerenzanell’articolazione delle membra e delle relative pose».
43 Ivi, p. 46: «lo stretto legame tra immagini ed esegesi guidiana è del resto dimostrato dal fattoche esse si trovano en bas de page del lungo commentario che segue il testo dell’Inferno (trascrittonelle prime trenta carte): le immagini svolgono pertanto il ruolo di richiamare le sequenze ritenutepiù significative […] e di fissarne nella memoria l’interpretazione guidiana, quasi come sostitutovisuale della narrazione dantesca».
44 GUIDO DA PISA, ad Inf. XII, 11-12.45 In questo manoscritto, che organizza il testo su un’unica colonna ma si arricchisce ai margini
e nell’interlinea di un fittissimo apparato di glosse, le illustrazioni figurano delimitate da una corniceminiata in rosso e vengono inserite a inizio canto nella parte superiore del foglio, oppure nel margineinferiore, o anche, come si è visto per l’Egerton 943, tra due versi del canto, mostrando una gran-dissima originalità nella gestione degli spazi finalizzati alla decorazione; questa, tutt’altro che or-namentale, riveste un ruolo esegetico ben preciso. Per la storia e la descrizione del codice, cfr. G.SAVINO, Stratigrafia del Dante Filippino, in Chiose Filippine. Ms. CF 2 16 della Biblioteca orato-riana dei Girolamini di Napoli, a c. di A. MAZZUCCHI, Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 73-83;per l’esame stilistico e i problemi di attribuzione delle miniature, cfr. A. PERRICCIOLI SAGGESE, Leminiature del Filippino, ivi, pp. 85-95.
46 Ivi, ad Inf. XII, 19.47 Ibid.: «non venit doctus amore femine, sed solummodo amore virtutis ad cognoscendum, in-
tellectiva cognicione, penas ut caveat se a sceleribus, propter que posset incurrere huiusmodi penaset ut sciat docere alios et cavere, et cetera». Sulle chiose cfr. A. MAZZUCCHI, Introduzione, ivi, pp.17-46. Cfr. anche ID., Chiose Filippine, in Censimento dei commenti danteschi cit., pp. 160-66 eC. CALENDA, L’edizione dei testi: i commenti figurati, in *Intorno al testo cit., pp. 426-29.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 47
fissa il simbolo, la nota contigua ne chiarisce il significato e la glossa verbale lopotenzia con riferimenti didattico-morali, lo stesso Minotauro entra a far parte diun simbolismo tale per cui la sua stessa modalità di rappresentazione figurata di-viene un elemento parlante.
Fortemente somigliante a un centauro è, invece, il mostro del ms. 8530 dellaBiblioteca parigina dell’Arsenal e quello che emerge dalla miniatura a c. 9r delcodice già 514 di Holkham Hall, ora Holkham misc. 48 della Bodleian Librarydi Oxford. Ritraggono il guardiano nella stessa conformazione fisica il Palatino313 (o Dante Poggiali) e il più tardo Vaticano Latino 4776, risalente all’ultimodecennio del Trecento.
I primi due manoscritti, per le cui illustrazioni, purtroppo, non ci si può avva-lere del confronto con l’esegesi verbale48, si presentano singolari per la presenzadi alcuni dettagli che legano l’immagine direttamente al testo dantesco, grazie adaspetti di dinamicità che nelle altre riproduzioni figurate sono assenti. Il Mino-tauro dell’Arsenal rimanda all’immagine del centauro non solo nell’aspetto, maanche nella precisa caratterizzazione di guardiano, nel momento in cui, munitodi arco e faretra, è ritratto sul punto di saettare. Le corna che presenta sul capo,poi, sorprendentemente, potrebbero far ripensare alla tortuosa questione interpre-tativa legata a quelle fonti classiche che accennavano alle corna – Tebaide e He-roides – e che avallavano la creazione di un Minotauro con testa di toro: ilmanoscritto parigino sembrerebbe dimostrare che, al tempo di Dante, un’icono-grafia in cui corna di animale compaiono su una testa umana è invece possibile.È vero che, configurandosi come attributo tipico del mondo diabolico, queste po-trebbero essere semplicemente il frutto di un’operazione di cristianizzazione delmito, che allinea il mostro ad un diavolo infernale, ma potrebbero anche fungereda indizio importante di una diversa iconografia del guardiano, che nel tempo sisarebbe distaccata dall’immagine classica e, in tutta coerenza, sarebbe poi con-fluita anche nelle miniature dei codici danteschi.
Qualche risposta più certa a questo interrogativo, allora, può essere ricercatanella tradizione iconografica del Minotauro al di fuori della Commedia, in uncontesto privo di eventuali influenze esegetiche e, per questo, maggiormente pro-bante. Parlare di Minotauro, come si è visto, per l’intera tradizione letteraria eiconografica significa sempre parlare anche di Teseo e di labirinto, sostanzial-mente alludere agli episodi di Creta. In base alla cultura con la quale si relazio-nano, poi, l’eroe ateniese e la domus Daedali costruiscono ogni volta una propriaspecifica simbologia, toccando, senza sorpresa alcuna, l’apice di allegorizzazioneproprio nel Medioevo49. Infatti, se per l’arte romana, per esempio, al centro di
48 Il ms. Holkham Hall è privo di commento; quello parigino, il ms. 8530 dell’Arsenal, presentaalcune glosse sparse, identificate con traduzioni latine del commento di Iacomo della Lana e ridu-zioni o frammenti dell’Anonimo Lombardo, ma assenti nel caso specifico di Inferno XII. Cfr. lascheda del ms. 8530, in Censimento dei commenti danteschi cit., p. 937.
49 Uno spunto a procedere in questa direzione è fornito da Giuseppe Izzi (G. IZZI, «variarummonstra ferarum»: dal Minotauro ai Centauri, in Dante e il mondo animale, a c. di G. Crimi e L.Marcozzi, Roma, Carocci Editore, 2013, pp. 79-91, a p. 82) che, recuperando il mito cretese di Pa-sifae e Dedalo, allude rapidamente alla simbologia cristiana del labirinto e accenna, in nota, a dueoccasioni iconografiche in cui un mostro figura al centro di un labirinto quale simbolo del Male.
ALESSANDRA FORTE48
numerosi mosaici è sempre presente una Minotauromachia e il mostro di Cretaconserva le sue sembianze classiche, coerentemente con tutte le espressioni arti-stiche di stampo ellenico50, nell’arte medievale si ha una radicale inversione ditendenza e il labirinto subisce un processo graduale di cristianizzazione. Se neimosaici pavimentali delle chiese dell’Italia settentrionale e centrale è ancora rav-visabile qualche influsso di arte classica, nel tipo di labirinto percorribile che co-mincia a decorare le grandi cattedrali francesi51 il Minotauro e il suo uccisorescompaiono e vengono enfatizzate simbologie nuove, legate al trionfo del Benesul Male, secondo una lettura in chiave penitenziale: il labirinto diventa una sortadi Via Crucis, che estende i corridoi del modello cretese da 7 a 1152, pone il suoingresso a occidente, dispone le spire in modo tale che per l’osservatore siano su-bito visibili i quattro bracci di una croce ad esso sovrapposta, in senso tecnico,certo, ma principalmente figurale.
Decisamente interessanti si mostrano in questo senso le illustrazioni di ma-noscritti realizzati tra il X e il XIII secolo che accolgono il labirinto cristianizzatoa 11 spire e non escludono il mostro dal centro. Questi codici vanno dai computidedicati al calcolo della Pasqua (quindi opere espressamente incentrate sul con-cetto di Redenzione legato all’uscita dal Labirinto-Ade) ad enciclopedie, cronacheo cosmografie che, proprio perché neutre dal punto di vista filosofico e religioso,si fanno esclusivamente portatrici del modo di intendere e rappresentare quel mitonel Medioevo. In molti di questi codici è presente un Minotauro ribaltato nellesue forme, e quando non presentato in vesti centauresche, in linea di massimatrasformato in diavolo cristiano53. Si presenta come un centauro armato di spada
Nello specifico, lo studioso segnala il mosaico pavimentale di San Savino a Piacenza (l’opera èormai interamente perduta ma, a giudicare dall’iscrizione che la accompagna, il Minotauro moltoprobabilmente doveva indossare le vesti di un diavolo) e un manoscritto del IX secolo contenenteil commento di Servio all’Eneide (un disegno molto rovinato sembra riprodurre un Minotauromezzo toro e mezzo uomo o diavolo). Per descrizioni più approfondite dei due labirinti citati daIzzi, si rimanda a H. KERN, Labirinti. Forme e interpretazioni: 5000 anni di presenza di un arche-tipo, Milano, Feltrinelli, 1981, rispettivamente a p. 211 e p. 160.
50 Cfr. in proposito KERN, Labirinti cit., pp. 37-60 e pp. 97-124. Cfr. anche la voce Labirinto,in G. HEINZ-MOHR, Lessico di iconografia cristiana, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1984,pp. 192-93.
51 Cfr. la descrizione generale che ne dà P. SANTARCANGELI, Il libro dei labirinti, Milano, Sper-ling & Kupfer, 2000, pp. 194-212 e le singole schede dettagliate di KERN, Labirinti cit., pp. 196-218.
52 Il numero dei corridoi – 11 – non è casuale ma va ricondotto ancora alla simbologia numericamedievale, la quale vi leggeva «il peccato, per la trasgressione e per l’eccesso – in quanto va oltreil numero dei dieci comandamenti –, e per l’incompiutezza, in quanto non raggiunge il numero deidodici apostoli» (KERN, Labirinti cit., a p. 186). Cfr. anche H. DE LUBAC, Esegesi medievale: i quat-tro sensi della scrittura, Roma, Edizioni Paoline, 1972, p. 1017: «indice […] del male morale, delpeccato, della perversione; poiché oltrepassa di un’unità questo numero della perfezione che èquello della legge di Dio».
53 Un esempio è il ms. lat. 13013 della Biblioteca Nazionale di Parigi, in cui, a c. 1r, figura unlabirinto a 11 corridoi con al centro un Minotauro in forma di diavolo, seduto in trono. Esemplifi-cativo è anche il cod. 89 della Stiftsbibliothek (monastero benedettino di Admont), in cui Teseo ar-mato lotta contro un Minotauro sempre in vesti demoniache (miniatura a c. 1v). Si tratta di dueeccezioni che potrebbero essere spiegate risalendo al contenuto dei codici: il primo è un manoscrittomiscellaneo di contenuto computistico, il secondo tramanda la Historia ecclesiastica tripartita di
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 49
e con corna sul capo il mostro dell’autografo del Liber Floridus di Lamberto diSaint-Omer, identico per conformazione e attributi anche in due copie più tardedel codice (fig. 1)54; simile è l’illustrazione del computo di Tegrimi, risalente aiprimi decenni dell’XI secolo, in cui il Minotauro presenta parte superiore umana,corpo animalesco e spada, scudo ed elmetto55; sempre ad un centauro è ricondu-cibile il protagonista del primo foglio del ms. lat. 12999 conservato alla BibliotecaNazionale di Parigi (fig. 2), in cui il mostro che divora una testa di giovane tra lepareti di un labirinto forse troppo stretto sembra ricordare l’illustrazione del mo-saico pavimentale purtroppo perduto di San Michele Maggiore a Pavia56; ancoracentauresco è il mostro raffigurato tra le carte della Chronologia Magna di Pao-lino Veneto, sia in una prima copia ampliata dell’autografo che in una versioneridotta più tarda57. Su questa linea proseguono anche manoscritti cronologica-mente posteriori (ma in generale diverse rappresentazioni artistiche), fra i qualiil più significativo è il ms. Barb. Lat. 4112 della Biblioteca Vaticana, datato 1419e contenente proprio la Commedia di Dante (fig. 3). Sull’ultimo foglio del codice(c. 209r), che non possiede corredo illustrativo se non per le iniziali di cantica, èpresente un’immagine di labirinto con al centro un Minotauro-centauro58. Un’il-lustrazione di questo tipo rappresenta un vero e proprio punto di contatto tra l’ico-
Cassiodoro. Sembrerebbe, dunque, abbastanza coerente con la materia trattata la presentazione diun simbolo del Male in vesti cristianizzate. Per una descrizione più dettagliata dei due codici citati,cfr. KERN, Labirinti cit., pp. 136 e 146.
54 I codici a cui si fa riferimento sono il ms. 92 della Biblioteca Universitaria di Gand, del 1121,contenente l’autografo del Liber Floridus di Lamberto di Saint-Omer (miniatura a c. 20r); il Cod.Guelf. 1 Gudianus latinus 2° della Herzog-August-Bibliothek di Wolfenbüttel, risalente al XII-XIIIsecolo (miniatura a c. 19v); il ms. 724/1596 del Musée Condée di Chantilly, risalente al XV secolo(miniatura a c. 21 v).
55 L’illustrazione è a c. 12r del ms. M 925 conservato alla Pierpont Morgan Library di NewYork.
56 Il mosaico è stato ricostruito grazie all’accostamento delle parti superstiti con un disegnocinquecentesco (ms. Barb. Lat. 4426, Roma, Biblioteca Vaticana, c. 35). Il labirinto che emerge daquesta ricostruzione si compone di 11 spire e presenta al suo centro un Minotauro centauresco ar-mato di spada e attaccato da Teseo; una mano del mostro tiene stretta una testa umana per i capelli,e un corpo acefalo è disteso ai suoi piedi. L’illustrazione vive all’interno di una fortissima simbo-logia cristologica, in cui il labirinto figura come il mondo terreno e il ciclo dei Mesi posto in altorappresenta le attività che vi svolgono periodicamente gli uomini; Teseo che sconfigge il Minotaurosi pone come simbolo della Redenzione, affiancato da una rappresentazione di Davide, altra figuraChristi, che sconfigge Golia; infine, stessa simbologia possiede la lotta tra un uomo e un drago,raffigurata in uno dei quattro angoli che circondano il labirinto centrale. Cfr. KERN, Labirinti cit.,pp. 209-10. Sul mosaico in particolare, cfr. A. PERONI, Il mosaico pavimentale di S. Michele Mag-giore a Pavia: materiali per un’edizione, «Studi Medievali», s. III, XVIII/2 (1977), pp. 705-43. Pergli studi danteschi, segnala l’opera artistica come esempio di iconografia medievale ribaltata delMinotauro già MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre” cit., p. 99.
57 Si fa riferimento a due codici trecenteschi: il ms. lat. 4939 della Biblioteca Nazionale diParigi (miniatura a c. 21r) e il ms. Vat. Lat. 1960 della Biblioteca Apostolica Vaticana (miniatura ac. 264v). Cfr. KERN, Labirinti cit., pp. 148-49.
58 Il catalogo Brieger-Meiss-Singleton non segnala la presenza di questa illustrazione; informasolo che il codice possiede «an historiated initial and a framed miniature at the beginning of eachcantica (fols. 8r, 75r, 141r)», Illuminated Manuscripts cit., vol. I, p. 327. Accenna a questo «labirintodel Minotauro», invece, la scheda del ms. Barb. Lat. 4112 del Censimento dei commenti danteschicit., pp. 491-92.
ALESSANDRA FORTE50
nografia del labirinto e l’iconografia dantesca, e conduce a pensare che la culturamedievale molto probabilmente confondeva e sovrapponeva Minotauro e cen-tauri, oppure tendeva a differenziarli per attributi e corporatura specifica (toro ocavallo) ma sostanzialmente ne lasciava intatta l’immagine complessiva59.
Alla luce di questa documentata tradizione iconografica, allora, ancor più coe-renti risulteranno le sembianze del Minotauro del codice dantesco di HolkhamHall che, perfettamente aderente al testo, lungo un terreno scosceso accenna unoslancio in avanti, conferendo all’immagine quell’idea di dinamicità che nuova-mente riporta alla penna di Dante, a quel paragone con il toro «che si slaccia / […]che gir non sa, ma qua e là saltella» (Inf. XII, 22-24). In più, il guardiano della«ruina», in questo codice, si morde entrambe le mani, compiendo un gesto di fon-damentale importanza perché rivelatore di un’identità. Un simile gesto, infatti, erastato già adottato precedentemente dal Dante Poggiali, «portatore del più anticocorredo illustrativo della Commedia»60, precisamente nella vignetta incorniciataall’inizio di c. 28r; mancando, all’interno di questo manoscritto, una raffigurazionedei centauri saettatori, la vecchia «infamïa di Creti» diventava anche unica rap-presentante dell’intero canto.
Il Palatino 313 raffigura il mostro con una certa compostezza, immobile nellasua posa, decisamente più imponente nelle sue proporzioni rispetto alle due figuredi poeti e apparentemente calmo: anche il gesto di mordersi la mano non esprimerabbia furiosa. Il mostro si presenta umano nella parte superiore del corpo, dalpetto in su, e taurino nella parte inferiore: garanzia che si tratti di una natura tau-rina e non equina, per la vicinanza con l’immagine classica del centauro, risiedenella coda dell’animale che si avvicina, appunto, maggiormente a quella di unbue; lo stesso si può affermare per gli zoccoli e la corporatura61. L’immagine,posta nel margine superiore del foglio e sovrastante il testo scritto su due colonne,si circonda di un fitto apparato di glosse da entrambi i lati. Le cosiddette ChiosePalatine, a proposito della figura del Minotauro, forniscono al lettore informazionisulla leggenda mitica di Pasifae e Minosse, ma anche la loro rilettura alla luce
59 Una conferma deriva dal Lessico di iconografia cristiana che, alla voce Centauro, precisa:«nel Medioevo [il centauro] è stato frequentemente scambiato col Minotauro, soprattutto nei mo-saici pavimentali delle chiese» (HEINZ-MOHR, Lessico di iconografia cristiana cit., p. 95).
60 A. SPAGNESI, Le miniature del «Dante Poggiali», in Chiose Palatine. Ms. Pal. 313 della Bi-blioteca Nazionale Centrale di Firenze, a c. di R. ABARDO, Roma, Salerno Editrice, 2005, pp. 30-42, a p. 42. Nonostante lo spostamento della datazione del codice agli anni ’50 del Trecento propostada Petrocchi, anche Ciardi Dupré del Poggetto, concorde con Spagnesi, colloca il codice non oltregli anni ’30 del secolo, riconoscendolo come il primo codice miniato della Commedia a noi perve-nuto: cfr. CIARDI DUPRÉ DAL POGGETTO, “Narrar Dante” cit., p. 82. Già Meiss, considerando il ma-noscritto un prodotto della bottega di Pacino di Bonaguida, lo definiva «the earliest survivingCommedia with framed illustrations» (MEISS, The smiling pages cit., p. 49).
61 Nella realizzazione delle miniature vengono identificate quattro mani, risalenti all’area giot-tesca e a quella di Pacino di Bonaguida. Il miniatore di questo canto dovrebbe appartenere alla se-conda fascia di intervento, di ambito daddesco come la prima, che illustra i canti V-XIII (da c. 11va c. 30v). Per la datazione e diversi problemi di attribuzione delle miniature, cfr. SPAGNESI, Le mi-niature del «Dante Poggiali» cit. Cfr. anche ID., Il Palatino 313 della Biblioteca Nazionale di Fi-renze: alcune considerazioni sul’illustrazione della «Commedia» a Firenze nel Trecento, in «Rivistadi storia della miniatura», 1-2 (1996-1997), pp. 131-40.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 51
della spiegazione razionale che, per prima, era comparsa nel commento servianoall’Eneide62. Vere e proprie relazioni tra l’esegesi scritta e quella figurata non ri-sultano immediatamente visibili, ma l’immagine è nuovamente un dato che, nel-l’incertezza generale, individua una strada ben precisa.
Particolarmente imponente e massiccio, questo Minotauro-centauro potrebbefungere da base iconografica per un’ultima, singolare suggestione fornita all’os-servatore dal codice Vat. Lat. 4776. Il manoscritto vaticano contiene, per l’interocanto XII dell’Inferno, esclusivamente una raffigurazione dei centauri63. L’imma-gine, infatti, mostra una larga fossa di sangue in cui figurano immersi alcuni voltidi tiranni e, attorno ad essa, disposti nei quattro angoli della miniatura, quattro fi-gure di centauri armati; in tutto questo, dunque, il Minotauro risulterebbe assente,secondo una scelta iconografica che si concentra esclusivamente sulla secondaparte del canto. Tuttavia, la figura di centauro disegnata in basso a destra e piùprossima all’osservatore compie un gesto che potrebbe mettere in discussionequesta affermazione, dal momento che il guardiano, nelle sue pose, sembra ricor-dare proprio il Minotauro di Holkham Hall e, ancor di più, quello del Dante Pog-giali: il mostro porta una mano all’altezza della bocca e sembra compiere il gestodi morderla. Questo gesto, per la sua stretta aderenza al testo, non lascerebbedubbi sull’identificazione del mostro, considerando che una conformazione cen-tauresca del Minotauro, soprattutto a questa altezza cronologica, certamente nonsorprende, riconosciuta com’è al mostro di Creta già da buona parte della tradi-zione medievale, da quasi tutti gli altri codici danteschi, ma basterebbe ancheconsiderare soltanto il Palatino 313, in cui già si consegna all’osservatore un Mi-notauro-centauro ritratto nel gesto di mordersi. È anche vero che, se una mano èportata alla bocca, l’altra stringe una freccia, e questa è un’arma che il testo dan-tesco affida esclusivamente ai centauri, ma non mancano esempi di codici, nonsolo danteschi64, che presentano il Minotauro dotato di armi o di corno; in più,questo mostro in primo piano, rivolto verso l’osservatore, non pare per niente in-teressato ai dannati, a differenza dei compagni guardiani che si allungano sullevittime e tengono bene in vista lo strumento delle loro torture; in particolare unodi loro, il primo in alto a sinistra, ai più comuni arco e freccia unisce persinoscudo ed elmetto. Indicatore del fatto che non si tratti di soli centauri potrebbeessere già lo stesso numero delle figure miniate, abbastanza sospetto se si consi-
62 Dopo aver esposto i punti principali della «favola», si aggiunge, a maggior chiarimento, che«la istoria vera è questa: Tauro fu un notaio di Minos lo quale Pasife amò e giacque con lui ne lacasa di Dedalo, ma però ch’ella partorie doppia figura di tauro e di uomo, sì che l’una fu generatada Minos e l’altra da Tauro, onde il fanciullo nato fue chiamato Minotauro», Chiose Palatine, adInf. XII, 12.
63 Ci informa di questa scelta iconografica la descrizione integrale delle illustrazioni del codicericavabile dal catalogo Brieger-Meiss-Singleton. A proposito dell’illustrazione di c. 42v, il catalogosegnala che «Dante and Virgil observe the centaurs shooting and stabbing at the tyrants in Phlege-thon», Illuminated Manuscripts cit., vol. I, p. 329.
64 Un primo esempio di codice dantesco è il ms. 8530 dell’Arsenal di Parigi precedentementeanalizzato, in cui il mostro figura munito di arco e faretra; ma cfr. anche la miniatura del ms. It. IX.276 della Biblioteca Marciana di Venezia, c. 9r. Per i codici non danteschi, tre dei cinque esempiprecedentemente menzionati presentavano un Minotauro armato.
ALESSANDRA FORTE52
dera che i saettatori di Inf. XII sono sì in numero maggiore di tre – «dintorno alfosso vanno a mille a mille», ci informa Dante – ma solitamente il canone icono-grafico si concentra esclusivamente sulle tre figure direttamente nominate (Nesso,Chirone e Folo) e, quando un miniatore vuole rendere l’idea più caotica del canto,alludendo ad un numero altissimo di saettatori, aggiunge un gruppetto di centauriammassati sul fondo della scena. In questo caso, assente qualunque schiera, questounico guardiano in più rispetto al numero canonico necessariamente insospettisce.Questa figura, inoltre, unica frontale rispetto all’osservatore, risulta ulteriormenteeccezionale se si richiama alla memoria quello straordinario affresco che è l’In-ferno di Nardo di Cione, realizzato nella Cappella Strozzi di Santa Maria Novellaa Firenze, e se ne confronta la parte centrale (centauri che saettano i dannati delFlegetonte) proprio con questa miniatura. L’affresco di Nardo mette in scena ildettato dantesco con elevatissima fedeltà e il codice vaticano, a sua volta, conscrupolosa precisione, accoglie al suo interno le scelte iconografiche del pittorefiorentino65. I tre centauri armati della miniatura di c. 42v, non a caso, possiedonotutti un esatto corrispettivo nell’affresco della Cappella Strozzi, corrispettivo chesi mostra identico sia nelle pose assunte (tensione delle braccia o delle zampe,torsione del busto) che nelle armi impugnate (arco e frecce o lancia). Risulta,invece, assente, un guardiano che possa assomigliare al primo mostro raffiguratoin basso a destra, oggetto del nostro interesse. Quest’ulteriore circostanza sem-brerebbe confermare la totale novità di questa introduzione, che grazie al gestorivelatore del mordersi permette un’identificazione più certa e una distinzionetra figure ben precisa.
Se, tornando all’analisi della miniatura, si vuole tralasciare o considerare ca-suale il numero dei mostri rappresentati – magari lasciandosi influenzare dalfatto che la collocazione spaziale sia la stessa, senza distinzione di luogo per ledue categorie di guardiani – si potrebbe obiettare che la figura sull’angolo destroabbia il nome del centauro Chirone, pensando forse al movimento che il precet-tore del mito compie per scostarsi la barba dal volto; se si vogliono considerare,invece, significative tutte queste numerose corrispondenze, diviene doveroso ri-conoscere a questo mostro l’identità di Minotauro66. Pur in assenza di una rispo-sta certa alla questione, resta sicuramente suggestiva l’indecisione che unmodello iconografico può generare nel momento in cui viene riutilizzato persoggetti differenti, portando, in un caso già molto controverso come questo, aduna forte confusione di identità.
Ora, esplorate le diverse modalità di rappresentazione del mostro al’internodei codici miniati della Commedia, è possibile giungere a qualche conclusione
65 I rapporti tra il codice vaticano e l’affresco di Nardo di Cione sono evidentissimi. Vere e pro-prie corrispondenze iconografiche vengono segnalate sia da MEISS, The Smiling Pages che da BRIE-GER, Pictorial Commentaries to the «Commedia», in Illuminated Manuscripts cit., a pp. 49-50 e ap. 102.
66 I versi a cui si farebbe riferimento per l’identificazione con Chirone sono: «Chirón prese unostrale, e con la cocca / fece la barba in dietro a le mascelle» (Inf. XII, 77-78). Partendo da un’ideadi semplificazione dell’illustrazione, il miniatore avrebbe praticato una scissione del gesto in dueparti: con una mano il centauro terrebbe la freccia, con l’altra andrebbe a spostarsi la barba. Tuttavia,si ritiene molto più convincente la prima ipotesi di identificazione.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 53
più certa in merito alla questione relativa alla conformazione fisica dell’«infamïadi Creti». Come mostrato, le fonti classiche e medievali, sebbene analiticamentee ripetutamente interrogate, non forniscono un aiuto adeguato. Nel suo complesso,comunque, per diverse ragioni, la critica dantesca tende quasi unanimemente ariconoscere che Dante abbia ribaltato l’immagine classica del Minotauro. Qualcheposizione che non esclude la possibilità di un recupero totale del mito, compren-sivo della conformazione fisica del mostro, è presente, ma si tratta sempre di po-sizioni che poi, in definitiva, riconoscendo la questione ancora aperta, non sipronunciano67. Unica vera eccezione all’interno della voce critica generale è laposizione di Steven Botterill che, nel suo The Form of Dante’s Minotaur, si schieraa favore di un Minotauro inequivocabilmente conforme al mito classico: è piùverosimile, afferma Botterill, che Dante abbia chiarito poco la conformazione delsuo guardiano proprio perché si trattava di qualcosa di ovvio e scontato per il suopubblico e non che, volendo innovare, non abbia impiegato tutte le sue forze pergarantire al lettore dettagli distintivi indiscutibili, dettagli che avrebbero dise-gnato quel nuovo mostro in forme ben definite, senza lasciare spazio alcuno adincertezze interpretative68. Non della stessa opinione si mostrava, invece, GuidoMazzoni, quando attribuiva proprio a Dante la «colpa» della mancata chiarezza69
o, eliminata la possibilità di influenze da parte di modelli iconografici preesi-stenti, riconosceva al poeta la libertà totale di inventare qualcosa di completa-mente nuovo70. Concorde si è mostrata nel tempo buona parte della critica; si ètentato di chiarire la conformazione del Minotauro rifacendosi a criteri di vero-simiglianza o di corrispondenza tra le descrizioni dantesche e gli effettivi movi-menti del mostro71, ma c’è stato anche chi come Tartaro ha presto confutatoquesta serie di posizioni un po’ forzate e altre ancora72, fino a suggerire di arren-dersi all’evidenza dell’impossibilità di approdare ad una conclusione certa: «de-signato in modo generico […] il Minotauro resta nell’Inferno un’entità sfuggentea ogni preoccupazione iconografica e proposito descrittivo»73. Sulla stessa lineaha proseguito Mazzucchi, definendo la questione sostanzialmente «ancoraaperta»74, ma insieme fornendo spunti di ricerca molto significativi: lo studioso
67 Cfr. ad es. C.F. GOFFIS, Canto XII, in Lectura Dantis Neapolitana, vol. I: «Inferno», a c. di P.Giannantonio, Napoli, Loffredo, 1986, pp. 211-30, a pp. 221-22.
68 Scrive BOTTERILL, The Form of Dante’s Minotaur cit., a p. 73: «were Inferno XII to presenta human-headed monster, one would expect the text to call attention to the novelty in some way,as it does elsewhere when classical precedent is being modified. Instead […] the text furnishes nodetails incompatible with the traditional image, and no indication that a new image is being substi-tuted for it».
69 G. MAZZONI, Il canto XII dell’«Inferno», in ID., Almae luces malae cruces, Bologna, Zani-chelli, 1941, pp. 221-38, a p. 227.
70 Ibid.: «archeologo, a’ suoi tempi, neppur egli poteva essere né fu: e le classiche medaglie esculture, dove il Minotauro è sempre un uomo con testa di toro, gli rimasero ignote e dunque nongli fecero forza».
71 Cfr. I. BORZI, Dal Minotauro a Chirone. Inf. XII, in ID., Verso l’ultima salute. Saggi danteschi,Milano, Rusconi, 1985, pp. 61-97, a pp. 68-69 e U. BOSCO, Il canto XII dell’«Inferno», in Letturedantesche, vol. I: «Inferno», a c. di G. Getto, Firenze, Sansoni, 1962, pp. 211-19, a pp. 212-13.
72 Cfr. TARTARO, Il Minotauro e i Centauri cit., pp. 75-76.73 Ivi, pp. 77-78.74 MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre” cit., p. 99.
ALESSANDRA FORTE54
rimanda ai «responsi contrastanti»75 delle fonti di Dante, di quelle letterarie comedi quelle iconografiche, e in tal modo illustra in maniera molto efficace la realedifficoltà di individuare una strada univoca all’interno della questione; conclude,poi, ammettendo la possibilità che il poeta, «al pari dei miniatori, potrebbe esserestato suggestionato nell’associare anche figurativamente il mostro cretese al cen-tauro […] dalla ravvicinata segnalazione dei due mostri in Sant’Agostino e in Isi-doro di Siviglia» o che sia avvenuto per il Minotauro lo stesso processo inventivoscaturito in Dante per Caco, gigante cantato da Ovidio e Virgilio semplicementecome semihomo o semifer, ma divenuto in Inf. XXV un centauro a tutti gli effetti76.Sulla base di questi e altri approfondimenti iconografici presentati da Mazzucchi,Bellomo ha poi fatto presente come, sebbene «l’iconografia antica lo rappresen-tava come un uomo dalla testa di toro, […] nel Medioevo si sviluppò anche l’im-magine di un toro con il busto e la testa umane» e si è mostrato propenso aconcludere che «Dante lo immagina probabilmente proprio così»77.
Nei manoscritti miniati trecenteschi, s’è visto che un’illustrazione di questotipo è la più frequente e questo porta a pensare che o un’immagine simile dominavala cultura trecentesca, e per questo non aveva alcuna difficoltà ad essere ripropostanei vari codici – seppur con qualche differenza da miniatore a miniatore – oppureche l’operazione di recupero e inveramento svolta da Dante era stata talmente in-novativa che la sua esegesi figurata non poteva avere dubbi su come rappresentareil primo guardiano di Inf. XII. È vero che esiste la possibilità, per un miniatore, dipossedere modelli di base per l’illustrazione di un intero canto – si pensi alla co-modità di utilizzare un unico stampo per Minotauro e centauri – però si è anchevisto come non siano pochi i casi in cui, nonostante la generale somiglianza, esi-stano poi dettagli distintivi utili per una più specifica identificazione dei guardiani.Che il Minotauro di tutte le illustrazioni dei manoscritti danteschi del Trecento –eccezion fatta per il solo codice budapestiano – si presenti come un toro con latesta di uomo è un fatto innegabile e, se tutti i miniatori hanno proceduto in unastessa direzione, il loro comportamento è un dato che vuole dire qualcosa. Partendodal presupposto che l’incertezza del testo di Dante è innegabile, in quanto una de-scrizione dettagliata della conformazione fisica del Minotauro oggettivamentemanca – e ne è testimonianza il disaccordo degli unici commentatori che si pro-nunciano sulla questione –, se tutti i miniatori hanno raffigurato il mostro con que-ste sembianze, è doveroso concludere che questa immagine fosse il prodotto di uncanone iconografico esistente in quel momento, magari di tradizione autonoma,come potrebbe essere quella dei labirinti illustrati, fonte comune per tutti i miniatorisenza implicare necessariamente rapporti tra i codici, ma, appunto perché possibile,
75 Ibid. Accenna all’incertezza iconografica tipica del mondo medievale – ma in definitiva lasciala questione ancora sospesa – anche C. CARUSO, Canto XII, in Lectura Dantis Turicensis, vol. I: «In-ferno», a c. di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Cesati, 2000, pp. 165-82.
76 MAZZUCCHI, “Quelli che si lascion condurre” cit., pp. 100-01. Per quanto riguarda la figuradi Caco, cfr. la voce relativa nell’Enciclopedia Dantesca (vol. I, pp. 741-742) e B. GUTHMÜLLER,Canto XXV, in Lectura Dantis Turicensis cit., pp. 345-57; ma anche R. HOLLANDER, Canti XXIV-XXV.La settima zavorra, in Esperimenti danteschi. «Inferno» 2008, a c. di S. Invernizzi, Milano, Marietti,2009, pp. 175-201.
77 DANTE ALIGHIERI, Inferno, a c. di S. BELLOMO, Torino, Einaudi, 2013, p. 183.
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MINOTAURO DANTESCO 55
probabile punto di partenza anche per Dante nel momento in cui ergeva la vecchia«infamïa di Creti» a guardiano del suo cerchio dei violenti.
Se il Minotauro dei codici danteschi, per un miniatore, non è nient’altro cheil Minotauro di un più comune labirinto, estrapolato dalla sua domus pagana peressere collocato sulla «ruina» infernale del nuovo mondo cristiano, allora cre-scono le probabilità che lo stesso Dante lo abbia visto e conseguentemente im-maginato in queste forme, senza alcuna contraddizione col fatto che le sue fontiprivilegiate fossero i testi dei vecchi poeti classici. Del resto, non soltanto vederee riconoscere la forte simbologia che incarna un labirinto in una chiesa o in uncodice del suo tempo, ma anche leggere la stessa Tebaide, per Dante, voleva direrisalire agli avvenimenti di Creta attraverso una rilettura morale e individuare inTeseo la figura Christi che annuncia la Redenzione, proprio grazie a quell’uscitavittoriosa da un labirinto che tanto assomiglia alla discesa trionfante di Cristo agliInferi. «Il labirinto è il mundus concepito, secondo il senso medioevale-cristiano,come una specie di sottomondo […] Il Minotauro al centro è l’inferno, il demonio;il labirinto è un camminare nell’errore, che conduce a rovina sicura se non inter-viene il Cristo-Teseo»78. Se Dante non impiega tutte le sue forze per sottolinearel’innovazione di queste sembianze – e non si vuole credere che la sua per primafosse un’incertezza – allora è forse doveroso concludere che ciò accade perché ilsuo lettore conosceva già quel mostro e ne immaginava senza dubbi le forme, al-l’interno di un contesto fortemente moralizzato in cui il messaggio fondamentalerestava la sconfitta del Male. Su questa linea, d’altronde, procedeva la maggiorparte delle chiose alla Commedia79, ma basta pensare soltanto alla preminenzache, nei pochi versi dedicati all’«infamïa di Creti», lo stesso Dante riconosce aquel «duca d’Atene» che si fa principe cristiano.
Ruolo di rilievo, allora, in questa indagine, va riconosciuto all’illustrazione delcodice, nel momento in cui fornisce al lettore uno strumento di comprensione im-mediata di un dato che, nella sua generalità, produce equivoci. L’immagine, cheper forza di cose consegna un messaggio al suo osservatore, in questo caso ha so-stituito l’esegesi scritta, riuscendo a dare una risposta ad un quesito che la tradi-zione letteraria precedente e il commento successivo non erano stati in grado dirisolvere. Glossa interpretativa di questa figura infernale si fa l’immagine stessa,attraverso gli appunti esegetici di un miniatore che sta trasferendo in figura la suainterpretazione del testo contiguo, la sua conoscenza generale di un soggetto, l’im-maginario collettivo di un tempo e di una società.
78 SANTARCANGELI, Il libro dei labirinti cit., p. 189.79 Si consideri per esempio quanto scrive GUIDO DA PISA a commento dei versi 19-20 di Inf.
XII: «Iste igitur dux, id est Christus, Minotaurum, id est Diabolum, occidit proiciendo in os eiuspicem et pilos, id est carnem et sanguinem in sua potestate ponendo, et sic genus humanum ab eiusliberavit, sicut liberavit Theseus populum Athenarum».
ALESSANDRA FORTE56
Fig. 1. Autografo del Liber Floridus di Lamberto di Saint-Omer, Gand, BibliotecaUniversitaria, ms. 92, c. 20r.