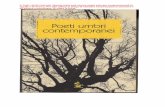Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto nell'esegesi posteriore e...
Transcript of Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto nell'esegesi posteriore e...
Testi e studi di cultura classica
Collana fondata daGiorgio Brugnoli e Guido Paduano
Diretta daGuido Paduano, †Alessandro Perutelli, Fabio Stok
60
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 3
Totus scientia plenus.Percorsi dell’esegesi virgiliana antica
a cura diFabio Stok
Edizioni ETS
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 5
www.edizioniets.com
© Copyright 2013EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN: 978-884673782-3
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma «Tor Vergata»
(fondo PRIN 2009)
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 6
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto nell’esegesi posteriore
e nei poeti di I sec. d.C.*
di Giancarlo Abbamonte
È noto che tra i primi commentatori dell’Eneide di Virgilio vada anno-verato il pensatore stoico Lucio Anneo Cornuto (Leptis Magna c. 20 d.C. – post 68 d.C.), di cui ci sono pervenuti frammenti e testimonianze in greco e latino1; la tradizione diretta ci trasmette sotto il suo nome un’opera in greco sulla mitologia ( jEpidromh; tw'n kata; th;n JEllhni-kh;n qeologivan paradedomevnwn), di cui è ormai generalmente accettata la paternità cornutiana2.
Cornuto fu, probabilmente, un liberto legato alla potente famiglia de-gli Annei: secondo la tradizione biografica antica, fu il maestro dei poeti Lucano e Persio3 e dovette interessarsi molto ad argomenti di poetica,
* Desidero ringraziare Massimo Gioseffi, Giuseppe Ramires e Riccardo Scarcia per i loro sug-gerimenti che hanno migliorato questo lavoro, di cui resto l’unico responsabile.
1 Testimonianze e frammenti grammaticali di Anneo Cornuto sono raccolti e pubblicati in MAZZARINO 1955, di cui si segue qui la numerazione.
2 Il testo dell’Epidromè con traduzione italiana e commento è stato pubblicato da RAMELLI 2003, che fornisce un’utile presentazione della figura di Cornuto e del suo pensiero per il pubblico italiano (su questo lavoro si legga però la recensione di MC ALBANY 2004). Sul pensiero di Cor-nuto, in particolare in riferimento alla poesia e all’allegoria, esistono numerose pubblicazioni a partire dalla dissertazione di REPPE 1907 e dall’articolo di NOCK 1931 nel quinto supplemento della RE, il quale ha avuto il merito di essere stato il primo ad aver tentato un confronto tra i passi di Cornuto e Seneca. Contemporaneamente al lavoro di Nock, J. Tate portava avanti nel mondo anglosassone una ricerca sull’interpretazione allegorica nell’Antichità, i cui risultati apparvero in lavori pubblicati a varie riprese su The Classical Quarterly: in questi studi, Cornuto e la sua Epi-dromè avevano un ruolo assai importante (cfr. in part. TATE 1929). In tempi più recenti sono tor-nati sull’allegoresi MOST 1989, che rappresenta lo sforzo più impegnativo di comprendere i vari aspetti del pensiero filosofico di Cornuto e metterli a contatto con la cultura del suo tempo, TORRE 2003, BELLANDI 2003, e i due contributi di SETAIOLI 2004, mentre dell’esegesi virgiliana di Cor-nuto hanno trattato più specificamente GEYMONAT 1984, nella voce dedicata a Cornuto per l’En-ciclopedia Virgiliana, ancora MOST 1989 e CUGUSI 2003.
3 La notizia del discepolato di Lucano e Persio alla scuola di Cornuto è data nella Vita Persi (4-5) [= T. 4 e T. 6 MAZZARINO], da cui apprendiamo pure che, alla precoce morte di Persio, Cor-nuto fu nominato erede e curò l’edizione delle satire di Persio: cfr. Vita Persi 5, 8 [= T. 6, T. 7, T.
Giancarlo Abbamonte
16
portando avanti una consolidata tradizione stoica che ricercava negli an-tichi poemi tracce di un sapere primigenio ed originale. Secondo gli Stoici, questa antica forma di sapienza sarebbe stata riferita in forma mi-tica dall’umanità antica e riprodotta dai poeti, i quali avrebbero però an-che deturpato con le loro licentiae il messaggio originale4. Da questa concezione prende avvio la ben nota interpretazione allegorica della poesia, che caratterizza la critica letteraria stoica5.
Il Compendio cornutiano sulla mitologia si inquadra in questa pro-spettiva, che ricercava nei racconti mitologici, e nelle opere poetiche in particolare, le tracce di questa antica sapienza, di cui gli Stoici sarebbero stati i migliori interpreti attraverso l’allegoresi, in quanto il loro pensiero sarebbe stato l’unico in grado di cogliere tale sapienza, seppur per vie diverse da quelle praticate dagli uomini antichi.
Accanto a questo interesse epistemologico, Cornuto manifestò anche un’attenzione specifica verso i temi di poetica. Lo dimostrano la quinta satira che il poeta Persio volle dedicargli6, i frammenti delle sue opere esegetiche sul poema virgiliano, di cui si tratterà nel presente lavoro, e la dedica di uno di essi al poeta Silio Italico – una circostanza riferita dal grammatico Carisio e su cui si ritornerà in questa sede7. A queste testi-monianze si aggiunga un passo significativo dello storico Cassio Dione, in cui si racconta che Cornuto sarebbe stato esiliato da Nerone intorno al 65 d.C. dopo che era stato interpellato dall’imperatore stesso per dare un giudizio sulla qualità delle sue performances poetiche ed aver espresso un’opinione poco lusinghiera8.
L’oggetto del presente lavoro sarà l’esegesi di Cornuto relativa ad al-cuni passi virgiliani: essa non è sempre facilmente ricostruibile, in quan- 8 MAZZARINO].
4 Il tema è discusso a proposito di Cornuto già a partire da REPPE 1907: la più recente messa a punto della questione è in SETAIOLI 2004.
5 Generalmente, l’approccio di Cornuto a questi problemi del mito è considerato in linea con l’ortodossia stoica: cfr. SETAIOLI 2004, 341-49.
6 Sul rapporto tra Cornuto e Persio cfr. MOST 1989, 2050-53, e BELLANDI 2003. 7 Char. Gramm. I p. 125,16 K. [= p. 159,27 B. = fr. 35 MAZZARINO]: Civitatiumʼ Annaeus
Cornutus ad Italicum de Vergilio libro X: “Iamque exemplo tuo etiam principes civitatium, o poe-ta, incipient similia fingere”.
8 Cfr. Cass. Dio 62,29,1-4, in part. § 2, in cui si dice che Nerone progettava un poema epico sulla storia di Roma, ma prima di iniziarne la composizione avrebbe consultato alcuni intellettuali della sua epoca, e si cita solo Cornuto come il più famoso (pri;n kai; oJtiou`n aujtw'n sunqei'nai, ejskevyato, paralabw;n a[llou" te kai; jAnnai'on Kornou'ton eujdokimou'nta tovte ejpi; pai-deiva/).
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
17
to con l’eccezione di Gellio il punto di vista di Cornuto ci è noto sola-mente attraverso testi e commenti successivi di molti secoli, quali i Commenta Veronensia, Macrobio, il commento di Servio e le aggiunte del cosiddetto Danielino (di seguito, SD), i testi grammaticali e i glossa-ri. Si tratta di testi nati in epoca tardo-antica, quando il lavoro di Cornuto su Virgilio (costituito da una o due opere, poco importa9) era tutt’altro che sicuro che fosse ancora pienamente disponibile, mentre sembra più probabile che di esso si conservassero solo frustuli relativi a singoli pro-blemi, trasmessi talvolta in forma anonima dai vari testi scolastici e so-prattutto dai cosiddetti commentari variorum, tra cui va forse annoverato quello di Donato.
In proposito, Aldo Setaioli ha valutato, in un recente lavoro apparso in due puntate sull’“International Journal of Classical Tradition”10, la presenza dell’esegesi stoica (e dunque anche cornutiana) in Servio e ne-gli altri commentatori tardo-antichi come un’eredità di natura fossile, di cui questi intellettuali adopererebbero alcune categorie concettuali, tal-volta abusandone, talaltra travisandole o banalizzandole. Manca in Ser-vio, ma anche nel SD e negli Scholia Veronensia, l’intero sfondo teoreti-co e soprattutto la visione del mito e del ruolo della poesia che stanno dietro le parole di Cornuto11.
Di fronte al panorama degli studi cornutiani, il presente lavoro si pro-pone due obiettivi: da un lato, si proverà a ricostruire le modalità con cui alcune opinioni di Cornuto furono assorbite, e talvolta modificate o sem-plificate, dai successivi commenti virgiliani: il primo caso che si prende-rà in esame permetterà di valutare anche l’apporto di Cornuto allo studio del testo virgiliano12; dall’altro, si indagherà se le singole interpretazioni virgiliane proposte da Cornuto, di cui siamo a conoscenza, abbiano avu-
9 Sul problema se Cornuto abbia scritto una o due opere dedicate all’esegesi virgiliana ritorna-
no quasi tutti gli studi su Cornuto menzionati alla nota 2: seguendo la canonica distinzione di Leo, REPPE 1907, 27-30, ha parlato di uno uJpovmnhma e di un suvggramma, seguito da NOCK 1931, 997, e in tempi recenti da GEYMONAT 1984, 897, CUGUSI 2003, 215-16, RAMELLI 2003, 12 e 122 nota 45, SETAIOLI 2004, 341 nota 40, più dubbioso ZETZEL 1984, 263 nota 40.
10 Cfr. SETAIOLI 2004. 11 Di fronte a notizie così tarde e scarne appare frettoloso il giudizio con cui l’esegesi di Cor-
nuto è liquidata da ZETZEL 1984, 38-41. 12 Per lo studio delle varianti cornutiane si rimanda a TIMPANARO 2001, 25-35, ma su questo
argomento la bibliografia è vasta a partire dall’edizione virgiliana di Ribbeck fino alle più recenti edizioni virgiliane che danno quasi sempre conto in apparato delle varianti che si fanno risalire a Cornuto: cfr. GEYMONAT 2008, CONTE 2009, RIVERO 2011.
Giancarlo Abbamonte
18
to un effetto sulle scelte di poetica compiute dal suo allievo Lucano o da Silio Italico, il dedicatario di un lavoro di Cornuto su Virgilio, ovvero se si riscontri una traccia di queste posizioni cornutiane in altri poeti epici di I sec. d.C.13.
Si tratta di un campo di ricerca poco o punto battuto nella pur ampia messe di studi su Cornuto apparsi nell’ultimo secolo, in cui è sempre stata privilegiata (e giustamente!) un’analisi dei frammenti di esegesi virgiliana del filosofo stoico volta a collocarli all’interno della tradizione interpretativa che si andò formando attorno ai poemi del Mantovano. Un’eventuale ricaduta dell’esegesi di Cornuto sull’attività poetica di au-tori a lui coevi o legati da qualche forma di relazione sembra essere stata tralasciata anche dagli studiosi, ormai numerosissimi, che si interessano all’epica post-virgiliana.
In questo quadro, la sola eccezione è rappresentata dal lavoro su Cor-nuto di Glenn Most, il quale ha provato a rintracciare alcuni spunti offer-ti dall’allegoresi cornutiana e dalla sua visione della poesia negli autori che furono in contatto con il filosofo stoico. Così, nel caso di Lucano lo studioso americano era giunto a conclusioni piuttosto deludenti: elemen-ti come l’assenza degli dei, la visione stoica della fisica, della divinazio-ne e dell’etica, ma soprattutto una Weltanschauung antifrastica rispetto all’Eneide, che traspaiono dal Bellum civile, possono essere attribuibili al generale background stoico piuttosto che ad un preciso influsso di Cornuto, mentre scene come quella della maga Eritto sarebbero state si-curamente considerate una licentia da Cornuto (un mito inventato dal poeta e slegato dal patrimonio mitico originario) e quindi condannate14. Più promettente era, invece, l’indagine portata avanti da Most sul poema di Silio, il quale non rinuncia alla presenza degli dei, ma da stoico orto-dosso attribuisce loro un significato allegorico: Giove, ad esempio, rap-presenta sempre l’etere, Giunone l’aria; non mancano poi altri riferimen-ti alle divinità che richiamano da vicino le teorie cornutiane espresse nell’Epidromè15.
Anche da questa cursoria sintesi risulta evidente come Most si sia in-
13 Mi limito in questa sede all’esame dei poemi epici post-virgiliani e di alcuni passi delle tra-
gedie di Seneca, mentre non considero l’eventuale rapporto tra le satire di Persio e il pensiero di Cornuto, per cui rimando a BELLANDI 2003.
14 MOST 1989, 2053-57. Cfr. i frr. 29 e 30 MAZZARINO, in cui Cornuto critica Virgilio per aver inventato due miti.
15 MOST 1989, 2057-59, ripreso in RAMELLI 2003, 27-30.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
19
teressato al rapporto tra le teorie cornutiane espresse nell’Epidromè e le strutture dei due poemi. Allo stesso livello strutturale rimangono i lavori di Torre e Cugusi apparsi nel volume curato da Gualandri e Mazzoli e dedicato alla gens degli Annaei16. Tenendo conto, invece, soprattutto dei frammenti di esegesi virgiliana e meno dell’Epidromè, la presente ricer-ca non indagherà le questioni di carattere generale, ma cercherà di stabi-lire se le singole tracce dell’esegesi virgiliana di Cornuto, che ci sono trasmesse da fonti successive, contengano scelte lessicali, morfologiche o esegetiche di cui si noti una presenza nelle opere di Lucano e Silio Ita-lico; inoltre, si terrà conto delle eventuali occorrenze di questi fenomeni in Ovidio, Seneca e in un altro poeta epico di età flavia, Papinio Stazio, per poter aver un quadro completo del dibattito da prima di Cornuto al-l’epoca in cui scrissero i due poeti che furono a contatto con Cornuto17. Sulla base del valore di ogni singola testimonianza, ma anche della fre-quenza con cui ritornano le proposte dei diesiecta Cornuti membra nei versi dei poeti di I sec. d.C., si tenterà di valutare se e quanto questa pro-duzione poetica abbia risentito dei dibattiti poetici sui poemi virgiliani che erano avvenuti alla scuola di Anneo Cornuto.
Nella sua edizione, Antonio Mazzarino ha raccolto 14 testimonianze e 41 frammenti di Cornuto: le testimonianze forniscono solo elementi di supporto al presente ragionamento, ma non entrano nel merito di proble-mi virgiliani; tra i frammenti, invece, due sono considerati dall’editore incertae sedis, due sono giudicati giustamente dei falsi. Inoltre, i primi 19 frammenti della raccolta di Mazzarino provengono dal De orthogra-phia di Cassiodoro e riguardano problemi di ortografia di singole parole o dell’uso di lettere dell’alfabeto latino; anche i frammenti 23 e 33, rela-tivi alle opere virgiliane, toccano problemi di ortografia (rispettivamen-te, l’uso di Orcus senza aspirazione e la declinazione del nome di Dido-ne nelle forme del genitivo Didus e dell’accusativo Didun). Questi temi non saranno discussi, in quanto, trattandosi di errori poco significativi, gli strumenti dell’ecdotica non permettono di risalire alla lezione preferi-
16 Cfr. TORRE 2003 e CUGUSI 2003, il quale però arriva a conclusioni diverse da Most (cfr.
CUGUSI 2003, 237-38), ritenendo che alcune scelte presenti nel poema di Lucano, come l’assenza dell’apparato mitologico e lo stile fortemente espressionistico, dipendano dal magistero di Cornu-to e siano la causa dello scontro tra il “virgiliano” Nerone e la coppia Lucano-Cornuto.
17 Si è prestata attenzione all’opera di Stazio, in quanto l’autore mostra nella Silva 2,7 (Gene-thliacon Lucani ad Pollam) di aver avuto stretti contatti con la moglie di Lucano, Polla Argenta-ria, che manteneva desto il ricordo del marito e della sua poesia.
Giancarlo Abbamonte
20
ta da un singolo scrittore a causa delle frequenti oscillazioni ortografiche dei manoscritti medievali e umanistici che ci trasmettono queste opere18.
Fr. 31 M. ap. Serv. Aen. 9,348, p. 66 Ramires: ET MVLTA MORTE RECEPIT PVRPVREVM multi hic distinguunt, ut sit sensus talis: “eduxit gladium multo cruore purpureum”. Alii multa morte recepit, ut sit: “eduxit gladium cum multo cruore”, et sic in-ferunt purpuream vomit ille animam secundum eos qui animam sanguinem dicunt. RECEPIT eduxit, ut hastamque receptat ossi-bus haerentem (Aen. 10,383-384). vel secundum Homerum e[l-labe porfuvreo" qavnato" kai; moi'ra krataihv (Hom. Il. 5, 83). Cornutus nocte legit et adnotavit: utrum “nocte” pro “morte”, an cum multa nox esset?19.
Il punto di partenza è il seguente passo virgiliano relativo all’aristia di Eurialo, Aen. 9,343-350:
Nec minor Euryali caedes: incensus et ipse perfurit ac multam in medio sine nomine plebem, Fadumque Herbesumque subit Rhoetumque Abarimque ignaros, Rhoetum vigilantem et cuncta videntem, (sed magnum metuens se post cratera tegebat), pectore in adverso totum cui comminus ensem condidit adsurgenti et multa morte recepit: purpuream vomit ille animam et cum sanguine mixta vina refert moriens20.
Tra le vittime di Eurialo l’unico ad accorgersi dell’assalto è Reto, che si
18 Ad es., Orcus ha una sola occorrenza in Lucano (6,715) e nessuna in Silio, mentre Didone non è mai nominata da Lucano e compare numerose volte in Silio, ma mai nelle forme suddette di genitivo e accusativo.
19 Si segue il testo stabilito da RAMIRES 1996, che si allontana sensibilmente da quello di THI-LO 1881-1887, ripreso da Mazzarino, e si adotta qui anche il sistema grafico dell’edizione di Ra-mires, che usa il tondo per il testo tradizionale di Servio, il grassetto per SD e il corsivo per le cita-zioni all’interno del commento. Sulle differenze con cui è edito questo passo nell’edizione di Thilo e in quella di Ramires vd. infra.
20 «Né minore la strage di Eurialo; anch’egli infiammato infuria e molta folla in mezzo priva di rinomanza assalta, e Fado ed Erbeso e Reto e Abari, incoscienti, Reto da sveglio e mentre tutto osservava, ma grandemente temendo si nascondeva dietro un cratere; a lui d’accosto tutta quanta, nell’atto di alzarsi, la lama nel petto proteso nascose, e la ritrasse sparsavi la morte. Vomita quello l’anima vermiglia e rigurgita morendo vini misti a sangue» trad. ital. di R. Scarcia. Da qui in poi, quando non è esplicitato l’autore della traduzione, si deve intendere che essa sia di chi scrive.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
21
nasconde dietro un cratere di vino e viene passato a fil di spada. L’im-magine di Virgilio è quella di Eurialo che prima affonda la spada nel petto di Reto e poi la estrae, provocando così l’emorragia e la fine di Re-to, che in una scena assai macabra muore sputando contemporaneamente vino e sangue21.
Servio fornisce alcune spiegazioni dell’espressione virgiliana multa morte sulla base della differente punteggiatura che si dà del passo e delle due lezioni purpuream e purpureum. SD invece riferisce solamente la lezione discussa da Cornuto, multa nocte, che sarà da intendersi per me-tonimia (nocte = morte) o in riferimento all’ora notturna in cui avvenne la strage.
Già il testo di SD, che è stato ricostruito da Ramires sulla base del te-stimone F, aveva indicato il precedente dell’immagine di Virgilio in Hom. Il. 5,82-83 (to;n de; kat j o[sse / e[llabe porfuvreo" qavnato" kai; moi'ra krataihv22), che F riporta da solo, mentre nel testo edito da Thilo la citazione greca di Omero mancava23. Una morte simile a quella di Re-to, per emorragia intervenuta dopo che l’arma è stata estratta dal corpo dell’eroe colpito, trova un precedente omerico nell’episodio della morte del troiano Antiloco ad opera di Merione, Il. 13,567-575:
Mhriovnh" d j ajpiovnta metaspovmeno" bavle douri; aijdoivwn te meshgu; kai; ojmfalou', e[nqa mavlista givgnet j “Arh" ajlegeino;" oji>zuroi'si brotoi'sin e[nqa oiJ e[gco" e[phxen. oJ d j eJspovmeno" peri; douri; h[spair j... o[fra oiJ ejk croo;" e[gco" ajnespavsat j ejgguvqen ejlqw;n h{rw" Mhriovnh": to;n de; skoto;" o[sse kavluye24.
Come il Reto di Virgilio, anche Antiloco muore solo dopo che la lancia è stata estratta: manca in Omero qualsiasi riferimento alla multa morte, mentre la morte è qui caratterizzata dall’oscurità, come nella variante di
21 L’immagine dell’uomo che muore sputando l’anima e il vino compare anche in Stat. Theb.
10,321-323. 22 «A lui sugli occhi scesero rossa la morte e duro il destino». 23 La presenza del modello omerico in questo episodio è discussa da SCAFFAI 2006, 116-18. 24 «Ma Merione seguendolo [scil. Antiloco], mentre si allontanava, lo colpì con la lancia tra il
pube e l’ombelico, dove Ares diventa più doloroso per i sofferenti mortali. Lì gli conficcò la lan-cia, mentre quello, colpito, si contorceva […] finché avvicinandosi a lui, l’eroe Merione, non gli estrasse la lancia dalla pelle. Il buio allora ricoprì gli occhi».
Giancarlo Abbamonte
22
Cornuto25. Secondo Scaffai, sarebbe opportuna la spiegazione data da Servio
(eduxit gladium cum multo cruore) in quanto «[…] mors equivale al gr. porfuvreo" qavnato", di cui Virgilio recepisce la nota cromatica del colore cupo del sangue, trasferendola però alla metafora purpuream ani-mam, in modo da creare una continuità semantica fra sangue, anima e morte»26.
Venendo poi alla variante cornutiana multa nocte, essa è generalmen-te rigettata da editori e studiosi del testo virgiliano, i quali a partire da Heyne e Ribbeck fino alla recente edizione spagnola accolgono in testo multa morte, che è trasmesso dai venerandi codici virgiliani tardo-anti-chi27.
L’opinione più articolata e autorevole in proposito resta quella e-spressa da Timpanaro, il quale riteneva che la variante nocte non fosse una congettura di Cornuto: «[…] è inverosimile che un congetturatore ri-manga perplesso su due modi diversissimi di intendere la propria emen-dazione»28. E aggiunge che Cornuto «[…] considerò morte insostenibile, rimase incerto se nocte, da lui letto in un manoscritto si potesse intende-re come sinonimo di morte (Cornuto avrà pensato a espressioni come immolat ingentique umbra tegit di Aen. 10,541 […] in aeternam clau-duntur lumina noctem, 746, o ad analoghe espressioni omeriche), oppure in riferimento alla strage compiuta da Eurialo e Niso, che si svolge ap-punto a notte alta»29.
Dalle edizioni agli studi si osserva che con gli argomenti di Timpana-ro concordano Zetzel, il quale sposa l’idea di una variante antica accolta da Cornuto30, Scaffai che pensa ad una variante pre-cornutiana, ma la ri-
25 Questa corrispondenza non è stata notata da Scaffai, né da altri studiosi. 26 SCAFFAI 2006, 117, ma l’interpretazione serviana del verso è abbastanza ricorrente: cfr. RE-
BERT 1933. 27 La lezione multa morte è già in HEYNE 1821, III, 267 e nota a 267-268, e RIBBECK 1894-
1895, III, 649. Tra gli editori più recenti, mentre GEYMONAT 1984, 898, si era mostrato più cauto e non aveva preso posizione nei confronti della variante di Cornuto, GEYMONAT 2008, 509 ad l., adotta morte e in apparato riporta le parole di SD; anche CONTE 2009, 273 ad l., presenta morte in testo e registra in apparato la variante nocte di SD e Cornuto; l’ediz. spagnola [= RIVERO 2011, 143 ad l.] accoglie morte e in apparato menziona la variante nocte, indicata da Cornuto, e la posizione in proposito di Timpanaro 2001, 34, cui rimanda condividendone l’argomentazione a favore di morte.
28 TIMPANARO 2001, 34: gli argomenti restano qui immutati rispetto a TIMPANARO 1986, 74. 29 TIMPANARO 2001, 34. 30 Cfr. ZETZEL 1984, 40.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
23
fiuta sulla base del confronto con Omero31 e del consensus di editori e studiosi virgiliani32, e Cugusi, il quale non considera attribuibile a Cor-nuto la congettura nocte, mentre ritiene che la lezione multa morte si in-quadri benissimo sia nei modelli omerici sia nel linguaggio virgiliano33.
Passando all’analisi dei testi poetici post-virgiliani, si osserva che il sintagma multa morte non è ripreso da alcun poeta della latinità, mentre esistono casi in cui compare multa nocte in autori del I sec. d.C. Il primo è un luogo delle Silvae di Stazio, in cui multa nocte compare in enjam-bement: Nos certe taceamus et obruta multa / nocte tegi propriae patia-mur crimina gentis (Stat. Silv. 5,2,89-90)34.
È un passo dell’apostrofe che Crispino rivolge al poeta, nella quale lo prega di astenersi dallo scrivere versi malevoli nei confronti della madre, morta a seguito di una condanna per veneficio, in quanto aveva tentato di uccidere lo stesso Crispino, il quale si mostra qui clemente e pio verso la colpevole madre. Nella sua apostrofe, Crispino invita Stazio a passare sotto silenzio l’episodio per far dimenticare questo terribile evento: l’espressione crimina multa nocte obruta fa riferimento all’oblio che de-ve cancellare i misfatti compiuti dalla madre di Crispino e la multa nocte richiama la morte, confermando in qualche modo la prima interpretazio-ne della variante multa nocte suggerita da Cornuto35.
31 In realtà, esiste almeno un passo, in cui l’immagine della notte, come metonimia della mor-
te, è presente anche in Omero: ajmfi; de; o[sse kelainh; nu;x kavluye (Hom. Il. 5,310). Il riferimen-to è qui ad una perdita di sensi da parte di Enea, colpito da Aiace, ma nei versi successivi si assiste all’intervento di Afrodite, che salva Enea da sicura morte.
32 Cfr. SCAFFAI 2006, 117. 33 Cfr. CUGUSI 2003, 234-35, il quale porta a confronto i seguenti passi: totum cui comminus
ensem / condidit (Aen. 9,347-348) ma anche in ore / condidit advorso (Aen. 9,442-943); ensem tu-mido in pulmone recondit (Aen. 10,387); ferrum adverso sub pectore condidit (Aen. 12,950). Il modello omerico riferito da Cugusi è Hom. Il. 21,117-118. Inoltre, secondo Cugusi, la lezione multa morte si giustificherebbe insieme alla variante purpuream… animam, nel senso che estraen-do la spada ci sarebbe stata un’emorragia di sangue e la conseguente morte. Cfr. ille [scil. Pallas] rapit calidum frustra de vulnere telum: / una eademque via sanguis animusque secuntur (Aen. 10, 486-487); multo vitam cum sanguine fudit (Aen. 2,532); e Hom. Il. 13,574-575.
34 «Noi di certo passeremo sotto silenzio e lasceremo che i delitti della propria famiglia siano nascosti, sepolti da una notte profonda».
35 L’espressione non è oggetto di commento da parte degli studiosi antichi (Calderini, Mark-land), né dei moderni commentatori della Silva, VOLLMER 1898 e GIBSON 2006, ma la iunctura è conservata nella traduzione francese: cfr. FRÈRE - IZAAC 1961, II, 187: Pour nous tout au moins gardons le silence, et laissons les crimes de notre propre maison s’ensevelir dans de profondes tè-nèbres; e anche in quella inglese: cfr. MOZLEY 1961, 295: Let us least keep silence, and suffer the crimes of our own house to be buried deep in whelming darkness.
Giancarlo Abbamonte
24
Il secondo passo è offerto da Silio Italico: […] luxuque solutum / om-ne decus multaque oppressum nocte pudorem (Sil. Ital. 2,501-502)36. I due versi ricorrono all’interno del discorso che la dea Lealtà tiene ad Er-cole, il quale si lamenta con lei della distruzione di Sagunto, avvenuta a causa della mancanza di lealtà dei Cartaginesi. La dea risponde che sono state le condizioni di corruzione degli uomini a determinare il suo allon-tanamento dalla terra. Tra le disgrazie del mondo la dea annovera la fine del pudore, cancellato da lunghe notti di lussuria. Come già in Stazio, ri-corre nei Punica non solo l’espressione multa nocte, ma anche la dipen-denza dell’ablativo dal participio di un verbo che significa “seppellire”: in entrambi la lunga notte serve a cancellare, ma in Silio non si può e-scludere un riferimento alla notte come momento topico per compiere atti di lussuria37.
Il terzo passo che si esaminerà è anch’esso tratto dai Punica di Silio Italico, 10,344-348:
Ausis, dive, voco nec posco, ut mollibus alis des victum mihi, Somne, Iovem. Non mille premendi sunt oculi tibi nec spernens tua numina custos Inachiae multa superandus nocte iuvencae. Ductori, precor, immittas nova somnia Poeno […]38.
Subito dopo la battaglia di Canne, Annibale, reso tracotante dalla vitto-ria, decide di partire subito alla conquista di Roma. Preoccupata da que-sta prospettiva, Giunone invoca il dio Sonno e per rendere la divinità be-
36 «il senso dell’onore si dissolve nel lusso e il pudore è sepolto in una fitta oscurità». 37 Tale è l’interpretazione di ERNESTI 1791, I, 104-05 ad l.: «multa nocte oppressum pudor est
Est penitus oppressus, ita ut emergere non possit, vitiorum caligine et obscuritate, inquit Marsus. Haec sententia mox per partes docetur luculentius», confermata da RUPERTI 1795, I, 150: «nocte concubitu, ut III,429 vel proprie, etsi sensus idem est. Vitiorum caligine, Mars. 504, cfr. XI,183, ubi Drak. comparavit Lucan. I,175. Sen. Herc. Fur. v. 253 et in Hippol. V. 543». Si sofferma su multa nocte anche SPALTESTEIN 1986-1990, I, 156 ad l., confermando l’interpretazione di Ernesti e muovendo anche qualche rimprovero sull’efficacia poetica dell’espressione, di cui non ha notato il confronto con la variante virgiliana: «Multa nocte étonne certes au premier bord, mais nocte reprend en fait une idée usuelle: la nuit est le temps des amours (n. 3,429), donc aussi celui des adultères, des viols etc., multa ne faisant que dramatiser l’idée, sans grande nécessité il est vrai (ce qui explique que l’on ait pensé à “cacher dans le plus profonde de la nuit” […]».
38 «O dio, non ti chiamo, né ti chiedo un’impresa ardita, come consegnarmi Giove, o Sonno, vinto. Non bisogna chiudere i mille occhi, né è il guardiano della giovenca figlia di Inaco, sprez-zante del tuo potere, che devi vincere con una notte profonda».
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
25
nevola alle sue richieste ricorda due imprese sicuramente più difficili di quella che Giunone sta richiedendo ora: l’aver infuso il sonno a Giove e ad Argo dagli innumerevoli occhi39. In questa circostanza Giunone chie-de al dio Sonno di scendere a coprire gli occhi di Annibale e di farlo ca-dere in un lungo sonno (multa nocte)40. Qui, pur essendo ancora una vol-ta presente un participio reggente (superandus), il significato dell’e-spressione fa riferimento alla lunghezza del sonno durante l’intera notte, ovvero al secondo significato proposto da Cornuto.
Dopo il I secolo d.C., l’espressione ritorna in poeti della Tarda Anti-chità, come il medico Quinto Sereno nel Liber medicinalis, a proposito dei veleni di ragni e scorpioni, o in una scena di risveglio del protagoni-sta del Cupido cruciatus di Ausonio41.
In conclusione, da un lato tutti i manoscritti virgiliani tardo-antichi e il commento di Servio riportano la lezione multa morte, dall’altro i poeti post-virgiliani fino alla Tarda Antichità sembrano ignorare questa espressione, che non utilizzano mai per creare un intertesto. Tra gli ese-geti, Cornuto conosce e discute solo la lezione multa nocte, secondo una notizia data dallo scolio di SD che non tratta la lezione multa morte, mentre tra i poeti multa nocte è utilizzata da Stazio, Silio Italico e da due poeti della Tarda Antichità.
L’assenza della iunctura multa morte nei testi poetici e la sua prima attestazione nel commento di Servio lasciano aperto l’interrogativo se essa fosse effettivamente una lezione virgiliana o tanto antica quanto multa nocte, come lasciano intendere di solito gli editori moderni, i quali la accolgono e le affiancano l’altra lezione multa nocte, considerata coe-
39 Sui precedenti letterari che ricordano queste due imprese si rimanda a SPALTESTEIN 1986-
1990, II, 80, ad l. 40 RUPERTI 1795, II, 81, in apparato registra la lezione multa morte del codex Puteanus, men-
tre nel commento osserva con finezza: «344-347: Non Argus tibi sopiendus est, custos Ius, filiae Inachi, in vaccam mutatae, quae fabula vel tironibus nota est ex Ovid. Met. I,624 sqq. […] nocte, somno. v. ad II,563. multa, propter multos oculos». ERNESTI 1791, II, 503-04, si limita a chiosa-re: «multa nox somnus altissimus», seguito da SPALTESTEIN 1986-1990, II, 81, che però non spie-ga multa.
41 Cfr. Quint. Seren. Liber medic. 860-863: Sunt minimae specie, sed dirae vulnere pestes, / quae magis in tenui latitantes corpore fallunt, / Scorpius ut gravis est et araneus: haec mala sem-per / captant securos multa iam nocte sopores («Sono flagelli piccoli d’aspetto, ma terribili, quan-do feriscono, questi che sono capaci di ingannare meglio, in quanto si nascondono dietro un corpo piccino. Lo scorpione è pericoloso quanto il ragno. Questi due sono mali che spesso colpiscono mentre si dorme tranquillamente nel pieno della notte»). Auson. Cupid. cruc. 101: Quae postquam multa perpessus nocte Cupido.
Giancarlo Abbamonte
26
va, ma debole. Si potrebbe avanzare con cautela l’ipotesi che Cornuto abbia propo-
sto una doppia interpretazione di multa nocte, mentre non sia affatto in-tervenuto su multa morte, proprio perché all’epoca di Cornuto, Stazio e Silio Italico questa lezione non era nota, altrimenti la sua forte espressi-vità metaforica avrebbe verisimilmente attirato l’attenzione di Cornuto e dei poeti coevi. Il fatto poi che multa morte compaia nei venerandi ma-noscritti virgiliani non deve sorprendere, perché i più antichi tra essi ri-salgono alla stessa epoca e furono commissionati dagli stessi ambienti senatori in cui è stato prodotto il commento di Servio che riporta e di-scute la lezione multa morte.
Fr. 38 M. [= C. Plinius Secundus fr. 97 M.]: CGL V 29,4 Goetz ʽIngluviemʼ Cornutus ʽventremʼ, Plinius ʽedacitatemʼ.
Il passo è tratto dalle Glossae Placidi, un glossario che doveva essere in origine molto più ampio di come ci sia pervenuto oggi42. Come spesso accade nei glossari, la notizia è assai breve, ma è per noi fondamentale, perché è l’unica fonte a collegare il nome di Cornuto alla spiegazione del termine ingluvies con la pancia e lo stomaco (venter). Tuttavia, la di-scussione sul significato di ingluvies è a noi nota anche attraverso altre fonti, tra cui è degno di nota un passo di Servio e SD: «INGLVVIEM ventris capacitatem. Et aliter: Varro ad Ciceronem in libro XXIII. Inglu-vies tori, inquit, sunt circa gulam, qui propter pinguedinem fiunt atque interiectas habent rugas. Sed nunc pro gula positum. Et ʽimprobusʼ hic avidus» (Serv. + SD, Georg. 3,431 p. 310,5-9 Th.)43.
Le posizioni di Servio e di SD rispetto all’identificazione dell’inglu-vies sono opposte tra loro, mentre risultano invertiti i ruoli rispetto a ciò che abbiamo visto per la variante morte / nocte: in questo caso, Servio riproduce grosso modo il significato di venter che il glossario attribuisce a Cornuto, senza nominare il filosofo stoico, mentre SD propone la se-conda ipotesi, che vedremo spesso ritornare nei grammatici, negli eruditi e nei poeti, cioè l’identificazione con il gozzo e la gola, che forse si ri-chiamava al pensiero di Verrio Flacco44; inoltre, SD menziona una fonte
42 Vd. GOETZ 1888-1922, V, vi. 43 In questo caso e negli altri in cui Servio è citato secondo l’edizione THILO 1881-1887, il te-
sto in tondo è quello del Servio vulgato, mentre il corsivo indica il testo di SD. 44 Si tratta dell’identificazione dominante: cfr. Colum. 8,5,17. Tra gli esegeti e i commentatori
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
27
antica come Varrone, rivelando l’origine pre-cornutiana e forse perfino pre-virgiliana della discussione su ingluvies. Il fatto poi che in questo ca-so sia Servio a condividere l’opinione di Cornuto rivela la tortuosità con cui queste testimonianze cornutiane viaggiassero all’interno della tradi-zione esegetica di Virgilio.
È anche da notare che la giustapposizione di due opinioni opposte, ri-salenti a Servio e a SD, all’interno della tradizione serviana, è un esem-pio significativo, che testimonia la profonda differenza che caratterizza in alcuni casi i due materiali e che in questo caso riguarda le Georgiche, un testo per cui la tradizione che noi definiamo ʽDanielinaʼ non dipende in realtà da alcuno dei codici di Pierre Daniel, ma da un solo manoscritto in grafia beneventano-cassinese di X secolo, che difficilmente si potrà connettere ai codici di SD usati da Daniel per l’Eneide45.
Il passo virgiliano cui si riferiscono i commenti di Servio e SD ri-guarda la descrizione di un serpente che vive nel Salento (in Calabris), Georg. 3,425-431:
Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis squamea convolvens sublato pectore terga atque notis longam maculosus grandibus alvum, qui, dum amnes ulli rumpuntur fontibus et dum vere madent udo terrae ac pluvialibus Austris, stagna colit ripisque habitans hic piscibus atram improbus ingluviem ranisque loquacibus explet.46
La tradizione esegetica moderna a partire da Heyne ha sempre dato una certa prevalenza all’interpretazione che identifica l’ingluvies con la go-la47. L’ipotesi di Heyne, che riconosceva nell’ingluvies il gozzo degli uc-
cfr. Schol. Bern. ad Georg. 3,431 (Ingluviem gulam; ingluvies est spatium gulae), Porph. ad Hor. Epist. 1,13,10 tutti i glossari accettano l’identificazione con la gula, fatta eccezione per le Glossae Placidi: cfr. Paul. Fest. s.v. ingluvies p. 112 M. (= p. 99,21-22 Lindsay); GL V, 27,16 (= V 77,19); IV,90,46; IV,249,28; V,460,33 e ad indicem di GOETZ 1888-1923, VI, 576.
45 Sulla natura del cosiddetto commento di SD alle Georgiche e sulla storia della sua pubblica-zione prima dell’edizione di Daniel sia consentito il rimando ad ABBAMONTE 2012, 146-50.
46 «C’è anche un famoso serpente, malvagio, che vive tra le balze del Salento: snodando il dorso squamoso con il petto sollevato e ricoperto di grandi macchie sull’ampio ventre, questi vive negli stagni prendendo a dimora le rive, finché i corsi d’acqua sgorgano impetuosi dalle sorgenti e le terre sono ancora infradiciate dall’umida primavera e dalle piogge meridionali, e riempie smo-datamente di pesci e rane chiacchierone la nera ingluvie (pancia/gola?)».
47 Cfr. HEYNE 1821, I, 390-91: «431 ingluviem improprie dixit pro ventre, ut jam Servius; nam
Giancarlo Abbamonte
28
celli (provlobo") o al massimo un generico riferimento alla voracità, ri-torna quasi identica nel commento di Forbiger, che aggiunge qualche fonte al ragionamento di Heyne48. In tempi più recenti, questa esegesi è stata generalmente accolta, ma c’è anche da dire che spesso il passo non ha ricevuto alcuna cura interpretativa49.
Venendo al frammento di Cornuto relativo all’ingluvies, esso è stato assegnato da Reppe ai lavori esegetici su Virgilio50, mentre Mazzarino lo collocava tra quelli Incertae sedis. In questo caso, l’intertestualità ci per-mette forse di comprendere meglio la posizione di Cornuto sul significa-to di questo termine. In effetti, nel suo commento al passo Mazzarino os-serva senza soffermarsi sul problema: «ʽingluviemʼ ap. Georg. 3,431 in-venis. – cf. ad Plin. fr. 97»51. Sulla questione è tornato più recentemente Cugusi, che presenta la questione dell’originaria collocazione del passo in maniera aperta e senza prendere posizione, sottolineando opportuna-mente il fatto che esisteva su questa parola una doppia interpretazione e riprendendo anche una notizia data sia da Heyne che da Forbiger, i quali avevano richiamato un luogo di Silio per un confronto letterario52.
Il passo di Silio si dimostra qualcosa di più di un luogo parallelo: è una testimonianza, finora sottovalutata dalla critica, del significato che Silio dava del termine ingluvies e dichiara quale fosse la sua posizione nella dibattuta questione. In effetti, il termine compare solo in dodici oc-correnze nella poesia latina e mai prima di Virgilio: dopo Virgilio e Ora-zio, ingluvies è presente solo in Silio tra gli autori del primo secolo d.C.53, mentre le altre otto occorrenze riguardano autori cristiani di età
proprie est provlobo", ut in avibus, primum in gutture cibi receptaculum. Laudat Cerda Aristot. Histor. Anim. II c. 17 […]. Silium haec imitatum esse, notat idem. Locus est lib. VI 155-158. A-tram autem dixit, h. funestam, exitiosam, luctuosam. improbus, immodice avidus, vorax, v. ad Georg. I,119». È interessante che ad Aen. 2,471 (qualis ubi in lucem coluber mala gramina pa-stus) HEYNE 1821, II, 247-48, proponga di emendare in lucem con ingluviem sulla base di questo passo (cfr. apparato di GEYMONAT 2008, 236).
48 Cfr. FORBIGER 1872, I, 437, ad Georg. 3,425-431: «Ita apud Apulei. Met. V. p. 70. Ele-ment. Priusquam bestia ingluvie voraci me misellam hauriret. Quare etiam pro voracitate dici constat, ut ap. Hor. Sat. I, 2, 8. Iahn. in Proleg. ad Pers. p. XVIII. ad h. l. spectare censet Placidi glossam in A. Mai Auct. class. III. p. 476. (Vid. Ribbeck. Proleg. p. 128.)».
49 L’interpretazione con gula è accolta da DELLA CORTE 1986, II, 64 ad Georg. 3,431, mentre i commenti ad l. di RICHTER 1957, MYNORS 1990 ed ERREN 2003 non trattano il tema.
50 Cfr. REPPE 1907, 45-46, 80. 51 Cfr. MAZZARINO 1955, 208. 52 CUGUSI 2003, 222 e nota 69. 53 In realtà, ai vv. 51-52 del Bellum civile di Petronio (Praeterea gemino deprensam gurgite
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
29
post-costantiniana e, in un caso, gli Epigrammata Bobiensia54. È importante fornire il contesto in cui il termine occorre nei Punica
di Silio Italico, 6,151-159: Monstrum exitiabile et ira telluris genitum, cui par vix viderit aetas ulla virum, serpens centum porrectus in ulnas letalem ripam et lucos habitabat Avernos. Ingluviem immensi ventris gravidamque venenis alvum deprensi satiabant fonte leones aut acta ad fluvium torrenti lampade solis armenta et tractae foeda gravitate per auras ac tabe afflatus volucres55.
Maro, un superstite della spedizione di Regolo, racconta la marcia del-l’esercito nel deserto libico presso il fiume Bagrada, dove le truppe in-contrano un bosco scuro e una grotta dall’aspetto infernale, abitata da un serpente di dimensioni gigantesche, la cui pelle si conservò a lungo a Roma56. Silio stabilisce dunque un collegamento tra l’espressione inglu-viem immensi ventris e il serpente dalle dimensioni straordinarie con un preciso richiamo al passo delle Georgiche, in cui il termine ingluviem era riferito alla parte del corpo di un serpente: attraverso la parola inglu-vies Silio ha dunque instaurato un rapporto tra il serpente del suo passo e quello virgiliano, ma ha anche voluto prendere posizione in relazione al significato del termine57.
plebem / faenoris illuvies ususque exederat aeris), il ms. L (Leidensis 261) presenta la lezione in-gluvies (vs. illuvies/inluvies degli altri testimoni): cfr. l’apparato di ERNOUT 1974, 137 ad l. Ringrazio Stefano Poletti per aver attirato la mia attenzione su questo problema testuale.
54 Dati tratti dal sito internet Musisque deoque (http://mqdq.it): una di queste occorrenze è un frammento dei Mimographi di incerta paternità e datazione. Non è questa la sede per esaminare le occorrenze del termine in tali autori, ma è opportuno osservare tra loro una decisa spaccatura tra chi considera il termine riferito alla gola e chi allo stomaco.
55 «Un mostro distruttivo, prodotto dalla rabbia della terra, del quale nessuna generazione di uomini ne vide mai uno simile: un serpente lungo cento braccia abitava questa riva e questi boschi infernali. A saziare l’immensa capacità del suo stomaco e il suo smisurato ventre erano leoni cat-turati presso la sorgente o armenti condotti al fiume dalla torcia del sole rovente o uccelli trascina-ti giù dalla nauseabonda pesantezza nell’aria e dal maleodorante soffio».
56 Sulla pelle di questo serpente lungo centoventi piedi, che fu conservata a Roma almeno fino alla guerra di Numanzia, cfr. Plin. Nat. 8,37; Gell. 7,3; Liv. Per. 18 (testi raccolti in SPALTESTEIN 1986-1990, I, 400, ad Sil. Ital. 6,140).
57 Il collegamento tra il luogo siliano e Verg. Georg. 3,431 è evidenziato anche nei commenti
Giancarlo Abbamonte
30
La sua interpretazione di ingluvies è rimarcata, con una puntigliosità finanche insistita, dal genitivo immensi ventris, che collega al di fuori di ogni dubbio l’ingluvies allo stomaco e non alla gola58. Silio ha dunque proposto un’interpretazione del termine ingluvies in linea con quanto sappiamo che pensasse in proposito Cornuto e per illustrare la sua posi-zione ha costruito un testo poetico che richiama da vicino il passo virgi-liano del serpente in cui compare l’ambiguo termine ingluvies.
Di fronte a questi elementi, non sembra costituire un serio ostacolo l’obiezione di chi ritiene che Silio avrebbe precisato ingluviem immensi ventris per prendere le distanze dalla spiegazione del filosofo stoico che limitava l’ingluvies al solo stomaco59. Il passo del glossario che ci dà la notizia è troppo sintetico e potrebbe non rappresentare il punto di vista compiuto di Cornuto: è più verisimile che Cornuto abbia pensato ad un’identificazione di ingluvies con l’area dello stomaco e con la capacità dello stomaco stesso, secondo la definizione che ne dà Servio, piuttosto che alla pancia sic et simpliciter, come ci informa nella sua brevità il glossario. In questo caso, ci sarebbe una precisa consonanza tra ciò che dice Silio e la spiegazione del glossario, ma anche quella di Servio.
Come corollario di tale ricostruzione si avrebbe che l’intertesto silia-no sarebbe un argomento a favore di coloro che ritengono che Cornuto abbia preso posizione sul significato di ingluvies proprio a partire dal passo delle Georgiche e questo potrebbe indurre a dare ragione a Reppe e spostare il frammento che Mazzarino aveva collocato tra quelli incer-tae sedis nella sezione dei frammenti In Vergilium commentariorum.
Il fatto poi che né Servio né SD menzionino il nome di Cornuto, ma che entrambi conoscano e presentino uno dei due termini del dibattito su ingluvies rivelererebbe che probabilmente all’epoca dei due commenti questa discussione era stata separata dall’opera di Cornuto e assorbita in forma anonima all’interno di qualche commento o testo cui attinsero i
di ERNESTI 1791, I, 295 ad l. e RUPERTI 1795, I, 412 ad l.: nel fornire il locus similis, però, nessu-no dei due commentatori accenna alla proposta di Cornuto.
58 SPALTESTEIN 1986-1990, I, 401-02, coglie il confronto con Verg. Georg. 3, 430, ma ignora la discussione cornutiana e perciò critica l’insistenza di Silio: «Si ingluviem ici a son sens propre (“estomac”), comme le comprend le TLL 7,1,1557,25, ventris est plus ou moins redondant […]; dans tous les cas, le sens de “voracité” est plus tardif (si l’on excepte Hor. Sat. 1,2,8, d’ailleurs douteux, et Gell. 6,16,4».
59 Vd. CUGUSI 2003, 222 nota 69, che cita il commento di Forbiger, in cui Silio è però men-zionato come passo parallelo e non contro la spiegazione di Cornuto (cfr. supra il testo di Heyne alla nota 47, ripreso alla lettera da Forbiger: nota 48).
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
31
virgilianisti dell’età di Servio. Fr. 22 M. ap. Gell. 2,6, 1, 4, 19-25: [1] Nonnulli grammatici aeta-tis superioris, in quibus est Cornutus Annaeus, haut sane indocti neque ignobiles, qui commentaria in Vergilium composuerunt, re-prehendunt quasi incuriose et abiecte verbum positum in his ver-sibus […]. [4] Item aliud verbum culpaverunt: “per tunicam squalentem auro latus haurit apertum” (Aen. 10,314), tamquam si non convenerit dicere “auro squalentem”, quoniam nitoribus splendoribusque auri squaloris inluvies sit contraria. […] [19] Tertium restat ex is, quae reprehensa sunt, quod “tunicam squalentem auro” dixit. [20] Id autem significat copiam den-sitatemque auri in squamarum speciem intexti. ʽSqualereʼ enim dictum a squamarum crebritate asperitateque, quae in serpentium pisciumve coriis visuntur. [21] Quam rem et alii et hic quidem poeta locis aliquot demonstrat: “Quem pellis, inquit, ahenis / in plumam squamis auro conserta tegebat” (Aen. 11,770-771), [22] et alio loco: “Iamque adeo rutilum thoraca indutus ahenis / hor-rebat squamis” (Aen. 11,487-488). [23] Accius in Pelopidis ita scribit: “Eius serpentis squamae squalido auro et purpura pertextae” (Acc. frr. 517-518 R.). [24] Quicquid igitur nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut in-cuteret visentibus facie nova horrorem, id ʽsqualereʼ dicebatur. [25] Sic in corporibus incultis squamosisque alta congeries sor-dium ʽsqualorʼ appellatur. Cuius significationis multo assiduoque usu totum id verbum ita contaminatum est, ut iam ʽsqualorʼ de re alia nulla quam de solis inquinamentis dici coeperit60.
60 «[1] Alcuni grammatici della generazione precedente, fra i quali vi è Anneo Cornuto, uomi-
ni davvero non privi di dottrina né di fama che composero dei commenti a Virgilio, criticano il verbo che trovano in questi versi come posto senza cura e con negligenza […] [4] Ugualmente po-sero sotto accusa un’altra parola: “Gli aprì e trafisse il fianco attraverso la tunica ruvida d’oro”, come se non fosse opportuno dire auro squalentem, perché l’aspetto sordido della ruvidezza è in contraddizione con la lucentezza e lo splendore dell’oro. […] [19] Fra le cose che sono state criti-cate rimane come terza il fatto che Virgilio disse tunicam squalentem auro. [20] Quanto all’e-spressione, essa significa una abbondanza e gran quantità d’oro intessuto a mo’ di squame. Squa-lere (“essere ruvido”, “essere scaglioso”), infatti, è stato detto così dall’abbondanza e dalla ruvidi-tà delle squame che si vedono sulla pelle dei serpenti e dei pesci. [21] La qual cosa, come altri, in-vero anche questo poeta indica in alcuni passi: “Che una pelle copriva – dice – intessuta d’oro, con squame bronzee a moʼ di piume”, [22] e in un altro luogo: “E già appunto, rivestito di una co-razza lucente, era irto di squame di bronzo”. [23] Accio scrive così nei Pelopidi: “Le squame di quel serpente tutte intessute d’oro in scaglie e di porpora”. [24] Dunque tutto ciò che era eccessi-vamente impregnato e ricoperto di qualche cosa tanto da incutere per il suo aspetto strano un bri-
Giancarlo Abbamonte
32
È questo un caso assai significativo, in quanto a riportare l’opinione di Cornuto è un autore che visse circa un secolo dopo il filosofo stoico e dunque è a lui più vicino degli studiosi tardo-antichi; inoltre, Gellio conserva sia l’argomentazione usata da Cornuto contro Virgilio sia la ri-sposta di qualche esegeta virgiliano, che egli aveva fatto propria; infine, come vedremo, è significativo che l’argomento di Cornuto e l’obiezione riportata da Gellio siano riferiti anche all’interno dei Saturnalia di Ma-crobio e del commento serviano con le stesse parole che leggiamo nelle Noctes Atticae, mentre Nonio li riprende nella sostanza, ma con qualche modifica nella lingua.
Il problema riguarda il significato del verbo squaleo e del suo partici-pio squalens che Virgilio adopera in alcuni passi con un significato di-verso da quello solito di “essere sporco” “essere polveroso” (ma il pro-blema si allarga anche al sost. squalor e all’agg. squalidus): riferito alle corazze degli eroi questo verbo assume talvolta in Virgilio il significato di “essere ruvido”, “essere fornito di scaglie”, che nasconde in sé un’ac-cezione positiva vicina ad “essere luminoso”, “essere splendente”. Dalle parole di Gellio sembra che Cornuto contestasse quest’uso e accusasse Virgilio di improprietà lessicale (tamquam si non convenerit dicere “au-ro squalentem”).
Per rispondere all’accusa di Cornuto, Gellio porta avanti un ragiona-mento che tende a dimostrare come l’accezione negativa, ovvero la con-dizione di degrado fisico di un oggetto o di una persona, e quella positi-va di “essere ruvido”, da cui “essere splendente”, siano correlate e dipendano da una presunta etimologia di squaleo, che condividerebbe la medesima radice di squama / squamma (ʽscagliaʼ, ʽsquamaʼ)61. Secondo Gellio, squaleo farebbe riferimento in origine alla rugosità e alla screzia-tura della pelle dei pesci caratterizzata da scaglie, o a quella squamosa dei serpenti e dei rettili. A questo significato di base, Virgilio avrebbe aggiunto un uso traslato, riferito alle scaglie delle corazze degli eroi e ai loro riflessi luminosi, che provocherebbero nello spettatore lo stesso ri-
vido di orrore a chi lo guardava, questo era detto squalere (“essere ruvido, scaglioso”). [25] Così nei corpi mal curati e squamosi il profondo accumulo di sudiciume si chiama squalor. E con il fre-quente e costante uso di questo significato tutta quella parola è stata contaminata al punto che or-mai si è incominciato a dire squalor di nessuna altra cosa se non della sola sporcizia» Trad. ital. di F. Cavazza, cfr. CAVAZZA 1985, 199-205.
61 Si tratta di un’etimologia sbagliata, che si basa su una parte in comune dei due termini: cfr. CAVAZZA 1985, 398 n. 21.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
33
brezzo che produce la vista della pelle squamosa di un serpente62. Il si-gnificato negativo di “essere sporco”, “essere trasandato”, divenuto in seguito dominante, deriverebbe, invece, dal fatto che nell’intercapedine dei corpi squamosi e delle pelli rese squamose dall’incuria si annidereb-bero polvere e sporcizia. Prima di analizzare la tradizione esegetica post-gelliana, si riportano i cinque luoghi virgiliani in cui il termine ha il si-gnificato positivo di “essere ruvido” ed “essere splendente” in riferimen-to a conchiglie, rettili, api o armature:
1) Aut lapidem bibulum aut squalentes infode conchas (Verg. Georg. 2,348)63. Per permettere il drenaggio delle acque vicino ai giovani tralci appena piantati Virgilio suggerisce di mescolare alla terra pietre pomici e conchiglie, che con la loro superficie rugosa permettono alle acque di defluire64. 2) Absint et picti squalentia terga lacerti / pinguibus a stabulis (Georg. 4,13-14)65. Le lucertole dalla schiena screziata devono es-sere tenute lontane dalle arnie, perché sono ghiotte di miele. 3) Melior vacua sine regnet in aula. / Alter erit maculis auro squalentibus ardens (Georg. 4,90-91)66. Virgilio sta descrivendo le caratteristiche dell’ape regina che prenderà il potere nell’alvea-re: tra esse, si nota che la vincitrice ha riflessi più luminosi, pro-dotti da macchie che le screziano il corpo. È abbastanza evidente che in questo caso Virgilio faccia riferimento alla luminosità e al-lo splendore del pelo (le api non hanno squame!)67. 4) Huic gladio perque aerea suta, / per tunicam squalentem auro
62 Si noti che Gellio si limita a registrare il solo significato di “essere rugoso” e non accenna
all’ulteriore accezione (“risplendere”, “essere luminoso”), che sarà esplicitata da Servio. Tuttavia, conosce quest’accezione quando osserva: […] quoniam nitoribus splendoribusque auri squaloris inluvies sit contraria (6,2,4).
63 «Rincalza [scil. la terra] con pietre porose e conchiglie ruvide». 64 Sul significato di squalentis cfr. il commento ad l. di ERREN 2003, 464-65. È interessante
notare che HEYNE 1821, I, 305 ad l. insista sull’idea di muco e saliva connessi a squaleo: «[…] et squalentes conchas, mucosa aliqua saliva inductas. Cf. ad Ge. IV,91». Vd. infra nota 63.
65 «Le lucertole con le loro schiene screziate stiano lontano dalla grasse stalle». 66 «Si lasci che la migliore regni nella reggia deserta: una delle due [scil. la migliore] apparirà
splendente per le macchie screziate d’oro». 67 Cfr. HEYNE 1821, I, 418 ad l.: «Sed squalere, etsi communiter de corpore illuvie et sordi-
bus obducto dicitur, ex primo ac proprio significatu de madore corrupto ac muco; tum apud poetas de quacumque re, cui aliquid illinitur, incrustatur, adeoque etiam de colore adscititio usurpatur. Omnino squalent, quae non sunt laevia ac nitida conf. ad Aen. X,314, quae vero tantum ab asperi-tate spectantur, ea horrere dicuntur, etiam sine sordium notione».
Giancarlo Abbamonte
34
latus haurit apertum. (Aen. 10,313-14)68. Enea uccide il gigante-sco Terone con la spada, che passa attraverso la cotta di bronzo e la tunica intessuta con fili d’oro: in questo caso, il verbo può indi-care sia lo splendore che l’oro conferisce alla tunica sia il fatto che la superficie sia resa irregolare, e dunque ruvida, dai fili d’o-ro69. 5) Ipse dehinc auro squalentem alboque orichalco / circumdat lo-ricam umeris, simul aptat habendo / ensemque clipeumque et ru-brae cornua cristae (Aen. 12,87-89)70. L’armatura di Turno intrec-cia parti d’oro e di oricalco, che la rendono ruvida (o screziata)71.
È indicativo che nel suo ragionamento Gellio non riporti i tre passi delle Georgiche, che gli avrebbero confermato in qualche modo l’etimologia da lui avvalorata: si tratta di una mancanza che forse non è casuale e sul-la quale si ritornerà in seguito.
L’interpretazione etimologica che leggiamo in Gellio è ripresa alla lettera nel commento di SD a Verg. Aen. 10,314, cioè al passo da cui prende spunto il lungo ragionamento di Gellio in risposta a Cornuto:
TVNICAM SQVALENTEM splendentem loricam. “squalentem auro” splendentem auro. Et significat copiam densitatemque auri in squamarum speciem intexti: squalere enim dictum a squama-rum crebritate atque asperitate, quae in serpentum pisciumve co-riis visuntur: alibi ‹11,770-771› “Quem pellis, inquit, ahenis / in plumam squamis auro conserta tegebat”, et alibi ‹11,487-488› “Iamque adeo rutilum thoraca indutus ahenis / horrebat squa-mis”. Quicquid igitur inculcatum obsitumque aliqua re erat squa-lere dicebatur (Serv. + SD, Aen. 10,314 p. 426,11-18 Th.).
Come si vede, sia Servio sia SD danno una prima spiegazione del parti-cipio squalentem come corrispondente di ʽsplendenteʼ, che non era un
68 «A costui [scil. Terone] trapassa il fianco squarciato attraverso la cotta di bronzo e la tunica
screziata d’oro». 69 La doppia interpretazione del verbo si ritrova nella maggior parte dei commenti a partire da
HEYNE 1821, III, 358 ad l. 70 «Egli [scil. Turno] poi indossa sulle spalle l’armatura irta/splendente/screziata d’oro e di
bianco oricalco, e contemporaneamente adatta nel modo migliore la spada, lo scudo e le punte del rosso pennacchio».
71 I commentatori propendono in questo caso ad interpretare squalentem come riferimento allo splendore a partire da HEYNE 1821, III, 518 ad l.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
35
significato annoverato da Gellio. Subito dopo, il solo SD riprende alla lettera ampi pezzi della spiegazione di Gellio e riporta anche gli altri due passi virgiliani menzionati da Gellio, ma non accenna alla polemica con Cornuto.
A proposito degli altri passi virgiliani summenzionati, si osserva che nei due luoghi dell’Eneide citati anche da Gellio, il commento di Servio e le eventuali aggiunte di SD non fanno ulteriori riferimenti al significa-to di squaleo o alla sua origine da squamis72. Per quanto riguarda, inve-ce, i passi delle Georgiche, manca in Servio un riferimento a squaleo a proposito di Georg. 4,13, mentre nel luogo del secondo libro in cui squalentis è riferito alle conchiglie, il participio è interpretato da Servio in accezione negativa, come sinonimo di ʽsordidoʼ73. La paretimologia e il significato corrispondente a ʽsplendenteʼ sono, invece, confermati nel commento di Servio a Verg. Georg. 4,91: «SQVALENTIBVS splen-dentibus: quod a squamis venit, ut || “Squamis auroque trilicem” (Aen. 3, 467); nam si a squalore est, sordidum significat, ut “Squalenten barbam” (Aen. 2,277)» Serv. Georg. 4,91 pp. 326,32-327,2 Th.
Servio ricorda qui non solo l’etimologia a squamis, ma anche quella che farebbe derivare squaleo a squalore e che imporrebbe al verbo il so-lo significato negativo di “essere sporco”. Quest’altra etimologia trova qualche corrispondenza nei glossari e porta il ragionamento nel campo delle differentiae verborum74. Una tale distinzione sembra aver avuto un ruolo nel differente impiego di squaleo e squalor nei poeti successivi a Virgilio: come si vedrà, tutti i poeti presi in esame adoperano il sostanti-vo squalor solo nell’accezione negativa di ʽsqualloreʼ, ʽpolvereʼ, ʽspor-ciziaʼ.
L’etimologia a squamis e il significato di ʽsplendenteʼ sono ricordati anche da SD a proposito di Aen. 2,277 (squalentem barbam), un passo in cui è evidente l’accezione negativa di ʽsordidoʼ: «SQVALENTEM modo sordidam, alibi ‹10,314› lucentem: “Per tunicam squalentem auro”, a squamis» (SD Aen. 2,277 p. 266,1-2 Th.).
Prima di Servio, era tornato sul significato del verbo squaleo il lessi-cografo Nonio Marcello, il quale aveva dedicato al verbo un lemma che non riprende alla lettera il testo di Gellio, ma lo riecheggia assai da vici-
72 In Serv. Aen. 12,87 p. 583 Th. è spiegata l’origine dell’oricalco. 73 «SQVALENTES [sic] sordidas» Serv. Georg. 2,348 p. 249,19 Th. 74 Nei glossari latini squaleo è quasi sempre collegato a sordeo (cfr. GOETZ 1888-1923, VII ad
indicem), solo GOETZ 1888-1923, V,147,6 ricorda l’etimologia a squama.
Giancarlo Abbamonte
36
no, 452 M. = 725,18-726,2 L.: SQVALERE non sordium plenum esse tantummodo, ut nunc con-suetudine persuasum est, sed et honesta re abundare et refertum esse veteres honesta auctoritate posuerunt; ducique hanc signifi-cantiam a squamis putant. Ut enim est in corporibus sordium alta congeries, qua squalere dicuntur, ita quod fuerit qualibet re densa-tum, oneratum inculcatumque squalere voluerunt. Vergilius lib. X (314): “et tunicam squalentem auro”. || Accius in Pelopidis (517): “Eius serpentis squamae squalido auro et purpura praetextae” (sic).
Come si vede, Nonio usa alcune espressioni presenti in Gellio (densa-tum, inculcatumque), molti concetti analoghi (la prevalenza del signifi-cato negativo nella consuetudo, l’etimologia a squamis, il concetto di ac-cumulazione di materiali differenti alla base dell’idea di squalere) ed in-fine ricorre nella selezione dei testi a due passi già adoperati da Gellio: Verg. Aen. 10,314 e il frammento tratto dai Pelopidi di Accio.
Anche Macrobio nei Saturnalia riprende assai da vicino la spiegazio-ne del virgiliano squaleo proposta da Gellio, attribuendo però gli argo-menti al suo interlocutore Servio. La discussione su questi versi è inizia-ta dal poeta Avieno: Sed ne hoc verbum ex diligentia Vergiliana venire mihi videtur: “per tunicam squalentem auro” (Aen. 10,314). Non enim convenit dicere “auro squalentem”, quoniam nitori splendorique auri contraria sit squaloris inluvies (Macr. Sat. 6,6,6).
Queste accuse di improprietà di linguaggio, che Gellio attribuiva a Cornuto, sono qui mosse con le stesse parole nei confronti di Virgilio dal poeta Avieno: manca però una menzione del filosofo stoico75. Ad es-se così risponde il personaggio di Servio dei Saturnalia (6,7,17-19):
Tertium restat ex iis, quae reprehensa sunt, quod “tunicam squa-lentem auro” dixit. Id autem significat copiam densitatemque auri in squamarum speciem intexti. ʽSqualereʼ enim dictum ab squa-marum crebritate asperitateque, quae in serpentium pisciumve coriis visuntur. Quam rem et alii et hic idem poeta locis aliquot
75 Poco prima, Macrobio aveva fatto così esprimere il personaggio Avieno: Tunc Avienus, to-
tus conversus in Servium: “Dicas volo – inquit – doctorum maxime, quid sit quod cum Vergilius anxie semper diligens fuerit in verbis pro causae merito vel atrocitate ponendis, incuriose abiecte in his versibus verbum posuit […]” (Macr. Sat. 6,4).
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
37
demonstrat: “Quem pellis, inquit, aenis / in plumam squamis auro conserta tegebat” (Aen. 11,770-771). Et alio loco: “Iamque adeo rutilum thoraca indutus aenis / horrebat squamis” (Aen. 11,487-488). 23. Accius in Pelopidis ita scribit: “Eius serpentis squamae squalido auro et purpura praetextae” (Acc. frr. 517-518 R., ma che legge pertextae in Gell.). Quicquid igitur nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut incuteret visentibus facie nova hor-rorem, id ʽsqualereʼ dicebatur. Sic in corporibus incultis squamo-sisque alta congeries sordium ʽsqualorʼ appellatur. Cuius signifi-cationis multo assiduoque usu totum id verbum ita contaminatum est, ut iam ʽsqualorʼ de re alia nulla quam de solis inquinamentis dici coeperit.
Macrobio ha ripreso alla lettera la spiegazione di Gellio, incluse le cita-zioni adoperate nelle Noctes Atticae, tra cui quella di Accio; nei Satur-nalia queste spiegazioni sono attribuite a Servio. Da questa raccolta di passi dipendenti da Gellio si osserva che il personaggio di Servio dise-gnato da Macrobio ricorre all’argomentazione di Gellio che, invece, è assente nel commento vulgato di Servio, mentre essa è ripresa alla lette-ra da SD proprio a proposito di Verg. Aen. 10,317, il passo da cui aveva preso le mosse Gellio. Si configura dunque un accordo tra il personaggio di Servio e il testo di SD, che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, i dubbi espressi da Kaster sul rapporto tra le opinioni espresse dalla figura di Servio delineata da Macrobio e il commento serviano vulgato76.
L’accordo in Gellium tra Macrobio e SD, e in parte Nonio, non può essere casuale: esso attesta che sul significato di squaleo l’unico mate-riale a disposizione degli eruditi di IV-V secolo, era il passo di Gellio; sembra dunque trovare qui ulteriore conferma l’ipotesi che la conoscen-za delle opinioni di Cornuto avvenisse a quell’epoca attraverso la media-zione di fonti intermedie – in questo caso, di Gellio. Inoltre, la situazio-ne rappresentata dalle testimonianze di SD e Macrobio dimostra come il dibattito sul significato di squaleo fosse rimasto praticamente fermo a quanto aveva dichiarato Gellio, mentre uno sviluppo del dibattito sull’in-terpretazione del verbo squaleo, successivo al passo di Gellio, traspare dai versi di Claudiano e denota un certo progresso in alcuni settori della lessicografia e dell’esegesi virgiliana di IV-V secolo, che però non è re-gistrato dai commentatori di tipo tradizionale, come SD, Macrobio o
76 Cfr. KASTER 1980.
Giancarlo Abbamonte
38
Servio, e da lessicografi come Nonio. Nel passaggio dalla tradizione esegetico-grammaticale ed erudita a
quella poetica si assiste ad un fenomeno assai interessante, che denota una presa di posizione dei poeti post-virgiliani del I-II sec. d.C. di fronte al significato controverso di questo verbo e dei suoi derivati. Una situa-zione controversa si registra già in Ovidio, che adopera il sostantivo squalor e l’aggettivo squalidus solo in senso negativo; anche il verbo squaleo (e il suo participio presente squalens) mantengono quasi sempre l’accezione negativa ad eccezione di un caso: […] et latrare canes et hu-mus serpentibus atris / squalere et tenues animae volitare uidentur77 (Ovid. Met. 14,410-11).
Dopo aver trasformato Pico nel picchio, la maga Circe evoca alcune divinità infernali a sua difesa: la natura reagisce a queste presenze infer-nali. In questo passo, il verbo squaleo non è adoperato nel significato so-lito di “essere sordido”, “essere ricoperto di polvere”, con cui lo usa di solito Ovidio, ma sembra fare riferimento ai riflessi paurosi che produce la massa brulicante dei corpi dal colore nero lucido dei serpenti – da no-tare è anche l’uso del verbo in riferimento ai serpenti, secondo l’etimolo-gia a squamis. Questo passo è assai importante, perché rivela che proba-bilmente già all’epoca di Ovidio la discussione sull’uso “positivo” di squaleo fatto da Virgilio era stata avviata e che essa era precedente allo stesso Cornuto.
Quest’uso di squaleo trova alcune conferme nelle tragedie di Seneca, il quale ricorre con maggiore frequenza al significato positivo e mostra di conoscere il significato etimologico e di alludervi nelle sue opere. Di seguito, si presentano e discutono i passi senecani: Nunc, nunc adeste sceleris ultrices deae, / crinem solutis squalidae serpentibus, / atram cruentis manibus amplexae facem, / adeste, thalamis horridae quondam meis / quales stetistis (Sen. Medea 13-17)78.
Nel monologo iniziale, Medea invoca le Erinni, che sono dette squa-lidae per i serpenti che si mescolano ai loro capelli. L’interpretazione corrente di squalidae è che le Erinni siano sozze, ma la presenza dei ser-penti nella scena rende assai più probabile che Seneca stia alludendo al-l’etimologia dell’aggettivo a squama e dunque si riferisca al brulicare
77 «Si videro cani latrare, la terra brulicare di neri serpenti e sottili anime volteggiare». 78 «Ora, ora, venite a me, dee vendicatrici del delitto, dai capelli squallidi per i / brulicanti di
serpenti sciolti, abbracciate con mani sozze di sangue la nera fiaccola. Venite a me, in quell’orribi-le aspetto con cui vi presentaste al mio talamo».
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
39
della massa di serpenti tra i crini delle Erinni. Il secondo luogo è tratto dall’Agamennone: Instant sorores squalidae,
/ anguinea (Heinsius : sanguinea codd.) iactant verbera (E : uerba PCS) (Sen. Agam. 759-760)79. Il passo presenta un’altra volta le divinità fem-minili della vendetta, ma la tradizione del testo è incerta: anguinea è un raffinato emendamento di Heinsius, accolto da Tarrant che mette a con-fronto espressioni simili a verbera anguinea in altri poeti latini80. In real-tà, l’emendamento di Heinsius trova conferma anche per la presenza di squalidae, usato anche qui in modo etimologico e riferito ai serpenti, compagni delle Erinni. Si può dunque concludere da questi due passi che Seneca conosce la paretimologia di squaleo a squamma e l’uso positivo del verbo, cui ricorre in due occasioni.
Prima di passare a Lucano, si prenderà in esame un luogo della tragedia Hercules Oetaeus: O dirum malum ! / Vtrumne serpens squali-dum crista caput (virumne serpens squalido cristam caput E) / vibrans an aliquod et mihi ignotum malum? Herc. Oet. 1253-55)81. Il passo mo-stra un gioco etimologico reso perfino insistente dalla presenza di crista e vibrans, che danno l’idea del baluginare della luce sulla superficie di-somogenea delle squame del serpente82.
Un atteggiamento non molto dissimile da quello di Seneca si osserva nel nipote, Lucano, il quale non adopera mai il sostantivo squalor e l’ag-gettivo squalidus, ma ricorre frequentemente (undici occorrenze) al ver-bo squaleo (4) e al participio presente squalens (7). Se Lucano mantiene generalmente il significato negativo, due casi meritano di essere esami-nati: Vadimus in campos steriles exustaque mundi, / qua nimius Titan et rarae in fontibus undae, / siccaque letiferis squalent serpentibus arva (Lucan. 9,382-84)83.
È l’inizio del discorso che Catone tiene ai suoi soldati prima di inizia-
79 «Mi stanno addosso le sozze sorelle e lanciano addosso i serpenti […]». 80 Cfr. TARRANT 1976, 315, che sostiene la lezione anguinea verbera sulla base di Verg. Aen.
7,450-451, Ovid. Ibis 157, Sen. Herc. Fur. 88, Med. 961-962, Thy. 96-97, Val. Fl. 7,149, Herc. Oet. 1001-1002, e riporta due casi di confusione tra i termini anguinea e sanguinea ([Tib.] 3,4,87; Ilias Lat. 891).
81 «Spaventoso flagello! Sei un serpente che agita il capo dalla cresta irta oppure un male sco-nosciuto perfino a me» trad. in ROSSI 2000, 143, che non coglie l’elemento etimologico.
82 Fuori strada è la traduzione di CUCCIOLI MELLONI 1987, 689: «O male terribile! Sei un ser-pente, che squote il suo sporco capo irto di cresta o qualche altro male ignoto a me?».
83 «Ci inoltriamo in distese desertiche e parti infuocate della terra, dove il sole brucia e rare so-no le onde tra le sorgenti, aridi i campi brulicano di serpenti mortali».
Giancarlo Abbamonte
40
re la marcia nel deserto della Sirte. Lucano descrive senz’altro una natu-ra arida, in cui il verbo finale squalent fa riferimento appunto allo squal-lore polveroso del paesaggio desertico e privo d’acqua; tuttavia, il verbo, come già in Seneca, compare in riferimento ai serpenti che infestano la zona, in quanto Lucano richiama l’etimologia di squaleo e i riflessi luc-cicanti dei dorsi dei serpenti numerosi84.
In un altro passo di Lucano ritorna l’uso etimologico del participio, ma questa volta non in riferimento ad un serpente: Sic Libycus densis elephans oppressus ab armis / omne repercussum squalenti missile tergo / frangit et haerentis mota cute discutit hastas (Lucan 6,208-210)85. Lu-cano sta qui descrivendo una scena di battaglia, in cui un elefante è at-taccato da tutti i lati e colpito da lance, riesce a spezzare tutte le armi grazie alla sua pelle rugosa. Per definire la qualità e la durezza di questa pelle Lucano ricorre al participio squalenti che conserva un significato ambiguo, perché da un lato esso può fare riferimento al fatto che la pelle dell’elefante sia sporca e piena di polvere (ʽpolverosoʼ, ʽsporcoʼ), ma dall’altro allude anche alla sua durezza, prodotto della forte rugosità del-la superficie, che mette l’elefante al riparo dai colpi di arma da lancio86.
L’ultimo autore di questo periodo che si prenderà in considerazione è Silio Italico87, nel quale si incontrano 26 occorrenze di squaleo e dei suoi derivati così ripartite: il sostantivo squalor ricorre tre volte in acce-zione negativa88, l’aggettivo squalidus ha due occorrenze, che sono ne-gative89, il verbo squaleo ricorre quattro volte e solo in senso negativo90,
84 Anche BADALÌ 1988 traduce squalent con “brulicano”, mentre WICK 2004, 147, pur richia-mando Ovid. Met. 14,410, ritiene, con MORFORD 1967, 10 nota 2, che qui possa esserci anche un’ipallage per squalida arva.
85 «Così, l’elefante libico, pressato da un nugolo di armi, spezza tutti i dardi che ribattono sul suo rugoso dorso e si squote di dosso con un movimento della pelle le lance conficcate».
86 Resta ambiguo l’uso del verbo squalebant in Lucan. 9,624-628, in cui il verbo, riferito agli arva, sembrerebbe avere un significato negativo simile a Lucan. 1,205-206 e 5,39, ma spinge alla cautela il fatto che gli arva siano quelli appartenenti alla Phorcynidos Medusae. Restano legati al significato negativo la traduzione di BADALÌ 1988, 491 (“si estendono desolati”) e il commento di WICK 2004, 251.
87 Pur mostrando un uso assai interessante di squaleo, si tralasceranno i poeti Stazio e Valerio Flacco, che esulano dalla presente ricerca. Le occorrenze del verbo squaleo nelle loro opere saran-no esaminate in un altro studio.
88 Cfr. Sil. Ital. 1,631; 3,541;5,440. I dati riferiti qui e di seguito sono tratti da WACHT 1989, II, 1055.
89 Cfr. Sil. Ital. 7,277 e 8,381, riferiti a due paludi. 90 Cfr. Sil. Ital. 4,251 (squalent a pulvere crines: uso quasi etimologico al negativo); 5,37 (la-
cus squalebat); 10,511 (squalebat barba); 14,591 (squalebat tellus).
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
41
mentre più complessa è la posizione del participio squalens, che compare 17 volte, ma non sempre con un significato negativo91.
Di seguito, sono riportate le cinque occorrenze in cui il significato è positivo: Sibilat insurgens capiti et turgentia circa / multus colla micat squalenti tergore serpens (Sil. Ital. 2,546-547)92. Silio sta descrivendo la Furia che si scaglia su Sagunto e che ha tra i capelli una massa di ser-penti guizzanti: fortemente etimologico l’uso di squalens riferito al dor-so squamoso dei serpenti93.
Anche nel secondo passo, è la Furia che richiama sulla scena un orri-bile serpente: Excitus sede, horrendum, prorumpit ab ima / caeruleus maculis auro squalentibus anguis. (Sil. Ital. 2,584-585)94.
Presso la tomba di Zacinto, eroe eponimo della città di Sagunto e amico di Ercole95, che aveva costruito la tomba del compagno nei pressi della città spagnola, la Furia evoca un orribile serpente ceruleo a mac-chie d’oro96.
In questo caso, la iunctura di Silio, auro squalentibus, costituisce un preciso richiamo a tre passi di Virgilio, che si riferiscono rispettivamente alle macchie del pelo dell’ape regina e al riflesso prodotto dal rilievo d’oro nelle armature di Terone e Turno97: a differenza di Virgilio, però, Silio utilizza squalens in senso fortemente etimologico e lo riferisce ad un serpente. In questo modo, la iunctura virgiliana (auro squalentibus) è
91 Questi i dodici luoghi in cui compare con un significato negativo: Sil. Ital. 1,83 (squalenti-
bus umbris); 1,211 (campis squalentibus); 1,674 (squalentia corpora); 2,668 (squalentem co-mam); 3,275 (squalentia barba); 3,655 (squalentes campi); 4,374 (squalentes campos); 6,405 (squalentem crinem); 6,428 (coma squalente); 8,475 (squalente campo); 10,227-228 (pulvere lu-cem squalentem etimol. negat.); 13,391 (squalentem introitum).
92 «Sibila levando il capo e, ingrossata per il collo rigonfio, guizza una massa di serpenti dal dorso squamoso».
93 Cfr. ERNESTI 1791, I, 108 ad l.: «Squalentes tergum in serpentibus est squamosum», confermato dal più recente SPALTESTEIN 1986-1990, I, 160, ad Sil. Ital. 2,547: «Squalenti renvoie aux écailles du serpent». Inoltre, SPALTESTEIN 1986-1990, I, 160 ad Sil. Ital. 2,546, osserva che la presenza di serpenti nelle Furie è un elemento tradizionale già nelle opere greche, che però è stato assai evidenziato dai poeti latini.
94 «Risvegliato dalla dea, balza fuori dalle profondità della sua tana (visione orribile!) un ser-pente ceruleo, con macchie rilucenti d’oro».
95 Cfr. Sil Ital. 1,273 sgg. 96 ERNESTI 1791, I, 110, ad l., ricorda opportunamente che gli antichi consideravano i serpenti
come genii locorum, mentre SPALTESTEIN 1986-1990, I, 165 ad Sil. Ital. 2,584, raduna i passi che si riferiscono a questo motivo letterario in Virgilio e Silio.
97 Cfr. Verg. Georg. 4,90-91, Aen. 10,314 e 12,87, riportati supra e ricordati come modello di Silio nei commenti di ERNESTI 1791, I, 108, e RUPERTI 1795, I, 154, ma solo in apparato.
Giancarlo Abbamonte
42
richiamata, ma in un contesto in cui è evidente l’uso etimologico, come se Silio abbia qui voluto prendere le distanze da Virgilio, che aveva riferito squalens in senso traslato a qualcosa di diverso da animali forniti di squame, e da serpenti in particolare98.
Nel terzo passo, il verbo è adoperato in una similitudine: Quantus per campos populatis montibus actas / contorquet silvas squalenti tergore serpens / et late umectat terras spumante veneno (Sil Ital. 3,208-210)99.
Giunto in sogno ad Annibale, Mercurio gli prospetta le conseguenze della sua spedizione e lo paragona ad un enorme serpente che distrugge la natura attorno a sé: Silio riprende qui la iunctura del primo passo e mantiene un uso fortemente etimologico di squalens, che si riferisce alla squamosità del dorso del serpente.
Le ultime due occorrenze del verbo fanno riferimento ad apparizioni divine: Vidi, crede, Iovem. Nec me mutata fefellit / forma dei, quod squalentem conversus in anguem / ingenti traxit curvata volumina gyro (Sil. Ital. 13,642-644)100.
Pomponia, la madre di Scipione, rivela al figlio che suo padre era Giove in persona, il quale trasformatosi in serpente possedette la donna: anche qui Silio ricorre ad un uso etimologico di squalens che fa riferi-mento allo spaventoso corpo del serpente ricoperto di squame101.
Dumque ea confuso percenset murmure vulgus, / ecce per obliquum caeli squalentibus auro / effulgens maculis ferri inter nubila visus / an-guis et ardenti radiare per aera sulco (Sil. Ital. 15,138-141)102. Silio de-scrive uno dei segni favorevoli che Giove Capitolino invia ai Romani: un enorme serpente brillante che attraversa il cielo103. Anche in questo
98 SPALTESTEIN 1986-1990, I, 165, ad Sil. Ital. 2,585, ricorda il solo intertesto delle Geor-
giche e riduce la scelta siliana ad un’endiadi abituale nel poeta (lo studioso rimanda alle sue osser-vazioni in SPALTESTEIN 1986-1990, I, 144, ad Sil. Ital. 2,401: nodis auroque).
99 «Come il serpente che, dopo aver sterminato le montagne, lungo i campi distrugge i boschi con il suo dorso squamoso e bagna le terre di spumante veleno per largo tratto».
100 «Credimi, ho visto Giove: non mi trasse in inganno il suo aspetto mutato, ché trasformatosi in uno squamoso serpente trascinò in una grande voluta le sue spire ricurve».
101 SPALTESTEIN 1986-1990, II, 261, ad Sil. Ital. 13,642, ricorda gli altri personaggi politici (Alessandro Magno e Augusti), che secondo la tradizione sarebbero stati concepiti dall’unione delle loro madri con divinità in forma di serpente.
102 «Mentre il popolo valuta queste parole con un confuso mormorio, ecco che attraverso il cielo un serpente brillante di macchie d’oro splendenti fu visto passare in mezzo alle nuvole e tracciare una scia di fuoco nell’aria».
103 RUPERTI 1795, II, 424, ad l., ricorda gli omina in forma di serpente presenti in Silio (2,584 sgg.; 4,476; 16,52 sgg.); ERNESTI 1791, I, 213-14, menziona Liv. 26,19 come fonte per questo
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
43
caso, Silio ripete la iunctura virgiliana auro squalentibus già usata in 2, 584-585104 e mantiene l’uso etimologico di riferire squalens ad un ser-pente, sebbene si tratti di un fenomeno celeste105. Si nota, però, in questo caso che le macchie dorate producono sicuramente un effetto di splendo-re e luminosità, come indica il verbo effulgens, e ciò induce a ritenere che in questo passo, unico in Silio, prevalga un’interpretazione di squa-lens legata al riflesso luminoso della pelle piuttosto che alla sua squamo-sità.
In conclusione, Silio Italico utilizza solo il participio squalens nel si-gnificato positivo di ʽsquamosoʼ, ʽsplendenteʼ, e lo riferisce sempre a serpenti (veri o celesti), attenendosi in questo modo all’etimologia del verbo a squama, che era già presente a Virgilio; in due casi vi è un’allu-sione, forse polemica, all’uso fatto da Virgilio, in quanto Silio recupera la iunctura virgiliana auro squalentibus, ma la attribuisce a serpenti, mentre manca nei Punica un uso traslato di squalens in riferimento alla scabrosità e ai riflessi di vesti e armature. Questo atteggiamento si in-quadra in un comportamento rispettoso del pensiero di Cornuto, che ab-biamo visto già nel caso di multa nocte e del significato di ingluvies.
In proposito, può essere indicativo il fatto che in un passo Silio ricor-ra a squama per indicare le parti di un’armatura, ma non faccia uso del verbo squaleo quanto ad aspero per indicare l’effetto dello sbalzo: Lori-cam induitur; tortos huic nexilis hamos / ferro squama rudi permixtoque asperat auro (Sil. Ital. 5,140-141)106. È la scena della vestizione del con-sole Flaminio prima di affrontare Annibale al Trasimeno: la sua corazza contiene scaglie (squama) di ferro misto ad oro, cui sono attaccati dei chiodi ritorti paragonati ad ami (hamos)107. Quest’insieme non rende uniforme la superficie della corazza e d’altronde la presenza delle parti in oro richiama l’immagine virgiliana delle armatura di Terone e di Tur-
episodio, mentre SPALTESTEIN 1986-1990, II, 349, ritiene che l’episodio sia un’invenzione di Silio e cita Verg. Aen. 2,692 e Liv. 9,35,7, solo per alcune espressioni analoghe a quelle che ricorrono in Silio.
104 Vd. supra. 105 Nella spiegazione del passo, MARTIN - DEVALLET 1992, 140 nota 2, osservano che si tratta
dello stesso serpente, in cui si era trasformato Giove per visitare la madre di Scipione (vd. supra Sil. Ital. 13,642-644).
106 «Indossa la corazza: ad essa le scaglie sono annodate ad uncini ritorti e sono rese ruvide da ferro non lavorato misto ad oro».
107 Questo particolare dell’armatura è presente anche in Verg. Aen. 3,467 (loricam consertam hamis auroque trilicem): cfr. SPALTESTEIN 1986-1990, I, 348 ad Sil. Ital. 5,140.
Giancarlo Abbamonte
44
no in cui era presente lo sbalzo dell’oro, indicato dall’espressione auro squalentem, che era stata ripresa da Silio in due scene di serpenti. Tutta-via il poeta dei Punica evita, in questo caso, il verbo squaleo e ricorre ad aspero, che è usato solo qui all’interno del poema con questa acce-zione108. La rarità dell’uso del verbo e le iuncturae virgiliane inducono a ritenere che questa scelta non sia stata casuale e che Silio abbia voluto a tutti i costi evitare l’uso metaforico di squaleo in riferimento alle arma-ture e alle corazze, che era stato invece adottato da Virgilio. Il metodo con cui Silio procede in questo caso non è molto diverso da quello che si era visto per il significato di ingluvies, in cui il poeta aveva esplicita-mente richiamato i versi virgiliani e insistito sull’interpretazione che identificava ingluvies con venter; nei Punica la iunctura virgiliana auro squalentibus torna in due occasioni, ma si riferisce sempre a serpenti, secondo un uso etimologico del verbo squaleo, e non è mai adoperato in relazione a parti di vesti umane: ciò in accordo con l’esegesi proposta da Cornuto.
Nel passaggio dai poeti di età flavia a quelli della Tarda Antichità si osserva una tendenza generale a considerare i poemi virgiliani un model-lo di perfezione: nel corso dei secoli erano lentamente caduti tutti gli ele-menti di polemica che avevano caratterizzato l’esegesi virgiliana nella sua fase iniziale. Questo “consolidamento” del giudizio positivo su Vir-gilio si rispecchia anche nell’uso del verbo squaleo da parte dei poeti, che hanno ormai messo da parte il dibattito del I sec. d.C. riferito da Gellio ancora nel corso del II sec. d.C.
Perciò, accanto ad una prevalenza del significato negativo (“essere sporco”, “essere polveroso”), secondo un trend che era già stato osserva-to da Gellio, si può notare come il verbo sia ormai usato nel significato positivo di “essere ruvido”, “essere splendente”, secondo le direttive in-dicate dall’intertesto virgiliano, mentre è assente l’interpretazione restrit-tiva proposta da Cornuto, che escludeva l’uso positivo in riferimento a vestiti. Un caso abbastanza evidente di questo uso virgiliano di squaleo è offerto da Claudiano, come mostrano i seguenti passi, Paneg. dictus
108 È indicativo in proposito che il commento di RUPERTI 1791, vol I, 347, ad l., porti a con-
fronto passi in cui compare l’aggettivo asper e non il verbo aspero (cfr. Verg. Aen. 5,267; Ovid. Met. 12,235; 13,700-701; Sil. Ital. 2,431; 11,277), mentre SPALTESTEIN 1986-1990, I. 348 ad Sil. Ital. 5,140 certifica in qualche modo quest’interpretazione semplicistica dell’uso di aspero in Si-lio: «Le TLL 2,827,11 cite le vers 141 pour asperare comme synonime de acuere, mais ce verb y reprend l’idée de aspera 2,432».
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
45
Probin. et Onor. 177-182: Laetatur veneranda parens et pollice docto iam parat auratas trabeas cinctusque micantes stamine, quod molli tondent de stipite Seres frondea lanigerae carpentes vellera silvae, et longum tenues tractus producit in aurum filaque concreto cogit squalere metallo109.
La madre dei due consoli, orgogliosa del riconoscimento guadagnato dai propri figli, si mette all’opera e fila una splendida veste consolare, in cui unisce dell’oro al tessuto: il verbo squaleo indica in questo caso lo sbal-zo che la presenza di oro duro nella trama produce sulla superficie liscia del tessuto, ma allude anche allo splendore del riflesso dorato rispetto al resto del tessuto. In questo passo, Claudiano ha accolto il suggerimento virgiliano di riferire squaleo a tessuti, ma sembra andare perfino oltre le parole di Virgilio, in quanto l’effetto di sbalzo o luminosità non è pro-dotto dal riflesso di un metallo su una tunica o nel contesto di un’arma-tura, ma dalla trama di una veste morbida, in cui il tessuto è misto a oro puro110.
Il secondo passo è tratto da una raffinata scena mitologica all’interno di un epitalamio, in cui compare Venere: Umbratura deam retro sinua-tur in arcum / belva; tum vivo squalentia murice terga / purpureis molli-ta toris (Claud. Epith. de nupt. Honor. 149-151)111. In questa delicata immagine mitologica, Venere entra navigando in una grotta, mentre una
109 «L’anziana madre si rallegra e con mano esperta già va preparando la trabea intessuta di fili
d’oro e cinture dall’ordito rilucente, che i Seri ricavano dai morbidi tronchi, cogliendo la lana ve-getale del bosco che la produce; va poi filando una striscia di stoffa sottile con un lungo ordito d’oro e costringe il tessuto ad accogliere lo sbalzo dell’oro intrecciato».
110 Sono debitore a GIOSEFFI 1999-2000, 111-14, in part. 114, dell’idea che Claudiano abbia usato la iunctura squalere metallo per entrare nel dibattito avviato da Cornuto e che il poeta abbia spinto il dibattito ad un punto sconosciuto a Cornuto, Silio e Gellio, in quanto ha applicato squale-re a vesti morbide che non vengono a contatto con armature. Lo studioso si è soffermato con fi-nezza sull’espressione claudianea squalere metallo, giungendo alla conclusione che essa sia stata adoperata per evitare l’imbrazzante formula auro squalere su cui si era tanto dibattuto, mentre manca dall’analisi di Gioseffi un’analisi del ruolo che l’elemento etimologico aveva avuto nella proposta di Cornuto, accolta da tutti i poeti di I sec. d.C. e bellamente trascurata da Claudiano.
111 «Per fare ombra alla dea, la belva si piega ad arco; poi, le spalle, rese ruvide da conchiglie di murice vive, sono ammorbidite da un letto di porpora: voluttuosa, Venere naviga in questa grot-ta».
Giancarlo Abbamonte
46
belva ammansita l’accoglie: nella descrizione si osserva che le spalle so-no ricoperte di una veste di conchiglie, che allude alla sua origine dalla spuma del mare e che questa copertura produce l’effetto di scabrosità espresso dal participio squalentia: inoltre, le conchiglie sono murici, cioè produttrici di porpora, e infatti subito dopo il poeta accenna a letti ricoperti di porpora. Anche in questo passo, il verbo squaleo conserva il significato di “essere scabroso”, “essere ruvido”, ma non ha alcun richia-mo ai rettili, né è applicato alla descrizione di metalli misti in forma di scaglie, ma di vesti.
In Claudiano si assiste, quindi, ad un’estensione del significato positi-vo di squaleo, che fa riferimento alla scabrosità o alla luminosità in chia-ve metaforica: inoltre, a differenza di Virgilio, l’uso del verbo non è li-mitato a superfici che vengono a contatto con metalli e a forma di sca-glie, ma si estende anche all’intreccio di metalli e conchiglie con tessuti e materiali morbidi. Una tale accezione non è registrata dai commentato-ri di Virgilio e dai lessicografi coevi o posteriori al poeta di Alessandria, in quanto il loro dibattito si era fossilizzato sulle posizioni che si erano venute fissando intorno al II d.C. – come si è già detto, per quanto ne sappiamo, commentatori e lessicografi a partire da Nonio, conoscono questo dibattito solo attraverso le parole di Gellio.
In conclusione, dal confronto tra i testi erudito-grammaticali e quelli poetici post-virgiliani di primo secolo d.C. si osserva una decisa limita-zione nell’uso di squaleo e dei suoi derivati. Mentre l’aggettivo squali-dus e il sostantivo squalor conservano costantemente il significato nega-tivo di ʽsporciziaʼ, ʽsporcoʼ, ʽpolverosoʼ, il verbo squaleo e il participio presente squalens dànno una netta prevalenza al significato negativo, ma non mancano casi a partire da Ovidio e dalle tragedie di Seneca, in cui essi conservano il significato positivo di “essere ruvido”, “brulicare”, ma anche “risplendere”, “riflettere”. Questa bipartizione tra squaleo-squa-lens e squalor-squalidus riproduce quella differentia che il commento di Serv. (+ SD) a Georg. 4,91 aveva fatto risalire ad una doppia etimologia di squaleo, a squamma e a squalore: la prima permetteva un uso positi-vo del verbo, la seconda invece imponeva un uso meramente negativo del sostantivo squalor, considerato all’origine dell’etimologia.
Per quanto riguarda la coppia squaleo-squalens, tutti i casi in cui essi hanno un significato positivo all’interno delle opere di Ovidio, Seneca, Lucano e Silio, nascondono un richiamo etimologico alle squame e al mondo animale: in particolare, quando occorre questo significato di
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
47
squaleo e squalens, compaiono sulla scena serpenti o mostri in forma di serpente, e non mancano intertesti virgiliani. Questo significa che la con-nessione etimologica tra squaleo e squama a proposito dell’uso positivo del verbo e la sua origine nella poesia virgiliana erano ben note. Inoltre, Ovidio dimostra che esse erano state rilevate ben prima delle osservazio-ni di Cornuto.
Tuttavia, la presenza dell’allusione etimologica costante e riferita ai serpenti in tutti questi autori e soprattutto in un poeta come Silio Italico, induce a ripensare la posizione di Cornuto, che forse era un po’ più com-plessa di come essa ci sia stata presentata da Gellio. È verisimile che tale etimologia fosse accolta anche da Cornuto, il quale condannava invece l’uso traslato proposto da Virgilio del verbo in riferimento allo sbalzo, alla scabrosità e allo splendore di tuniche e armature. In effetti, il riferi-mento di squaleo / squalens alle armature è assente in Ovidio, Seneca, Lucano e in Silio.
Sulla base dei passi di questi autori, è verisimile pensare che la critica di Cornuto non riguardasse l’uso etimologico di squaleo / squalens, ma solo l’estensione per traslato ad oggetti inanimati, differenti da animali, e in particolare ad armature e parti di vestiario in cui fossero presenti metalli. In proposito, non è casuale che Gellio non riferisca tra i passi criticati da Cornuto i due delle Georgiche in cui il verbo compare con un significato positivo e in riferimento a due animali, api e lucertole, ma di-scuta solo i passi dell’Eneide in cui il participio è usato metaforicamente in riferimento a tuniche e armature. Sappiamo che l’argomento etimolo-gico era uno dei criteri più seguiti dagli Stoici e dai grammatici per sta-bilire la proprietas verborum, e Gellio, quasi riecheggiando le parole di Cornuto, dichiara che l’accusa nei confronti di Virgilio era tanquam si non conveniret dicere “auro squalentem” (Gell. 2,6,4), cioè l’improprie-tà linguistica di usare questo verbo per indicare lo sbalzo dell’oro.
Una conferma di tale lettura dell’esegesi di Cornuto viene dall’ultimo passo dei Punica, in cui in un contesto analogo di descrizione di armatu-re che richiama anche l’intertesto virgiliano sotto accusa (auro squalen-tem), Silio ricorre al verbo aspero per segnalare lo sbalzo dei diversi me-talli.
Con un gioco di specchi e rifrazioni, che sarebbe degno dell’uso di squaleo, si è provato ad illustrare come alcuni passi di Silio Italico (ma anche di altri poeti di I. sec. d.C.) aiutino a comprendere meglio le pro-poste esegetiche di Cornuto e come queste, a loro volta, servano a farci
Giancarlo Abbamonte
48
contestualizzare alcune scelte linguistiche ed insistenze di Silio Italico nel dibattito sui poemi virgiliani della sua epoca. Inoltre, gli intertesti si-liani portano ulteriore luce sull’origine delle singole spiegazioni di Cor-nuto che ritroviamo in Gellio, nei glossari e nei commenti di Servio e di SD e permettono di valutare il materiale cornutiano che questi tardi commentatori ebbero a disposizione. Dal confronto con gli intertesti siliani, ma anche con Ovidio, si è giunti alla conclusione che sia nel caso della lezione multa nocte, sia per ingluvies sia per l’uso etimologico di squaleo Silio non è l’iniziatore del dibattito, ma aveva preso posizione su questioni che erano talvolta precedenti anche all’opera di Virgilio (vd. la posizione di Varrone su ingluvies) o si erano generate nei primi anni di pubblicazione dei poemi del Mantovano.
Infine, l’esame dei frammenti di Cornuto ha permesso di precisare la natura del debito contratto da Silio nei confronti dei poemi virgiliani: at-traverso i pochi passi delle opere virgiliane per cui conosciamo l’esegesi proposta da Cornuto, si osserva che i Punica non riflettono un’adesione tout court alla poetica virgiliana – una sorta di “virgilianesimo puro”, cui Silio non avrebbe potuto aderire, perché non è mai esistito. Le scelte di Silio rispecchiano, piuttosto, una lettura virgiliana filtrata attraverso l’in-terpretazione di Cornuto.
Bibliografia
ABBAMONTE G. 2012: Diligentissimi uocabulorum perscrutatores. Lessico-grafia ed esegesi dei testi classici nell’Umanesimo romano di XV secolo, Pi-sa.
BADALÌ R. 1988: Lucano, Guerra civile, Torino. BELLANDI F. 2003: “Anneo Cornuto nelle Satire e nella Vita Persi”, in
GUALANDRI - MAZZOLI 2003, 185-210. CAVAZZA F. 1985: Aulo Gellio, Le notti attiche, libri I-III, Bologna. CONTE G. B. 2009: P. Vergilius Maro, Aeneis, recensuit G.B.C., Berlin-New
York. CUCCIOLI MELLONI R. 1987: L. Anneo Seneca, Tragedie, a cura di G. Giar-
dina e L. C. M., Torino. CUGUSI P. 2003: “Lucio Anneo Cornuto esegeta di Virgilio”, in GUALANDRI
- MAZZOLI 2003, 211-44. DELLA CORTE F. 1986: Publio Virgilio Marone, Le Georgiche, 2 voll., a cura
di F. d. C. Genova.
Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto
49
ERNESTI I. CHR. THOPH. 1791: Caii Silii Italici Punicorum Libri Septemde-cim varietate lectionis et commentario perpetuo illustr. a I. Chr. T. E., 2 voll., Leipzig.
ERNOUT A. 1937: Pétrone, Le Satiricon, texte établi et traduit par. A. E., Paris. ERREN M. 2003: P. Vergilius Maro, Georgica, Band 2, Kommentar, Heidel-
berg. FORBIGER A. 1872: P. Vergili Maronis Opera ad optimorum librorum fidem
edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Ver-gili vita et carminibus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Al-bertus Forbiger pars I Bucolica et Georgica editio quarta retractata et val-de aucta, Lipsiae.
FORBIGER A. 1873: pars II Aeneidos lib. I-VI [...], Lipsiae. FORBIGER A. 1875: pars III Aeneidos lib. VII-XII, Carmina minora, Disserta-
tio de Vergilii vita et carminibus atque indices [...], Lipsiae. FRERE H. - IZAAC H.J. 1961: Stace, Silves (Livres IV-V), Paris. GEYMONAT M. 1984: s.v. “Cornuto (L. Annaeus Cornutus)”, in EV vol. I, Ro-
ma, 897-898. GEYMONAT M. 2008, P. Vergilii Maronis, Opera, edita anno MCMLXXIII
iterum recensuit M.G., Roma. GIBSON B. 2006: Statius, Silvae 5: Edited with Introduction, Translation and
Commentary by B.G., Oxford. GIOSEFFI M. 1999-2000: “Spigolature Claudianee (Virgilio, Claudiano e la
tradizione di commento a Virgilio)”, Voces 10-11, 111-14. GOETZ G. 1888-1923: Corpus Glossariorum Latinorum, 5 voll., Leipzig. GUALANDRI I. - MAZZOLI G. 2003: Gli Annei. Una famiglia nella storia e
nella cultura di Roma imperiale (Atti del Convegno Internazionale di Mila-no-Pavia, 2-6 maggio 2000), a cura di I. G. - G. M., Como.
HEYNE C. G. 1821: Publii Virgilii Maronis opera varietate lectionis et perpe-tua adnotatione illustrata a Christian Gottlieb Heyne... accedit index uber-rimus, 4 voll., London.
KASTER R.A. 1980: “Macrobius and Servius. Verecundia and the Gram-marian’s Function”, HSPh 84, 219-62.
MARTIN M. - DEVALLET G. 1992: Silius Italicus, La guerre Punique, vol. IV, texte établi et traduit par M. M. et G. D., Paris.
MAZZARINO A. 1955: Grammaticae Romanae Fragmenta aetatis Caesareae, collegit recensuit A. M., volumen primum, Torino.
MC ALBANY J. 2004: rec. a RAMELLI 2003, BMCR 15.06.2004. MORFORD M.P.O. 1967: The Poet Lucan: Studies in Rhetorical Epic, London. MOST G. W. 1989: “Cornutus and the Stoic Allegoresis: A Preliminary
Report”, in ANRW II,36,3, 2014-65. MOZLEY J.H. 1961: Statius, Silvae – Thebaid I-IV, Cambridge (Mass.).
Giancarlo Abbamonte
50
MYNORS R.A.B. 1990: Virgil, Georgics, edited with a commentary by R. A. B. M., Oxford.
NOCK A.D. 1931: s.v. “Kornutos”, in RE Suppl. V, Stuttgart, 995-1005. RAMELLI I. 2003: Anneo Cornuto, Compendio di teologia greca, a cura di I.
R., Milano. RAMIRES G. 1996: Servio, Commento al libro IX dell’Eneide di Virgilio. Con
le aggiunte del cosiddetto Servio Danielino, a cura di G.R., Bologna. REBERT H. F. 1933: “On Vergil Aeneid IX, 347 f.”, CJ 28, 679-80. REPPE R. 1907: De L. Annaeo Cornuto, Diss. Leipzig. RIBBECK O. 1894-1895: Publii Vergilii Maronis opera apparatu critico rec.
O. R.. 4 voll., Leipzig. RICHTER W. 1957: Vergil, Georgica, hrsg. und erklärt von W.R., München. RIVERO L. 2011: Publio Virgilio Marón, Eneida (Libros VII-IX), texto latino,
traducción y notas L. Rivero García, J.A. Estévez Sola, M. Librán Moreno, A. Ramírez de Verger, vol. III Madrid.
ROSSI E. 2000: Ercole sull’Eta, traduz. e comm. a cura di E.R., Milano. RUPERTI G.A. 1795: Caii Silii Italici Punicorum Libri Septemdecim varietate
lectionis et commentario perpetuo illustr. a G. A. R., 2 voll., Göttingen. SCAFFAI M. 2006: La presenza di Omero nei commenti antichi a Virgilio, Bo-
logna. SETAIOLI A. 2004: “Interpretazioni stoiche ed epicuree in Servio e la tradizio-
ne dell’esegesi filosofica del mito e dei poeti a Roma (Cornuto, Seneca, Fi-lodemo)” I-II, in IJCT 10, 335-76; 11, 3-46.
SPALTESTEIN F. 1986-1990: Commentaire des Punica de Silius Italicus, 2 voll., Genève.
TARRANT R.J. 1976, Seneca, Agamemnon, Cambridge. TATE J. 1929: “Cornutus and the Poets”, CQ 23, 41-45. THILO G. 1881 - 1887: Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina
commentarii, recensuerunt G. Thilo et H. Hagen, 3 voll., Lipsiae [rist. anast. Hildesheim 1986].
TIMPANARO S. 1986: Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma. TIMPANARO S. 1991: Virgilianisti antichi e tradizione indiretta, Firenze. TORRE C. 2003: Cornuto, Seneca, i poeti e gli dèi, in GUALANDRI - MAZ-
ZOLI 2003, 167-84. VOLLMER F. 1898: P. P. Statius, Silvarum libri, hrsg. von F. V., Leipzig. WACHT M. 1989: Concordantia in Silii Italici Punica, 2 voll., Hildesheim. WICK C. 2004, M. Annaeus Lucanus, Bellum civile. Liber IX. Kommentar,
München-Leipzig. ZETZEL J.E.G. 1984: Latin Textual Criticism, Salem (NH).
Indice
Fabio Stok Introduzione
7
Giancarlo Abbamonte Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto nell’esegesi posteriore e nei poeti del I sec. d.C.
15 Daniel Vallat Per transitum tangit: allusions, sens cachés et réception de Virgile dans le commentaire de Servius
51 Maria Luisa Delvigo Servio e i veteres
83
Caterina Lazzarini Servio: lezioni di stile. Citazioni di poeti fra esegesi e formazione
101 Olga Monno Saggio di scavo nella bibliotheca di un grammatico: Servio, Virgi-lio e Stazio
125
Giampiero Scafoglio Servio e i poeti romani arcaici
145
Fabio Stok Servio e la metempsicosi
165
Jean-Yves Guillaumin Nursia e i Gracchi (Servio ad Aen. 7, 715)
193
Liliana Pégolo La exégesis serviana acerca del carácter non enarrabile del escudo de Eneas
205
452
Carlo Santini Tracce serviane negli scolii alla Tebaide di Lattanzio Placido Giuseppe Ramires
219
Il valore delle aggiunte dei mss. a nella costituzione del testo dei Commentarii virgiliani di Servio
231
Stefano Poletti La tradizione delle interpolazioni a Servio tipiche del Reg. lat. 1495
257 Monique Bouquet Le Servius de Cristoforo Landino, d’après le commentaire aux Bu-coliques de Virgile
293
Carlo M. Lucarini Per la storia delle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato: dagli esemplari tardo antichi alla fase insulare e carolin-gia a Luxeuil
315
Luigi Pirovano Note filologiche al ‘nuovo’ Tiberio Claudio Donato
341
Massimo Gioseffi Interpretatio e paraphrasis da Seneca a Tiberio Claudio Donato
361 Marisa Squillante Talem monstrare Aenean debuit, ut dignus Caesari parens praebere-tur: Augusto in Tiberio Claudio Donato
391
Alice Daghini La brevitas nelle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato
401 APPENDICE: Il carteggio su Servio di Timpanaro – Ramires
429
Raffaella Tabacco Timpanaro, il latino tardo e gli strumenti elettronici
431
Paolo Esposito Servio, Timpanaro, Ramires e il metodo della filologia per litteras
443
Indice 451
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di novembre 2013
FINITO_000_pag.edit. 14/11/13 15.26 Pagina 1
Testi e studi di cultura classica
Collana fondata daGiorgio Brugnoli e Guido Paduano
Diretta daGuido Paduano, †Alessandro Perutelli, Fabio Stok
1. Giorgio Brugnoli, Foca: vita di Virgilio. Introduzione, testo, traduzione ecommento, 1983, 19952, pp. XX-58 [con due tavole fuori testo].
2. Fabio Stok, Percorsi dell’esegesi virgiliana. Due ricerche sull’Eneide,1988, pp. 200.
3. Giorgio Brugnoli, Identikit di Lattanzio Placido. Studi sulla scoliasticastaziana, 1988, pp. 82.
4. Elena Rossi, Una metafora presa alla lettera: le membra lacerate dellafamiglia. «Tieste» di Seneca e i rifacimenti moderni, 1989, pp. 154.
5. Domenico De Venuto, Il Bucolicum Carmen di F. Petrarca. Edizionediplomatica dell’autografo Vat. Lat. 3358, 1990, pp. XLVI-182.
6. Rosa Maria Lucifora, L’ablativo assoluto nella Pharsalia. Riflessioni sultesto e sullo stile di Lucano, 1991, pp. 172.
7. Nicoletta Palmieri, L’antica versione latina del «De Sectis» di Galeno(Pal. lat. 1090), 1992, pp. 236.
8. Alessandro Grilli, Inganni d’autore. Due studi sulle funzioni del prota-gonista nel teatro di Aristofane, 1992, pp. 232.
9. [Aristotele], De spiritu, a cura di Amneris Roselli, 1992, pp. 160.
10. Giorgio Brugnoli, Fabio Stok, Ovidius parw/dhvsa", 1992, pp. 218.
11. Preveggenze umanistiche di Petrarca. Atti delle giornate petrarchesche diTor Vergata (Roma-Cortona 1/2 giugno 1992), 1994, pp. 320.
12. Giorgio Brugnoli, Curiosissimus Excerptor. Gli «Additamenta» di Giro-lamo ai «Chronica» di Eusebio, 1995, pp. LX-248.
13. Carlo Santini, I frammenti di L. Cassio Emina. Introduzione, testo, tra-duzione e commento, 1995, pp. 228.
14. Tiziana Privitera, Didone mascherata: per il codice genetico di EmmaBovary, 1996, pp. 84.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 1
15. Pompei exitus. Variazioni sul tema dall’Antichità alla Controriforma, acura di Giorgio Brugnoli e Fabio Stok, 1996, pp. 260.
16. Patrizio Domenicucci, Astra Caesarum. Astronomia, astrologia e cata-sterismo da Cesare a Domiziano, 1996, pp. 194.
17. L. Iuni Moderati Columellae, Rei rusticae liber decimus (carmen de cul-tu hortorum), a cura di Francesca Boldrer, 1996, pp. 404.
18. Rosa Maria Lucifora, Prolegomeni all’elegia d’amore, 1996, pp. 192.
19. Marco Fucecchi, La teicoskopiva e l’innamoramento di Medea. Saggiodi commento a Valerio Flacco «Argonautiche» 6,427-760, 1997, pp. 300.
20. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. I Per suo richiamo, 1998, pp. 218.
21. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. II I tempi cristiani di Dante, 1998,pp. 212.
22. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. III Dante Filologo: l’esempio diUlisse, 1998, pp. 134.
23. Nicoletta Palmieri, L’eroe al bivio: modelli di “mors uoluntaria” in Sene-ca tragico, 1998, pp. 204.
24. Giorgio Brugnoli, Roberto Rea, Studi leopardiani, 2001, pp. 126.
25. Fabio Stok, Studi sul Cornu Copiae di Niccolò Perotti, 2002, pp. 240.
26. Lucio Anneo Seneca, Medea, introduzione, traduzione e commento diAnnalisa Németi, con un saggio di Guido Paduano, 2003, pp. 306.
27. Alessandro Perutelli, Prolegomeni a Sisenna, 2004, pp. 144.
28. Silvia Paponi, Per una nuova edizione di Nevio comico, 2005, pp. 172.
29. Emanuele Narducci, Cicerone e i suoi interpreti. Studi sull’opera e lafortuna, 2004, pp. 444.
30. Giorgio Brugnoli, Studi di filologia e letteratura latina, a cura di SilviaConte e Fabio Stok, 2004, pp. 252.
31. Hinc Italae gentes. Geopolitica ed etnografia italica nel Commento diServio all’Eneide, a cura di Fabio Stok e Carlo Santini, 2004, pp. 314.
32. Gli scolii a Lucano ed altra scoliastica latina, a cura di Paolo Esposito,2004, pp. 204.
33. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, I, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2005, pp. 210.
34. Giorgio Brugnoli, Fabio Stok, Studi sulle Vitae Vergilianae, 2006,pp. 160.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 2
35. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, II, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2005, pp. 110.
36. Tiziana Privitera, Terei puellae: metamorfosi latine, 2007, pp. 104.
37. «Vediamo se sei filologo….». Studi, interessi e curiosità di Giorgio Bru-gnoli, a cura di Riccardo Scarcia e Fabio Stok, 2007, pp. 158.
38. Una guerra in Colchide. Valerio Flacco, Argonautiche 6,1-426, introdu-zione, traduzione e commento a cura di Marco Fucecchi, 2006,pp. 392.
39. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, III, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2007, pp. 172.
40. Quinto Ennio, Le opere minori. Introduzione, edizione critica deiframmenti e commento a cura di Alessandro Russo, 2007, pp. 300.
41. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, IV, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2008, pp. 192.
42. Esegesi dimenticate di autori classici, a cura di Carlo Santini, FabioStok, 2008, pp. 404.
43. Agostino a scuola: letteratura e didattica, a cura di Fabio Gasti e Mari-no Neri, 2009, pp. 194.
44. Alessio Umbrico, Terenzio e i suoi nobiles. Invenzione e realtà di uncontroverso legame, 2010, pp. 136.
45. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, V, a cura diSergio Audano, 2010, pp. 168.
46. Sub Imagine Somni: Nighttime Phenomena in Greco-Roman Culture,edited by Emma Scioli and Christine Walde, 2010, pp. 340.
47. Devotionis munus. La cultura e l’opera di Adamo di Brema, a cura diRiccardo Scarcia e Fabio Stok, 2010, pp. 208.
48. Vates Operose Dierum. Studi sui Fasti di Ovidio, a cura di Giuseppe LaBua, 2010, pp. 272.
49. Sedula Cura Docendi Studi sull’Anthologia Latina per / con RiccardoScarcia, a cura di Tiziana Privitera e Fabio Stok, 2011, pp. 128.
50. Lorenzo Miletti, L’arte dell’autoelogio. Studio sull’orazione 28 K di ElioAristide, con testo, traduzione e commento, 2011, pp. 230.
51. Alessandro Perutelli, Studi sul teatro latino, a cura di Guido Paduano eAlessandro Russo, 2013, pp. 190.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 3
52. Tatiana Korneeva, Alter et ipse: identità e duplicità nel sistema dei per-sonaggi della Tebaide di Stazio, 2011, pp. 250.
53. Letteratura e Civitas. Transizioni dalla Repubblica all’Impero. In ricordodi Emanuele Narducci, a cura di Mario Citroni, 2012, pp. 456.
54. Claudio Buongiovanni, Gli epigrammata longa del decimo libro di Mar-ziale, introduzione, testo, traduzione e commento, 2012, pp. 480.
55. L’addio di Medea. Valerio Flacco, Argonautiche 8,1-287, introduzione ecommento a cura di Caterina Lazzarini, 2012, pp. 282.
56. Giancarlo Abbamonte, Diligentissimi uocabulorum perscrutatores.Lessicografia ed esegesi dei testi classici nell’Umanesimo romano di XVsecolo, 2012, pp. 250.
57. Edipo. Margini, confini, periferie, a cura di Patrizia Pinotti, MassimoStella, 2013, pp. 442.
58. Sebastiano Timpanaro, Giuseppe Ramires, Carteggio su Servio 1993-2000, a cura di Giuseppe Ramires, prefazione di Fabio Stok, 2013,pp. 286.
59. Patrizio Domenicucci, Il cielo di Lucano, 2013, pp. 110.
60. Totus scientia plenus. Percorsi dell’esegesi virgiliana antica, a cura diFabio Stok, 2013, pp. 454.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 4