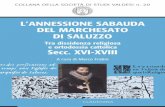Policromia delle strutture murarie. Riflessi della tecnica di costruzione a blocchi policromi nella...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Policromia delle strutture murarie. Riflessi della tecnica di costruzione a blocchi policromi nella...
POLICROMIA DELLE STRUTTURE MURARIERIFLESSI DELLA TECNICA DI COSTRUZIONE
A BLOCCHI POLICROMI NELLA CERAMOGRAFIA ETRUSCA E GRECA
di Cristina Ridi
Fra le molte peculiarità architettoniche rilevate nelle indagini più recen-ti presso l’Ara della Regina, un aspetto degno di interesse, sul piano dellatecnica costruttiva, è quello relativo alla realizzazione del muro 24, denomi-nato in letteratura “gamma”, databile entro l’inizio del VI secolo, i cui rife-rimenti stratigrafici, sono stati forniti nel contributo di Maria BonghiJovino1.
La qualificazione tipologica di tale struttura è ancora all’esame, benché,dalle analisi complessive nel perimetro del santuario, essa possa essere rite-nuta come un paramento funzionale alla statica della terrazza arcaica (Fig.1). Di tale struttura, obliterata quasi completamente in seguito alla monu-mentalizzazione della terrazza antistante al tempio nella fase dei CavalliAlati, resta tuttora a vista un filare, presso il lato sud orientale del monu-mento.
In via preliminare, è opportuno descrivere l’aspetto formale e tecnico diquest’opera muraria, che offre alcune specificità soprattutto sul piano delrapporto fra gli aspetti prettamente tettonici e quelli estetici, volti a poten-ziarne l’impatto visivo e ad offrire a chi si accostasse al santuario un’impres-sione di notevole imponenza.
La struttura venne realizzata in tecnica isodoma, con filari posati alter-nativamente per testa e per taglio: questa variante, ampiamente nota nellemurature in opera isodoma o pseudoisodoma2, aveva il vantaggio da un latodi rendere più stabile e resistente l’opera muraria, dall’altro di ottenere
1 BONGHI JOVINO, supra, pp. 7-46.2 ORLANDOS 1966, pp. 138 ss.
Cristina Ridi
peculiari effetti estetici attraverso il disegno formato dall’alternanza deigiunti e venne usata spesso anche per realizzare paramenti da riempire contecnica a sacco (Fig. 3). Il tipo canonico prevedeva l’alternanza di filari didiàtoni, che occupano tutta la larghezza della muratura e di corsi di blocchiper taglio, posati appaiati, definiti appunto suvn-duo. Nel nostro caso, lastruttura presenta un’alternanza di blocchi appaiati posti per taglio e bloc-chi per testa; questi ultimi tuttavia non occupano tutta la larghezza dellamuratura, essendovi addossati, sul lato non a vista del muro, alcuni piccoliblocchi irregolari. I conci, sebbene dotati di misure simili, non appaiono delresto perfettamente regolari, mentre l’ultimo filare, nella parte sud-orienta-le, possiede una risega a scarpa (Fig. 1).
Il muro gamma presentava un’unica facciavista a meridione (Fig. 4): sulsuo lato interno, a settentrione, si addossava infatti la gettata di argilla dellaterrazza arcaica. Qui, la porzione di muratura attinta appare grezza e carat-terizzata da blocchi irregolari e masse di argilla a sostegno soprattutto deifilari per taglio (Fig. 2).
In entrambe le porzioni di scavo nelle quali detta struttura è stata attin-ta sono stati individuati alcuni piani di vita sovrapposti e fra questi in par-ticolare un pavimento con una preparazione assai possente in pestato dimacco riportabile sulla base dei materiali della preparazione, alla secondametà del VI secolo, sovrapposta ad altri piani meno resistenti contenentimateriali databili entro l’inizio del VI. Sulla base dei dati stratigrafici e deimateriali archeologici, è stato pertanto possibile desumere per la posa diquesta struttura un terminus ante quem all’inizio del VI secolo3.
L’aspetto forse più peculiare nella realizzazione dell’opera muraria inoggetto è però la specifica ricerca coloristica ottenuta attraverso l’impiegodi pietre di natura diversa, finalizzato a potenziare l’effetto visivo propriodella tecnica di posa per testa e per taglio. Le pietre impiegate sono sedi-mentarie: roccia calcarea, (il macco locale di colore bianco), e di origine vul-canica (il tufo, nella varietà rosso e grigio-viola compatta, il noto nenfro).
L’effetto finale era quello di una scacchiera (Fig. 5), dove in particolareil nenfro viola e grigio scuro marca i filari posti per taglio, mentre il tuforosso si alterna con il macco, soprattutto nei filari posti per testa, in modotale che appare tanto perspicua la coerenza fra gli aspetti decorativi e la sta-tica stessa del muro da indurre a ritenere scarsamente probabile una sceltacasuale delle pietre di colore diverso, ma anzi a interrogarsi sulla profonda
154
3 BAGNASCO GIANNI in Tarchna IV c.s.
Policromia delle strutture murarie 155
4 WINTER 1971, pp. 78-79.5 NICHOLLS 1958-1959, pp. 53-54, 96-98; Fig. 32. Dallo schizzo ricostruttivo del
Nicholls, una torre, datata al tardo geometrico, venne costruita con uno zoccolo in conciirregolari in andesite grigia legati da argilla chiara, sormontato da filari di altezza varia-bile in blocchi squadrati in pietra bianca.
6 WINTER 1971, p. 79.
valenza della struttura sul piano formale e concettuale. Tale effetto colori-stico appare del resto peculiare nel complesso delle strutture santuariali inesame, soprattutto considerando che, sebbene in molteplici aree del tempiosi osservi l’impiego del tufo rosso in luogo del più comune macco, in nes-sun caso le murature producono una simile alternanza di pietre e colori dif-ferenti, tranne che, probabilmente, nel muro 36, che attende di essere inda-gato ma che potrebbe essere, sia strutturalmente che dal punto di vista tec-nico, apparentato al nostro.
La tendenza all’utilizzo di pietre di natura e colori contrastanti a scopodecorativo e scenografico è conosciuta largamente nel mondo greco e grecoorientale4, da cui probabilmente prese origine e dove ne sono infatti statericonosciute precoci attestazioni, come dimostrano, per citare solo un esem-pio, alcuni documenti dell’architettura militare di Smirne5. Tali ricerchedecorative nei muri in pietra, basate sul contrasto dei colori e del trattamen-to della superficie dei blocchi, trovano forse ascendenze nelle più antichecostruzioni in materiali misti, nelle quali allo zoccolo in blocchi di pietra sisovrapponeva un alzato in mattoni di fango o in legno6. L’effetto otticoveniva spesso accentuato dal trattamento differente delle superfici dei conci,dalle dimensioni, dall’altezza e dallo stile delle assise.
Tenendo conto dell’innegabile distanza fra l’originale apparenza dellestrutture architettoniche antiche e la loro restituzione moderna e della con-seguente difficoltà nel reperire confronti validi nella documentazione dispo-nibile in letteratura, si è ritenuto utile estendere la ricerca non solo alletestimonianze archeologiche, ma anche al gruppo documentale delle rap-presentazioni figurative.
Riguardo alla struttura qui all’esame, il cui studio nell’ambito dellemurature di età arcaica in area mediterranea è in corso, l’eccezionale corpusdella pittura vascolare ha infatti potuto offrire alcune suggestioni relativealle possibili valenze concettuali espresse dagli elementi coloristici e dalpeculiare effetto a scacchiera che ne definiscono il carattere in modo tantoperspicuo. In particolare, l’esame delle raffigurazioni di edifici di varia natu-ra, dotati di murature rappresentate con blocchi in colori diversi, talvolta
Cristina Ridi
niente affatto marginali sul piano semantico e narrativo della composizione,ha portato in molti casi a rilevare altresì l’occorrenza di specifiche ambien-tazioni, che forse permettono di leggere in filigrana la resa policroma di unedificio non già come la semplice aderenza a una convenzione figurativa, maprobabilmente come una scelta precisa, allusiva di un tipo di monumento,centrale per la descrizione di un evento e la comprensione del suo significa-to da parte dei fruitori antichi. È su questo aspetto in particolare che vorreisoffermarmi, prendendo in esame alcuni documenti appartenenti alla pittu-ra funeraria etrusca e alla ceramografia etrusca e greca.
Per quanto attiene in primo luogo ai documenti pittorici e ceramografi-ci d’Etruria, uno dei più antichi nel quale compare la raffigurazione di unedificio a blocchi regolari in colori diversi è rappresentato dalla celebre oino-choe della Bibliothèque Nationale, di provenienza vulcente e attribuita allascuola del Pittore della Sfinge Barbuta, databile all’ultimo quarto del VII se-colo7 (Fig. 7). Essa raffigura episodi secondo alcuni riferibili alla saga troia-na, secondo altri più generici: il fregio principale sulla spalla viene general-mente interpretato come la rappresentazione del cavallo di Troia; segue unoscontro fra armati e una parata di carri, cavalieri e fanti che sembrano uscitida una struttura in cui sono state, anche se non unanimemente, riconosciutele mura di Troia. Questa consiste in tre assise di blocchi dipinti alternativa-mente in colore paonazzo, bruno e bianco, con una resa di insieme partico-larmente vivace, il cui effetto è sottolineato dallo spuntare delle teste di trepersonaggi sulla sommità della merlatura. Dall’altro lato delle mura sembra-no uscire altri personaggi appiedati, nei quali vengono riconosciuti gli esuli,dopo la caduta di Troia. È rilevante notare come, secondo d’Agostino, lascena del cavallo, in particolare l’immagine di un guerriero che getta uncavaliere a terra, trascinandolo per i capelli, potrebbe prestarsi a una dupliceallusione: al cavallo di Troia ma anche all’agguato di Achille a Troilo8.
Il gruppo più consistente di documenti etruschi che attestano la presen-za di edifici a blocchi policromi è però relativo alla fase cronologica del 540-530 a.C. e comprende l’unico esempio nell’ambito della pittura funeraria,la Tomba dei Tori di Tarquinia, e alcuni vasi pontici, il cui legame stilisti-
156
7 Oinochoe Bibliothèque Nationale 179, ZEVI 1969, pp. 39-57; MARTELLI 1987b,p. 25 e p. 114, n. 62, scheda a pp. 279-280 con bibliografia precedente; CAMPOREALE
1989, p. 916; SZILÁGYI 1992, p. 122, n. 102; in riferimento al tipo di tecnica rappre-sentato vd. CAMPOREALE 2008, pp. 15-32, p. 21.
8 D’AGOSTINO 1985, p. 6; MARTELLI 1987b, pp. 279-280.
Policromia delle strutture murarie
co con la prima è del resto ampiamente noto9. Per la maggior parte, le sceneraffigurate hanno come tema l’agguato di Achille a Troilo.
A prescindere dalla natura dell’edificio presso il quale Achille tendel’agguato al principe troiano, la tomba dei Tori rappresenta forse il confron-to più puntuale per la struttura muraria in esame, tanto più significativo inquanto proveniente proprio da Tarquinia10 (Fig. 6). L’altare-fontana, luogodel sacrificio di Troilo, sorge sopra un basso plinto formato da due lastre,quella inferiore bianca e quella superiore rossa; esso è formato da sei assisedi blocchi, formate talvolta da quattro elementi, talvolta da tre. Nei filari sialternano irregolarmente l’azzurro, il rosso e il bianco. I blocchi sono a lorovolta sormontati da un coronamento costituito da una modanatura a trelastre, rossa, bianca e celeste. La struttura allude alla funzione della fontanaperché elemento legato al racconto tradizionale e alla simbologia connessaall’acqua, ma riflette le caratteristiche di un altare in quanto, come ormaiacquisito da tempo, l’episodio stesso dell’uccisione di Troilo da parte diAchille rappresenta sul piano iconografico e semantico, un vero e propriosacrificio umano offerto ad Apollo Timbreo e ne diviene anzi modello para-digmatico11. A tal proposito, in una lettura ideologica della rappresentazio-ne, il richiamo al sacrificio dei prigionieri e al culto di Apollo, come sotto-lineato da G. Colonna12, nonché il possibile rimando alla famiglia Spurin-nas, identificata nella figura di Achille13, potrebbe offrire, in relazione altempio dell’Ara della Regina e al ruolo svolto dalla gens degli Spurinnas
157
9 BUCCELLATO - GATTI 1978, pp. 193-200; GIULIANO 1988, p. 40.10 La bibliografia su questa tomba e sulle sue raffigurazioni, data l’eccezionalità
planimetrica e decorativa del complesso, è ovviamente vastissima: per un’ampia rasse-gna bibliografica, vd. STEINGRÄBER 1984, pp. 353-355. Vd. in particolare PALLOTTINO
1937; BANTI 1955-1956, p. 143 ss.; GIULIANO 1969, pp. 3-26, ora in GIULIANO 2001,p. 69 ss.; SIMON 1973, pp. 27-42; OLESON 1975, p. 189-200; CRISTOFANI 1976, p. 2ss., p. 3; HANNESTAD 1976, p. 50 ss.; STEINGRÄBER 2006, p. 92; per osservazioni spe-cifiche sulla raffigurazione dell’episodio mitico in ambito etrusco, e sul tipo di edificiorappresentato, vd. in particolare PRAYON 1977, pp. 181-197, pp. 182-183; per unapproccio di tipo iconologico CERCHIAI 1980, pp. 25-39; CERCHIAI 1999, pp. 115-119.
11 PRAYON 1977, pp. 181-197, pp. 182-183; CERCHIAI 1980, pp. 25-39, p. 27, pp.29-30; D’AGOSTINO 1985, pp. 1 ss.
12 COLONNA 1984, pp. 557-578, in particolare pp. 570-572; vd. inoltre HARARI
1987, p. 289; MARTELLI 1987b, pp. 279-280 e pp. 289-291; CERCHIAI 1999, pp. 115-119; NARDI 1997, pp. 443-463.
13 COLONNA 1984, pp. 557-578, pp. 570-571. Sulla valenza di matrice gentiliziaconnessa in particolare alla máchaira, vd. anche CERCHIAI 1980, pp. 25-39, pp. 37 ss.
Cristina Ridi
un’interessante suggestione, forse suffragata dalla stessa scelta formale e co-loristica di una parte del complesso santuariale, antecedente di oltre cin-quant’anni alla realizzazione dell’affresco della Tomba dei Tori.
Restando in Etruria, in un’anfora attribuita al Pittore del Sileno14, cherappresenta ancora il tema dell’agguato di Achille a Troilo (Fig. 9) compa-re nuovamente la struttura avente la funzione di fontana-altare, resa con unacampitura a quadretti che suggerisce l’idea dei blocchi regolari, con policro-mia non al suo interno, bensì nel coronamento e nel plinto. Anche in que-sto caso, tale struttura esprime l’ambivalente significato di fontana e di alta-re, come è evidenziato dalla raffigurazione presente sull’altro lato del vaso,dove la rappresentazione del sacrificio di Polissena (secondo l’interpretazio-ne più comune) appare centrata su un edificio simile15.
Un’anfora del Pittore di Tityos (530-520)16 reca su un lato la fase suc-cessiva all’agguato (Fig. 8): l’altare, sul quale Achille, si accinge a sacrifica-re la sua vittima che si dibatte come una preda sulla sua spalla, è raffigura-to come una struttura a sei assise di blocchi regolari di colore bianco, neroe rosso, che si alza da tre gradini, coronata da quattro lastroni bianco, nero,rosso e di nuovo nero. Le somiglianze stilistiche con la Tomba dei Tori sonoevidenti e molto simile è la resa della struttura dell’altare.
Ancora nell’ambito della produzione pontica, ma allontanandosi daltema di Achille e Trolio, una raffigurazione complessa e interessante è con-servata su un’oinochoe del British Museum e datata al 520-51017 (Fig. 10).Essa offre l’immagine di un edificio di ampie dimensioni con muratura inblocchi di colori contrastanti, inserito in un contesto di combattimento. Lastruttura, piuttosto complessa, è caratterizzata da due alti elementi collega-
158
Per una lettura in chiave ideologica della rappresentazione del mito di Achille e Troilo,in rapporto ad un rispecchiamento in Achille della gens titolare della Tomba Calabresi,vd. anche PAIRAULT MASSA 1992, pp. 23-24.
14 Anfora Louvre, E 703, RIZZO 1987, p. 33 e p. 152, n. 105; scheda a p. 302 conbibliografia precedente.
15 Si dovrà peraltro aggiungere come nelle rappresentazioni vascolari i due nucleimitici relativi all’uccisione di Troilo e al sacrificio di Polissena vengano spesso abbina-ti, per le analogie iconografiche, per i collegamenti nella struttura del racconto mitolo-gico, ma soprattutto per la simbologia sacrificale da entrambi evocata: vd. CERCHIAI
1980, pp. 25-39, p. 35; D’AGOSTINO 1985, p. 6.16 Anfora Reading, University Collection, RIZZO 1987, p. 34 e p. 155, n. 108,
scheda a p. 303 con bibliografia precedente.17 Oinochoe B. M. 1926.6-28.1, RIZZO 1987, p. 159, n. 111, scheda a pp. 304-
305 con bibliografia precedente.
Policromia delle strutture murarie
ti fra loro, uno dei quali con tetto a doppio spiovente ed elemento acrote-riale sul colmo, l’altro coronato da una sorta di merlatura. La rappresenta-zione riproduce con notevole vivacità una tecnica in muratura, nella quale iblocchi quadrangolari di forma regolare sono dipinti, nella parte con tettospiovente in bruno rossiccio e bianco alternati, e nell’altra porzione in brunoe nero alternati. Fra questi due elementi esiste uno spazio occupato da unafigura femminile assisa di profilo: secondo l’interpretazione della Haynes18,questa complessa rappresentazione potrebbe alludere alla cella di un tempiopiuttosto che alle mura di una città: la figura femminile che si intravvedenel vano centrale, presenta inoltre caratteristiche comuni ad alcune figureconosciute nei prodotti lici di arte funeraria. Questo apporto microasiaticonella scena, che fa certo parte del patrimonio proprio dei vasi pontici,potrebbe però suggerire anche per la scena di combattimento che si svolgeintorno al suddetto edificio un’ambientazione microasiatica.
Nella stessa fase cronologica dei precedenti, è necessario considerare unalastra del Louvre della Collezione Campana19, proveniente da Cerveteri edatata alla fine del VI secolo (Fig. 11). L’altare, riproduce in maniera preci-sa e regolare la tecnica a blocchi policromi, con una ricerca specifica, peresempio nel ripetersi su tre registri paralleli dell’alternanza del blocco chia-ro e di quello bruno.
In merito a questo primo gruppo di documenti, sono da rilevare inprimo luogo l’ambientazione troiana o microasiatica di quasi tutte le raffi-gurazioni, nonché la peculiarità dell’edificio altare-fontana in blocchi poli-cromi nelle scene dell’agguato e dell’uccisione di Troilo.
Tale rappresentazione differisce dalla maggior parte delle immagini gre-che a figure nere, nelle quali la fontana è raffigurata in forma di pilastro, nondando perciò adito a quella ambiguità semantica che in ambito etrusco sot-tolinea in maniera così incisiva la coesistenza delle due funzioni per questoedificio20.
159
18 HAYNES 1980, pp. 1-4, pp. 3-4.19 RONCALLI 1965; vd. anche DURAND 1991, p. 53, Fig. 4.20 PRAYON 1977, pp. 181-197, p. 183. Per un repertorio di immagini di fontane
nel mondo greco in età classica e arcaica, vd. DUNKLEY 1935-1936, p. 142 ss. Nellaceramografia etrusca si distacca dagli esempi sopra presentati un’anfora di Villa Giulia5200 (CAMPOREALE 1969, pp. 59-76, pp. 70-74), nella quale la fontana è resa a pila-stro. L’episodio dell’agguato alla fontana è conosciuto precocemente nella ceramografiacorinzia (nella bottiglia di Timonidas) e con una certa varietà nella ceramica attica,mentre nella ceramica laconica sembrerebbe che i personaggi agissero direttamente nel
Cristina Ridi160
Tuttavia, nel novero dei documenti ceramografici greci a figure nereraffiguranti il tema di Troilo alla fontana, è possibile individuare un pic-colo gruppo di vasi, databili in un arco di tempo dal secondo quarto delVI a entro il 530, che possono essere avvicinati per la tipologia dell’edi-ficio-fontana alle rappresentazioni etrusche e nei quali possiamo osserva-re come a una struttura, spesso bassa e quadrangolare con protome leo-nina, corrisponda una resa coloristica della muratura. Sempre nell’ambi-to di quell’episodio, tale resa coloristica caratterizza inoltre in alcuni casianche edifici più complessi, nei quali sono riconoscibili fountain houses olo stesso tempio di Apollo Timbreo: sebbene il problema sia tuttora incorso di studio, a una prima ricognizione sui documenti greci di questafase recanti immagini di edifici, fontane o altari, sembrerebbe che per lamaggior parte dei casi tali strutture murarie policrome siano riferibili adepisodi della saga troiana.
Il dinos eponimo del Pittore del Louvre E 87621 (Fig. 12) mostrasulla spalla il motivo dell’agguato di Achille a Troilo presso una fontanala cui struttura, bassa e larga, è caratterizzata da una resa a scacchiera,ben definita anche attraverso l’incisione. Inoltre la fontana, sebbene man-cate del plinto, ha un coronamento superiore. Un’idria del Pittore diLondra B 7622 (Fig. 13) ripete una scena analoga: anche in questo caso,la struttura, in opera quadrata, ha i blocchi suddipinti in paonazzo ebianco.
Vi sono poi altri esempi nei quali la struttura della fontana è più similea un pilastro, ma compare la resa a blocchi policromi, come nel caso di unframmento di kantharos del Puskin Museum23 (Fig. 14).
Particolarmente vivaci sono le rappresentazioni di murature a scac-chiera degli fontane monumentali relative allo stesso episodio mitico. Indue coppe di Siana, quasi gemelle e probabilmente da riferirsi alla stessamano pittorica, la scena riguarda il momento dell’inseguimento: la fon-tana, con colone doriche e muratura a scacchi a colori differenti, in un
santuario di Apollo (vd. ZANCANI MONTUORO 1954, p. 289, nt. 3). Nelle lamine degliscudi di Olimpia la fontana non compare affatto. Vd. a tal proposito Paribeni Enci-clopedia, p. 1077; CERCHIAI 1980, pp. 25-39, pp. 29-30 e Fig. 3.
21 Dinos Musée du Louvre E876, E. POTTIER, CVA France 2. Musée du Louvre 2,Paris 1923, p. 11. Pl. 22.
22 Idria New York, Metropolitan Museum 45.11.2, Para, p. 524; Addenda II, p. 23.23 Kantharos Moscow, Pushkin State Museum of Fine Arts M1012, N. SIDOROVA,
CVA Russia 1. Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow 1, Roma 1996, p. 44, Pl. 48.
Policromia delle strutture murarie
esemplare è rappresentata di lato24 (Fig. 15), nell’altro di prospetto25
(Fig. 16).L’episodio è presente anche in alcune coppe laconiche26 (Figg. 18-19),
nelle quali il riferimento a un edificio in opera a scacchiera, è secondo laZancani Montuoro da riportare allo tempio stesso di Apollo Timbreo27.Ancora, a titolo di esempio, si può ricordare un calice chiota28, che recal’immagine dell’edificio dietro il quale Achille tende l’imboscata a Troiloreso a scacchi policromi (Fig. 17)29. Raffigurazioni di strutture a scacchierae altari in blocchi policromi ricorrono anche, nella stessa fase, in scene diver-se da quelle dell’agguato di Achille a Troilo: pare a questo proposito assairilevante la raffigurazione su un’anfora tirrenica30 (Fig. 20), dove compareuno spalto a scacchi colorati, che da taluni è stato collegato alla corsa dicavalli di Anfiarao, da altri una corsa di carri riportabile ai giochi funebri inonore di Patroclo, quindi ancora a un’ambientazione troiana31.
Infine, possiamo notare come la rappresentazione di blocchi di colorediverso ricorra talvolta per la resa dell’altare su cui vengono uccisi Priamo eAstianatte nelle scene di Ilioupersis, o di altri altari di forma diversa, ancorarelativi a episodi della saga trioana, come nel caso di un’anfora di Lydos32
(Fig. 21) o di una pisside di Berlino33 (Fig. 22).Concludendo questa rassegna, di fronte a tale repertorio di immagi-
ni di edifici rappresentati a blocchi policromi, ci si deve in primo luogochiedere se essi in effetti riflettano una precisa tecnica costruttiva, comenel caso del muro 24, ovvero siano la resa pittorica di strutture dotate di
161
24 Coppa New York, Metropolitan Museum GR521, G. RICHTER, CVA UnitedStates of America 11, New York, Metropolitan Museum of Art 2, pp. 1-2, Pl. II.2c.
25 Coppa Louvre CA6113, LIMC I, s.v. Achilleus 310, Pl. 89.26 Coppa Samo, perduta vd. LIMC I, s.v. Achilleus 264, Pl. 83; coppa Villa Giulia,
vd. LIMC I, vd. Achilleus 261, Pl. 82.27 ZANCANI MONTUORO 1954, p. 289, nt. 3.28 Calice Istanbul CND 1963 (560), LIMC I, s.v. Achilleus, 254, Pl. 81.29 Agli esempi di edifici a scacchi, a titolo di ulteriore spunto, si possono altresì
aggiungere cinque rappresentazioni a figure nere di altari campiti da una scacchiera tra-sversale suddipinta in bianco, tre dei quali riferibili all’episodio della morte di Troilo euno dei quali alla morte di Polissena: vd. EKROTH 2001, p. 119, nt. 17.
30 Anfora Firenze, Museo Archeologico Nazionale 3773, ESPOSITO - DE TOMMASO
1993, p. 26, Fig. 21.31 AMYX 1983, pp. 37-52, p. 41; SHAPIRO 1994, pp. 35-38.32 Anfora Berlino, Pergamon Museum F1685, ABV, 109.24, 685.33 H. MOMMSEN, CVA Deutschland 61, Berlin, Antikenmuseum 7, Berlin 1991, pp.
54-56, Taf. 42.4.
Cristina Ridi
stucchi o intonaci colorati, oppure ancora, se essi siano da considerareniente di più che l’esito di una convenzione figurativa.
Dobbiamo tuttavia a tal proposito ricordare l’apporto della documenta-zione archeologica, che mostra precoci attestazioni dell’arte di costruire inmateriali e colori diversi proprio nella Grecia d’Asia. Inoltre, nella docu-mentazione figurata, a una prima ricognizione, la presenza di tali struttureapparentemente a scacchi di colori diversi pare riconducibile a un gruppopiuttosto ristretto di documenti, riferibili spesso all’episodio di Achille eTroilo, ma anche ad altri temi narrativi, per la maggior parte di ambienta-zione troiana. A questo riguardo inoltre, è utile ricordare l’ipotesi, riferitain particolare alle rappresentazioni etrusche dell’episodio, che alla base ditali raffigurazioni non vi fosse tanto un repertorio iconografico, quanto piut-tosto un ciclo epico, forse di origine microasiatica34.
In particolare per le rappresentazioni delle fontane nell’episodio diAchille e Troilo dunque, la centralità semantica di questo elemento dalpunto di vista narrativo, ne determinerebbe anche la centralità sul pianocompositivo e ciò induce a chiedersi se, al di là di eventuali e possibili con-venzioni pittoriche, la specificità nell’aspetto di tali strutture e in particola-re l’opera a scacchiera, sottenda a una scelta del ceramografo volta a rispet-tare un effettivo elemento del racconto mitologico o un concetto architetto-nico proprio dell’area geografica di riferimento.
Sulla base di tali elementi, è possibile dunque ritenere non casuale ilricorso alla policromia nelle rappresentazioni di edifici prese in esame. Talericerca cromatica e disegnativa potrebbe, sul piano concettuale, sottendereuna specificità architettonica e forse anche una specificità funzionale deimonumenti raffigurati. In quest’ottica, il ricorso alla documentazione figu-rata permette dunque di delineare possibili percorsi interpretativi in meri-to alle valenze architettoniche e soprattutto concettuali espresse nell’edifi-cazione del muro gamma, unica struttura a tecnica policroma finora messaa luce nel contesto santuariale dell’Ara della Regina, e nella quale, ricordia-mo, l’uso delle pietre locali di colori diversi venne sapientemente integratonella tessuto stesso della muratura.
162
34 D’AGOSTINO 1985, p. 8, per un’ipotesi di un poema diffuso in Occidente. Perl’idea di un ciclo epico della Grecia Orientale vd. NARDI 1997, pp. 443-463, pp. 458ss. con bibliografia. Per Cerchiai, esisterebbe un referente iconografico non ancora iden-tificato: vd. CERCHIAI 1990, 2, pp. 61-66 con bibliografia.
Policromia delle strutture murarie 163
Figura 1 – Il muro 24 presso il lato meridionaledel tempio.
Figura 2 – Tecnica di costruzione della struttura:lato settentrionale.
Cristina Ridi164
Figura 3 – Tecnica di posa per taglio e per testa (da ORLANDOS 1966).
Figura 4 – Tecnica di costruzione della struttura: lato meridionale, le assise con-servate nella porzione presso l’angolo sud-orientale della terrazza e nell’areaantistante alla medesima (disegno E. Invernizzi).
Figura 5 – L’effetto a scacchiera (disegno E. Invernizzi).
Policromia delle strutture murarie 165
Figura 6 – Tarquinia, Tomba dei Tori (da STEINGRÄBER 1984, Fig. 158).
Figura 7 – Oinochoe BibliothèqueNationale 179, Scuola del Pittoredella Sfinge Barbuta (da MARTELLI
1987a, Fig. 62).
Figura 8 – Anfora Reading, Univer-sity Collection, Pittore di Tityos (daMARTELLI 1987a, Fig. 108b).
Cristina Ridi166
Figura 9 – Anfora Louvre E 703, Pittoredel Sileno (da PRAYON 1977, Taf. 96,2).
Figura 10 – Oinochoe British Museum1926.6-28.1 (da HAYNES 1980, Fig.12).
Figura 11 – Musée du Louvre, Collezione Campana, La-stra (fine del VI secolo) (da STEINGRÄBER 2006, p. 62).
Policromia delle strutture murarie 167
Figura 13 – Idria New York, Metropolitan Museum 45.11.2, Pittore London B 76 (565-555) (daLIMC I, s.v. Achilleus 234, Pl. 79).
Figura 14 – Kantharos Moscow, Pushkin StateMuseum of Fine Arts M1012, Pittore di Berlino1686 (da CVA Russia 1, Pushkin State Museum ofFine Arts, Moscow 1, Roma 1996, Pl. 48).
Figura 12 – Dinos Paris, Musée du Louvre E876, Pittore Louvre E876 (570-550) (da CVA France 2,Musée du Louvre 2, Paris 1923, Pl. 22).
Cristina Ridi168
Figura 15 – Coppa NewYork, Metropolitan Mu-seum GR521, Pittore C(575-555) (da CVA UnitedStates of America 11, NewYork Metropolitan Museum ofArt 2, pp. 1-2, Pl. II. 2c).
Figura 16 – Coppa Louvre CA6113 (570-560 (da LIMC I, Pl. 89. s.v. Achilleus310.
Figura 17 – Calice Chio-ta, Istanbul CND 1963(560) (da LIMC I, s.v.Achilleus 254, Pl. 81).
Policromia delle strutture murarie 169
Figura 20 – Anfora Firenze, Museo Archeologico Nazionale 3773 (565-550)(da SHAPIRO 1994, Fig. 22).
Figura 18 – Coppa laconica, perduta,da Samo (560-550) (da LIMC I, s.v.Achilleus 264, Pl. 83).
Figura 19 – Coppa laconica, Roma,Villa Giulia (560) (da LIMC I, s.v.Achilleus 261, Pl. 82).
Cristina Ridi170
Figura 21 – Anfora Berlino, Pergamon Museum F1685, Lydos (550-540) (da J.BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, a Handbook, London 1974, trad. it.,Vasi ateniesi a figure nere. Un manuale, Milano 1990, Fig. 67).
Figura 22 – Pisside Berlino, Antikensammlung F3988 (550 ca) (da F. LISSARRA-GUE - F. THELAMON (éds.), Image et Ceramique Grecque, Rouen 1983, Fig. 3).
Policromia delle strutture murarie
Bibliografia di riferimento
ABV J.D. BEAZLEY, Attic Black-figure Vase-painters, Oxford 1956.
Addenda II T.H. CARPENTER, Additional References toABV, ARV2 and Paralipomena, Oxford1989.
AMYX 1983 D.A. AMYX, Archaic Vase-Painting vis-à-vis. “Free” Painting at Corinth, in W.G.MOON (ed.), Ancient Greek Art andIconography, Madison 1983, pp. 37-52.
BAGNASCO GIANNI in Tarchna IV c.s. G. BAGNASCO GIANNI, Lo scavo all’esternodella terrazza del Tempio dei Cavalli Alati.Lato meridionale e orientale. Letture e interpre-tazione, in Tarchna IV c.s.
BANTI 1955-1956 L. BANTI, Problemi della pittura arcaicaetrusca: la Tomba dei Tori di Tarquinia, inStEtr XXIV, 1955-1956, pp. 143 ss.
BONGHI JOVINO - M. BONGHI JOVINO - C. CHIARAMONTE
CHIARAMONTE TRERÉ 1987 TRERÉ (a c. di), Tarquinia: Ricerche, scavie prospettive, Atti del Convegno Inter-nazionale di Studi “La Lombardia pergli Etruschi” (Milano, 24-25 giugno1986), Milano 1987.
BUCCELLATO - GATTI 1978 A. BUCCELLATO - S. GATTI, Gruppo deivasi pontici. Alcune osservazioni sul proble-ma dei rapporti con la coeva pittura tombaletarquiniese, in ArchCl XXX, 1978, pp.193-200.
CAMPOREALE 1969 G. CAMPOREALE, Banalizzazioni etruschedi miti greci III, in StEtr 1969, pp. 59-76, pp. 70-74.
CAMPOREALE 1989 G. CAMPOREALE, La mitologia figuratanella cultura etrusca arcaica, in Atti delSecondo Congresso InternazionaleEtrusco (Firenze, 26 maggio-2 giugno1985), (Studi Etruschi, suppl.), I-III,Roma 1989, pp. 905 ss., p. 916.
CAMPOREALE 2008 G. CAMPOREALE, La città murata d’E-truria nella tradizione letteraria e figurati-va, in La città murata in Etruria (Chian-ciano Terme-Sarteano-Chiusi), Atti del
171
Cristina Ridi
XXV Convegno di Studi Etruschi edItalici (30 marzo - 3 aprile 2005), Pisa-Roma, pp. 15-32.
COLONNA 1984 G. COLONNA, Apollon, les étrusques et Li-para, in MEFRA, 96, 2, 1984, pp. 557-578.
CERCHIAI 1980 L. CERCHIAI, La màchaira di Achille:alcune osservazioni a proposito della Tombadei Tori, in AION 1980, pp. 25-39.
CERCHIAI 1990 L. CERCHIAI, Achille e Troilo in Etruria:alcune ipotesi su due cippi chiusini, inDialArch 1990, 2, pp. 61-66.
CERCHIAI 1999 L. CERCHIAI, L’immagine di Apollo nel-l’agguato a Troilo: osservazioni su tre anforeetrusche a figure nere, in D’AGOSTINO -CERCHIAI 1999, pp. 115-119.
CRISTOFANI 1976 M. CRISTOFANI, Storia dell’arte e accultu-razione. Le pitture tombali arcaiche di Tar-quinia, in Prospettiva, 7, 1976, pp. 2 ss.
D’AGOSTINO 1985 B. D’AGOSTINO, Achille e Troilo: immagini,testi e assonanze, in AION 1985, pp. 1-8.
D’AGOSTINO - CERCHIAI 1999 B. D’AGOSTINO - L. CERCHIAI, Il mare, lamorte, l’amore. Gli Etruschi, i Greci e l’im-magine, Roma 1999.
DUNKLEY 1935-1936 B. DUNKLEY, Greek Fountain-Buildingsbefore 300 b.C., in BSA 36, 1935-1936,pp. 142 ss.
DURAND 1991 L. DURAND, Images pour un autel, in R.ETIENNE - M.-T. LE DINAHET (éds.),L’espace sacrificiel dans les civilisations me-diterraneennes de l’Antiquite, Actes duColloque tenu a la Maison de l’Orient(Lyon, 4-7 juin 1988), Paris 1991, p. 53.
EKROTH 2001 G. EKROTH, Altars on Attic vases: theidentification of bomos and escara, in C.SCHEFFER (ed.), Ceramics in context:Proceedings of the Internordic colloquium onancient pottery held at Stockholm 13-15June 1997, Stockholm 2001, pp. 115-126.
ESPOSITO - DE TOMMASO 1993 A.M. ESPOSITO - G. DE TOMMASO,Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
172
Policromia delle strutture murarie
Antiquarium. Vasi Attici, Firenze - Mi-lano 1993.
GIULIANO 1969 A. GIULIANO, Osservazioni sulla Tomba deiTori di Tarquinia, in StEtr XXXVII,1969, pp. 3-26.
GIULIANO 1988 A. GIULIANO, Pittura vascolare e pitturaparietale, in M.A. RIZZO (a c. di), Unartista etrusco e il suo mondo. Il Pittore diMicali, Catalogo della Mostra (Roma,22 marzo-30 giugno 1988; Milano,dicembre 1988), Roma 1988, p. 40.
GIULIANO 2001 A. GIULIANO, Scritti minori, Roma 2001.HANNESTAD 1976 L. HANNESTAD, The Followers of the Paris
Painter, København 1976, pp. 50 ss.HARARI 1987 M. HARARI, Dibattito, in BONGHI JOVI-
NO - CHIARAMONTE TRERÉ 1987, p.289.
HAYNES 1980 S. HAYNES, Ein Lykisches Motiv, in RM87, 1, 1980, pp. 1-4.
MARTELLI 1987a M. MARTELLI (a c. di), La Ceramica degliEtruschi. La pittura vascolare, Novara1987.
MARTELLI 1987b M. MARTELLI, La ceramica etrusco-corin-zia, in MARTELLI 1987a, p. 25 e p. 114.
NARDI 1997 G. NARDI, Nuovi bracieri ceretani, inEtrusca et Italica. Scritti in ricordo diMassimo Pallottino, Roma 1997, pp.443-463.
NICHOLLS 1958-1959 R.V. NICHOLLS, Old Smyrna: the Iron AgeFortifications and associated remains on thecity perimeter, in BSA, 1958-1959, pp.35-137.
ORLANDOS 1966 A. ORLANDOS, Les matériaux de construc-tion et la technique architecturale des anciensgrecs, Paris 1966.
OLESON 1975 P. OLESON, Greek Myth and EtruscanImagery in the Tomb of Bulls at Tarquinia,in AJA 79, 1975, pp. 189-200.
PAIRAULT MASSA 1992 F.-H. PAIRAULT MASSA, Iconologia e poli-tica nell’Italia antica, Milano 1992.
PALLOTTINO 1937 M. PALLOTTINO, Tarquinia, in MonAntXXXVI, 1937.
173
Cristina Ridi
Para J.D. BEAZLEY, Paralipomena. Additions toAttic Black-figure Vase-Painters and toAttic Red-figure Vase-Painters, Oxford1971.
PARIBENI Enciclopedia E. PARIBENI, in EAA, vd. Troilo ePolissena, p. 1077.
PRAYON 1977 F. PRAYON, Todesdämonen und dieTroilossage in der Frühetruskischen Kunst,in RM, 84, 1977, pp. 181-197.
RIZZO 1987 M.A. RIZZO, La ceramica a figure nere inMARTELLI 1987a, p. 33.
RONCALLI 1965 F. RONCALLI, Le lastre dipinte da Cerveteri,Firenze 1965.
SHAPIRO 1994 H.A. SHAPIRO, Myth into art. Poet andPainter in Classical Greece, London-NewYork 1994.
SIMON 1973 E. SIMON, Die Tomba dei Tori und dieEtrusckische Apollonkult, in JdI, 88,1973, pp. 27-42.
STEINGRÄBER 1984 S. STEINGRÄBER (a c. di) Catalogo ragio-nato della Pittura Etrusca, Milano 1984.
STEINGRÄBER 2006 S. STEINGRÄBER, Affreschi Etruschi, dalperiodo geometrico all’Ellenismo, Verona2006.
SZILÁGYI 1992 J.G. SZILÁGYI, Ceramica etrusco-corinziafigurata, I (630-580 a.C.), (MonumentiEtruschi 7), Firenze 1992.
Tarchna IV c.s. M. BONGHI JOVINO - G. BAGNASCO
GIANNI (a c. di), Tarquinia. Il santuariodell’Ara della Regina. Ipotesi di ricostru-zione dei templi arcaici c.s.
WINTER 1971 F.E. WINTER, Greek Fortification,London 1971.
ZANCANI MONTUORO 1954 P. ZANCANI MONTUORO, L’agguato aTroilo nella ceramica laconica, in BdA 39,1954, pp. 289 ss.
ZEVI 1969 F. ZEVI, Nuovi vasi del pittore della SfingeBarbuta, in StEtr 1969, pp. 39-57.
174