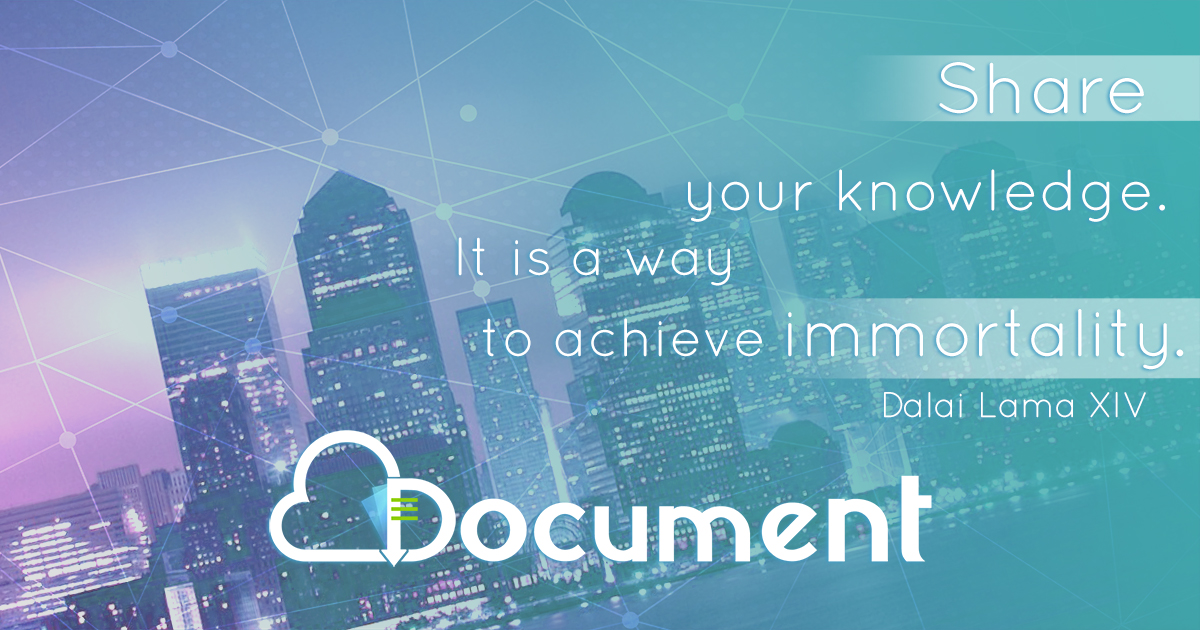Crisi ideologica del Pakistan e rilettura di Nazìr Akbarabadi († 1830), «Vita sociale» 29...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Crisi ideologica del Pakistan e rilettura di Nazìr Akbarabadi († 1830), «Vita sociale» 29...
Crisi ideologica del Pakistane rilettura di Nazìr Akbarabadi († 1830),«Vita sociale» 29 (1972) 530-549.
1 La «rilettura» 5 Sua personalità artistica2 Un popolo in cerca di sé 6 Piccola antologia poetica
3 Muhammad Iqbàl 7 NAZÌR AKBARABADI, Admi-Namah = Il poema dell'uomo
4La poetica dissonate di Nazìr | Mirza Ghalib | Nasikh
ةةةة ةةةة
1. La «rilettura» sta diventando, nella critica contemporanea, un fenomeno letterario di estremo interesse. Un testo dimenticato, uno scrittore o poeta passato in sordina, o addirittura ignorato dai contemporanei, tornano alla ribalta con una urgenza di messaggio che s'impone al lettore d'oggi. S'impone finanche al critico che spesso è costretto a verificare la validità dei propri strumenti d'analisi proprio là dove una breccia improvvisa ha fatto crollare la presunzione d'imprendibili fortezze. Capovolgimenti storici e osmosi di strutture sociali creano una sfasatura di stratificazioni di messaggi culturali in cuiuna voce fuori campo s'inserisce, con insospettata sceltadi tempo, denunciando la rottura e affermando nel contempo la propria significanza. Si opera allora il recupero storico, non come cammino a ritroso inteso a rilevare fatti e messaggi così come congelati nel monumento archeologico, ma come sensibilità critica a cogliere il rientro in fase, di un movimento perduto, nelritmo di composizione dell'oggi. Il critico - per riprendere il discorso della «rilettura» - si trova a
saggiare il messaggio di un testo in un quadro referenziale che accetti un movimento, per così dire, a spola: un continuo confronto cioè tra il locus storico-culturale in cui il testo venne alla luce e il locus storico-culturale che al medesimo offre le condizioni di lettura. Un testo, si sa, vive nella lettura che di esso si fa. Ma lettura è essenzialmente opera d'interpretazione o, perlomeno, di decodificazione. Le condizioni culturali - le chiavi di decodificazione, appunto - che assecondano una lettura e quindi un'intelligenza del valore semantico di un testo, entranocosì di diritto e nell'analisi dell'oggetto del tecupero e tra gli elementi che si presume costituiscano l'assettotecnico di una critica letteraria.
Questo ci pare tanto più vero qualora il testo in questione si situi in un'area geografica dove condizioni sociali e tradizioni culturali danno poco spazio all'autonomia di vita del testo come tale. In culture, vogliamo dire, dove la scolarizzazione non ha ancora monopolizzato l'istruzione e dove la traditio orale - sostenuta da un eccezionale potere mnemonico - è lo scrigno vivo di una letteratura.
Ci riferiamo alle letterature orientali, di cui in questo articolo si offre un saggio. La pubblicistica occidentale opera una frettolosa mistificazione nei riguardi delle culture orientali quando intende fare il bilancio dell'istruzione e civilizzazione di quei popoli sulla base dell'analfabetismo. Non sarà superfluo notare che se la scuola e la carta stampata non definiscono ancora il tipo tecnico d'istruzione dimolti paesi asiatici, ci sono invece altri formidabilie autoctoni mezzi di comunicazione sociale a noi estranei e tanto efficaci quanto i nostri. In connessione con la letteratura urdu si può citare il caso della musha'ira, pubblica competizione poetica. Lapopolarità di essa, la particolare tecnica del verso urdu fortemente mnemonico fanno della poesia un mezzo
di circolazione d'idee la cui efficacia e rapidità è per noi inimmaginabile. «Un poemetto rivoluzionario diIqbàl ) - letto in una riunione politica la mattina - la sera era già, senza editori e senza stampa, sulla bocca di tutti...» (A. BAUSANI, Il Poemia Celeste di M. Iqbal, Bari 1965, p. 29).Qui l'esegesi è costretta a ricostruire il messaggio
del testo sulla scia mobile di una tradizione vivente, dicui il testo segue le vicende. Il testo è strappato all'autore ed è privato di quella nettezza di contorni e veicolazione protettiva assicurata dalla redazione scritta. Esso diventa pubblica proprietà del gruppo socio-culturale, di questo condivide le peripezie storiche, rispecchia l'evoluzione culturale, caricandosi di volta in volta di nuovi e diversi significati.
2. Vorremmo presentare un caso tipo di rilettura proprionel contesto di una civilizzazione orientale che offre caratteristiche emblematiche di recupero letterario suaccennato. Si tratta di un testo e della personalità di un poeta urdu (lingua franca dei musulmani dell'India e attualmente lingua nazionale del Pakistan): NAZIR AKBARABADI († 1830).
■ La letteratura urdu, poco conosciuta in Europa, merita invece attenzione per la sua ampiezza e per glieccellenti livelli artistici conseguiti nel corso della sua evoluzione. Per i lettori italiani è consigliabile l'ottima, anche se introduttiva, Storia delle Letterature del Pakistan del prof. A. BAUSANI, Nuova Accademia, Milano 1958. Del medesimo studioso un autorevole saggio critico su uno dei più grandi poeti urdu: La Poesia di Ghalib, in «Orientalia Romana», 3, ISMEO, Roma 1969, pp. 97-167.
Un caso tipo, dicevamo. Perché si presenta sulla scenadella critica letteraria urdu e, di più, alla coscienza di una nazione in cerca di se stessa come quella
pakistana, con una prepotenza che scompiglia i quadri di critica prestabiliti e angustia le coscienze educate a gonfi ideologismi, nazionali o religiosi che siano. I critici letterari fanno fatica a riquadrare la poesia di un bohémien entro i rigidissimi schemi delle forme poetiche urdu; le nuove generazioni dello stato musulmanodel subcontinente (Repubblica Islamica del Pakistan) sono scosse da una voce che, al di là della tronfia letteratura ufficiale e delle demagogie politico-religiose, risuona di una aggressività corposa e di una sincerità tutta populista. Un sensismo estetico di cui è capace solo l'uomo della strada, ma tale di sfidare ogni tipo d'alienazione ideologica, sia essa letteraria çhe religiosa o politica. Il giovane pakistano prende coscienza, alla lettura di Nazìr, d'esser vissuto in una nube gonfiata di slogan e triti ideali, dove calchi consunti di moduli poetici, sogni irreali di restaurazione del medioevo religioso, miti nazionalisticie tentazioni comunali trattengono l'uomo comune in una fase falsa e astorica del suo divenire. Per stringere di più i termini del discorso, la riscoperta di un poeta scomodo ai critici e inutile ai politici, coincide con una profonda crisi della società pakistana. Una crisi definibile, in termini approssimativi, come il crollo deimiti.
Si sa come il Pakistan, sorto dalla partizione dell'India britannica nel 1947, abbia inteso raccogliere le istanze e le speranze dei musulmani del subcontinente indiano che non ritenevano possibile la convivenza con gli indù in un unico stato. Il poeta-filosofo Muhammad Iqbàl († 1938) e la guida politica M. Alì Jinnah († 1948)raccolsero i frutti, eterogenei ma sofferti, di un'autentica rinascita islamica maturata in India durantela seconda metà del XIX secolo.
■ Muhammad Iqbàl massimo poeta urdu del sec. XX, il Tagorne della comunità musulmana dell'India. In traduzione italiana sono reperibili il Jawed-Namah (Il
Poema Celeste, Bari 1965) ed un'antologia poetica (Poesie, Parma 1956), ambedue a cura di A. Bausani.Cf. W. CANTWELL SMITH, Modern Islam in India, London 1946.Ma varie circostanze storiche spinsero il movimento
islamico, discretamente riformista al suo nascere, a convogliare i fermenti di una genuina Renaissance nella pista restrittiva e mortificante del nazionalismo e massimalismo religioso. Si potrebbe accennare alla crescente insofferenza, spesso trasformatasi in turbolenze di piazza, tra indù e musulmani; al malcelato trattamento di favore che la viceregenza britannica riservava al partito indù; al movimento del Khilafat in India come tentativo revivalistico dell'ideale del Califfato musulmano (idolo infranto in Turchia da MustafàKemal nel 1922-1924). Tutte congiunture che spinsero le forze musulmane dell'India a raccogliersi sotto le insegne di una restaurazione fideistica della Ummah (comunità dei credenti), di una tentazione di rinnovare gli antichi splendori degl'imperatori Moghul, di una volontà di ricostruire una polis fedelmente modellata sull'archetipo coranico e medinese.
I venticinque anni di vita della giovane nazione sono stati la storia di una graduale, inesorabile erosione dell'ideologia che aveva proliferato su autentiche istanze di rinascita. La cronistoria del tentativo di varare una definitiva Costituzione Islamica ne può essereun esempio. M. Alì Jinnah, realizzatore dello stato del Pakistan e primo governatote generale, tenta una linea dicompromesso tra stato aconfessionale e stato islamico a favore di uno stato musulmano, in pratica con evidenti tinte laiche. Il prestigio personale di Jinnah tiene a bada le punte massimalistiche rappresentate dagli 'ulema (dottori della legge coranica) e dai partiti islamici. Madopo la sua morte viene promulgata una costituzione fortemente islamica, tra conflitti di diverse tendenze
(Costituzione della Repubblica Islamica del Pakistan, 1956). Il colpo di stato del 1958 segna l'abolizione della costituzione. Ayub Khan, autore del coup e di stretta formazione militare, si sottrae alle disquisizioni dei giuristi e teologi musulmani. Promulga nel 1962 una seconda costituzione. L'aggettivo islamico non appare nella denominazione ufficiale dello stato, ma agitazioni popolari inducono il regime a reinserirlo. Il tono generale è meno confessionale che nella costituzione precedente. Si crea un Consiglio Consultivo dell'Ideologia Islamicacol compito di assistere il governo circa l'islamicità del suo operato (A. GUIMBRETIERE, La nouvelle constitution du Pakistan, «Orient » 24 (1962) 29-47). In pratica i partitireligiosi sono tenuti al margine della vita del paese manmano che Ayub forza le libertà politiche. Nell'aprile del'69 lunghi mesi di agitazioni di massa fanno cadere il regime di Ayub. Prende le redini del paese Yahyah Khan, capo dell'esercito, che impone la legge marziale e abolisce a sua volta la costituzione del '62. Gli avvenimenti tragici che accompagnarono il regime di Yahyah Khan sono ancora freschi di cronaca. La rivolta della provincia orientale e lo smembramento del Pakistan sono la denuncia più evidente del bluff dell'unità religioso-ideologica che era servita come copertura ad unvero asservimento coloniale e sfruttamento economico della provincia bengalese.
■ Lo sfruttamento era già stato denunciato in un'operacome quella di GUNNAR MYRDAL, Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, New York 1968 (trad. it. Saggio sulla povertà di undici paesi asiatici, voll. 3, Milano 1971) che il governo pakistano mise al bando al suo apparire.In Pakistan occidentale le elezioni del dicembre 1970
rivelano un altro incredibile sfaldamento dell'ideologia islamica: i partiti islamici (in particolare il Jama'at-e-Islami del Maulana Maududi) subiscono una dura sconfitta a
favore del People's Party capeggiato dal socialista Alì Bhutto. Intanto tendenze regionalistiche tornano ad affiorare con prepotenza (in Pakistan occidentale ci sonoben quattro province etnicamente e linguisticamente differenziate) portando sulla scena politica elementi d'identità regionale e componenti etnico-culturali riallacciabili alla fase pre-islamica della comunità musulmana dell'India. Andato a monte il progetto di Yahyah Khan di far varare una nuova costituzione dai partiti vincenti nelle elezioni del '70, il nuovo presidente Alì Bhutto si trova oggi di fronte all'insoluto problema costituzionale proprio in un momento in cui il paese è, politicamente e ideologicamente, su posizioni capovolte. Difficile prevedere la direttiva che il «socialista» Alì Bhutto imprimerà ad una ennesima costituzione del Pakistan. Più difficile prevedere se le masse popolari, ancora suscettibili di remore religiose massimalistiche, permetteranno il fatidico colpo di volano. Certo è che reazioni critiche tipo «Il Pakistan va in rovina perché inostri governanti non hanno mai attuato una legislazione totalmente ed unicamente islamica» si fanno sentire anchein settori, per così dire, illuminati. Due personalità come I. H. Qureshi (ex-rettore dell'università di Karachie storico dell'lslam indiano) e B. Z. Kaikaus, giurista di fama, hanno recentemente avallato proposte di una costituzione a forte tinte revivalistiche.
■ I. H. QURESHI, Ideology of Pakistan, «Daily News», Karachi, Setp. 13, 1971; B. Z. KAIKAUS, Islamic Constitution, «Morning News», Karachi, chap. I, Sept. 27, 1971; chap. Il, Sept. 28, 1971. Ecco alcune proposte costituzionali di Kaikaus: Il Pakistan dovrà essere uno stato islamico fondato sul Corano e sulla Sunnah (Tradizione), col nome di Khilafat-e-Pakistan (Khilafat, califfato, è la vicegerenza che il capo dei musulmani esercita in nome di Allah secondo alcuni, diMaometto secondo altri). La sovranità spetta soltanto
ad Allah nel cui nome è esercitato, nella comunità musulmana, ogni potere. Corano e Sunnah debbono fungere da legge costituzionale del paese e nessuna legge può essere promulgata se in conflitto con essi. In quest'ultimo caso Qadi e Mufti (tradizionali giureconsulti musulmani) dirimeranno la questione. Alle sètte musulmane verranno applicati i loro statutiparticolari in materia non concernente il bene pubblico (non si fa cenno alla posizione giuridica, intale stato, dei cittadini non-musuImani i quali verrebbero automaticamente a ricadere nella classe deidhimmi, protetti, ma in fondo cittadini di seconda classe). Reinserimento nel codice penale delle punizioni coraniche...Le medesime riflessioni si potrebbero fare a proposito
di altri temi della presente rivoluzione culturale del Pakistan. E i medesimi inceppi, frustrazioni, contraddizioni si ripetono invariabilmente. Lo studioso dell'Islam moderno che è W. Cantwell Smith sintetizza così il dramma dell'Islam a confronto col mondo moderno:
«Il malaise fondamentale dell'Islam moderno è la sensazione che qualcosa non abbia funzionato nella storia islamica» (Islam in Modern History, Princeton 1955,p. 41). Una pista per accostare più da vicino quel «qualcosa»
è suggerita da un insigne studioso dell'Islam indiano, Aziz Ahmad (Islamic Culture in the Indian Environment, London 1964; An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh 1969). Anoi pare che la sua annotazione sia da raccogliere come un valido contributo a scoprire il motivo di fondo che sta all'origine delle angustie e delle inestricabili contraddizioni del mondo musulmano contemporaneo. In più ha il vantaggio d'essere una analisi fatta da uno stesso musulmano che tenta di capire il dramma in cui si dibattela sua comunità di fede.
«Il punto cruciale del problema - scrive A. Ahmad - è quello dell'umanesimo. In termini lati l'umanesimo è definito da Pierre Mesnard 'toute conception théorique, toute attitude pratique qui affirment la valeur exceptionelle de l'homme'. Il suo punto di partenza in Occidente è un 'anthropocentrisme réfléchi', un'attitudine sconosciuta nell'Islam classico. Nell'Islam classico, nella totalità delle correnti tradizionalistiche e fondamentalistiche e nell'insieme del pensiero modernista indo-islamico - eccetto in quello Iqbàl - Dio e non l'uomo rimane la figura chiave dell'universo che domina la vita politica, sociale, economica e culturale dell'uomo» (Islamic Modernism in India and Pakistan: 1857-1964, p. 271).La cosa non poteva esser detta in modo più chiaro.
L'Islam è una cultura che si è arrestata ad una fase pre-umanistica dell'evoluzione della civilizzazione mediterranea e si presenta oggi ad un mondo ad esso irriconoscibile: perché trasformato da conquiste culturali e sociali che vanno dall'umanesimo alla rivoluzione francese. E' forse qui il dramma più profondoche angustia la coscienza islamica moderna. Si fa menzione, nella citazione surrifetita, di Iqbàl . E, datala coincidenza del pensiero di Iqbàl con l'area culturaleislamica di cui ci stiamo occupando, non possiamo sorvolare il suo nome.
3. Muhammad Iqbàl (1873-1938), massimo poeta urdu del XXsecolo, filosofo, coscienza della comunità indo-musulmana, è colui che ha forgiato - e continua a forgiare con le sue opere - le menti delle nuove generazioni musulmane dell'India e soprattutto del Pakistan che l'ha proclamato suo poeta nazionale. Immenso è il suo influsso sui giovani e sulle correnti moderniste dell'Islam. La sua poesia - popolarissima presso tutti gli strati sociali, analfabeti compresi - è portavoce d'una rinnovata coscienza islamicache tenta di recuperare secoli di declino all'insegna di
una filosofia dell'azione, del dinamismo, dell'ardire, del valore e autonomia dell'uomo. E a questo proposito c'interessa, nel contesto del nostro discorso, mettere in evidenza proprio la ri-esegesi proposta da Iqbàl dei testi coranici sull'uomo. Ci pare che la parte più originale del pensiero d'Iqbàl - per il resto tanto flamboyant quanto nebuloso - sia il tentativo di gettar le basi d'una antropologia islamica la cui validità non è solo quella di rendere possibile all'Islam il dialogo col mondo moderno, ma soprattutto di porsi come riflessione che parta dall'interno stesso dell'Islam. E chi conosce l'irritabilità congenita del musulmano nei riguardi di tutto ciò gli viene «dal di fuori» saprà apprezzare il punto. E' a partire infatti da una ri-esegesi del testo coranico che Iqbàl si crea lo spazio, entro l'omnidivoranteteocentrismo della teologia classica (tawhìd), per una antropologia che si situi tra un universo in divenire e un Allah dialogante. E questo è appunto il contributo offerto dalla prima delle famose Lectures di Muhammad Iqbàl, raccolte in volume col titolo The Reconstruction of Religious Thought in Islam (citeremo nella ristampa del 1965, Lahore, Pakistan).
La creazione - nel pensiero Iqbàl - è un impegno di Dio a porre ad extra un rapporto significante perché dialogico. L'universo non è il risultato «of a mere creative sport» (The Reconstruction, p. 10). Esso non è un tutto compiuto e chiuso, ma una realtà germinale con la vocazione alla crescita e allo sviluppo in forza di un dinamismo interno (ib., p. 10, dove si cita Corano: 3, 188;35, 1; 29, 19. L'ultimo testo parla di una seconda nascita della creazione). L'uomo è posto al centro della creazione come cooperatore di Dio, di cui esercita, nell'universo, lavicegerenza (ib., p. 11: «he (l'uomo) carries within him a great trust». Si cita Corano 33,72). Qui si fa l'autonomia e la grandezza dell'uomo. A p. 12 si riporta il passo coranico caro a tutti i modernisti musulmani: «Dio non opera cambiamento nelle condizioni degli uomini fintanto
che questi non operino cambiamento in ciò che è in loro stessi» (Corano 13,12/13,11).
Non intendiamo qui aprire il problema - legittimo, peraltro - del valore tecnico dell'esegesi iqbaliana nel contesto della scienza coranica e della traditio islamica (sunnah e hadith). Ci pare, comunque, che lo spazio teologico per una antropologia coranica in nuce è fatto. Leidee iqbaliane meritano d'esser raccolte dal musulmano moderno, enucleate e soprattutto orientate pragmaticamente verso un riassetto interno delle diverse comunità musulmane. Nella prospettiva d'Iqbàl la teologia islamica classica dell'unità di Dio (Tawhìd), gelosamente e angustamente intra-teologale, acquista uno sbocco geocentrico. La tentazione, sempre ricorrente, del predeterminismo divino - dovuto alla nozione di Dio esasperatamente trascendente ed omni-esautorante - e del conseguente determinismo e fatalismo etico, è esorcizzata nell'esegesi iqbaliana. E nuovi orizzonti per la crescita el'autonomo farsi dell'uomo nel mondo sono aperti:
«E' compito dell'uomo prender parte alle profonde aspirazioni dell'universo che lo circonda e fare il proprio destino e quello del mondo, ora adattandosi alle sue forze ora piegando le forze dell'universo peril proprio fine. E in questo processo di evoluzione ascendente Dio diventa co-operante con l'uomo a condizione che sia questi a prendere l'iniziativa» (ib., p. 12).Nelle opere poetiche gli stessi temi sono ripresi con un
affiato ed un impeto propri del potente linguaggio d'Iqbàl.■ Per risparmiare al lettore non specialista eccessivitecnicismi di citazioni delle opere originali d'Iqbàl,indicheremo nel testo unicamente la pagina de Il Poema Celeste, a cura di A. Bausani, Bari 1965, a cui rimandiamo per i dettagli bibliografici. Ci scusiamo parimenti con lo specialista per aver rinunciato, datoil contesto dell'articolo, alle notazioni diacritiche nei casi di traslitterazione dall'urdu o arabo.
«Iddio non vive senza il gusto del dialogo... » (p. 270). E se sipensa che questo dialogo si apre tra l'Allah coranico e il muslim (il credente che si abbandona incondizionatamente alla volontà omnioperante di Dio), ci si rende conto del messaggio inquietante che il poeta indo-musulmano propone ai fratelli di fede. La riconquistata autonomia dell'uomo si esprime in accenti conturbanti, quasi blasfemi alle orecchie del pio, tradizionale musulmano:
«Molto ho da fare ora nel mondo, ora sii Tu ad aspettarmi!E il dì della resa dei conti, di fronte al registro dell'opre,svergognami pure, Signore, ma vergognati un poco Tu ancora» (p.277).In un famosissimo struggente poema (Shikwah) Iqbàl
interroga Dio sul perché del declino e prostrazione dell'Islam attuale. E' un sincero esame di coscienza del musulmano moderno e nel medesimo tempo una Protesta - shikwah, appunto - contro Allah:
«Siamo famosi, noi, per la nostra rassegnazione,cantiamo storie di dolore, parliamo di destino,siamo liuti silenti popolati di grida represse.Se un lamento ci sfugge dal labbro, vogliate ora scusarci.O Dio! Ascolta, da chi t'è tanto fedele, proteste,dall' assuefatto alla lode, ora, lagnanze! » (p. 231).Sul rapporto uomo-universo:«Son troppo vecchie queste stelle, troppo consunto il firmamento: io ho bisogno di un mondo neonato e nuovo!...Dicon gli sciocchi: Adattati dunque al Destino!Io dico: A te s'adatti il Destino, altrimenti lotta con lui!» (p. 280).«Sì, son lo Straniero, sì, sono il Colpevole, mail Tuo desolato deserto non seppero popolare gli Angeli!» (p. 278).«Oltre ormai al monotono piacere dell'Unione Eterna, voglioconoscere il gusto del sospiroso lamento.Donami la lotta e il bisogno dell'Uuomo, dona il bruciore dell'Uomoall'animo mio!» (p. 252).
E con evidente invito al risveglio dei popoli musulmani si conclude il grande inno alla natio islamica (Millat):
«Il canto d'Iqbal sembra segnale di campana:ecco, la nostra Carovana si mette di nuovo in cammino» (p. 229).
4. Pensiamo che sia questo il contesto culturale dell’attuale comunità musulmana del Pakistan - riscoperta del valore dell’uomo e della sua autonomia nel costruire lacittà terrestre - che ha favorito la rivalutazione e la rilettura di un poeta come Nazìr Akbarabadi, di un secolo anteriore a Muhammad Iqbàl (1873-1938). Ma - diciamolo subito - Iqbàl e Nazìr, per quanto contraddittorio possa sembrare, hanno ben poco in comune. Se l’uno e l’altro disdegnano i clíché della trita tematica convenzionale e ritrovano la freschezza della vena poetica nella riscopertadell’uomo e del suo dramma storico, lo fanno per vie del tutto diverse, se non addirittura opposte. Scolastico ed accademico l’uno, autodidatta e antintellettualista l’altro; aristocratico e rifinito l’uno, popolano e grezzo l’altro; idealista Iqbàl - il filosofo dell’Io e dell’Uomo-, concreto e corposo Nazìr - il cantore del bottegaio, delvenditore ambulante, dell’amico incontrato per istrada...-; impegnato l’uno alla revivificazione dell’Islam e al risveglio sociale e politico dei musulmaní, bohémien l’altro, vagabondo del mondo, senza ideali da svendere o politiche da appoggiare, acuto ed ironico descrittore dei volti anonimi, eppure reali, che brulicano nelle vie di Delhi o nel bazar di Agra; profetico l’uno nel preconizzarela perfetta immagine dell’uomo di domani, immediato ed empirico l’altro nel cogliere la miseria e le angustie della folla umana di oggi; stilista e persianeggiante l’uno, populista ed incolto l’altro, nei temi come nel linguaggio. In breve, la poesia sgorga in Iqbàl da una fantasia dal fervore profetico, in Nazìr da un bruciore epidermico per il gusto dei sensi. Il resto è evidente di suo.
Ma veniamo più direttamente a Nazìr.
Ecco come un critico pakistano, in un’eccellente opera sulla letteratura urdu, introduce Nazìr Akbarabadi:
«Nazìr è stato guardato con freddezza dai vecchi criticiperché un eccentrico che non quadrava entro gli schemi della poesia tradizionale. Egli fu un outsider e subì lasfortuna di chiunque non sottoscriva ai gusti imperanti del tempo. Con l’affrancamento della poesia da vecchie convenzioni, il suo merito è stato riconosciuto. E, comeè naturale in casi del genere, il pendolo ha oscillato atal punto nella direzione della lode da far sorgere il timore che (Nazìr) venga stimato oltre il merito» (MUHAMMAD SADIQ, A History of Urdu Literature, Oxford 1964, 111).E infatti ci sembra alquanto esagerato il giudizio del
prof. Bausani che considera Nazìr «uno dei migliori, se nonil migliore poeta di tutta la letteratura urdu classica» (Letterature del Pakistan, in Storia delle Letterature d’Oriente, Vallardi, Milano 1969, 603). Più nuancé il giudizio del sopraccitato critico pakistano. Questi, dopo aver notato che il verso di Nazìr non offre ulteriori suggestioni poetiche al di là della sua tenue trasparenza, conclude sinteticamente:
«La sua (di Nazìr) poesia è la sublimazione del genio dell’uomo ordinario. Se un uomo della strada divenisse, per una misteriosa trasformazione, poeticamente vocale, scriverebbe come Nazìr» (MUHAMMAD SADIQ p. 116).E, infatti, se l'immediato sensismo estetico di Nazìr da
una parte dà freschezza e verità ai suoi versi, dall’altra consuma tutta la carica poetica nella tenue tessitura del verso stesso. Nessuna dimensione di paradigma, o sistema associativo - per rifarci alla nozione saussuriana dei due assi del linguaggio - crea un qualsiasi spazio evocatico diriserva poetica che si ponga al di là delle componenti grammatico-sintattiche del verso naziriano. E questo proprio nel cuore d’una tradizione letteraria urdu, che - sulla scia della poesia persiana - trova il gusto del poetare nella frangia estrema della sfera d’associazione
del linguaggio, là dove il fervore evocativo raggiunge il suo acme. Ne risulta una tecnica elaboratissima dove il simbolismo più sbrigliato, evocato ab extra, rifluisce sulla tessitura sintattica del verso facendovi opera di disturbo fino a scompigliare i nessi semantici, e creando nel medesimo tempo la meraviglia poetica. In condizioni stilisticamente ottimalí, la qualità di siffatta poesia potrebbe raggiungere vette altissime d’emozione. Ma molte sono pure le probabilità di rischio. La forza dell’ondata straripante dal “fuori campo” asseciativo potrebbe riversarsi sul sintagma con tale capricciosità da travolgere il tenuissimo filo del discorso sintattico. Sarebbe allora la conflusione e il sovvertimento assoluto del rapporto sintagma-sistema (necessario, del resto, per ogni enunciato che abbia senso). In tal caso tutto significherebbe tutto. Al di là dell’unico rifugio possibile, il silenzio, sarebbe il non-senso della pura equivocità e la dissoluzione stessa della poesia.
Chi ha dimestichezza con la letteratura persiana, e di quella urdu sulla scia del persianismo, sa che codesta poesia si è mossa, con equilibrismo più o meno fortunoso, sullo spartiacque del massimo simbolismo e della pura equivocità (tutto può essere metafora di tutto). La maturazione di tale stile poetico coincise con la fine del XVIII e inizio del XIX secolo, e quindi col periodo del poetare di Nazìr Akbarabadí. Mirza Ghalib segnò il massimo del perfezionismo estetico e l’apogeo della poesia urdu classica. Fu colui che sfruttò appieno le potenzialità poetiche della fascia associativa del linguaggio, premendo la parola verso arditissime zone di polisemia ma evitando, con un salvataggio dell’ultima ora, lo scoglio della dissoluzione del linguaggio. Ma non tutti i poeti seppero mantenere l’equilibrio sulla corda tesa. E la poesia urdu rimarrà, anche in esperienze recentissime, vocazionalmente ghalibiana. Il campo simbolico-associativo sarà praticamente il registro unico di tutta la poesia urdu.
Questo andava detto per situare la poesia di Nazìr a partire da una analisi interna al suo linguaggio e all'uso
che egli ne fa. A nostro avviso Nazìr è una curiosa isola poetica della storia della letteratura urdu, perché l’unicoche costruisca il suo verso respingendo da esso il rigurgito del campo metaforico e affidando quasi esclusivamente al composto grammatico-sintattico le possibilità di emozione estetica. L’atteggiamento dei critici del tempo, i qualí o ignorarono o disdegnarono Nazìr non sapendo dove “collocarlo” criticamente, corferma il nostro giudizio. Sbagliarono invece costoro a negare ogni valore alla poesia di Nazìr sull’assunto (meglio, esperienza culturale univoca) che non ci fosse altro modo di far poesia se non quello, per intenderci, ghalibiano.
Per rendere meno astratto il discorso, diamo alcuni esempi della poesia di Ghalib. Lo riteniamo doveroso, perché il lettore abbia la possibilità di constatare la complessità, l’elaboratezza, la smaliziata compattezza formale della poesia urdu, e non sia lasciato con l’impressione che la poesia di Nazìr, strutturalmente e formalmente del tutto elementare, costituisca il tipo di poesia urdu, che anzi - l’abbiamo detto - va considerata un’eccezione. Nel contempo il lettore potrà cogliere per contrasto la singolarità propria del poeta Nazir nella geografia critica della letteratura urdu.
Da Mirza Ghalib (Agra 1797 - Delhi 1869) scegliamo a caso alcuni sha’r (unità completa di verso, di due emistichi; il ghazal è composto di più sha’r, ma questi sono per lo più formalmente compiuti e quindi unità poetiche autonome):
1. La Coscienza distenda pure quanto vuole la rete dell’Udire:il Significato è la Fenice della sua propria Parola.Potrà sembrare sibillino al lettore occidentale, ma una
volta afferrati i riferimenti «fuori campo» dell’esasperatosimbolismo di tale poesia, la coerenza semantica della sua tessitura stilistica è facilmente assicurata. Qui: il significato profondo è inesprimibile con parole, essendo esso l’inesistente uccello (Fenice) e cioè il silenzio della sua possibile espressione (II emistichio). Ogni
tentativo di carpire la parola è inutile così come gettare la rete ad un uccello inesistente (Fenice) (I emistichio).
2. Ho tentato di trattenere i Sospiri, ma a fiotti sono rigurgitati;son divenuti ora la Sutura della mia «Lacerazione del colletto».Disperazione e follia (= metafora della lacerazione del
colletto) sono state coperte dai sospiri. Questi, esseri...filiformi (e qui è assicurata la coerenza della metafora), fanno ora da appariscente filo di sutura della «lacerazionedel colletto», quando avrei voluto farli passare inosservati.
3. Vorrei andarmene dove non ci sia nessuno, nessuno che mi parli o sappia la mia lingua. Vorrei costruire una casa senza porta né muri dove né guardiano ci sia né prossimo.A parte l’arditezza di protendere l’immagine della casa
(che pure è ritenuta) fino al limite della sua dissoluzione(impossibile una casa senza porta e muri!), c’è qui nell’originale urdu un’altra sorprendente evocazione fuori campo, e questa volta al livello puramente lessícale. Prossimo o vicino di casa, è in urdu ham-saya, letteralmente «co-ombra», colui cioè che è con me sotto la medesima ombra. Se l’inesistenza del guardiano è introdottanel tessuto verbale per un richiamo logico (mancanza di porta, quindi... ), l’inesistenza del prossimo (co-ombra) emerge dal campo associatívo puramente lessicale-etimologico, al massimo del formalismo poetico. La co-ombra non può esistere là dove ombra non c’è, visto che si tratta di una casa... senza muri!
Siamo al limite delle potenzialità poetiche scovate negli sfasamenti dei due assi del linguaggio. E non tutti ipoeti urdu escono indenni da siffatte arditezze. Nasikh († 1838) ad esempio, contemporaneo di Nazìr, rischia di sovvertire a tal punto le costanti del linguaggio da concludere ad una commistione dissolvitrice della poesia stessa (si pensi all’arzigogolo della poesia secentistica italiana). Eccone due esempi:
1. Mi son dissolto nel fiume d’amore. Mi basterà per tomba la cupola d’una bolla!La coerenza del tutto è affidata al labile filo della
rotondità e quindi somiglianza d’una bolla d’acqua con la cupola del mausoleo-tomba!
2. Arde perfino il riflesso della tua faccia di fuoco: il mercurio s’è liquefatto dietro lo specchio.Si suppone che l’ardentissima amante (dalla faccia di
fuoco!) stia rimirandosi nello specchio, che ne subisce le... disastrose conseguenze di cui al secondo emistichío.
Dai testi poetici di Nazìr, che riporteremo più avanti, il lettore avvertirà d’istinto come ci si muova in tutt’altro mondo poetico. Non intendiamo con questo introdurre una valutazione preferenziale per l’uno o l’altro modo di far poesia, ma ci premeva illustrare e determinare il registro tecnico-formale proprio di Nazìr. Questi contrae al massimo la propria emozione poetica entroil semplice supporto grammatico-sintattico del verso (pianosintagmatico del linguaggio). Acquista immediatezza, efficacità plastica, verismo. Ma la sua poesia si consuma in ciò che il verso grammaticalmente significa. Non ci sonoaltre zone poetiche di contorno, che accompagnano - allargandola - la sintassi del verso. Questo è letto, ed è già esaurito.
5. Nazìr Akbarabadi (Akbarabad era chiamata dai musulmani la città di Agra) nacque a Delhí nel 1740 circa. La famiglia, per sfuggire ai disordini politici e militari che tempestavano la capitale dell’impero moghul ormai in decadenza, riparò ad Agra (sud-est di Delhi). Agra fu la scena umana della poesia di Nazìr, e ad Agra egli morì nel 1830, anni in cui gli inglesi portavano a termine la quasi totale soggezione dell’India.
Due fatti vanno subito notati per fissare la fisionomia della personalità artistica di Nazìr. Primo, egli non fu poeta di corte. L’importanza di ciò è decisiva se si tien conto che tutta la letteratura urdu, ad eccezione di quella
del XX sec., è una letteratura che vegeta, si sviluppa e simodella sulla vita delle corti musulmane - imperiali o vassallatiche - dell’India. E delle corti risente l’atmosfera come pure le vicende politiche. I poeti urdu sono regolarmente stipendíati a corte, e al servizio del mecenate - imperatore o nawab che sia - spendono il loro talento poetico. La letteratura urdu ebbe per culla le corti dei regni musulmani del Deccan (1400-1600), fiorì poinell’India del nord presso la corte dell’imperatore moghul di Delhi. Sullo scorcio del ‘700, l’insicurezza di Delhi, bersagliata militarmente da più fronti e a più riprese, favorì un vero e proprio esodo dei poeti che rifugiarono presso stati vassallí più quietí - Hyderabad, Rampur, Bhopal e, più vicino, Oudh. Ogni corte originò così una “scuola” con caratteristiche e temperamento poetico-letterario propri. Nazìr, caso unico nel periodo classico della letteratura urdu, non è al soldo di alcuna corte, e di conseguenza non si riallaccía ad alcuna scuola.Caso impensabile di extravagans per i critici del tempo, chelo ignorano non riuscendo ad incasellarlo entro i rigidissimi schemi della poesia di maniera.
Secondo fatto. Nazìr, fuori della serra della vita di corte, vive la propria esperienza poetica tra il brulichio delle masse popolari, vagabondo spensierato e scapigliato nelle strade rigurgitanti di vita e di miseria dell’oriente, nei bazar pullulanti delle angustie e dei brevi piaceri dei poveri, nelle mille botteghe in cui si litiga lo spicciolo ed il pezzo di pane: nel cuore, insomma, della “commedia umana”, nella sua più densa corposità, di contro alla vacua esistenza dei privilegiati del paradiso delle corti.
L’incidenza di ciò sulla poesia di Nazìr è facilmente intuibile. Costituzíonalmente ostile e anticonformista nei riguardi della sussiegosa poesia cortigiana, impone - con scandalo di tutti - forme strofiche e tecniche di versificazione insolite (il nazam, agile poemetto a strofe con versi e rime scorrevoli, di contro al costrettissimo ghazal, modello della poesia dotta e ufficiale). Immerso
fino al collo nella vita del popolino, capovolge i temi poetici. Questi, cristallizzati nella tematíca della vita di corte, avevano esaurito la propria capacità di suggestione poetica favorendo una produzione tanto massiccia quanto vieta. Si ricorre con più frequenza al plagio dei modelli persiani, ma tutto termina ad una colluvie di diwan (raccolte di ghazal) dove si rifriggono, fino alla nausea, i temi dell’amata lontana, del canto dell’usignolo, del lirismo floreale, e si saccheggiano logore metafore di repertorio, come quelle della candela-falena, dell’amato-omicida, dell’efebo-anfitrione ecc. Nazìr, con scorno di tutti, fa poesia - e degnissima poesia - cantando il cetriolo di Agra, il cocomero del bazar, la farina e cicerchie (bellissimo è appunto il poemetto su ata-dal), i quattrini, l’oppio, le feste popolari, le stagioni, la povertà, l’amore di suburra, la morte... Un’altra innovazione di Nazìr: il lessico. Di contro un tronfio snobismo dei poeti cortigiani che rimpinzano il loro urdu di arabo e persiano (le lingue dotte) credendo di dar lustro a sé e alla lingua, Nazìr spalanca all’urdu la porta del linguaggio popolare, immettendo nella lingua letteraria uno spesso strato di lessico vernacolo (prevalenza di termini hindi, lingua del popolo). E l’urdu acquista elasticità, nitidezza e varietà proprie delle lingue che si rinnovano nel contatto vivo colsuolo umano-sociale di una cultura. Soprattutto ha inizio il fenomeno della socializzazione dell’urdu. Questo, svincolandosi dal monopolio di palazzo (urdu-e-mu’alla, lingua appunto del campo o corte imperiale) guadagna stratisempre più popolari contribuendo a creare l’amalgama linguistico-culturale della comunità musulmana dell’India.
Non è possibile qui presentare un’antologia dell’opera di Nazìr. Cercheremo invece di raccogliere alcuni temi sparsi nel tentativo di fissare il punto focale della sua poetica: la meraviglia e l’amore per l’uomo. Dove uomo sta non per un ideale astratto né per una infinzione poetica, ma per chiunque - o tutti - di una folla umana si muova sulla scena del mondo consumando la propria vita dietro i
banalissimi bisogni umani. È in atto l’ingenua funzione poetica dello sguardo del popolano che riconosce la medesima materia umana dietro i tenui (tenui all’ironia delpoeta!) sipari - il mestiere forse, o il censo, la casta, la religione, la razza - che spaccano verticalmente la comunità degli uomini. Qui un universale livellamento è prodotto ad opera della curiosità e ironia poetica di Nazìr. Lo sguardo del popolano restituisce la solidarietà agli attori della scena del mondo. Una solidarietà riscoperta non per una vocazione etica o ideologica, ma perl’ostinata impertinenza di mettere a nudo le elementari, ingloriose concupiscenze che accomunano gli esseri umani. Èla funzione ironica della simpatia di Nazìr. E l’ironia, ora benevola ora amara, fa da catalizzatore poetico alla variopinta galleria umana che scorre davanti all’occhio delpoeta. E qui si fa, anche al livello formale, l’unità del genio poetico di Nazìr, spesso accusato di dispersione nella sua incontenibile curiosità. L’ironia dà compattezza formale alla girandola dei mille colori che ritraggono la vita e l’agitarsi dell’uomo. E così tutto ciò che è irrinunciabilmente e quotidianamente umano trova posto nei versi del popolano Nazìr: debolezze e bisogni, ansie e cupidigie, miserie e follie; pane, lucro, casa, affari, amore, povertà, morte ... ; e le mille e mille cose che fanno il teatro della vita dell’uomo: strada, città, feste,tempo, stagioni, cielo - quello che intende il contadino, il saltimbanco, il rivendugliolo... E da questo panorama del mondo emerge, compatta e vera, la figura dell’uomo che lo stampo poetico dell’ironia naziríana accomiata con un tocco finale di profonda simpatia.
Ma una simpatia ed una commozione che non si fanno mai coinvolgimento, mai moralismo. L’ironia è là a contenere leemozioni entro l’area poetica della pennellata leggera, dell’emozione annuita, dell’annotazione veristica ma mai cruda, dell’accoramento per l’affamato e il meschino ma chenon si fa né prostrazione né ribellione. Si definiscono quisia i termini della grandezza di Nazìr che i limiti del suotemperamento artistico. Il gusto del dettaglio umoristico,
dell’angolatura deformante, della commistione grottesca, della contaminatio irriverente escludono il piglio dantesco,ma in compenso danno alla “commedia umana” del poeta di Agra un tono che non trova riscontri nelle letterature d’occidente.
Una connaturale simpatia, dunque, per l’uomo, chiunque ecomunque sia. Non certo umanesimo nel senso europeo della parola. Ma la riscoperta ingenua e pre-critica del valore dell’uomo come tale, così com’è, in una società dove forme religiose alienanti tendevano a polverizzare l’uomo al cospetto di un teismo esasperato (fosse di marca islamica oindù). La riaffermazione dell’uguaglianza di base degli uomini, laddove stratificazioni di casta e privilegi feudali avevano spaccato la società in raggruppamenti culturalmente ed economicamente schizofrenici. La trepidazione per l’uomo senza volto del popolo, trascinato a guerre che non lo riguardavano, consunto in una povertà endemica, fagocitato dagli altrui interessi, ignorato infine dai poeti, per i quali evidentemente la poesia non aveva nulla da spartire con l’ingloriosa esistenza dell’uomo del volgo.
Né si può parlare di socialismo nel caso di Nazìr Akbarabadi. Lo scioperato e scanzonato poeta di Agra non nutriva né teorie né ambizioni di profetismo sociale. Né deriva la curiosità intellettuale d’analisi degli squilibridella sua società. Si può parlare forse di un populismo estetico. Una viscerale simpatia a cogliere il variopinto mondo dell’uomo comune, a registrare con meticolosità e arguzia i suoi ingredienti, il suo dimenarsi, il suo crescere, il suo morire... E oggi è forse proprio questo che, in una società dove ideologie crollano per avere scavalcato l’uomo, ridà a Nazìr Akbarabadi un posto onorevole nella lettura e nella critica contemporanea urdu.
6. Ma lasciamo al lettore il gusto d’apprezzare da sé il poeta di Agra. Ecco una succinta antologia del cantore dell’uomo comune.
Da La Pagnotta. Roti è il pane a forma di schiacciata rotonda, tuttora nutrimento base delle popolazioni dell’India. Comprensibile la forza... evocativa che il roti esercita sugli stomachi affamati, come provano i due versi finali.
Quando van giù nel ventre sàpide le pagnotte non resta più un angolo in corpo cbe non riempiano le pagnotte. Fanno ammiccare con gli occhi alle belle, le pagnotte, e invitano le mani a lisciare il bel petto, le pagnotte. Insomma quanti son gusti, tutti li dànno le pagnotte! Senza pagnotte nel corpo, non c’è più gusto all’azionenon piace vagar nelle fiere, passeggiare nei prati. In cuore al famelico non c’è attrazione per Dio. È vero quel che disse qualcuno, non è falsità: Persino Dio fanno venir in mente, le pagnotte!Se domandasse qualcuno a qualche affamato fachiro per che cosa creò Dio questo sole e la luna, quello direbbe: «Bravuomo, ti benedica Iddio! A me quelli non sembrano affatto né luna né sole: Bravuomo, a me sembra proprio che sían pagnotte!».(traduz. Bausani, Le Letterature del Pakistan, Milano, 1958,
152).
Aggiungiamo, di nostra traduzione, un'altra strofa interessante per la contaminatio che la parola nur - luce spirituale, divina nella terminologia religíosoteologica urdu - introduce nel bel mezzo del contesto culinario:
Forni, fornelli, pentole e marmitte: qui si squaderna la virtù del Creatore!Lo splendore, alla bocca del forno, è la Presenza (di Dio).Fra le tante luci (nur), specialissima è questa: in questa luce (nur)... compaiono a vista pagnotte!Da La Povertà:Ditemi un pò, ora: quel Sapiente dalla gloria sovrana, al quale s'ínchinano nababbi e khan reverenti... se diventa povero? Povero, non vale nulla Loqman
e se pur fosse un Gesù, non lo guarderebbero in faccia: Sì, soffoca anche la saggezza del saggio, Povertà!Quando quel brutto giorno s'abbatte su una bella fanciulla, distribuisce a tutti per amore o per forza baci a destra e sinistra, e mai a nessuno viene in cuore affetto per lei. Se ha una bellezza che valga mille rupie... ahimè, a quale alto prezzo, nel mondo, si vende, la Povertà.(Bausani, 153-154).Da Paisa, l'inno ai quattrini (paisa è l'unità monetaria
della valuta indo-pakistana):Là dove i soldi han disteso le loro reti potenti, s’impigliano l’ali e le penne pure degli angeli! Davanti ai soldi, che contano queste graziose fanciulle? I soldi fan pure uscire le fate dai loro castelli di sogno! I soldi sono forma e bellezza, i soldi sono ricchezza se non avesse soldi, l’uomo sarebbe schiacciato dal cielo!Per che si levan le lance e gli scudi? Pei soldi. Per che volteggian le spade e le frecce? Pei soldi. E la gente si piglia ferite sul campo... Pei soldi! Sino al punto che si fan tagliare le teste... Pei soldi! I soldi son forma e bellezza, i soldi sono ricchezza se non avesse soldi, l’uomo sarebbe schiacciato dal cielo!(ib., p. 152).
Dall’Inno al Cocomero (Tarbùz) significativa è la strofa seguente dove, ad opera di una metatesi d’immagini, è creato un effetto di surrealismo tutto moderno tra l’orridoe il giocoso:
Spietata e crudele è quell’amante sanguinaria, fa un massacro, notte e giorno, dei suoi trepidi amanti. Ieri proprio m’avvenne di passare nella sua strada e tal magazzino di teste tagliate di martiri a mucchi vidi colà, proprio come al bazar cocomero sopra cocomero!(ib., p. 156).Da La Morte (Maut):
Uno il mondo s’è goduto, ed è morto un altro nelle strette è vissuto, ed è morto anche lui. Il dòtto t’ha tenuto a lezione, ed è morto il deficiente che il petto batteva, è morto anche lui. Morto è lo sventurato, morto il gaudente. Chi è rimasto in vita? Chiunque è venuto andato se n’è! (Traduciamo dall’antologia naziriana in A.L.SIDDIQI,
Nazir Akbarabadi: unka ‘ahad aur sha’iri (N.A.: la sua epoca e la sua poesia), Lahore, II ed., 1967 (in urdu). L’autore, attuale preside della facoltà urdu all’università di Karachi, è il critico più autorevole di Nazìr e l’artefice della sua rivalutazione).
Due strofe da un altro nazam che, per il suo ritornello, potrebbe essere una parafrasi del «Pulvis es...»:
Giace la salma del ricco in una cassa di zinco nel ventre della nuda terra il povero è sepolto. Che dire, amici? Entrambi li divora la polvere. Chi di polvere è fatto, polvere torna!Uno giace in un sudario da mille rupìe un altro, derelitto, nudo è sepolto. Carne e cuore d’entrambi rodono i vermi. Chi di polvere è fatto, polvere torna!
Dalla famosa Città del Terrore (Shahar ashob) traduciamo alcune stanze. Non si tratta di finzione poetica - estraneadel resto al temperamento artistico di Nazìr - ma di una descrizione di fatti reali. La città in questione è Agra. Si è cercato di datare la poesia in riferimento ad un'invasione militare o carestia particolare. Ma il tentativo sembra votato a sicuro insuccesso. Dalla morte diAurangzeb (1707), che segna l'inizio del declino dell’impero moghul, al grande mutiny del 1857 il tratto della pianura gangetica che va da Delhi, Agra a Luknow e oltre, è teatro d’incursioni, guerre, saccheggi e carestie d’una crudeltà e frequenza inimmaginabili. Nadir Shah di Persia, Shah Abdali Afghani attaccano a più riprese l’India
settentrionale ordinando massacri e saccheggí; i Sikh si organizzano in forza militare, si ribellano al sultanato diDelhi e combattono per l’indipendenza del Panjàb; dal sud ibellicosi Marathi scatenano quattro guerre successive nei territori dell’impero moghul (dal 1775 al 1818); popolazioni tribali, i Rohilla, assaltano dal nord; e intanto gl'inglesi stringono il cerchio da est. In tale miserevole stato di cose, gli eredi fantocci dei grandi Moghul e i numerosi nawab (principi vassalli) assistono indifferenti, nel lusso e nella corruzione della vita di corte, agli ultimi singulti d'un mondo in sfacelo. E i poeti assoldati distraggono i cortigiani con sollazzevoli ghazal. Fuori, la miseria e la prostrazione di milioni d’esseri umani sfruttati e dimenticati. Solo Nazìr registrale loro sofferenze.
Dalla Città del Terrore:Oggi non ho animo neppure di parlare immerso come sono in tetri pensieri, notte e giorno. Il mare ondoso della mia parola s’è sedato. E come potrebbe la lingua non esser incollata nella bocca quando la gente di Agra non sa come sfamarsi?Neppure il pane quotidiano, ecco quale miseria! Non è un trucco; è palese come la luce del giorno, la miseria! Tra muro e porta s’è insediata la miseria al punto che ogni casa ha inondata la miseria!
Dopo aver detto che in città è sparito ogni bene, persino «il pericolo dei ladri e il timore degli scippatori» - l'ironia rifà capolino anche in una poesia dal tono accorato -, Nazìr continua:
Cambiavalute, mercanti, gioiellieri e banchieri trafficavano in contanti, vivono a credito ora. Polvere a manciate è caduta nel bazar. Seggono oziosi i merciai in bottega come tanti ladri inquadrati a giudizio.Operai e impiegati d’alto rangoneppure una giornata racimolano, i meschini!
Seduti sino a vespro se ne stanno al negozios'alzano poi esclamando: «Scarogna! Lo fortuna, impotente, ci ha abbandonati!».Divenuta di nessuno, votata è Agra alla rovina: dìrute le case, rifugio aperto la città! Opra del giardiniere è custodire il giardino:e non diverrebbe, questo, deserto qualora né giardiniere ci fosse, né padrone, né recinto? Perché, amici, questo vento ha spirato sulla nostra città? Tale una miseria che senno e sensi ha perso la gente e chi dissennato era digià, tale è rimasto. Sapiente tu sei: prova a sciogliere il nodo!
7. L’Admi-Namah (Poema dell’uomo) è il canto in cui Nazìr dà la somma della sua simpatia per l’uomo, della sua capacità di dettaglio, della sua ironia. Versi semplici, incolti. Le strofe, discontinue, sono altrettanti flash su tenui unità bozzettistiche: cronaca di strada, memorie contaminatorie, riduzioni fantasiose, enumerazione orizzontale dei dettagli (il conato, inesprimibile, all’universale astratto?): funzioni elementari della fantasia popolare con cui il volgo compone la sua visione del mondo. Eppure, a lettura finita, il quadro d’insieme che ne salta fuori (si direbbe uno stile “macchiaiuoli”) è d’una compattezza di tessitura e d’un’urgenza di messaggio che lascia sconcertati (e bisogna sempre riportarsi ad un’epoca letteraria stilisticamente pre-realistica, al contesto dell’alienante poesia urdu del tempo, alla mentalità di casta e strutture sociali dell’India dell’800).
L’unità formale di composizione è affidata ad uno stilema che a prima vista potrebbe passare per ripetizione,espediente comunissimo nella stilistica orientale. Si tratta di so hai wo bhi àdmi (= è uomo anche lui), ripetuto, qua e là, persino due volte in un sol verso. In effetti il suo valore semantico è sapientemente distribuito, nel
poemetto di Nazìr, tra funzioni diverse che vanno, in un continuo crescendo, da semplice ritmo d’assonanza o ritornello o commento, a contrapposizione ironica, ad asserto beffardo, a proclamazione inappellabile. Lo stilemaimpone un martellamento mentale che segna il tempo al crollo degl’idoli eretti sulla miseria umana. E quando, dopo la scorribanda bizzosa e ostinata (l’elenco è un’altrapeculiarità della poesia naziriana, una tecnica semplice, da stornellate... ), tutto è livellato, si erge dal cumulo di macerie l’unica cosa superstite allo scrutinio capriccioso di Nazìr: l’uomo, chiunque esso sia, di qualsivoglia rango, stoffa, destino. L’uomo di Nazìr la spunta persino con la morte, a suo modo; certamente col male: «E l’avanzo di forca... è uomo anche lui!».
Traduciamo il poemetto <dall’originale in lingua urdu>come è riportato dall'antologia naziriana in A.L.SIDDIQI[1]. L’asintatticità e le arditezze d’apocopidel verso urdu di Nazìr non rendono facile il lavoro di traduzíone. Qua e là siamo ricorsi ad una traduzione leggermente perifrastica. Un qualche tentativo di ricreare il sapore popolano dell’originale è stato fatto con la preferenza ad un lessico intenzionalmente vulgaris.
Poemadell’uomo
ةةةةةةةة
Chi è re sulla terra non è altro che uomoe uomo è il pitocco, uomo il mendicante.Riccone e miserabile, uomini sono.Uomo è chi s’abbuffa d’ogni ben di Dio,
e chi un tocco di pane mendica è uomo anche lui.Santo santone e baciapile non è altro che uomouomo è il miscredente e chi pieno fino al gozzo è d’empietà;e chi con miracoli e portenticon ascesi e austerità se ne vola al Creatore, è uomo anche lui.Si spacciò per Iddio Faraone,Sciaddàd Dio si fece del proprio paradisoe Dio si proclamò pubblicamente Nimród…[2].E faccio punto. Son cose rísapute! Alla fin fine chi mise su tanta cresta era uomo anche lui.Qui uomo è il tizzone d’inferno e la luce celesteuomo il vicino, uomo il lontano.Gloria e vergogna dell’uomo fan mostra sulla scenadel mondo.Satana, anch’egli, non è che un uomo più buggeronedegl’altri. E chi è Guida e Profeta è uomo anche lui.È uomo, mio caro, chi costruì la moscheauomo chi l’uffizio vi fa e il sermoneuomini il Corano vi recitano e la Preghiera solenne[3].Chi poi le babbucce vi sgraffigna non è altro che uomo[4]
e chi il ladro acciuffa e bastona è uomo anchelui!Uomo è chi dona la vitae uomo chi infilza.Chi il prossimo di fango ricopre è uomo anche lui.Uomo è chi manda grida d’aiuto e chi accorre in aiuto è uomo anche lui.Danza e strepita il buffone di corte,
i calzoni si slaccia e nudo piroetta sulla propriaabiezione.Chi lo spettacolo si godee si sbudella dalle risa non è altro che uomo; e lui, il buffone... è uomo anche lui!Uomo è chi intraprende un viaggiouomo chi assalta ed impicca.Uomo è preda, uomo è trappola.Ci scappa, amico mio, l’onest’uomo ma il ribaldo... è uomo anche lui!Uomo è chi sposa, uomo chi è sposato,giudice, avvocato e testimone non son altro che uomini;uomini quei della bandae uomini gli addetti alle torce. E chi va a nozze è uomo anche lui.Uomo è l’araldouomini cavalieri e fantaccini.Chi, scarpe sotto braccio, con huqqa[5] e fiasco frettoloso vae quei che il palanchino s’incollano uomini sono; chi poi sul palanchino monta è uomo anche lui.Chi mette bottega e siede al bancone è uomo anche lui.Un gran vociare di «prendi» e «porta», al bazàr!Brulicano, cesta sul capo, i venditori ambulanti;mercanzie, chincaglie e rivenduglioli d’ogni rismae mestiere. L’acquirente, poi, è uomo anche lui.Qui fan buriana e s’azzuffano gli uni,e se la filano gli altri al solo vederli.Schiavo e lacchè sono uomini, uomo il bracciante.Uomo è chi vuota le latrine[6]
e chi di merda le riempie... è uomo anche lui!Chi è stracarico di gemme e rubini
e chi nel fango a sbrodolarsi è ridotto, è uomo anche lui.Chi è più nero del rovescio d’una pentolae chi risplende come una fetta di luna, è uomo anche lui. Bellimbusto e racchio, non son altro che uomini.È uomo chi sfoggia ricchezzebardato d’oro e zecchini- un luccichio da levante a ponente! -soffocato da scialli, broccati, velluti... E chi sbrendoli indossa è uomo anche lui.Ti meraviglierai. Sta’ a sentire che sorta d’istrionica:medesimo è l’uomo che ruba e che lascia le tracceche scippa e che chiede elemosina.L’uomo, che bel pezzo di bassa lega! E chi fosse forgiato di purissimo acciaio, sarebbe uomo anche lui.Uomini sono che fanno la cassa da mortoche acconciano e portan la salmache fan piagnistei e cantano il requiem[7]:imprese funebri e funerali sono, insomma, mestierida uomo. E chi crepa - povero diavolo! - è uomo anche lui.Nobili e plebei, re e ministrionorevoli e cafoni: tutti uomini sono.Qui uomo è il discepolo uomo il Maestro[8].Chi è buono, o Nazìr, qui gli dànno dell’uomo: e l’avanzo di forca... è uomo anche lui!
[1] A.L.SIDDIQI, Nazir Akbarabadi: unka ‘ahad aur shà‘iri (N.A.: la sua epoca e la sua poesia), Lahore, II ed., 1967 (in urdu). L'autore, attuale preside della facoltà urdu all'università di Karachi, è il
critico più autorevole di Nazir e l’artefice della sua rivalutazione.[2] Tre re dell’antichità, accomunati, nella tradizione delle letterature islamiche, per la loro iattanza.[3] Nell’originale: Imàm è colui che attende alla moschea e guida la preghiera ufficiale. Khutbah è il sermone di pragmatica in occasione della Preghiera solenne (namàz, preghiera ufficiale d’obbligo) del venerdì.[4] I musulmani, scalzi durante la preghiera ufficiale, lasciano le scarpe fuori della moschea.[5] Grande pipa ad acqua, diffusissima in oriente.[6] Gli spazzini (scavangers) formano una classe-casta, l’infima e la più disprezzata.[7] Rendo con Requiem l’originale Kalimah, la formula di fede islamica. Nella pratica religiosa essa svolge, più o meno, la medesima funzione del «segno di croce» presso i cristiani.[8] Grandissima è la riverenza con cui in tutto l’oriente è circondato il Maestro (sia egli sheikh o murshid, ustàd, guru...); a lui il discepolo si rimette con incondizionata fiducia e acritico assenso.
finis