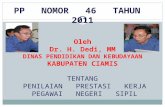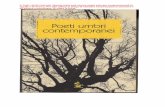Lo sguardo di Atena e la violenza di Aiace su Cassandra da Alceo ai poeti tardoantichi, "PP",...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Lo sguardo di Atena e la violenza di Aiace su Cassandra da Alceo ai poeti tardoantichi, "PP",...
LA PAROLA DEL PASSATO
RI V I S TA DI S TUDI A N T ICH I
FA S C I C O L O C C C L X X X I V
[ESTRATTO]
NA POL I
M A C C H I A R O L I E D I T O R E
2 01 2
LA PAROLA DEL PASSATO . RIVISTA DI STUDI ANTICHIFONDATA DA
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI E GAETANO MACCHIAROLI
Direzione: Pia de Fidio - Gianfranco Fiaccadori - Valeria Gigante LanzaraResponsabile: Gisella Macchiaroli
Consiglio direttivo: Luigi Beschi - John K. Davies - Sergio DonadoniHans Joachim Gehrke - Michel Gras - Johannes Kramer
Gianfranco Maddoli - Dirk Obbink - Raffaella Pierobon BenoitMirjo Salvini - Salvatore Settis - Marisa Tortorelli Ghidini
Gernot Wilhelm - Fausto ZeviRedazione: Marco Di Branco - Agostino Soldati
Coordinatore: Luigi Vecchio
in collaborazione con l'istituto italiano per gli studi filosofici
pubblicazione realizzata con il sostegno di
VOLUME LXVII/2012 - FASCICOLO III (CCCLXXXIV DELLA SERIE)
TomaÂsÏ VõÂtek, False Heraclitus: Heraclitean dubia and their typology 161
n o t e c r i t i c h e e f i l o l o g i c h e
Silvana Ciampa, Lo sguardo di Atena e la violenza di Aiace suCassandra. Da Alceo ai poeti tardoantichi 198
t e s t i e m o n u m e n t i
Andre Jacob, Deux fragments de diptyques liturgiques byzantins surostraka deÂcouverts dans la grotte de Leucaspide, preÁs de Tarente 216
r a s s e g n e
Valeria Gigante Lanzara, Gerard Lambin, Le Chanteur HeÂsiode(Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2012: Collection«InterfeÂrences»), 148 pp. 234
Printed in Italy . Arte Tipografica - Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
NOTE CRITICHE E FILOLOGICHE
LO SGUARDO DI ATENAE LA VIOLENZA DI AIACE SU CASSANDRA
DA ALCEO AI POETI TARDOANTICHI *
Al ricordo di mio fratello Pino
Nell'esaminare l'episodio del sacrilegio di Aiace Oileo, l'attenzionedegli studiosi si eÁ fermata in particolare sulla natura della colpa di Aiace.L'eroe greco, comandante del contingente locrese nella spedizione controTroia, durante la presa della cittaÁ insegue Cassandra, entrata nel tempiodella dea Atena per trovarvi rifugio, e commette un atto sacrilego, tra-scinando via la fanciulla e facendo cadere contemporaneamente il simu-lacro di Atena, al quale Cassandra, supplice, si era aggrappata.1 In alcunefonti, l'empietaÁ di Aiace eÁ aggravata dalla violenza usata verso la figlia diPriamo. Per vendicare questo oltraggio, rimasto impunito da parte degliAchei, la dea provocheraÁ il naufragio dell'eroe e dell'intera flotta greca diritorno da Troia. Ci si eÁ a lungo interrogati sulla natura del sacrilegio diAiace, se si tratti cioeÁ soltanto di una violazione del diritto di asilo, edunque di un atto blasfemo nei confronti della divinitaÁ, aggravato se-condo alcune versioni dalla caduta della statua di culto, o piuttosto di
198 note critiche e filologiche
* Un cordiale ringraziamento al prof. Giulio Massimilla, per aver letto illavoro in corso di preparazione. Miei sono, naturalmente, eventuali errori e im-precisioni.
1 Per un'interpretazione complessiva della figura di Cassandra nella tradi-zione letteraria e iconografica sono fondamentali Davreux 1942 e Mazzoldi2001. Vd. anche Neblung 1997.
un'azione sacrilega resa ulteriormente empia dalla violenza sessuale neiconfronti di Cassandra, consumatasi sotto gli occhi della dea.
Ai fini della nostra discussione, toccheremo soltanto marginalmente iproblemi connessi con i diversi aspetti del mito proposto e ci soffermeremoinvece sul particolare dello sguardo di Atena. Nella cultura greca l'attostesso del vedere ha sempre rivestito una grande importanza.2 La vista eraconsiderata un senso privilegiato, in quanto il piuÁ acuto.3 Questa centralitaÁdella vista nel mondo greco eÁ testimoniata anche da una notevole ricchezzalessicale legata alla sfera semantica del vedere, che spesso equivale alconoscere in quanto percezione integrale della realtaÁ.4 Non a caso unepiteto molto frequente di Atena, la dea della sapienza, eÁ `glaucopide',usato da Omero non meno di novanta volte. La pertinenza di questoepiteto allo sguardo eÁ connessa con la civetta, per la sua eccezionale capa-citaÁ visiva. Esso simboleggia dunque la funzione conoscitiva dell'intel-letto.5
Anche nell'episodio mitico preso in esame, la forza espressiva degliocchi si carica di un valore semantico non riducibile a semplice descrizioneo dettaglio secondario. Attraverso lo sguardo o la sua negazione, Atenaprende le distanze dall'azione empia che si sta consumando al suo cospetto,comunica la sua ira e disapprovazione nei confronti di Aiace e preannunziauna terribile vendetta. Il mio studio si propone pertanto di sviluppare unariflessione sull'importanza del tema dello sguardo della dea in relazione allacolpa di Aiace, all'interno di un'indagine che va da Alceo agli epici tar-doantichi.
1. Lo sguardo di Atena `sotto le ciglia' (Alc., fr. 298 V. = SLG S262)
Il tema mitico dell'oltraggio di Aiace affonda le sue radici in tempiantichi e attraversa generi letterari diversi. La prima attestazione certa eÁriscontrabile nell'Ilioupersis, stando al sunto di Proclo, ove si legge cheAiace Oileo portava via con la forza Cassandra dall'altare di Atena,facendo cadere simultaneamente il simulacro della dea.6 Null'altro l'epi-
199note critiche e filologiche
2 Sull'importanza dello sguardo nella Grecia antica vd. Rizzini 1998, Fran-zoni 2006, Deonna 2008.
3 Cf. Pl., Phdr. 250d; Arist., Metaph. I 1 (980a i).4 Sui verba videndi vd. Snell 1963, pp. 20-24, Rizzini 1998, pp. 85-87,
Onians 1998, pp. 97-100.5 Vd. Napolitano Valditara 1994, pp. 78-88.6 Il. Pers., secondo Procl., Chrest. 239 Severyns = PEG p. 89. 15-16 = EGF
tomatore aggiunge, selezionando e condensando il materiale, con la con-seguente probabile perdita di alcuni dettagli importanti.
La prima testimonianza utile, invece, in cui lo sguardo inizia arivestire una funzione importante nell'aÁmbito della comunicazione nonverbale in questo episodio mitico, ci eÁ offerta da Alceo. Il fr. 298 V. =SLG S262, restituito da due papiri (P. Oxy. 2303 largamente integratoda P. Colon. 2021),7 tramanda porzioni di un carme in cui eÁ probabileche Alceo utilizzasse questo mito quale exemplum all'interno di un cantopolitico, come pare si possa desumere dalla prima strofe superstite delframmento.8 Il testo papiraceo eÁ alquanto mutilo: non esiste un solo rigocompleto. L'unica parte del carme che possiamo leggere con una certacontinuitaÁ riguarda proprio l'episodio mitico di Aiace Locrese. Concen-treremo dunque la nostra attenzione sui vv. 8-27:9
]e\.m mat* x<i> P. q. i.a*. lx pa* i|\A]h.ama* a| poktka* i] do|] a.pappe* ma cemei* xdtrle* ]mee| de+ po* kim e> pgpom 11...... ] ... [ .. ].a-| Daiuobo* m s\ a> la].m oi\lx* ca d% \ [a\p]t+. se.i.* veo|ja]i+ pai* dxm a\ ts.a.Daqda* mi]o. m pe* diom ja* sgNveM" 15k]Nt.* MrrNam g# kh\ o\ko* MamN e> vxm]N.[a>. M]c.mNa| Pa* kkaMdNo| a/ he* xMmN-Nri he]ort* kairi pa* msxm-]s.a. Nsa l.aja* qxm pe* utje. 19ve* qqerNr. i d\ a>. l.uo]im paqhemi* jam e> kxmNp.a.qersa* jo]iram a\ ca* klasi
200 note critiche e filologiche
p. 62.23-24: Jarra* mdqam de+ Ai> a| o< \Ike* x| pqo+ | bi* am a\porpx& m rtmeue* kjesai so+sg& | \Ahgma& | no* amom.
7 Per P. Oxy. 2303 vd. Lobel 1951, pp. 84-87, Barner 1967; per P. Colon.2021, Merkelbach 1967 e 1968. Le principali edizioni di riferimento sono Voigt1971, SLG S262, Campbell 1982, Liberman 1999.
8 Si puoÁ ipotizzare, infatti, che i versi precedenti alla narrazione miticacontenessero un'allusione all'attuale situazione politica di Mitilene, e nello speci-fico un collegamento, oltre che tra l'empietaÁ di Aiace e quella di Pittaco, l'avver-sario politico di Alceo, tra la mancata punizione del primo da parte dei Greci (conconseguente punizione divina) e l'invito a sbarazzarsi del secondo, il quale rischiadi trascinare alla rovina tutta la comunitaÁ.
9 Il testo proposto eÁ quello di Liberman 1999. Dettagliato commento delcarme in Hutchinson 2001, pp. 215-227. Le traduzioni di tutti i passi poeticisono di chi scrive.
No\ KMo* Njq.o|, ot\d\ e> ]deire± N.o. |.. poke* lx do* se. MqNq. ]am 23Nm" a\ de+ dei&.mom t\p\ Mo> N]uqtri± rl[....Np. MeNk. MiNdm.x* heira ja+. s oi> mopa± ...[. po* mNs.o. MmN, e\j d\ a\ua* msoi|± e\nap[i* mNa|. e\.jt* ja hte* kkai|. 27
`... nel tempio la figlia di Priamo / ... di Atena dispensatrice dimolto bottino / ... toccandole il mento / mentre i nemici prendevanod'assalto la cittaÁ / ... e Deifobo nello stesso tempo / ... dalle mura unlamento / ... e gemiti di bambini / riempivano la pianura troiana. / ...giunse in preda ad un furore distruttivo / ... di Pallade sacra che tra tutti/ ... gli dei beati eÁ la piuÁ ... / ... per i sacrileghi. / Dopo aver trascinatocon entrambe le mani la fanciulla / ... disposta dinanzi alla statua / ... ilLocrese, non ebbe timore / ... dispensatrice di guerra / ... ma essaterribilmente sotto le ciglia / ... divenuta livida, sul mare colore delvino / ... e con invisibili tempeste / improvvisamente lo sconvolse'.
Ad Alceo non interessa qui tanto il dramma umano di Cassandraquanto la reazione della dea che, stando a cioÁ che sopravvive del testotramandatoci, da sotto le ciglia diviene d'un tratto livida per la collera.Due sono le espressioni che maggiormente interessano ai fini della no-stra discussione, cioeÁ t\p\ o> uqtËi e pekidmx* heiËa (v. 24 s.), intorno allequali ruota una serie di spinosi problemi.10 Ci si aspetterebbe qui, conDenis L. Page, un verbo connesso alla sfera del guardare.11 Il nesso t\p\
o> uqtri suggerisce una prospettiva dall'alto verso il basso,12 che eÁ certa-mente un privilegio degli deÁi, i quali dall'Olimpo assistevano alle vi-cende umane sulla terra.13 Risalta di conseguenza la posizione d'inferio-ritaÁ di Aiace.
Per quanto riguarda invece il verbo pekidmo* olai al v. 25,14 eÁ giaÁstato osservato come esso ricorra anche nel fr. 72 Hollis (= 374 Pfeif-
201note critiche e filologiche
10 Sulle varie difficoltaÁ che questi versi pongono vd. Van Erp Taalman Kip1984, pp. 8-11.
11 Page 1955, p. 284.12 Vedremo invece come, a partire dalle fonti ellenistiche, il sollevamento
degli occhi veicoli al contrario una prospettiva inversa, dal basso verso l'alto.13 Frontisi-Ducroux & Vernant 2003, p. 52 s.14 EÁ problematica la presenza degli obeli in corrispondenza dei vv. 25-31,
variamente interpretati dagli studiosi. Alcuni ritengono che possa trattarsi di versida trasporre in un punto diverso del carme, altri che siano versi assenti in unodegli esemplari collazionati dallo scriba, altri ancora che essi rechino una versionealternativa. Vd. Porro, in CLGP, p. 87.
fer) di Callimaco, che proprio a questo passo di Alceo doveva essersiispirato: g< de+ pekidmxhei& ra jai+ o> llari kono+ m t< podqa* n / o\rrole* mg.15 Siain Callimaco sia in Alceo, rileva Van Erp Taalman Kip, il participiopekidmxhei& ra non deve essere necessariamente inteso in senso metafo-rico, con riferimento all'ira di Atena, ma potrebbe realmente alludere adun mutamento di colore negli occhi o sul volto della dea. Siamo dunquein presenza di una manifestazione animata di un oggetto inanimato,volta ad esprimere un moto interiore.16
2. Lo sguardo distolto di Atena nei poeti ellenistici
L'episodio in questione doveva occupare ampio spazio anche nellatragedia, per via dei numerosi spunti drammatici a cui si prestava lafigura di Cassandra. A parte la menzione di Euripide nelle Troiane,17
sappiamo, ad esempio, dai pochi frammenti rimastici, che Sofocle avevacomposto una tragedia intitolata Aiace Locrese, in cui l'oltraggio diAiace doveva giocare certamente un ruolo importante.18
In etaÁ ellenistica, l'empietaÁ di Aiace viene rivestendosi in manierapiuÁ marcata di una connotazione erotica. Come abbiamo visto, nel-l'Ilioupersis e nelle fonti pre-ellenistiche,19 Aiace si macchiava della colpadi empietaÁ, dovuta alla violazione del diritto d'asilo a cui Cassandra,inseguita dal nemico, giustamente ricorreva, rifugiandosi presso il Pal-
202 note critiche e filologiche
15 Si eÁ ipotizzato che il frammento, attribuito all'Ecale, facesse riferimentoallo sguardo torvo che Atena rivolge alla cornacchia, all'interno di un aition chedoveva spiegare l'assenza di questo volatile sull'Acropoli di Atene, da qui banditoper aver portato alla dea la cattiva notizia dell'apertura, da parte delle Cecropidi,della cesta che conteneva Erittonio (cf. Call., Hec. fr. 70.12-14 Hollis = 260.27-29 Pfeiffer).
16 Van Erp Taalman Kip 1984, pp. 9-10.17 Cf. Eur., Tr. 69-71 e 616-617.18 Cf. frr. 10-18 Radt, con particolare attenzione al fr. 10.19 Oltre alle attestazioni giaÁ citate, dobbiamo ricordare l'epigramma del-
l'arca di Cipselo, di cui ci informa Pausania (V 19, 5) che era posto accanto aldipinto con la scena del sacrilegio. In aÁmbito pittorico, sempre da Pausania ap-prendiamo che il tema dell'affronto di Aiace era presente anche negli affreschi diPolignoto nella Lesche dei Cnidi a Delfi (ivi, X 26, 3) e nella StoaÁ poikile ad Atene(I 15, 2), nonche in un dipinto di Paneno, collaboratore di Fidia, sul trono di Zeusad Olimpia (V 11, 5). Non eÁ ben chiara la natura dell'oltraggio di Aiace secondoPausania, che in questi passi si trova a descrivere opere pittoriche appartenenti adun'etaÁ piuÁ antica, ma si ritiene che il gesto violento di Aiace non si fosse ancoracaricato di significati erotici. Vd. Pardini 1989, p. 202.
ladio. A cioÁ si aggiungeva poi, in alcune fonti, l'aggravante della cadutadella statua, che costituiva il culmine del sacrilegio di Aiace.
Il motivo dello stupro, invece, compare in termini espliciti soltantocon Callimaco e Licofrone. In quest'ultimo i versi, relativi al tragicodestino toccato in sorte a Cassandra, possono essere considerati il fulcrodel poema licofroneo. La profetessa troiana, dopo averci narrato letragiche morti di alcuni dei suoi familiari piuÁ cari, ci conduce tra imeandri sofferti della sua esistenza, narrandoci la sua vicenda umanadi mantis e parthenos violata (Alex. 348-364):20
\Ecx+ de+ skg* lxm g< ca* lot| a\qmotle* mge\m paqhemx& mo| kaimot stji* rlarima> mi| seqa* lmxm ei\| a\ mx* qouom rse* cgm 350ei< qjsg& | a< kibdt* rara ktcai* a| de* la|g< so+ m Hoqai& om Psx& iom < Xqi* sgm heo+ mki* psoms\ a\ke* jsqxm e\jbakot& ra delmi* xm,x= | dg+ joqei* am a> uhisom pepale* mgpqo+ | cg& qa| a> jqom, Pakka* do| fgkx* lari 355sg& | liromt* luot Kauqi* a| Ptkai* sido|,sg& lo| biai* x| ua* rra pqo+ | so* qcot ke* vo|caluai& rim a% qpg| oi\ma+ | e< kjtrhg* rolai,g< pokka+ dg+ Bot* deiam Ai> htiam Jo* qgma\qxco+ m at\da* nara sa* qqohom ca* lxm. 360g= d\ ei\| se* qalma dotqasockt* uot rse* cg|ckg* ma| a> mx rsqe* wara vx* resai rsqasx& i,e\n ot\qamot& perot& ra jai+ hqo* mxm Dio* |,a> majsi pa* ppxi vqg& la silakue* rsasom.
`Ed io, sventurata, che rifiuto le nozze, / tra le mura della miacamera verginale, fatta di pietra, / senza copertura, dopo aver inabissatoil mio corpo / nella stanza priva di tetto di un carcere oscuro / per averrespinto dal mio letto di nubile / il dio dei semi, di Ptoo, delle stagioni,che mi desiderava ardentemente, / come volessi serbare intatta la vergi-nitaÁ / fino all'estrema vecchiaia, ad imitazione di Pallade, / la dea cheodia le nozze, Lafria, protettrice delle porte, / allora, come colomba,saroÁ trascinata violentemente nel nido dello sparviero, / come piccionenel becco dell'uccello da preda, / pure invocando piuÁ volte la dea deibuoi e dei gabbiani, / la vergine che difende, protegge dalle nozze. / Maella, volgendo in alto gli occhi verso la volta / del soffitto, scolpito inlegno, si adireraÁ contro l'esercito, / lei che era caduta dal cielo e daltrono di Zeus, / bene preziosissimo per il re, mio antenato'.
203note critiche e filologiche
20 Testo secondo l'ed. Hurst 2008.
La causa prima, che sta all'origine di tutte le sventure della profe-tessa troiana, rintracciabile giaÁ nell'attacco di questa sezione di versi, eÁ ilrifiuto, da parte di Cassandra, delle nozze con il potente dio Apollo, ilquale, invaghitosi di lei, le aveva promesso il dono della profezia, a pattoche ella gli accordasse poi i suoi favori. Cassandra, una volta appresal'arte profetica, rifiutoÁ di unirsi ad Apollo, venendo meno cosõÁ alla pro-messa fatta. La vendetta del dio fu atroce e crudele. Egli non la privoÁ deldono della profezia ma, per una sorta di legge del contrappasso, fece sõÁche, vaticinando, non fosse mai creduta.21
EÁ degna di nota l'insistenza di Cassandra sulla propria verginitaÁ dapreservare. Suo desiderio eÁ imitare Pallade Atena (Pakka* do| fgkx* lari,v. 355), la dea che odia le nozze (liro* mtluo|, v. 356), osservando lacastitaÁ fino al termine della sua vita (pqo+ | cg& qa| a> jqom, v. 355). Ma quellapaqhemi* a, cosõÁ strenuamente difesa dalle avances di un dio tanto potente,le saraÁ tolta violentemente da Aiace, figlio di Oileo, re della Locride. Al v.357 ha inizio, infatti, la seconda parte di questa sequenza di versi, dedi-cata al racconto dello stupro di Cassandra. Sg& lo| in posizione incipitaria,oltre a situare sul giusto sfondo temporale la rievocazione dell'episodiomitico, enfatizza il momento della fatidica notte della presa di Troia,durante la quale va collocata la vicenda. Fra le molte brutture della guerratrova posto anche quel gesto di violenza, perpetrato ai danni di Cassandra.Licofrone cela i due protagonisti dell'episodio sotto le consuete metaforeanimali (v. 357 s.), tratte dal suo ricco bestiario.22 L'immagine che eglievoca, replicata poi con qualche variante al verso successivo, eÁ quella
204 note critiche e filologiche
21 Cf. Aesch., Ag. 1202-12; Lyc., 1454-57; [Apollod.], III 12, 5; Quint.Smyrn., XII 526-528; Triph., 417 s.; Hyg., Fab. 93; Serv., ad Aen. II 247; schol.Lyc. 353, p. 70.3-7 Leone. Cf., piuÁ in generale, Lyc., 1451-60, i vv. conclusivi delmonologo, ove Cassandra continua ad incarnare il prototipo della profetessa ina-scoltata, perennemente combattuta fra il dovere morale di rivelare il contenutodelle sue profezie e la certezza di non essere presa sul serio.
22 Al v. 358 si pone un problema testuale, che solleva non poche difficoltaÁinterpretative. Seguendo l'edizione di Hurst 2008 accolgo la lezione: caluai& rima% qpg|. Meno plausibile mi sembra l'assetto testuale proposto da Scheer 1881,che corregge caluai& rim in calwai& rim e accoglie la lezione alternativa a% qpai|, cosõÁda avere calwai& rim a% qpai|, `dagli artigli ricurvi': in questo modo, peroÁ, si eÁcostretti ad intendere a% qpg, propriamente `falce', in senso traslato (il testo diScheer eÁ accettato da Holzinger 1895). Un'interessante alternativa prospettaGigante Lanzara 2000, pp. 90 s. e 254 s., che adotta il testo dell'edizioneteubneriana di Mascialino 1964 e mantiene caluai& rim a% qpai| (`dal beccoforma-adunca'), conservando il valore sostantivale dei due termini. A favore dia% qpg|, si noti comunque che questo vocabolo designa non solo la falce, ma anche,giaÁ in Hom., Il. XIX 350, un uccello da preda (cf. Eustath., ad l., e vd. Thompson
eschilea dello sparviero (so* qco|), che trascina nel suo nido (pqo+ | ke* vo|) lacolomba (ua* rra).23 La connotazione violenta dell'atto sacrilego compiutoda Aiace eÁ espressa con brutale evidenza dall'avverbio biai* x|.
Lo stupro avviene nel tempio di Atena, al cospetto del suo simula-cro che, in segno di disgusto, solleva in alto lo sguardo. A differenza diquanto avviene in Alceo, la prospettiva visiva della dea eÁ ora dal bassoverso l'alto: attraverso i suoi occhi riusciamo anche ad ammirare la finelavorazione in legno del soffitto. Dunque neppure Atena, la dea allaquale eÁ intimamente legata Cassandra, che invano la invoca piuÁ volte(pokka* , v. 359), riesce a impedire la violenza.24 Siamo in presenza di unautentico paradosso tragico, sintetizzato dal poeta al v. 359 s.: proprioAtena, la dea che difende e protegge da nozze violente, assiste impo-tente allo stupro, senza poter fare alcunche in soccorso della fanciulla.
L'oltraggio perpetrato da Aiace nei confronti di Cassandra avraÁripercussioni gravissime su tutto l'esercito greco. La vendetta delladea non si faraÁ attendere: una terribile tempesta si abbatteraÁ sulla flottaachea. Nei versi immediatamente successivi ha inizio il lungo raccontodedicato al tragico destino che attende Aiace e numerosi altri Greci.25
Anche in Callimaco (Aet. I, fr. 42 Massimilla = 35 Pfeiffer) l'e-pisodio veniva interpretato in chiave erotica, costituendo probabil-mente lo spunto per la narrazione dell'aition di un rito alquanto incon-sueto, che prevedeva l'invio annuale a Troia, da parte dei Locresi, didue vergini, scelte a sorte, in espiazione della colpa del loro antenato. Lapratica avrebbe avuto inizio dopo la morte di Aiace, quando la Locridefu devastata da una terribile pestilenza.26 Consultato l'oracolo di Delfi,
205note critiche e filologiche
1895, p. 35 s.). A quanto pare, inoltre, come oi\ma* | ripete e varia ua* rra, cosõÁa% qpg| ripete e varia so* qcot.
23 Cf. Aesch., Suppl. 223 s. Per so* qco| si puoÁ richiamare Call., fr. 272Massimilla (= 647 Pfeiffer; di cui Massimilla 2010, p. 549). Vd. anche GiganteLanzara 1998, p. 414.
24 Il legame tra l'eroina e la dea doveva essere percepito in qualche modo sindall'etaÁ arcaica, dal momento che Ibico adopera per Cassandra l'epiteto omericockatjx& pi| (fr. 303a PMGF), usato esclusivamente come connotazione della deaAtena. Oltre a Davreux 1942, p. 22, vd. Tentorio 2002, pp. 133-149.
25 Seguendo la tradizione omerica (Od. IV 499 ss.), Licofrone (387-395)immagina che Aiace si salvi dalla tempesta, scatenata da Atena, grazie all'inter-vento di Poseidone, il quale peroÁ , adiratosi alla fine con il Locrese che si eÁ vantatodi essere scampato alla morte senza l'aiuto divino, apre con il tridente gli scogli sucui l'eroe si era rifugiato, facendolo precipitare in mare. Vd. Durbec 2011, p. 70.
26 Secondo [Apollod.], Epit. VI 20 e Tzetze, in Lyc., 1141, p. 335.12-13Scheer, invece, il rito avrebbe avuto inizio tre anni dopo la caduta di Troia.
che ne indicoÁ la causa nell'ira di Atena, non ancora placata per l'attosacrilego, fu istituito il singolare rito, che avrebbe avuto la durata di unmillennio. Le vergini locresi sbarcavano di notte sul lido troiano. Seriuscivano a scampare alla lapidazione da parte dei Troiani e a giungereincolumi al santuario di Atena, divenivano sacerdotesse della dea, at-tendendo ad umili mansioni; se invece venivano uccise, i loro corpierano bruciati su rami secchi e le loro ossa gettate in mare.27 Il rito eÁnarrato in maniera pressoche analoga anche da Licofrone, in una lungasequenza che va dal v. 1141 al v. 1173.28
Al di laÁ delle molteplici e complesse questioni legate ai passi esa-minati, merita senz'altro una particolare attenzione, nel contesto dellaviolenza sessuale, la presenza del dettaglio mitico, tutt'altro che secon-dario, della torsione oculare della statua di Atena durante lo stupro,nella narrazione dei due poeti alessandrini. CosõÁ Licofrone, Alex. 361 s.:
206 note critiche e filologiche
27 Per un commento esaustivo al frammento callimacheo, vd. Massimilla1996, pp. 312-314. La piuÁ antica testimonianza su questo rito ci viene fornita daEnea Tattico (XXXI 24). Tra le numerose fonti letterarie che attestano l'usanza,oltre a Call., Aet. fr. 42 Massimilla (= 35 Pfeiffer), ricordiamo Timae., FGrHist.566 F 146a-b, Lyc., 1141-73, Strab., XIII 1, 40 (600-01c), Euph., fr. 192 VanGroningen = 53 CA = fr. adesp. vel dub. 9, EGF, p. 161, Polyb., XII 5, 7,[Apollod.], Epit. VI 20 ss., Aelian. V.H., fr. 47 Domingo Foraste (= 50a-g D.-F.),Iambl., De vita Pythag. VIII 42, Serv. [Dan.], in Verg. Aen. I 41, Hieron., C. Jovin.I 41, Tzetz., Chil. V, Hist. 23, 737-45. Vi eÁ poi una ricca tradizione scoliastica:schol. [ad] in Il. XIII 66, schol. in Lyc. 1133-67, pp. 213-217 Leone, Tzetz., inLyc. 1141-72, pp. 335-340 Scheer (parti di questi scoli rinviano fra l'altro ai giaÁcitati frr. di Timeo e Callimaco). Infine, non possiamo non tener conto dellapreziosa testimonianza epigrafica sul tributo locrese (IG IX I2 3, nr. 706), rinve-nuta a Vitrinitsa, nella Locride occidentale e pubblicata da Wilhelm 1911 (=Schmitt 1969, nr. 472). Non affrontiamo in questa sede le complesse questionistoriche e interpretative inerenti a questo rito, dovute alla molteplicitaÁ delletestimonianze, che non sempre concordano fra loro. Per la vastissima bibliografiasul tema delle vergini locresi, rimandiamo a Ragone 1996 (che tra l'altro presentain appendice, pp. 74-95, una raccolta completa di tutte le fonti, con traduzione) ea Mari 2000, p. 294 ss. Panoramica generale sul tema delle vergini locresi inRedfield 2003.
28 Il passo eÁ stato preso in considerazione da Momigliano 1945, p. 52, comeargomento valido per una datazione alta dell'Alessandra (inizio sec. III). Dal mo-mento che il tributo conobbe un periodo di sospensione dopo la guerra focese, valea dire nel 346 a.C. (stando alle testimonianze di [Apollod.], Epit. VI 22, e Tzetz.,in Lyc., 1141, p. 336.5-6 Scheer) e un successivo ripristino sotto il regno di unAntigono (Aelian., fr. 47 Domingo-Foraste = 50a-g D.-F.), da lui identificato colGonata, lo studioso ne deduce che l'opera licofronea, mostrando di conoscere lasospensione del tributo ma di ignorarne la ripresa, doveva necessariamente esserestata composta nel lasso di tempo intermedio.
g= d\ ei\| se* qalma dotqasockt* uot rse* cg|ckg* ma| a> mx rsqe* wara vx* resai rsqas{& .
`Ma ella [Atena], volgendo in alto gli occhi verso la volta / delsoffitto, scolpito in legno, si adireraÁ contro l'esercito'.
E Callimaco, Aet. I, fr. 42 Massimilla (= 35 Pfeiffer):
Jara* mdqam ca+ q sg+ m Pqia* lot, i< je* sim ot# ram \Ahgma& |, e\m s{& sg& | heot&rgj{& jasz* rvtmem, x% rse sg+ m heo+ m sot+ | o\uhaklot+ | sot& noa* mot ei\| sg+ mo\qoug+ m sqe* wai.
`Fece infatti violenza a Cassandra, figlia di Priamo, pur essendoella supplice di Atena, nel recinto sacro della dea, sicche la dea volse gliocchi della statua verso il soffitto'.
Il simulacro della dea, dinanzi all'atto di hybris commesso da Aiace,sembra anche qui, come in Alceo, animarsi ed essere percorso da un fre-mito di vita, che culmina questa volta nel gesto di volgere gli occhi alsoffitto del tempio.29
Purtroppo non siamo in grado di confrontare direttamente il testo diLicofrone con quello di Callimaco, dal momento che il passo degli Aitia (fr.42 Massimilla = 35 Pfeiffer) ci eÁ noto solo da un insieme di resocontiscoliastici. Se dunque eÁ ammissibile, come sostiene Giulio Massimilla, chegli Aitia contenessero almeno un cenno allo stupro, col dettaglio del gestodi scandalo della statua,30 ignoriamo peroÁ i termini esatti in cui cioÁ venivanarrato.
Alla luce delle testimonianze pervenuteci, si eÁ propensi a ritenereche il particolare sia stato introdotto ex novo proprio in etaÁ alessandrina.Inoltre, sulla base della testimonianza di [Apollod.], Epit. V 22,31 in cuipure confluiscono tradizioni diverse, non sarebbe da escludere l'idea cheil dettaglio dello sguardo distolto potesse costituire, a partire da Calli-maco, un aition per la raffigurazione della statua di Atena con gli occhi
207note critiche e filologiche
29 Per analoghe situazioni, sebbene in aÁmbiti differenti, cf. Eur., I.T. 1165ss., Ar., Pax 682, Eraclide Pontico, fr. 49 Wehrli.
30 Massimilla 1996, p. 313, ad fr. 42. Vd. Pardini 1995, p. 106 n. 6: `Delresto, a giustificare la successiva popolaritaÁ del gesto di scandalo del Palladio nonsi potrebbe immaginare di meglio che l'autoritaÁ letteraria di un Callimaco'.
31 Ai> a| de+ o< Kojqo+ | Jara* mdqam o< qx& m peqipepkecle* mgm s{& noa* m{ sg& |\Ahgma& | bia* fesai" dia+ <sot& >so so+ no* amom ei\| ot\qamo+ m bke* peim: `Aiace Locrese,vedendo Cassandra aggrappata all'immagine di Atena, la violentoÁ; percioÁ [sidice] che la statua ha gli occhi rivolti al cielo'.
rivolti verso l'alto. D'altronde, il poeta dedica piuÁ di qualche aition aisimulacri divini con caratteristiche insolite,32 in accordo col desideriodella divinitaÁ di voler perpetuare il ricordo dell'offesa subõÁta.33
Un argomento a sostegno dell'ipotesi secondo la quale il particolaredella dea che distoglie lo sguardo dinanzi alla violenza subita da Cassan-dra era forse presente in Callimaco puoÁ scorgersi nella stessa familiaritaÁdel poeta con questa immagine. Stando al fr. 662 Pfeiffer, Callimaco,parlando di un massacro dei Lemni avvenuto nel tempio di Atena Bi-stonia in una cittaÁ della Tracia di nome Seri ad opera degli Spartani,avrebbe proposto l'immagine della dea che si copre gli occhi per nondover assistere alla crudele scena di violenza. Questo frammento ditradizione indiretta, costituito anche da uno scolio,34 va letto con ladebita cautela.35 Non a caso, il frammento callimacheo presenta diffe-renze rispetto alle altre fonti, che collocano invece l'episodio a Siri inMagna Grecia per mano dei Ioni.36
Fra le testimonianze che riportano l'episodio del massacro ritro-viamo Licofrone (978-92), e anche con lui assistiamo alla reduplicazionedel gesto di scandalo del simulacro della dea Atena. I versi licofronei sulmassacro dei Ioni presentano notevoli difficoltaÁ interpretative,37 ma quelche a noi interessa in questa sede eÁ che per la seconda volta, come forseappunto anche in Callimaco, la statua distoglie lo sguardo a fronte di unatto di violenza. A voler essere piuÁ precisi, nel primo episodio, quellorelativo allo stupro, la dea solleva gli occhi verso il soffitto, mentre nelsecondo, inerente al massacro di Siri/Seri la dea chiude/si copre gli occhi.CioÁ costituisce un ulteriore argomento per suffragare l'idea della vici-nanza dei due poeti nella trattazione dell'intera vicenda di Cassandra ±in termini di modernitaÁ del contenuto mitico.
208 note critiche e filologiche
32 Cf. fr. 110 Massimilla (= 667 Pfeiffer + SH 276) sulla statua di Atenafasciata a Teutide, frr. 35-38 Massimilla (= 31b-e Pfeiffer) sulla statua di Arte-mide leucadia, fr. 111 Massimilla (= 187 Pfeiffer) sul simulacro di Artemidestrangolata.
33 Vd. Massimilla 1996, p. 440.34 Schol. Ov., Ib. 379.35 Vd. D'Alessio 1996, p. 764 s., ad l.36 Lyc., Alex. 978-992, schol. Lyc., 987a, p. 191.15-21 Leone, Tzetz., in
Lyc. 987, p. 310.5-21 Scheer, Strab., VI 1, 14, Iust., XX 2, 3.37 Tra i numerosi contributi sulla complessa questione del massacro di Siri,
che ben si inquadra da un punto di vista storico nel contesto delle lotte tra i colonidella Magna Grecia, ricordiamo: Musti 1988, pp. 95-122; Moscati Castel-nuovo 1989, pp. 125-129 in partic.; Braccesi 1998, pp. 305-314; Gigante Lan-zara 2003, pp. 40-48; Russo 2006, pp. 7-21.
Sebbene, infatti, il tema dello stupro fosse giaÁ ampiamente sfrut-tato nella produzione iconografica a partire dal VI secolo,38 in aÁmbitopoetico Callimaco e Licofrone sembrano essere stati i primi a codificareesplicitamente la variante erotica della vicenda della figlia di Priamo.39
Se di innovazione si vuole parlare in etaÁ ellenistica a proposito deidue poeti, lo si potraÁ fare pertanto nei termini di una differente perce-zione del mito, con la connotazione marcatamente erotica della violenzasu Cassandra, e in materia di dettagli, quale ad esempio il prodigio dellospostamento dello sguardo divino come segno di ribrezzo e di pudore.
3. Lo sguardo distolto di Atena nei poeti tardoantichi
SaraÁ proprio questo particolare dello sguardo ad essere ereditato inepoca successiva dai due poeti epici, che tanto devono a Licofrone:Quinto Smirneo e Trifiodoro. Il recupero del dettaglio avviene semprenell'aÁmbito della violenza sessuale.
Nel XIII libro dei Posthomerica Quinto segue, difatti, la versionealessandrina dell'episodio della violenza di Aiace, riprendendo il detta-glio dello sguardo (420-429):40
\Akk\ ot\ la+ m ot\d\ at\sg+ e\t* uqxm Sqisoce* meia 420pa* lpam a> dajqt| e> gm, e\pei+ g# mt* oi< e> mdohi mgot&Jarra* mdqgm z> rvtmem \Oike* o| o> bqilo| ti< o* |,htlot& s\ g\ de+ mo* oio bebkalle* mo|. = G de* oi< ai\mo+ mei\ropi* rx ba* ke pg& la jai+ a\ me* qa si* raso kx* bg|.Ot\de* oi< e> qcom a\ eije+ | e\re* dqajem" a\kka* oi< ai\dx+ | 425jai+ vo* ko| a\luevt* hg, bkortqa+ | d\ e> <r>sqewem o\pxpa+ |mgo+ m e\| t< wo* qouom, peqi+ d\ e> bqave hei& om a> caklajai+ da* pedom mgoi& o le* c\ e> sqelem" ot\d\ o% ce ktcqg& |kg& cem a\ sarhaki* g|, e\pei+ g# uqe* ma| a> are Jt* pqi|.
209note critiche e filologiche
38 Per le molte attestazioni iconografiche dell'episodio di Aiace e Cassandravd. O. Touchefeu, s.v. `Aias II', in LIMC, pp. 339-349.
39 Contrariamente a quanto pensano Severyns 1928, p. 361 e Davreux1942, p. 12 ss. e d'accordo invece con Mazzoldi 2001, p. 39 e prima ancora conMeyerhoff 1984, p. 147 con n. 57, non credo che il tema dello stupro fosse giaÁpresente nella versione dell'Ilioupersis di Arctino ne tanto meno in Alceo. Troppostrano sarebbe il silenzio di Proclo sull'argomento. Sull'intera questione, vd.anche Pardini 1989, p. 202 e Mazzoldi 2001, pp. 47-48.
40 Testo greco secondo l'ed. Vian 1969.
`Ma neppure la stessa saggia Tritogenia / rimase del tutto senzalacrime, perche fu dentro il suo tempio / che il potente figlio di OileodisonoroÁ Cassandra, / reso folle nell'animo e nella mente. Ma la dea poigli scaglioÁ contro / una sventura terribile e punõÁ l'uomo per l'oltraggio. /Ella non stette a guardare l'azione ignobile, ma pudore / e rabbia laavvolsero, e voltoÁ lo sguardo tremendo / verso al soffitto del tempio; lastatua della dea tuonoÁ d'intorno / e il pavimento del tempio tremoÁfortemente; ma Aiace non smise / l'infame empietaÁ, perche Ciprideaveva accecato la sua mente'.
Quinto arricchisce l'episodio immaginando che la dea non riesca atrattenere le lacrime e mostri il suo sdegno per la violenza consumatasinel suo tempio, non solo distogliendo lo sguardo, come avveniva neipoeti ellenistici, ma anche emettendo un boato e provocando un vio-lento terremoto. Ma nemmeno questo riusciraÁ a fermare l'empio Aiace,follemente accecato da Afrodite. Il dettaglio dell'insana follia, ispirataglidalla dea, eÁ un'ulteriore spia della dipendenza del poeta da Licofroneper questo episodio.41 Interessante risulta la testimonianza di Quintoche sembra volerci spiegare il significato del gesto della dea: non solopudore, ma anche rabbia.
Pure Trifiodoro riprende la scena, trasformandola in uno dei passipiuÁ suggestivi della Presa di Ilio (647-650):42
Jarra* mdqgm d\ z> rvtmem < Oikg& o| savt+ | Ai> a|Pakka* do| a\vqa* msoio heg& | t< po+ cot& ma perot& ram"g< de+ bi* gm a\ me* metre jai+ g< so+ pqo* rhem a\qgcx+ ma\ mh\ e< mo+ | \Aqcei* oirim e\vx* raso pa& rim \Ahg* mg. 650
`Il veloce Aiace, figlio di Oileo, violentoÁ Cassandra, / gettatasi alleginocchia della casta dea, Pallade; / Atena disapprovoÁ con la testa laviolenza e lei, che prima proteggeva gli Argivi, / per colpa di uno solo siadiroÁ contro tutti'.
Nel giro di soli quattro versi, Trifiodoro fissa la scena della vio-lenza, rendendola maggiormente d'impatto e raffigurando Cassandra
210 note critiche e filologiche
41 Cf. Lyc., vv. 403-407, dove leggiamo che Aiace, anche dopo la morte,continueraÁ a maledire Afrodite per avergli inspirato la folle passione sacrilega perCassandra. Sulla derivazione licofronea di questa vicenda in Quinto vd. Vian1959, p. 75. Per Licofrone come probabile fonte del XIII libro del poema epicodi Quinto, Id. 1969, p. 123 e n. 7.
42 Per il testo di Trifiodoro l'ed. critica di riferimento eÁ Livrea 1982. Vd.anche Gerlaud 1982.
caduta alle ginocchia della dea, che ancora una volta distoglie lo sguardo.Il verbo a\mamet* x, usato da Trifiodoro per evocare il gesto di pudoredella dea, indica propriamente l'azione del volgere indietro o in alto latesta in segno di disapprovazione o rifiuto.
Il dettaglio mitico dello sguardo della dea, levato in alto per nonassistere alla violenza, ebbe una certa eco anche nella poesia latina,soprattutto d'etaÁ augustea, che non accoglie peroÁ la variante dello stu-pro, ma segue piuttosto la versione arcaica e classica dell'episodio.43
Virgilio riprende di fatto il particolare della torsione oculare, tra-sferendolo da Atena alla stessa Cassandra come segno di stravolgimento(Aen. II 403-406):44
Ecce trahebatur passis Priameia virgocrinibus a templo Cassandra adytisque Minervaead caelum tendens ardentia lumina frustra, 405lumina, nam teneras arcebant vincula palmas.
`Ecco veniva trascinata Cassandra, la vergine figlia di Priamo, /con i capelli scomposti, dal tempio e dal santuario di Minerva, / levandoinutilmente al cielo gli occhi ardenti, / gli occhi, giacche legami tratte-nevano le mani delicate'.
La testimonianza virgiliana eÁ particolarmente significativa, inquanto mette in luce il nesso che sussiste, nei poeti ellenistici, fra ildettaglio dello sguardo e la natura della colpa di Aiace. Virgilio recuperadai poeti ellenistici il motivo dello sguardo distolto, pur non seguendo laversione alessandrina dello stupro, ma riallacciandosi alla tradizionearcaica e classica, ove l'empietaÁ di Aiace consisteva nella violazionedel diritto d'asilo. Osserva a ragione Alessandro Pardini: `nella suaCassandra Virgilio, poeta doctus, ha trasferito il gesto del Palladio, hacioeÁ voluto racchiudere, secondo un procedimento a lui caro, il trattopiuÁ caratteristico della variante mitica non adottata'.45
211note critiche e filologiche
43 Pardini 1989, p. 204, passa in rassegna anche i luoghi ovidiani, in cui ilparticolare ellenistico del gesto di pudore del simulacro divino, rifiutato da Ovidioper la vicenda di Aiace e Cassandra (Met. XIII 410 s.), nella quale non compare ilmotivo dello stupro, eÁ invece ripreso per altri miti (Met. IV 798 ss.: Minerva sicopre gli occhi con lo scudo per non assistere, all'interno del suo tempio, allostupro di Medusa ad opera di Poseidone; Fast. III 45 s.: quando Silvia subisceviolenza nel tempio di Vesta, i simulacri della dea si coprono gli occhi con le mani).
44 Vd. Gigante Lanzara 1999, p. 334.45 Pardini 1989, p. 204.
Abbiamo visto come, nel tempo, si assista a un processo di evolu-zione e rielaborazione del mito di Cassandra e Aiace. CioÁ che muta eÁsostanzialmente la natura della colpa di Aiace: da atto sacrilego, dovutoalla violazione del diritto di asilo, a violenza carnale. La gravitaÁ dellacolpa permane in entrambi i casi; cambiando peroÁ il contesto storico-religioso nel corso dei secoli, cambia anche la sostanza della colpa. Inquesto percorso evolutivo, di cui giaÁ Alceo segna una tappa importante,Callimaco e Licofrone daÁnno senza dubbio una svolta fondamentale allalettura del mito, giacche nelle fonti successive la natura della colpa diAiace saraÁ connotata quasi esclusivamente in chiave erotica.46
Silvana [email protected]
Abstract. ± The present paper focuses on the theme of Athena's sight, vs.Ajax the Lesser's fault, enjoyed in Greek poetry from Alcaeus to Callimachusand Lycophron and such late epic authors as Quintus Smyrnaeus and Triphio-dorus. Alexandrian poetry marks, in particular, a remarkable turning point inthe reading of that myth. While Ajax drags Cassandra away from the statue ofAthena, to which the maid had taken refuge, the goddess looks away as a disgustgesture ± so as not to see the act of hybris by Ajax. The significant detail ofAthena `withdrawing her eyes', by turning them away, during Cassandra's rapeis meant to underscore all the expressive strength of sight. Through both theglance and its negation, she keeps aloof from the impiety that is being com-mitted in her presence, conveys her wrath and disapproval, and announces aterrible revenge.
Bibliografia
Barner 1967 = W. Barner, Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos (Hilde-sheim, 1967).
Braccesi 1998 = L. Braccesi, Siri e la maledizione di Cassandra, in Sibille elinguaggi oracolari: mito, storia, tradizione, Atti del Convegno Interna-zionale di Studi, Macerata-Norcia, 20-24 Settembre 1994, a c. di I.Chirassi Colombo & T. Seppilli (Pisa, 1998), pp. 305-314.
CA = J.U. Powell, Collectanea Alexandrina (Oxonii, 1925).Campbell 1982 = D.A. Campbell, Greek Lyric. Sappho - Alcaeus (Cam-
bridge, mass., & London, 1982).
212 note critiche e filologiche
46 Oltre a Quinto Smirneo e Trifiodoro, cf. Strab., VI 1, 14 e XIII 1, 40;Plut., Mor. 856f; D. Chr., XI 153; [Apollod.], Epit. V 22.
Camps 1965 = W.A. Camps, Propertius. Elegies. Book IV (Cambridge,1965).
CLGP = G. Bastianini, M. Haslam & al., Commentaria et lexica Graeca inpapyris reperta, I. Commentaria et lexica in auctores, 1. Aeschines - Bac-chylides, i. Aeschines - Alcaeus (MuÈnchen & Leipzig, 2004).
D'Alessio 1996 = G.B. D'Alessio, Callimaco, Aitia, giambi e altri fram-menti, II (Milano, 20074).
Davreux 1942 = J. Davreux, La leÂgende de la propheÂtesse Cassandre (Paris,1942).
Deonna 2008 = W. Deonna, Il simbolismo dell'occhio. tr. it. di S. Stroppa(Torino, 2008).
Durbec 2011 = Y. Durbec, Ajax et le naufrage de la flotte grecque: l'Ale-xandra de Lycophron, vv. 365-416, «PdP», LXV, 2009, pp. 128-136 (=Id., Essais sur l'Alexandra de Lycophron, Amsterdam, 2011, pp. 63-70).
EGF = M. Davies, Epicorum Graecorum fragmenta (GoÈttingen, 1988).Franzoni 2006 = C. Franzoni, Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espres-
sione dell'arte greca (Torino, 2006).Frontisi-Ducroux & Vernant 2003 = F. Frontisi-Ducroux & J.-P. Ver-
nant, Ulisse e lo specchio. Il femminile e la rappresentazione di se nellaGrecia antica. Trad. it. (Roma, 2003).
Gerlaud 1982 = B. Gerlaud, Triphiodore, La prise d'Ilion (Paris, 1982).Gigante Lanzara 1998 = V. Gigante Lanzara, Il tempo dell'Alessandra e
i modelli ellenistici di Licofrone, «PdP», LIII, 1998, pp. 401-418.Gigante Lanzara 1999 = V. Gigante Lanzara, Echi dell'Alessandra nella
poesia latina, «Maia», 5, 1999, pp. 331-347.Gigante Lanzara 2000 = V. Gigante Lanzara, Licofrone, Alessandra
(Milano, 2000).Gigante Lanzara 2003 = V. Gigante Lanzara, Le vie del mare. Eroi e
cittaÁ nei vaticini di Cassandra, «PdP», LVIII, 2003, pp. 12-60.Hollis 1990 = A.S. Hollis, Hecale. Callimachus (Oxford, 1990, 20092).Holzinger 1895 = C. von Holzinger, Lycophron. Alexandra (Leipzig, 1895).Hurst 2008 = A. Hurst (en collab. avec A. Kolde), Lycophron. Alexandra
(Paris, 2008).Hutchinson 2001 = G.O. Hutchinson, Greek Lyric Poetry. A Commen-
tary on Selected Larger Pieces (Oxford, 2001).Leone 2002 = P.L.M. Leone, Scholia vetera et paraphrases in Lycophronis
Alexandram (Galatina, 2002).Liberman 1999 = G.L. Liberman, AlceÂe. Fragments. II (Paris, 1999).LIMC = Lexicon iconographicum mythologiae classicae, I (ZuÈrich-MuÈnchen,
1981).Livrea 1982 = E. Livrea, Triphiodorus, Ilii excidium (Leipzig, 1982).Lobel 1951 = E. Lobel, The Oxyrhynchus Papyri, XXI (London, 1951).Mari 2000 = M. Mari, Commento storico a Licofrone (Alex. 1141-1173), in
HesperõÁa, 10. Studi sulla grecitaÁ di Occidente, a c. di L. Braccesi (Roma,2000).
213note critiche e filologiche
Mascialino 1964 = L. Mascialino, Lycophronis Alexandra (Leipzig, 1964).Massimilla 1996 = G. Massimilla, Callimaco, Aitia. Libri primo e secondo
(Pisa, 1996).Massimilla 2010 = G. Massimilla, Callimaco, Aitia. Libro terzo e quarto
(Pisa-Roma, 2010).Mazzoldi 2001 = S. Mazzoldi, Cassandra, la vergine e l'indovina. IdentitaÁ di
un personaggio da Omero all'Ellenismo (Pisa-Roma, 2001).Merkelbach 1967 = R. Merkelbach, Ein Alkaios-Papyrus, «ZPE», 1,
1967, pp. 81-95.Merkelbach 1968 = R. Merkelbach, NachtraÈge zu Band 1 (Alkaios, Ari-
stophanes, Menander), «ZPE», 2, 1968, p. 154.Meyerhoff 1984 = D. Meyerhoff, Traditioneller Stoff und individuelle
Gestaltung. Untersuchungen zu Alkaios und Sappho (Hildesheim, 1984).Momigliano 1945 = A. Momigliano, The Locrian Maidens and the Date of
Lycophron's Alexandra, «CQ», 39, 1945, pp. 49-53 (= Id., Secondocontributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, 1960,pp. 446-453).
Moscati Castelnuovo 1989 = L. Moscati Castelnuovo, Siris. Tradizionestoriografica e momenti della storia di una cittaÁ della Magna Grecia (Bru-xelles, 1989).
Musti 1988 = D. Musti, `Una cittaÁ simile a Troia'. CittaÁ troiane da Siri aLavinio, «ArchClass», 33, 1981, pp. 1-26 (= Id., Strabone e la MagnaGrecia, Padova, 1988, pp. 95-122).
Napolitano Valditara 1994 = L.M. Napolitano Valditara, Lo sguardonel buio. Metafore visive e forme grecoantiche della razionalitaÁ (Roma-Bari, 1994).
Neblung 1997 = D. Neblung, Die Gestalt der Kassandra in der antikenLiteratur (Stuttgart-Leipzig, 1997).
Onians 1998 = R.B. Onians, Le origini del pensiero europeo intorno al corpo,la mente, l'anima, il mondo, il tempo e il destino, tr. it. di P. Zaninoni(Milano, 1998).
Pardini 1989 = A. Pardini, La colpa di Aiace e la poesia augustea, «MD»,22, 1989, pp. 201-206.
Pardini 1995 = A. Pardini, Aiace, Cassandra e la corresponsabilitaÁ dei Greci(tra l'\Iki* ot pe* qri|, Euripide ed Alceo), «BollClass», 16, 1995, pp.103-117.
Page 1955 = D.L. Page, Sappho and Alcaeus. An Introduction to the study ofancient Lesbian poetry (Oxford, 1955).
PEG = A. Bernabe , Poetae epici Graeci. Testimonia et fragmenta, I (Leipzig,1988).
Pfeiffer 1949-1953 = R. Pfeiffer, Callimachus, I-II (Oxford, 1949-53).PMGF = M. Davies, Poetarum melicorum Graecorum fragmenta, I (Oxford,
1991).Ragone 1996 = G. Ragone, Il millennio delle vergini locresi, in Studi elle-
nistici, 8, a c. di B. Virgilio (Pisa-Roma, 1996), pp. 7-95.
214 note critiche e filologiche
Redfield 2003 = J.M. Redfield, The Locrian Maidens. Love and Death inGreek Italy (Princeton, nj, & Oxford, 2003).
Rizzini 1998 = I. Rizzini, L'occhio parlante: per una semiotica dello sguardonel mondo antico (Venezia, 1998).
Russo 2006 = F. Russo, Episodi di sacrilegio nella storia di Siris, «ASCL»,LXXIII, 2006, pp. 7-21.
Scheer 1881 e 1908 = E. Scheer, Lycophronis Alexandra, I. Alexandra cumparaphrasibus ad codicum fidem recensita et emendata, indices subiecti, eII. Scholia (Berlin, 1881 e 1908).
Schmitt 1969 = H.H. Schmitt, Die StaatsvertraÈge des Altertums, III. DieVertraÈge der griechisch-roÈmischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.(MuÈnchen, 1969).
Severyns 1928 = A. Severyns, Le Cycle eÂpique dans l'eÂcole d'Aristarque(Paris, 1928).
SH = H. Lloyd-Jones & P. Parsons, Supplementum Hellenisticum (Berlin& New York, 1983).
SLG = D.L. Page, Supplementum lyricis Graecis. Poetarum lyricorum Grae-corum fragmenta, quae recens innotuerunt (Oxford, 1974).
Snell 1963 = B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo(1946), tr. it. di V. Degli Alberti & A. Marietti Solmi (Torino, 1963).
Tentorio 2002 = G. Tentorio, Cassandra glaucopide in Ibico, «Acme», 55,2002, pp. 133-149.
TGrF = B. Snell, R. Kannicht & S. Radt, Tragicorum Graecorum frag-menta, I-V (GoÈttingen, 1971-2004).
Thompson 1895 = D'Arcy W. Thompson, A glossary of Greek birds (Ox-ford, 1895).
Van Erp Taalman Kip 1984 = A.M. Van Erp Taalman Kip, Some Remarkson Alcaeus fr. 298 (Voigt), «Mnemosyne», 37, 1984, pp. 1-13.
Van Groningen 1977 = B.A. Van Groningen, Euphorion (Amsterdam,1977).
Vian 1959 = F. Vian, Recherches sur les Posthomerica de Quintus de Smyrne(Paris, 1959).
Vian 1969 = F. Vian, Quintus de Smyrne, La suite d'HomeÁre, III. Livres X-XIV (Paris, 1969).
Voigt 1971 = E.M. Voigt, Sappho et Alcaeus. Fragmenta (Amsterdam,1971).
Wilhelm 1911 = A. Wilhelm, Die lokrische MaÈdcheninscrift, «JOÈ AI», 14,1911, pp. 163-256.
215note critiche e filologiche
LA PAROLA DEL PASSATO - RIVISTA DI STUDI ANTICHI
la parola del passato eÁ sempre simile a una sentenzad'oracolo e voi non la intenderete se non in quanto saretegli intenditori del presente i costruttori dell'avvenire
nietzsche
LA PAROLA DEL PASSATO (PdP) fondata nel 1946, pubblica articoli,note critiche e filologiche, testi e monumenti, rassegne di studi antichi.
Norme di collaborazione. I testi vanno inviati in forma definitiva per la stampa, dat-tiloscritta e con versione elettronica, alla redazione: `La Parola del Passato', MacchiaroliEditore, e-mail [email protected]. Indicare nome e indirizzo dell'Autore, nu-mero di telefono, fax, e-mail, titolo corrente. Allegare un elenco delle eventuali figure,che devono essere ad alta risoluzione 300 dpi, con relative didascalie. Testi, disegni efotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Gli Autori riceveranno le bozzerelative. Trascorso un mese dalle spedizioni delle bozze all'Autore senza che questi abbiaprovveduto a restituirle corrette o a dare altra comunicazione, la rivista si riserva distampare l'articolo conforme al testo originale. Citazioni tra apici (` '), citazioni nellecitazioni tra `caporali' (« »). Nomi degli autori moderni in nota in maiuscoletto coniniziale puntata. Nomi e opere di autori antichi in latino secondo le rispettive abbrevia-zioni del LSJ e del Thes. l. Lat. Singole parole in latino e lingue straniere in corsivo.Citazioni in latino e in lingue straniere in tondo tra apici. Abbreviazioni e termini latinidi uso corrente in tondo: Id., Ead., ibid., ap., ad loc., scil., op. cit., supra, infra, passim.Usare cf., non cfr. Evitare il doppio spazio dopo il segno d'interpunzione. Nel testoil riferimento alla nota va messo dopo il segno d'interpunzione. Va rispettato uno spaziodopo i punti sospensivi. Le note bibliografiche vanno riportate nella lingua originaledella pubblicazione. Es. libro: G. Pugliese Carratelli, Scritti sul mondo antico (Napoli,1976). Es. contributo in vol. miscellaneo: A. Grilli, Cicerone, in I. Lana - E.V. Mal-tese (a cura di), Storia della civiltaÁ letteraria greca e latina (Torino, 1988), II, pp. 507-538.Es. articolo in periodico: M. Gigante, Simonide e Leopardi, «PdP», LIII, 1998, pp. 161-200. I testi accettati per la pubblicazione che non seguono le norme di collaborazionesaranno rispediti agli Autori per l'adeguamento allo stile della rivista. I collaboratoririceveranno gratuitamente, via e-mail, un estratto in formato pdf e, su richiesta e apagamento, trenta estratti cartacei dei loro scritti.Peer-review. Articoli e note inviati alla rivista per la pubblicazione sono sottoposti,nella forma del doppio anonimato, a peer-review di due esperti, dei quali almeno unoesterno alla Direzione e al Consiglio direttivo. Ogni due anni saraÁ pubblicato l'elencodei revisori.Prezzi. I fascicoli arretrati disponibili vengono venduti al prezzo di A 22,00 (Italia),Europa A 27,00, extra Europa A 30,00. L'abbonamento all'annata LXVII/2012 (numeri382-387 della serie) costa A 93,00, Europa A 115,00, extra Europa A 130,00. L'editorerinnova l'invio dei fascicoli eventualmente dispersi solo agli abbonati che autorizzano laspedizione in piego raccomandato. Essi dovranno in tal caso aggiungere all'importo del-l'abbonamento A 10,33 ± estero A 18,33.Pagamenti: bonifico bancario sul conto corrente në 3797 Unipol Banca, Agenzia 089,Napoli - codice IBAN në IT12 D031 2703 4110 0000 0003 797 - BIC: BAECIT2Bintestato a Macchiaroli Editore s.a.s., 80127 Napoli - Italia. I clienti che invianoassegni in moneta diversa dall'euro devono aggiungere il controvalore di 5 euro perspese di incasso. Citare sempre la fattura a cui si riferisce il pagamento.
Macchiaroli Editore 11 via Michetti 80127 Napolitelefono +39 081 5783129 - fax +39 081 5780568
e-mail [email protected].
Reg. Trib. Napoli n. 267 del 12.9.1949. Gisella Macchiaroli, responsabile