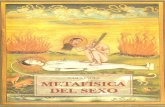I movimenti dei corpi celesti nel commento dello pseudo - Alessandro alla Metafisica di Aristotele
Transcript of I movimenti dei corpi celesti nel commento dello pseudo - Alessandro alla Metafisica di Aristotele
RI T A SALIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I movimenti dei corpi celesti nel commento
dello pseudo-Alessandro alla «Metafisica» di Aristotele zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{ Memoria presentata dal s.e. E nrico Berti nell'adunanza dell'8 maggio 2004)
E stratto
Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti
già dei Ricovrati e Patavina
Volume CXVI (2003-2004)
Parte III: Memorie della Qasse di Scienze Morali, Lettere ed Arti
TIPOGRAFIA " LA GARANGOLA" PADOVA
2004
RI T A SALIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I movimenti dei corpi celesti nel commento dello pseudo-Alessandro allazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metafìsica di Aristotele" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Memoria presentata dal s. e. E nrico Berti nell'adunanza dell'?, maggio 2004)
I. IL D I B AT T I T O I N T O R N O A ME T AP H . A 8
I l cap. 8 del libro A della Metafisica di Aristotele contiene la dimostra-zione dell'esistenza di una pluralità di sostanze immobili motrici dei cieli e la determinazione del loro numero. Esso è stato oggetto di un acceso dibat-tito che ne ha messo in dubbio la giusta collocazione all'interno del libro. Tale dibattito ' è sorto in seguito alla pubblicazione del volume di Jaeger sull'evoluzione del pensiero di Aristotele, in cui l'Autore sosteneva la ben nota tesi storico-genetica, secondo la quale il pensiero di Aristotele si sareb-be evoluto passando da una posizione iniziale di platonismo ad una fase di metafisica originale, per giungere infine ad una posizione di disinteresse per la metafisica a favore delle scienze empiriche. Là Jaeger sosteneva anche che il libro A altro non è che il testo di una conferenza contenente in sintesi tutta la filosofia teoretica di Aristotele, e appartenente ad un periodo ante-riore rispetto a quello degli altri libri della Metafisica, cioè al periodo ancora in parte platonizzante della Urmetaphysik.'^ Dal libro A , secondo Jaeger, si staccherebbe U cap. 8, che sarebbe stato inserito dagli editori in un periodo pili tardo.' A sostegno della sua tesi, Jaeger portava i seguenti indizi: (a) di-
* Questo lavoro deve molto alle discussioni coi proff. E nrico Berti e Robert W.
Sharples. A loro va il mio ringraziamento. E rrori ed imprecisioni sono naturalmente da
attribuire a chi scrive.
(') Per una sintesi delle diverse posizioni, cfr. ELDERS 1972, 60-63.
(') Cfr. JAEGER 1923, OTpdrt. 186 ss.; 300 ss.
(') Cfr. zW, 295. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) Cfr. wz, 298.
(') Cfr. ivi, 467 ss. JAEGER 1923,474, riporta che Lasson trasferì addirittura A 8 dal
testo alle note, con la sola eccezione della parte centrale (1073''8-1074''17), cioè quella
propriamente dedicata al calcolo delle sfere (cfr. Ad. LASSON 1907, 175 s.).
138 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARITA SALIS
versamente dal resto del libro, il cap. 8 sarebbe scritto in uno stile rifinito;* (b) esso interromperebbe il naturale proseguimento del discorso sulla costi-tuzione e l'essenza del Motore immobile iniziato nei capp. 6-7 e ripreso nel cap. 9, argomentando intorno a questioni puramente meccaniche e speciali-stiche;' (c) l'ammissione di una pluralità di motori immobili viene ripresa e criticata da Teofrasto,** il che proverebbe la tarda redazione del capitolo;' (d) l'uso dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evXoyov in 1074''14-17 e "24-25 mostrerebbe che in A 8 Aristo-tele ritiene la metafisica non più basata sul necessario, bensì sul probabile, e l'espressione èvvoiagzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA xàgiv (1073* 12) sottolineerebbe che tutta la tratta-zione serve soltanto a dare un'idea generale delle questioni affrontate;'" (e) il passo 1074 31-38, in cui Aristotele mostra l'unicità del cielo, non rientre-rebbe nel contesto del capitolo, in quanto presenterebbe lo stile abbreviato e frammentario del resto del libro ed interromperebbe il nesso grammatica-le con la parte precedente, giacché nel periodo che segue non si vede a chi si riferisca il plurale della frase: oxi BeoL xé e'unvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OXJXOL (1074''2-3). Jaeger ri-tiene che il passo escluda implicitamente l'esistenza di una pluralità di mo-tori immobili; esso sarebbe stato aggiunto in nota da Aristotele, il quale avrebbe mosso un'obiezione contro se stesso, e successivamente inserito nel testo da qualche editore;" (f) parlando di CaUippo, Aristotele usa l'imper-fetto, dal che si deduce che Callippo non doveva più essere in vita al mo-mento della stesura di A 8, e che perciò questo capitolo deve essere poste-riore al 330.'
Le argomentazioni dello Jaeger sono state criticate da Reale, il quale ha mostrato che (a) lo stile di A 8 non si distingue da quello degli altri capitoli, ma risulta anch'esso laconico e conciso;" (b) A 8 non interrompe il discor-so iniziato in A 6 e 7 e che prosegue in A 9: la dimostrazione dell'esistenza di una molteplicità di motori segue infatti alla dimostrazione dell'esistenza e della natura del Motore immobile, argomenti rispettivamente dei capp. 6 e 7, e, se A 9 ritorna a A 7, è per risolvere alcune difficoltà teoretiche; infine in A IO, dopo la soluzione del problema del modo d'essere del bene, Ari-stotele risolve alcune difficoltà storico-teoretiche;" (c) Teofrasto doveva leggere il libro così come lo leggiamo noi, in quanto riprende non solamen-
(") Cf r . jAE GE R 1923,470 s.
D Cfr. zw, 472-76.
(») Cfr. THE OPHR.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metaph. II, 5''17-27 Usener.
C) Cfr. JAEGER 1923, 476 s.
('") Cfr./W, 477-79.
('•) Cfr. iW, 480 ss.
(' ) Cfr. ZOT, 467-69.
(") Cfr. REALE 1984, 436-39 = W. 1964, 112-15. Cfr. anche REALE 1993,111,595.
(») Cfr. REALE 1984, 444 s. = Id. 1964, 120 s. Cfr. anche REALE 1993, III, 595.
I MOVIMENTI DEI CORPI CELESTI 139
te A 8, ma anche citazion i d i A 1 e 7;' ' (d) l'eÌJÀ.OYOV e l'espressione èvvot agzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA xàgiv si r iferiscono piut tosto ai ragionamenti ast ronomici;"" (e) 1074''31-38 si spiega sulla base del fatto che, n on stando i mot or i im m obil i suUo stesso piano del Mot or e immobile pr imo, ma essendo ad esso in fer ior i e diversi secondo la specie, la deduzione dell'un ità del cielo dall'un ità del Mot ore immobile pr imo n on è con traddit tor ia;'^ (f) le con clusion i d i Jaeger in merito all'uso dell' imperfet to in r ifer imento a Callippo sono molto pro-babili, ma, cadendo gli alt r i argomenti, esse vanno comunque estese a tutto i l libro.'«
Con divido le risposte d i Reale a Jaeger, eccetto che per i l pun to (d): Aristotele usa una pr ima voltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EvXoyov quando, dopo avere determinato i l numero delle sfere, dice che sarà "ragionevole" ammettere altrettante so-stanze e pr in cipi im m obil i e che se ciò sia anchezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necessario bisogna la-sciarlo determinare a quelli che sono piìi esperti in materia, vale a dire agli astronomi;^" questo già esclude la tesi d i Reale per cu i Ar istotele r iterrebbe l'astronomia basata sul verosimile e sul probabile. La seconda r icorrenza d i EvXoyov è in 1074''24, dove si dice che è ragionevole supporre che ci siano tante sostanze im m obili quan t i sono i movimen t i, e qu i i l r ifer imento è d i nuovo alla metafisica e n on all'ast ronomia. I l r ifer imento d i EvXoyov alla metafisica n on implica tuttavia che Aristotele la ritenga basata n on sul ne-cessario, ma sul probabile: i l carattere d i necessità della metafisica è innega-bile, in quanto piìi volte sottolineato dal testo,^' come lo stesso Reale n on manca di rilevare. Ritengo piut tosto che i l carattere d i probabilit à qu i at tri-buito alla metafisica vada r iferito solamente a quella parte d i essa che si oc-cupa di stabilire i l numero delle in telligenze mot r ici e che n on si debba estenderlo oltre quell'ambito. Dun que evXoyov n on si riferisce ai ragiona-menti ast ronomici, come vuole Reale, ma neppure è sufficiente a denotare i l carattere d i verosimiglianza della metafisica, come vuole Jaeger. Quanto al-la formula èvvoiag X^Qi , essa n on at tr ibuisce affatto all'ast ronomia carat-tere di probabilit à, ben sì denota i l carattere generale della successiva espo-sizione che da Aristotele viene data dei sistemi ast ronomici d i Eudosso e Callippo. AUe argomentazioni d i Reale aggiungo inolt re che i capp. 6 e 7
(") Cfr . R E A LE 1984,451-57 = Id. 1964,127-33. Cfr . anche R E A LE 1993, I I I , 595. ('") Cfr . R E A LE 1984,440-43 = Id. 1964,116-19. Cfr . anche R E A LE 1993, I I I , 595. (") Cfr . R E A LE 1984, 445-51 = Id. 1964, 121-27. Cfr . anche R E A LE 1993, I I I , 595.
Cfr . sotto, par. 5. ('«) Cfr , R E A LE 1984,431-36 = Id. 1964, 107-12. Cfr . anche R E A LE 1993, I I I , 595. (") Cfr . Metaph. A 8, 1074n4-15.
dr. ivi, 1074n6-17. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(21) Cfr .zM, 1073' '26;32;36;37. (22) Cfr . R E A LE 1984,443 = Id 1964, 119.
140 RITA SALIS
contengono già dei r ifer imen t i ad una pluralità d i sostanze immobili,^ ' i l che induce a ritenere che i l loro oggetto n on sia cost ituito dal solo Mot or e immobile pr imo, ma compren da tutte le in telligenze mot r ici. La determina-zione del numero dei mot or i segue direttamente la loro in t roduzion e, resa necessaria dall'esistenza d i un movimen to eterno, e prepara la trattazione delle aporie che r iguardano l' in telligenza divin a, argomento del cap. 9.
2. I L D I BA T T I T O I N T O R N O A LL' I D E N T I T À D I P SE U D O - A LE SSA N D R O
Alessandro d i Afrodisia (II sec.) fu i l più importan te commentatore antico d i Aristotele, tanto che venne detto "I l Commen tatore" per eccellen-za (l'è^riYilTrig). Tr a le opere d i Alessandro che ci sono pervenute c'è anche un commentario allazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metafisica,^'* del quale tuttavia è r iconosciuta l'auten t i-cità soltanto per la pr ima parte, comprenden te i commen t i ai l ib r i A - A , mentre i comment i ai restanti l ib r i E - N sono at t r ibuit i ad un autore che va sotto i l nome d i pseudo-Alessandro.
I l commentario a A rappresenta un 'eccezione nella parte n on autenti-ca dell'opera, in quanto soltanto per questo libr o si sono conservati nume-rosi frammenti del commento autentico, r ipor tat i nel Gran Commentario d i Aver roè al libro A.^ ' In un 'opera pubblicata nel ISS , * Freuden th al mo-strò che pseudo-Alessandro n on si servì del commento del vero Alessandro, e tale conclusione è ormai condivisa dagli studiosi. Con trar iamen te a quan-to attestato dal Codex Parisinus Graecus 1876, dove qualcuno premise i l nome d i Mich ele d i Efeso, letterato bizan t ino vissuto a cavallo tra l'undice-simo e i l dodicesimo secolo, al t itolo del commentar io al l ibr o E , e dallo pseudo-Filopono,^^ che si riferisce ad un passo del commento allo stesso l i -
(25) Cfr . A 6, IQll^lhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TaiJTag...or)(jLa5; A 7, 1072 ''l - 2 : ev xolc, àKivfixoig.
(2*') Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysica commentaria, edidit M .
Hayducli, Berolin i 1891 . (2') Delia versione araba del Gran Commentario al libro A , edita da Bouyges {TafsTr
ma ba'd at-tahi'at, Beirouth , Imprimerle catolique, 1948 , 3) , esistono due t raduzion i: una in francese d i A . M A R T I N : Averroès. Grand commentaire de la Métaphysique dAri-
stote (Tafsir ma ba'd at-tabi'at). Livre Lam-Lambda traduit de l'arabe et annoti, Paris
1984, e una in inglese d i C. G E N E Q U A N D : Ibn Rushd's Metaphysics. A Translation with
Introduction oflbn Rush's Commentary on Aristotle's Metaphysics, Book Lam, Leiden
1986.
(2'') Die durch Averroès erhaltenen Fragmente Alexanders zur "Metaphysik" des Ari-
stoteles untersucht und ùbersetzt, "Abh andlungen der kòniglichen Akademie der W is-senschaften zu Ber lin ", Ber lin 1885 .
(2') I l commento dello pseudo-FHopono alla Metafisica è perduto nell'originale gre-co, ma ci è pervenuto nella versione latina d i F. P A T R I Z Z I del 1 5 8 3 , ristampata nel 1991 . Pseudo-Filopono, riferendosi a E 4 , 1027 ' ' 31 , scrive: "Ephesius autem proprie entia dicit
I MOVIMENTI DEI CORPI CELESTI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA141
bro assegnandolo ad un efesino, in dican do con molta probabilit à propr io Mich ele, i l filologo tedesco escluse l' iden t ificazione d i pseudo-Alessandro con Mich ele d i Efeso, sulla base del fatto che nella seconda parte del com-mentario compaiono numerosi r ifer imen t i al politeismo. Secondo Freuden -thal doveva trattarsi d i un neoplaton ico, vissuto n on pr ima delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V sec, per-ché avrebbe fatto uso del commentar io d i Sir iano alla Metafisica come una delle sue fon t i, e n on pit i tardi del V I sec, in quanto dopo O lim piodor o n on ci furono più filosofi pagani.^** Freuden th al riteneva inolt re che pseu-do-Alessandro fosse un falsario, in quanto si r ifer iva alle opere d i Alessan-dro come se ne fosse lu i l'autore.^''
Se Taràn '° concordava con Freuden th al nel credere che pseudo-Ales-sandro fosse un pagano, riteneva tuttavia che n on sarebbe stato pseudo-Alessandro a fare uso del commento d i Sir iano, ben sì, al con t rar io. Sir iano si sarebbe servito del commento di pseudo-Alessandro, scambiandolo per i l commentario autentico, e lo stesso avrebbe fatto Simplicio. Negli ann i in -tercorsi tra Freuden th al e Tar àn , Praech ter " era tornato a sostenere l' iden -tificazione d i pseudo-Alessandro col crist iano Mich ele d i Efeso, afferman-do, con Freuden th al, che pseudo-Alessandro dipendeva da Sir iano, ma spiegando i r ifer iment i al politeismo col fatto che nel XI I sec. filosofia e re-
singulares suhstantia, et recte" (cfr. CAGL 2 , 25) . Cfr . anclie M O R A U X 2 0 0 1 , 4 2 3 n .;
T A R A N 1 9 8 7 , 2 1 6 , 2 2 0 e n . 2 0 ; E BBE SE N 1981 , 3. 87 . Su In parv. nat., 1 4 9 , 1 4 - 1 5 , in cui lo
stesso Michele dichiara di essere l'autore del commentario ai l ib r i Z - N , cfr. T A R A N 1987 , 2 3 1 s., M O R A U X 2 0 0 1 , 4 2 3 n . l , m a anche L U N A 2 0 0 1 , 5 7 s.
(2") Cfr . F R E U D E N T H A L 1985, 5 3 s. Con tro l'identificazione d i pseudo-Alessandro con Michele di Efeso erano anche Sepulveda, autore della versione latina del commenta-rio, e Bonitz, pr imo editore della versione originale greca. Nelle rispettive prefazioni so-stenevano i l pr imo che anche i l commento ai h br i E - N apparteneva ad Alessandro, ed i l secondo che la seconda parte del commentario sarebbe giunta fino a n oi in forma am-piamente rimaneggiata ad opera di un interprete posteriore ad Alessandro e inferiore a lui per ingegno.
(2') In quattro passi del commento ai l ibr i E - N della Metafisica pseudo-Alessandro rimanda al commento ai l ib r i A - A come se fosse stato lu i a scriverlo: 5 6 7 , 2 4 ; 6 3 0 , 3 1 - 3 2 ; 6 4 1 , 11- 12; 7 4 1 , 36- 37 . Inoltre ci sono altri otto riferimenti ad opere diverse d i Alessan-dro, che pseudo-Alessandro presenta come proprie: 4 4 1 , 8- 9; 4 4 5 , 13; 5 0 5 , 2 ; 5 8 9 , 23 - 25 (commentario al De anima); 475, 20 - 21 (commentario agli Analitici secondi); 7 0 3 , 4-7 e 15- 16 (commentario al De cae/o); 6 6 7 , 1 0 - 1 1 (commentario alla Fwzca); 6 7 2 , 11- 12 (com-mentario al De caeló). Infine pseudo-Alessandro riproduce quattro passi di Alessandro, uno dalle Quaestiones (685 , 30 - 687 , 2 2 = A L E X. , Quaest. 1.1) e tre dal De anima (694 ,
2 7 - 3 9 = A L E X. , De an. 108, 3- 15; 6 9 7 , 18- 39 = A L E X. , De an. 85 , 11- 86, 6; 6 9 9 , 1-11 =
A L E X. , De a«. 1 0 9 , 2 5 - 1 1 0 , 3 ) .
(">) Cfr . T A R A N 1987 , in pan. 2 1 8 - 3 2 .
(") Cfr . recensione a GAG XXI I , 2 , in "Gòt t in gisch e gelehrte An zeigen ", 11 , 1906 , pp. 882- 899.
142 RITA SALIS
ligione erano in dipen den t i l 'un a dall'alt ra. M a P . Mor au x " h a a sua volta affermato che pseudo-Alessandro è da iden t ificare con Mich ele d i Efeso, e che n é Sir iano ha ut ilizzato i l commento d i pseudo-Alessandro n é quest 'ul-t imo ha attinto dal commento d i Sir iano, ben sì en t rambi gli autor i h anno fatto uso d i una fonte comune, costituita dal commento dell'Alessandro au-ten tico.
Un a svolta significativa al dibat t ito è stata data dal recente volume d i C. Lu n a , " la quale ha forn ito una serie d i prove impressionan t i a favore del-la tesi d i Praech ter , e ha mostrato, con tro Ereuden th al, che i r ifer imen t i ad Alessandro confermano anzi l' iden t ificazione d i pseudo-Alessandro con Mich ele d i Efeso,'"* i l quale era solito r inviare ad opere alessandrine per d i p i l i come se fosse stato lu i a scr iver le." I r ifer imen t i esplicit i al politeismo presenti nel commentar io si possono, d'alt ra parte, spiegare ammettendo che pseudo-Alessandro si sia rifatto alla concezione del divin o propr ia dei Gr eci , che comprendeva tut to quanto c'era d i eterno e in cor rut t ibile. Shar-ples " ha affermato che Ereuden th al sembra avere ragione quando osserva che nessun crist iano avrebbe commentato i l passo finale d i A , che in Ar isto-tele è un 'energica dich iarazione della supremazia d i un singolo pr in cipio pr imo - " i l governo d i molt i n on è buon o; uno solo sia i l comandan te" - , di-cendo che i Mot or i im m obil i subordinat i sono anch 'essi dèi, anche se di-penden t i per partecipazione e volon tà dal pr imo in tellet to. Tut tavia Shar-ples suggerisce che qui potrebbe essere prevalso sul senso retorico u n desi-derio d i esattezza sullozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status dei M ot o r i immobiH subordin at i, oppure i l passo potrebbe essere stato r ipreso meccanicamente da una fonte n on cr i-stiana.
Riguardo al rappor to t ra pseudo-Alessandro e SimpHcio, già lo stesso Sharples ha rilevato che esistono delle difficoltà alla posizione d i Taràn .' ' ' Ne l par. 4 cercheremo d i mostrare come l' ipotesi che sarebbe stato Simpli-cio a fare uso del commento d i pseudo-Alessandro sia in fondata, e come dunque i l confron to tra i due commentar i relativamente ad alcun i passi d i
(") Cfr . M O R A U X 2 0 0 1 , 4 2 3 ss.
(") Trois Etudes sur la tradition des commentaires anciens à la Métaphysique d'Ari-
itofc, Leiden 2 0 0 1 , 1-71. («) Cfr . zw, 6 6 - 7 1 .
(") Cfr . anche SH A R P LES 2 0 0 3 , 191 s., U quale osserva che sarebbe stato piuttosto singolare da parte di un commentatore antico mirare a far passare per autentico un com-mentario spurio.
( ''•) Relativamente al commento di pseudo-Alessandro a Metaph. A , cfr. 7 0 7 , 34 ; 7 0 7 , 5 ; 709 , 3 3 ; 7 2 1 , 3 2 .
(") Cfr . SH A R P LES 2 0 0 3 , 191 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ») Cfr . zw, 204 - 06 .
(") Cfr . sotto, par. 4,
I MOVIMENTI DEI CORPI CELESTI 143 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Metaph. A 8 deponga a favore della defin it iva iden t ificazione d i pseudo-Alessandro col bizan t ino Mich ele d i Efeso.
3. P SE U D O - A LE SSA N D R O E L ' A N I M A Z I O N E D E L L E SFERE CELEST I
Ch e i cieli per Aristotele siano an imat i è fuor i dubbio: ben ch é n é nella Fisica né nella Metafisica sia contenuto alcun r ifer imento alle anime dei cie-l i , poich é questi vengono mossi dall' in tellet to soltanto in virtiì dell'appet i-zione, è necessario ammettere che i cieli posseggano per lomeno le pr ime due facoltà dell'anima.""' M a se i cor pi delle sfere celesti, le lor o anime e i motor i immobili siano tre cose distinte,'*' o se si debbano iden t ificare i mo-tor i con le anime delle sfere o se piut tosto si debba in tendere che le sfere non vengono mosse in ternamente dall'an ima, ma soltanto esternamente dai motor i è questione ancora dibat tuta tra gli in terpret i. Nella Fisica A r i -stotele afferma che, a differenza d i quanto avviene per i cor pi terrestri, le anime dei quali sono motor i im m obil i che, in quanto imman en t i al corpo che muovono, vengono esse stesse mosse per accidente, i mot or i im m obil i del cielo sono immobili anche per accidente,"" i l che sembrerebbe implicare che l'an ima del cielo sia da esso separata. In questo caso, per ò, sorgerebbe i l problema se si debba ammettere un 'an ima della sfera per ogn i motore, d i modo che ci sarebbero 56 anime delle sfere e 56 mot or i immobili."' '
La posizione d i pseudo-Alessandro e del vero Alessandro su questo
(-"') Cfr . SH A RP LES 2002, 4 e n . 12, i l quale a tale proposito rich iama A 5, 1071''2-3, in cui Aristotele dice che le cause di tutte le cose potrebbero essere l'anima e i l corpo, oppure l'intelletto, i l desiderio e U corpo, e rileva che i l vero Alessandro (fr. 21 Freuden-thal: TafsTr, 1535) riferiva la seconda alternativa ai cieli.
("") Cfr . BER T I 1997, 75-82, i l quale sostiene che i motor i immobili siano dist in t i dalle sfere. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(-•2) Cfr . BR O A D I E 1993, 390, 392 s., 397; K O S M A N 1994.
(-•0 G i LLl 9 9 4 , 2 9 s . e n . 3 4 . (-'-') Cfr . VIII259'^2-3; 16-20. Cfr . anche Dean., 14,408 a 30-34. E LD E R S 1972,213,
osserva che in Phys. V i l i 6,259''29-31 si dice che certi pr in cipi delle realtà celesti vengo-no mossi da altro, ma non viene specificato se si tratti di un 'in telligenza o di un 'anima o della natura animata di un pianeta o di una sfera; dunque, secondo l'Autore, ciò non è sufficiente per identificare quei pr in cipi coi motor i immobili d i Metaph. A 8. SH A R P LES 2002,19 e n . 97, r iporta che JA E G E R 1923/1948, 361 interpreta i l passo della Fisica come se significasse che c'è un unico motore immobile trascendente, cioè quello della pr ima sfera, e ritiene che qui Aristotele non si sia ancora impegnato a sostenere la pluralità dei motori immobili. Penso che ciò sia possibile, e comunque resta i l fatto che i l suddetto passo della Fisica quantomeno testimonia che Aristotele doveva già avere in mente la pluralità dei motori immobili.
(-") Cfr . P Aji . V i l i 6, 259'"24. («) Cfr . SH ARP LES 2003, 199.
144 RITA SALIS
pun to è ch iara: en t rambi dist inguono le anime delle sfere dai r ispet t ivi mo-tor i immobili , i l pr imo affermando che le cause efficienti delle sfere n on so-no le loro anime, in quanto queste n on sono dèi,"^ ben sì i mot or i immobili,"** e i l secondo sostenendo che per ogn i sfera c'è un motore immobile e un 'an i-ma."'' Se Alessandro iden t ificava le anime delle sfere con le loro nature,'" pseudo-Alessandro dappr ima iden t ifica le anime delle sfere con le loro for-me e asserisce anch 'egli che i l movimen to dovuto all'an ima e quello che deriva dalla natura sono uno e lo stesso,'^ ma poco più avanti '' l i dist ingue dicendo che, mentre le sfere r icevono dalla natura l'at t itudine a muoversi in circolo, l'an ima dà loro l'at tualità del movimen to.'"
In 701,5 ss. pseudo-Alessandro dice che le anime muovon o le sfere ma in modo diverso rispetto a quello in cu i le anime muovon o gli an imali, cioè forzando i loro corpi: le sfere sono mosse dalle an ime, come Aristotele ha stabilito nel II libr o delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De caelo,''^ e dalla causa pr ima come da un oggetto del desiderio. I l discorso d i pseudo-Alessandro sembra implicare che le sfe-re vengono mosse da un motore esterno, rendendo difficile immaginare co-me qualcosa che è separato dalle sfere possa cost ituire la loro anima.' ' '
(" ) Cfr . ps. A L E X . , In Metaph., 706, 31-33. I l fatto che i motor i immobili vengano detti cause efficienti non contrasta con l'at tribuzione al loro modo di agire d i un t ipo di causalità finale da parte degli in terpreti an tich i. I motor i immobili producono movimen-to in quanto cause efficienti, e dunque tale loro condizione costituisce i l presupposto fondamentale per la loro azione.
("«) Cfr , / w , 707, 1-2. ( ') Cfr . A L E X . , Quaest. 1.1,4,1 ss.; 1.25,40, 8-10; In Metaph. Ò15 s., 37 ss.; ap. SI M -
P L. , In De caelo, 380,5 ss. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ») Cfr . SiMPL., In De caelo, 380, 29 ss.
(") Cfr . ps. A LE X. , / KM e t ó p / ) . , 706, 33-34.
(«) Cfr . zW, 706, 34-36. (") Cfr ./W , 706,36-707,1. ('") A tale proposito SH A R P LES 2003, 199 s., r iporta l'osservazione di M E R L A N
1935, secondo la quale la distinzione tra la natura e l'an ima non è d i Alessandro, ma di Simplicio che riporta Alessandro, per cui pseudo-Alessandro segue non i l vero Alessan-dro, bensì Simplicio. Da ciò Mer lan deriva che, se pseudo-Alessandro avesse voluto farsi spacciare per l'Alessandro autentico, non avrebbe trascritto erroneamente le opin ion i d i Alessandro come riferite da Simplicio. Tuttavia Sharples ribatte che i l fatto che pseudo-Alessandro abbia riportato erroneamente i l pensiero dell'Alessandro autentico può es-sere dovuto ad incompetenza piuttosto che ad onestà. Inoltre Sharples nota che la tesi di Taràn per cui Simplicio dipende da pseudo-Alessandro lascia inspiegato i l fatto che Simplicio non rilevi che pseudo-Alessandro condivide la sua opin ione per cui la natura e le anime dei cieli sono distinte, anziché quella del vero Alessandro, che egli rifiuta in In De caelo, 380, 5 ss.
(") 12, 292^8 ss. Cfr . H A Y D U C K , ad loc
(") SH A RP LES 2003, 200, e 2002, 20 n . 96 suggerisce che qui sembra che pseudo-Alessandro stia semplicemente cercando di adattare l'argomento di De caelo, II 1,
I MOVIMENTI DEI CORPI CELESTI 145
In 1073 "24 Aristotele dice che i l pr imo Mot or e è immobile per sé e per accidente (KaO' aiJTÒ KaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kaxà (TV\i e r\KÓc,), ma alle 11. 33-34 e 39 si dice che i motor i delle sfere in fer ior i sono im m obil i per sé. Ciò sembra implicare che, mentre i l Mot or e pr imo è pr ivo anche d i quei movimen t i che ha l'an i-ma dei corpi an imati del mon do sublunare quando quest i si muovon o, gli altr i motor i im m obil i abbiano invece un qualche t ipo d i movimen to, ap-punto i l movimen to accidentale;' ' in tal modo verrebbe anche affermata una subordinazione e una dipendenza delle in telligenze mot r ici delle sfere in fer ior i dal pr imo Mot ore della sfera piìi esterna.
Ber t i "* ha escluso che i mot or i im m obil i subordinat i si muovano per accidente, in quanto una simile in terpretazione porterebbe a ritenere i mo-tor i immanen t i alle sfere e dunque ad iden t ificar li con le loro anime, e ha perciò ritenuto che n on si debba ammettere nessuna differenza tra i l modo in cui i l Mot ore immobile pr imo produce Ìl movimen to ed i l modo in cu i muovono i motor i subordinat i. L' in terpretazione dei passi suddet t i come escludenti l' immobilità accidentale per i mot or i subordin at i comportereb-be comunque, secondo Ber t i, l'ammissione per essi d i un qualche t ipo d i movimento, che, ad es., potrebbe essere cost ituito dal fatto che i mot or i, in quanto sono pensiero e pensano quanto vi è d i più eccellente, n on pensano solo se stessi, ma anche i l Mot or e pr imo, ad essi superiore, nei cu i con fron t i devono pertanto essere in potenza. Ciò tuttavia implich erebbe che gli alt r i motor i n on sono totalmente in atto, come invece i l Mot or e pr imo, ma Ber t i riconosce che difficilmente Aristotele avrebbe ammesso un a differenza d i questo t ipo e che è comunque certo che i l pr imo Mot or e immobile è l'ente supremo, mentre le altre in telligenze mot r ici sono ad esso subordinate.
Sharples ' ' r it iene, invece, che i l passo aristoteHco possa venire inter-pretato n el senso che l' immobilit à per sé e per accidente è propr ia solamen-te del Mot ore pr imo, mentre i mot or i delle sfere in fer ior i si muovon o per accidente, e cita Temist io,*° i l quale ammette che i mot or i subordin at i si muovono per accidente, come l'an ima, mentre i l pr imo Mot or e è immobile per sé e per accidente.
Secondo Lloyd " l' immobilit à assoluta e relativa in "24 ss. va estesa a
284''27 ss., cioè che l'anima non può muovere ri cielo con un 'azione costrittiva. Cfr . an-che ps. A L E X. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In Metaph., 691, 3 ss., in cui egli interpreta 107l' '34-36 nel senso che l'anima costringe i l corpo dell'animale a muoversi.
('") Cfr . sopra, n n . 44 e 45. Anch e T H E M . , In Metaph., 26, 4-9 Landauer, dice che, mentre la causa prima è immobile per sé e per accidente, gli altri motor i sono immobili soltanto per sé e tuttavia si muovono per accidente, come l'an ima. . .
n Cfr . BER T I 1977, 439 s. '
(«) Cfr , SH ARP LES 2002, 8 n . 34.
n Cfr . T H EM . , / «M e t e p A. , 26,5-9 Landauer. (") Cfr . L L O Y D 2000,253.
146 RITA SALIS
tut t i i motor i delle sfere, sebbene egli osservi che qu i tale specificazione è soltanto assunta e n on argomentata.
Nonostan te Aristotele n on abbia ben determinato i l rappor to tra i l Mot ore della pr ima sfera e i motor i im m obil i delle altre sfere, è in dubbio che egli ammetta una supremazia del pr imo rispetto ai secondi, e dunque che esista una qualche differenza tra essi.''^ Tut tavia n on credo che tale dif-ferenza possa consistere in un diverso t ipo d i immobilit à: i mot or i subordi-nat i devono essere anch 'essi n on soggetti a nessun movimen to, neppure ac-cidentale, in quanto ciò comporterebbe, come osserva Ber t i , una loro r idu-zione all'an ima, e dunque la loro immanen t izzazione. 11 pr imato del Mot or e supremo sembra basato piut tosto su una 'differenza specifica' r ispetto agli alt r i motor i.
Pseudo-Alessandro " rit iene che la causa pr imazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {i.e. Ìl pr imo Mot or e immobile) e, insieme, i mot or i delle sfere in fer ior i siano im m obil i per sé e per accidente.
Aver roè r ipor ta i frammenti del commento del vero Alessandro alla se-conda parte del libro A in numero molto min ore rispetto alla pr ima, in quanto egli possedeva soltanto due terzi del commentar io autentico e alcu-n i r ifer iment i del commentar io d i Alessandro alla seconda parte possono essergli giun t i n on direttamente da questa fonte ma per altre vie.'"* A propo-sito dalla questione dell' immobilit à del pr in cipio della pr ima sfera e dei mo-tor i delle sfere in fer ior i, Aver roè n on r ipor ta alcuna citazione d i Alessan-dro, ma una qualche luce sul suo pensiero pu ò venire dal commentar io d i Simplicio alla Fisica e dal De anima d i Alessandro.' ' ' In 1261, 33-37 SimpH-cio r ipor ta che, secondo Alessandro, la causa pr ima, la quale muove la sfera delle stelle fisse, sarà immobile per sé e per accidente, n é ver rà mossa da qualche altra cosa, perch é la sfera delle stelle fisse si muove d i un movimen-to un ico, r imanendo i suoi poli sempre nello stesso luogo, oppure per ch é essa non è la forma del corpo mosso, ma è piut tosto una sostanza separata. Dun que Alessandro riteneva che i l motore della pr ima sfera n on viene mos-so o perch é i l fatto che l'an ima muova i l suo corpo sferico n on implica che si
C' ) Cfr . Metaph. A 8, 1073''2-3, in cui Aristotele dice che delle intelligenze mot r ici una viene prima e un 'altra dopo, secondo l'ordine dei movimenti d i traslazione degli astri: ciò induce a ritenere che i l Motore immobile della sfera pivi esterna è pr imo rispet-to agli altri motor i immobili, e che dunque questi sono d i grado inferiore rispetto a lu i nella misura in cui se ne allontanano. Cfr . anche con K A H N 1985, 187 e SH A R P LES 2002, Se n . 36, De gen. et corr., II 10, 337''21: che i motor i delle sfere in feriori stiano in una qualche relazione col Motore della pr ima sfera è richiesto dall'unità del mondo.
Cfr . ps. A L E X . , In Metaph. 700, 13-14 e 701, 3-4.
(< ) Cfr . G E N E Q U A N D 1986, 7.
{ ) Sul modo in cui per Alessandro di Afrodisia i l motore muove il cielo, cfr. BE R T I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20m, passim.
I M O VI M EN TI DEI CORPI CELESTI 147
muova essa stessa, oppure perch é la causa pr ima è separata rispetto al pr i-mo cielo.'" In 1354, 26-34 Simplicio riferisce che, secondo Alessandro, i l motore della pr ima sfera n on si t rova in un luogo, in quanto è senza par t i né è la forma della sfera nella quale si t rova, ma è una sostanza incorporea che muove come oggetto del desiderio.'"' Simplicio n on dice n ulla circa i l pen-siero di Alessandro in rappor to ai mot or i im m obil i delle sfere in fer ior i, ma Don in i ha affermato che i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De anima d i Alessandro mostra che egli am-metteva una pluralità d i motor i trascendenti.'"'' D'alt r a parte, in diversi luo-ghi Alessandro r iprende la tesi dell'un icità che deriva dal passo conclusivo d i A,^ " i l che ha portato ad affermare che in Alessandro c'è la stessa oscilla-zione tra pluralità e un icità d i sostanze im m obil i che si t roverebbe in Ar isto-tele.^' Questo è vero, pur ch é n on si in tenda che tra un icità e pluralità vi sia un contrasto: se c'è una pluralità dei motor i im m obil i dei cieli, deve esserci un motore pr imo, perch é soltanto in questo modo viene garantita l'un ità dell'universo.^^
4. SI M P LI C I O F O N T E D I P SE U D O - A LE SSA N D R O
4.1. l sistemi astronomici di Eudosso ed Aristotele
Nella parte d i A 8 compresa in 1073^17-1074''17 è contenuta la r ispo-sta alla seconda questione posta in 1073''15, cioè quante sostanze mot r ici occorre ammettere. Aristotele parla dappr ima dei sistemi ast ronomici d i Eudosso e Callippo,^ ' e si basa soprattutto su quest 'ult imo per costruire Ìl propr io sistema d i sfere reagenti. Most reremo come i l commento d i pseu-
Cfr . SH A RP LES 2002, 18 s. e n . 92, dove si evidenzia che è caratteristica di Ales-sandro quella di elencare piiì spiegazioni senza a volte accordare una preferenza a qual-cuna di esse.
(") SI M P L. , In Phys., 1354, 34 ss. dice che secondo Alessandro i l Pr imo motore muove come causa finale, ma in 1361, 31-33 e 1362, 13-14, egli r iporta che Alessandro commentava De gen. corr., I 3, 318° 1 -5, attribuendo al Pr imo motore anche una cau-salità efficiente. SH ARP LES 2002,20 n . 94 suggerisce che tale contraddit torietà si potreb-be spiegare ritenendo che Simplicio stia interpretando i l pensiero d i Alessandro nel sen-so che c'è una causa efficiente del movimento dei cieli ma non della loro esistenza. Cfr . tuttavia sopra, n . 47.
Cfr . D O N I N I 1995, 114 s.
e*') Cfr . anche A C C A T T I N O - D O N I N I 1996, 283 s.
(™) Cfr ., ad es., Quaest. I l , 2,25 ss.; 125, 40, 3-8.
(") Cfr . A C C A T T I N O - D O N I N I 1996, 284. G l i Au t or i citano A 8, 1073''36-''3 e 1074^15 ss. per la pluralità delle sostanze immobili e 1074''31-37 per l'unicità.
Cfr . SH ARP LES 2002, 8 n . 36.
(") Cfr . SALIS 2000,14-17.
148 RITA SALIS
do-Alessandro relativo a questa sezione d i A 8 dipende per le par t i assenti
in Aristotele dal commentar io d i Simplicio alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De caelo, e che i l nostro esege-
ta n on comprende a pieno le spiegazion i ivi presenti. Ciò avviene in modo
particolare per le due cost ruzion i geometriche d i cu i pseudo-Alessandro si
serve per spiegare i l maggiore piano d i obliquit à del cerch io secondo i l qua-
le si muove la terza sfera della Lu n a rispetto a quello descrit to dal cerch io
secondo cui si muove la terza sfera del Sole n el sistema d i Eudosso, e i l fun-
zionamento delle sfere reagenti d i Ar istotele. En t rambe le cost ruzion i con-
tengono degli er ror i, imputabili al frain tendimento dei passaggi cor r ispon -
dent i nel commentario d i Simplicio (ciò avviene in maniera pit i evidente
nella seconda costruzione).
E ut ile per ciò che in tendiamo mostrare avere presente qualche n ot izia
sul commentario d i Simplicio. In esso sono r ipor tat i ampi estratti del
ITegl xcòvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA àveXixxova&v d i Sosigene i l per ipat et ico," maestro d i Alessan-
dro d i Afrodisia.'"^ In ragione delle cit azion i r iportare da Simplicio, è possi-
bile r icostruire quella che doveva essere la strut tura dell'opera. In 488,
(") Tali estratti assumono a volte la forma di citazioni letterali (cfr. 498, 4; 498, 10; 501,1; 501,25; 504, 17), oppure sono dei riassunti (cfr. 499, 16-501,21), o rimandano al contenuto generale dell'opera (cfr. 510, 24 ss.).
(") Così Sosigene è chiamato da P R O C L O , Hypotyp., I V 98, 130, 18 e da D E XI P P O , InCat.,l,A.
("') Ciò si ricava dallo stesso A LE SSA N D R O , In Meteor., 143,13, da T E M I ST I O , In De an., 61, 23, dallo pseudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- AMMONio, In An. pr., 39, 24 e da F I L O P O N O , In An. pr., 126, 20-23. E oggi definitivamente stabilito che l'autore del negL TU)V àv^Kvzxova&v non sia i l Sosigene astronomo che aiutò Cesare nella riforma del calendario (cfr. M O R A U X 2000, 323 e nn . 3 e 5), come in passato alcuni studiosi avevano ritenuto, essendo i l contenuto dell'opera di carattere astromonico. M O R A U X 2000, 324 n . 6 riporta le seguenti ragioni che provano l'appartenenza del trattato a Sosigene i l peripatetico: 1) Proclo, che utilizza lo stesso scritto d i Simplicio, attribuisce l'opera a Sosigene i l peripatetico; 2) l'autore dell'opera mostra una venerazione per Aristotele che fa pensare senz'altro ad un peripa-tetico; 3) i l Y lzQi TÓàv àv e À i TTO U CTtò v conteneva una parte dedicata alla spiegazione spe-cialistica di Aristotele (Metaph. A 8, 1073''17-1074''14); 4) i l fatto che Simplicio non sen-ta l'esigenza di fornire ulter ior i notizie su Sosigene induce a ritenere che egli dovesse es-sere noto ai commentatori, come noto doveva essere i l maestro di Alessandro, menzio-nato più volte dall'8|TiYr| tf|g nei suoi scrit t i; 5) in SI M P L. , In De caelo, 502, 22 si parla di un 'ipotesi avanzata da in terpreti d i Metaph. A 8 più an tich i, ed è improbabile che al tempo d i Cesare esistesse già una letteratura commentaristica suUa Metafisica; 6) in SI M -P L. , In De caelo, 509, 16-510, 26 vengono esposte alcune aporie sollevate da Sosigene in merito al confronto tra i l sistema degli eccentrici e degli epicicli e i l sistema aristotelico secondo il metodo, t ipico d i Alessandro, delle à jT O Q Ì a i KaL Xvazic,; è perciò facile pen-sare che tale metodo fosse propr io anche del maestro di Alessandro; 7) nel IleQl x c ò v àvEXiTTODcrw v ricorreva la forma di argomentazione in utramque partem, caratterizzata dallo sviluppo delle due tesi senza alcuna presa d i posizione, che compare anche in un frammento del commentario alle Categorie di Sosigene, conservato nel commento alla stessa opera di Dexippo (7,4-6).
I MOVIMENTI DEI CORPI CELESTI 149
18-24 Simplicio riferisce che Sosigene traeva dal II libr o dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Storia dell'astronomia d i Eudemo la not izia secondo la quale Eudosso d i Cn id o sa-rebbe stato i l pr imo dei Gr eci ad occuparsi del problema, formulato da P la-tone, di quali movimen t i regolari e ordin at i bisognasse supporre per salvare i fenomeni in torno ai movimen t i dei pianeti.^' I l r imando a tale problema doveva servire da in t roduzion e per l'esposizione dei diversi sistemi astrono-mici che avevano cercato d i r isolver lo: nella pr ima parte dell'opera, Sosige-ne doveva avere esposto le varie teorie basate sul sistema omocen t r ico (Eu-dosso,'** Callippo,'"' Ar istotele""), e la seconda doveva comprendere una trattazione dei sistemi più recent i, basati sugli eccen tr ici e sugli epicicli. Contrariamente, dunque, a quanto si sarebbe in dot t i a ritenere, l'oggetto delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rieQl Tw vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA àvzhxxova&y n on era ristretto solamente al sistema d i A r i -stotele: nelle par t i riprese da Sosigene, Simplicio estende i l termine òyzkixxovuai, che designa notoriamente le sfere reagenti d i Ar istotele, an-che alle sfere che n ei sistemi di Eudosso e Callippo n on reggono l'astro e che si dist inguono dalla sfera delle stelle fisse per direzione del movimen to, orientamento dell'asse, velocità e grandezza, con t r ibuen do a spiegare Ìl mo-vimento apparentemente irregolare degli astri. Le sfere d i Eudosso e Callip-po sono perciò dette 'reagenti' in rappor to al moto della sfera delle stelle fisse.
Simplicio espone i sistemi d i Eudosso, Callippo ed Aristotele nella par-te d i commento relativa a De caelo II12.** Il sistema d i Eudosso, con tenuto nel trattato perduto negl xaf&y, era stato descrit to dettagHatamente da Eudemo nella Storia dell'astronomia ed era passato successivamente n el IleQl T&v àvzhxxovaSìv d i Sosigene.**' I l commento d i pseudo-Alessan-
(") M o R A U x 2 0 0 0 , 3 3 5 , 5 4 , r iporta tuttavia che l' ipotesi secondo la quale i l sistema di Eudosso sarebbe la risposta al quesito formulato da Platone è ritenuta dubbia dagli studiosi. La notizia viene attribuita esplicitamente da Simplicio a Sosigene (488, 21- 22) , ma Moraux afferma che i l suo racconto non può essere preso per storico.
('«) Cfr . SI M P L. , In de caelo, 4 9 3 , 1 1 - 4 9 7 , 8.
(") Cfr . ivi, 4 9 7 , 8- 24.
(™) Cfr . ivi, 4 9 7 , 2 4 - 4 9 9 , 4 , dove 4 9 8 , 1-499, 4 è esplicitamente riferita da Simplicio a Sosigene.
("') Per questo motivo Teofrasto chiamava tali sfere avaCTXQOL (= 'senz'astri'). Cfr . SI M P L. , In De caelo, 4 9 1 , 1 9 - 2 0 .
(82) 2 9 3 ' ' ' 4 - l l . SI M P L. , In De caelo, 4 9 1 , 1 2 - 1 4 = ps. A L E X . , In Metaph., 7 0 3 , 2- 4: "E
ancora per questo motivo le altre traslazioni hanno un corpo solo" fino a: "la potenza d i un corpo limitato si esercita solo verso un corpo limitato".
("') E molto difficile stabilire in che misura Sosigene abbia attinto all'opera d i Eu -demo. I l rich iamo alla Storia dell'astronomia di Eudemo per U sistema d i Eudosso in SI M P L. , In De caelo, 4 8 8 , 18- 24 rende molto probabile l' ipotesi che Sosigene abbia tratto le informazioni sui sistemi più an tich i da Eudemo, sicché Simplicio potrebbe avere r i-preso le notizie su Eudosso e Callippo direttamente da Sosigene, nonostante in 4 9 7 , 17-
150 RITA SALIS
dro ^ a 1073''17 ss. è preceduto dallo stesso passo delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De caelo a cui Sim-plicio fa seguire l'esposizione dei sistemi omocentrici, e pseudo-Alessandro rinvia ad esso come al luogo dove si è parlato con molta accuratezza del nu-mero delle sfere ammesse da Eudosso, Callippo ed Aristotele e del come e del perché queste si muovono.**' L'esegeta, inoltre, rimanda allo stesso pas-so del De caelo i l lettore che voglia procurarsi una spiegazione di 1073 17-1074''15, cioè dell'intera sezione di A 8 in cui si tratta dei sistemi di sfere omocentriche.**^ Nella parte di testo che segue, pseudo-Alessandro dice che si rende ora necessario esaminare alcune espressioni non chiarite nel De caelo, a cominciare da quella secondo la quale lajjrima delle sfere del Sole è xfivzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p,èv jtQCOTTiv XTiv Twv àjt>iava)v ào-TQCOV e lvai (1073''19-20), e, a tale proposito, si preoccupa di rilevare che Aristotele non intende affermare che la sfera delle stelle fisse è la prima, sebbene essa sia effettivamente la prima: riprendendo Simpl., 493, 12-13, egli spiega che ciò che Aristotele intende dire è piuttosto che, delle tre sfere che trasportano i l Sole, la prima si muove con lo stesso movimento della sfera delle stelle fisse, vale a dire da oriente ad occidente, e rinvia ancora una volta al De caelo come al luogo in cui A r i -stotele ha spiegato i l movimento della sfera delle stelle fisse. A l t r i due r i -mandi al passo del De caelo in questione si trovano in 703, 25 e 704, 21, in cui pseudo-Alessandro parla rispettivamente del cerchio che si inclina obli-quamente sul piano dello zodiaco, che i l Sole sembra descrivere al suo cen-tro, e dell'uso che Aristotele fa delle sfere reagenti. Tali rinvìi, non sempre esatti,**** sembrano derivare la loro fondatezza dal fatto che Simplicio tratta dei sistemi di sfere omocentriche nella parte di commento dedicata a De caelo II 12, dove vengono anche esplicitamente citati dei passi relativi alla sezione in questione di Metaph. A 8.**'
D a Simplicio apprendiamo che Eudosso ammetteva tre sfere per ti Sole, tre per la Luna e quattro per ciascuno degli altri cinque pianeti; dun-que in totale contava ventisette sfere, inclusa quella delle stelle fisse. Egl i
24 egli r imand i esplicitamente a E u d e m o per le mot ivaz ioni che indussero C a l l i p p o a l -
l ' introduzione d i nuove sfere.
n C f r . p s . A L E X . , / « M e t ó / ) / 7 „ 702, 37-703, 4.
(X') C f r . sopra, n . 82.
r ) C f r . ps. A L E X . , / « M e t ó p Z ) . , 702 ,38-703 , 5.
r ) C f r . zra, 703 ,5 -8 .
C^^) È noto, ad es., che Aristotele ne l De caelo n o n menziona Eudosso e C a l l i p p o . È,
d'altra parte, esclusa l ' ignoranza da parte d i pseudo-Alessandro del contenuto del De
caelo, visto che i suoi numeros i altri r inv i i sono sempre corretti (cfr. 446, 22 e De caelo I
3; 686 ,25 e De caelo 112 ; 689, 38 e De caelo 112 ; 700, 7 e D e caelo 15-7 ; 701 ,24-25 e De
caelo 12 ; 720 ,8 e De caelo 13,270' '12 ss.; 732 ,4 e 7 D e caelo 11,268^23; 763 ,27 e D e cae
lo 18 ; 803,22 e D e caelo 112 ; 804 ,24 e D e caelo 112 ; 819, 38 e D e caelo 1 1 0 , 2 7 9 , 3 2 ss.).
C') C f r . S I M P L . , In De caelo, 497, 9-13 e 26 -498 ,1 ; 499 ,5 -7 e 9-11; 505 ,30-506 , 3.
('") C f r . / w , 493 ,12 -497 ,8 .
I M O V I M E N T I DEI CORPI CELESTI 151
ipotizzava che i pianeti fossero situati in un punto dell'equatore della sfera che ruotava intorno ai suoi poli con una velocità costante, e spiegava i l mo-to apparentemente irregolare dell'astro supponendo che i poli di ogni sfera venissero trasportati da una sfera piti grande e ad essa concentrica, che si muoveva con una velocità diversa e con un altro asse. I poli di questa sfera erano a loro volta collocati sulla superficie di un'altra sfera piti grande e ad essa concentrica, la quale ruotava con una velocità propria con un asse an-cora diverso, sicché la sfera più interna, che reggeva l'astro, riceveva l ' in -fluenza di tutte le altre sfere, i l cui moto si combinava col suo proprio movi-mento, dando così origine alle irregolarità del moto del pianeta. Simplicio dice che, secondo Eudosso, la prima sfera del Sole aveva lo stesso movi-mento della sfera delle stelle fisse, la seconda si muoveva lungo lo zodiaco e la terza lungo un cerchio inclinato sul piano dello zodiaco,^' giustificando l'introduzione di quest'ultima sfera sulla base dell'osservazione che ai sol-stizi estivo e invernale ti Sole non sorge sempre dagli stessi punti.''^ Le prime due sfere della Luna avevano lo stesso moto delle prime due sfere del Sole, mentre la terza si muoveva lentamente in una direzione opposta rispetto al-la seconda, a differenza di quanto avveniva per i l Sole, la cui terza sfera ruo-tava nella stessa direzione della seconda.''^
Le teorie solare e lunare di Eudosso esposte da Simplicio sono confer-mate da Aristotele,'''' che, secondo Simplicio, apprese i l sistema di Eudosso da Polemarco.*" Quanto pseudo-Alessandro dice su Eudosso e che non si ritrova nel testo di Aristotele è ripreso dal commentario di SimpHcio. In 703,20-21, dove si dice che nella prima sfera di ciascun pianeta i segni dello zodiaco costituiscono la figura dei pianeti che la riempiono, pseudo-Ales-sandro deve avere presente Simpl., 493, 13-14, come pure in Simplicio egli ritrovava la notizia che Teofrasto chiamava senz'astrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (àvaaTQOt) le sfere che non trasportavano i l pianeta (11. 22-23).' * In 703, 23-26, pseudo-Ales-sandro spiega 1073 "^20-21, in cui Aristotele afferma che la terza sfera del Sole e della Luna si muovono secondo un cerchio inclinato obliquamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n C f r . / w , 4 9 3 , 1 2 - 1 5 . ("2) C f r . zW, 4 9 3 , 1 5 - 1 7 .
(") C f r . zW, 4 9 4 , 2 6 - 4 9 5 , 1.
(*•) Cfr . Metaph. A 8 , 1 0 7 3 ' ' 1 7 - I 0 7 4 ' ' 2 2 . (") S I M P L I C I O , In De caelo, 4 9 3 , 5 - 8 , r iporta infatti che C a l l i p p o , dopo avere stu-
diato con Polemarco , che conosceva Eudosso , andò con l u i ad Atene per discutere con Aristotele le teorie d i Eudosso e per completarle e correggerle. I l per iodo dovrebbe dunque essere U 3 3 6 - 3 2 3 , quando Aristotele si trovava appunto ad Atene , durante i l re-gno d i Alessandro M a g n o . C f r . D R E Y E R 1 9 7 0 , 9 3 . Tuttavia Aristotele dovette conoscere personalmente Eudosso , i l quale faceva parte de l l 'Accademia , dove l o Stagirita dovette apprendere i l sistema d i sfere omocentriche.
('*) C fr . S I M P L . , D e cfle/o, 4 9 3 , 1 8 . C f r . sopra, n . 8 1 .
152 RITA SALIS
sul piano dello zodiaco, dicendo che i l cerchio che si inclina obliquamente sul piano dello zodiacozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA è quello che i l Sole, trasportato dalla sfera nella qua-le si trova, sembra descrivere al suo centro, e in Simplicio, 494, 8-9 ritrovia-mo la stessa menzione.
Anche la successiva costruzione geometrica con cui pseudo-Alessan-dro spiega la diversa inclinazione del cerchio secondo i l quale si muove la Luna rispetto a quello che descrive i l Sole rinvia al commentario di Simpli-cio. Conviene a tale proposito riportare per intero la traduzione del testo ad essa relativa e procedere dunque, con l'ausUio dei grafici che seguono, al r i -levamento dell'errore commesso da pseudo-Alessandro e dei parallelismi col commento di Simplicio. Dice l'esegeta in 703,28-704,4:
" L a frase: ' L a sfera de l la L u n a si m u o v e però se condo u n cerch io m a g g i o r m e n -
te in c l ina to r ispetto a q u e l l o secondo c u i s i m u o v e la sfera d e l So le ' equ iva le a d i re : il
p i a n o d i obliquità d e l c e r ch io che la L u n a s e m b r a descr ivere a l suo centro , è m a g g i o -
re d i que l l o che s e m b r a descr ivere i l So le n e l p r o p r i o centro ; si è appreso questo s u l -
l a base d e l fatto che, ne i l o r o m u t a m e n t i , i l So le e l a L u n a n o n sorgono dag l i stessi
p u n t i . L ' o r i z z o n t e sia in fat t i : aTiPf,iYS; invece l ' equatore sia 6£|3, i l c e r ch i o che s ' i n -
c l ina su l p i a n o de l l o z o d i a c o , che i l sole s e m b r a descr ivere al suo centro , sia a e y ;
que l l o che, a sua vo l ta , la l u n a s e m b r a descr ivere al suo centro sia T^e|J.. I l sole sorga a
seconda de l la stagione: q u a n d o c 'è i l so lst iz io estivo sorge d a l p u n t o a , e, invece ,
q u a n d o c 'è l ' e q u i n o z i o , d a l p u n t o 6. E ev idente che i l p i a n o d i obliquità magg iore è
l a c i r conferenza 6a. Q u a n d o l a l u n a si sposta verso N o r d , sorga d a l p u n t o r|; e v i d e n -
temente i l suo p i a n o d i obliquità maggiore è la c i r con ferenza 6T), e d è magg iore de l la
c i r con ferenza 6a, la quale era i l p i a n o d i obliquità magg iore d e l so l e " .
Secondo la ricostruzione di Sepulveda (diagramma 1),'" si ha che la l i -nea verticale è l'orizzonte, e è i l punto equinoziale, e 6 è i l punto in cui
{'') E n t r a m b i i disegni sono tratti dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alexandri Aphrodisei Commentaria in duode-
cim Aristotelis lihros de prima Philosophia, interprete LG. Sepulveda,Venetiis 1544, 197-98 (le lettere sono state riscritte, in quanto n o n tutte distintamente leggibil i ) . I l disegno 1 r iproduce, secondo Sepulveda, la spiegazione che pseudo-Alessandro dà della diversa incl inazione della terza sfera de l Sole e della terza sfera della L u n a rispetto al piano dello zodiaco (cfr. Metaph. A 8, 1073''21-22); i l disegno 2 spiega l 'azione delle sfere reagenti d i Aristotele. V a segnalato, a proposito del secondo diagramma, che nel l 'ediz ione della traduzione d i Sepulveda pubbl i cata a Par ig i nel 1536, 392, vengono r iprodotte delle sfe-re non omocentriche, che perciò n o n rispecchiano i l sistema aristotelico né la spiegazio-ne d i pseudo-Alessandro. N e p p u r e i l disegno 1 è identico nelle due ed iz ion i , e diverso è anche l ' ordine delle lettere che designano l 'or izzonte (nell 'edizione parigina la sequenza è: bgadmc anziché: cmdagb); ciò, tuttavia, non pare intaccare la correttezza del d iagram-ma riportato nel l 'edizione del 1536. Infine, in entrambe le ed iz ion i , la sequenza d i lette-re designanti l 'or izzonte sopra riportata risulta corretta, e perciò n o n corrispondente a quella d i pseudo-Alessandro. N e l l a versione lat ina, a = a ; b = |3; c = y; d = 6; g = r|; m =
I M O V I M E N T I DEI CORPI CELESTI 153
b
l'equatore attraversa l'orizzonte; a è i l punto da cui sorge i l Sole, che è più a Nord rispetto a 6, ed r| è i l punto da cui sorge la Luna, cioè ancora più a Nord. Dall'altro lato, i l Sole sta al punto y, e la Luna si trova ancora più a Sud nel punto [x. I l problema è che, andando verso est, abbiamo l'ordine aT)PY[té e non, come dice pseudo-Alessandro, aT)(3[,iYS. Se anche proviamo a disegnarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA il diagramma di modo che esso mostri le posizioni più a Nord , l'ordine sarà Prjayjiò, che dà, procedendo al contrario e cominciando da a: aT)[j,Y6p, che comunque non si adatta dal testo. I l punto è, daccapo, che Y dovrebbe stare tra (3 ed fi.
Possiamo ricavare la dipendenza di pseudo-Alessandro da Simplicio anche relativamente a questa sezione dai seguenti indizi: 1) la diversa incli-nazione dei cerchi secondo cui si muovono le terze sfere del Sole e della L u -na si deduce, secondo pseudo-Alessandro, dal fatto che, nei loro mutamen-ti, i l Sole e la Luna non sorgono dagli stessi punti (703, 32-34). Tale affer-mazione richiama Simplicio, 493,14-17, dove tuttavia le cose stanno un po' diversamente: Simplicio, infatti, dice che l'inclinazione della terza sfera del Sole sul piano dello zodiaco è ricavata dall'osservazione che i l Sole nei sol-stizi estivi ed invernali non sorge sempre dagli stessi punti; i l rilevamento di questo fatto da parte di pseudo-Alessandro è contenuto in maniera piutto-sto bizzarra anche in 703, 26-28, dove si dice che, quando c'è i l solstizio, i l Sole sembra cadere in quanto ai solstizi non sempre si vede sorgere dagli stessi punti; 2) del cerchio che la Luna sembra descrivere al suo centro (ps. Alex., 703, 36-37) si parla in Simpl., 495,3-4.
Tutto ciò mostra che, pur non ritrovandosi in Simplicio una descrizio-ne geometrica della diversa inclinazione dei cerchi secondo cui si muovono i l Sole e la Luna così come compare nello pseudo-Alessandro, i l commento del primo costituisce la fonte dell'argomentazione del nostro esegeta.
154 RITA SALIS
Simplicio dedica al sistema di Callippo solamente 16 righe (497, 8-24), e non è forse un caso che anche la trattazione che pseudo-Alessandro fa di questo sistema sia piuttosto breve e si l imiti ad una parafrasi del testo aristotelico.^"' Ben più estesa è invece la parte di commentario in cui Simpli-cio tratta del sistema di Aristotele,'"" ed anche da questa sezione pseudo-Alessandro trae elementi per costruire i l proprio commento.
Aristotele manteneva come base U sistema astronomico di Callippo, ma, ammettendo un unico cielo, riteneva che i sistemi di sfere di ciascun pianeta non fossero indipendenti l 'uno dall'altro. Aristotele aggiunge-va, dunque, altre sfere, aventi lo scopo di garantire e giustificare l ' indipen-denza di ogni complesso di sfere relativo ad un astro rispetto agli altri si-stemi di sfere al cui interno esso si trovava. Tali sfere, dette reagenti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{àveXixxovam) avevano i l compito di neutralizzare l'influsso che le sfere dei pianeti esercitavano sul pianeta immediatamente sottostante, e si muo-vevano perciò con la stessa velocità delle sfere da neutralizzare ma in dire-zione contraria. Esse erano inserite dopo l'ultima sfera di ciascun pianeta e prima della sfera più esterna del pianeta successivo."'^ Le sfere reagenti era-no tante quante le sfere di ciascun pianeta meno una, ad eccezione della L u -na, che, essendo l'ultimo dei pianeti, non aveva bisogno che i l moto delle
C a l l i p p o aveva apportato delle correzioni al sistema d i Eudosso , per rendere ra -gione d i altre irregolarità osservate nel moto degli astri: tranne che per Saturno e G i o v e , per i qual i mantenne le quattro sfere, egli ne aggiunse due alla L u n a e al Sole ed una per ciascuno degli altri tre pianeti , portando i l numero complessivo delle sfere a 34, compre-sa la sfera delle stelle fisse. A n c h e i n questo caso, le font i che ci permettono d i r icostruire i l suo sistema sono i l commentario d i S impl i c i o e i l cap. 8 de l l i b ro A della Metafisica d i Aristotele (1073''32-38): 1 'opera che sappiamo C a l l i p p o scrisse sulla sua teoria planeta-ria andò perduta ancora p r i m a de l tempo d i S impl i c i o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(") MoRAUX 2000, 336 ritiene che la parte de l commentario d i S impl i c i o relativa a C a l l i p p o n o n risalga del tutto a E u d e m o .
(™) C f r . S i M P L . , / « D e t a e / o , 4 9 7 , 2 4 s s . ("") I l verbo àveXiTTCO significa propriamente " ruoto a l l ' ind ie t ro " . ("' ) Se, ad es., poniamo che I, I I , III , I V sono le sfere d i Saturno ammesse da E u -
dosso e C a l l i p p o , e che l 'astro si t rov i nella sfera I V , dovrà esserci una sfera reagente I V a al l ' interno della sfera I V , che si muove rispetto ad essa con la stessa velocità m a i n dire-zione contraria; i n tal m o d o i mov iment i d i I V e I V a si annul lano a vicenda e I V « si muove come se fosse fissata della sfera III . Così al l ' interno d i I V a c i sarà una sfera III a
che si muoverà d i moto contrario e con la stessa velocità d i III , d i m o d o che i m o t i d i III e d i I H a si annulleranno a vicenda e la sfera III si muoverà come se fosse unita a II . In f i -ne, al l ' interno d i III a c i sarà la sfera reagente II a, che si muoverà, daccapo, con par i ve-locità della sfera II , ma a ritroso rispetto ad essa, e come se fosse attaccata alla sfera I. L ' u l t i m a sfera I si muove con lo stesso movimento delle stelle fisse, e dunque n o n ha b i -sogno che i l suo moto venga annullato. Ciò consentirà anche alla p r i m a sfera de l pianeta immediatamente sottostante d i n o n subire alcun t ipo d i inf luenza da l sistema d i sfere che precede. C f r . D R E Y E R 1970, 102,
I M O V I M E N T I DEI CORPI CELESTI 155
sue sfere venisse annullato. Secondo Aristotele, dunque, le sfere erano in totale 55.
A differenza dei sistemi astronomici di Eudosso e Callippo, i l sistema di Aristotele non era puramente matematico."" L a funzione che egli asse-gnava alle sfere, infatti, non era soltanto quella di spiegare i l moto dei piane-ti, ma esse erano concepite come dotate di un corpo e animate, cioè dotate di vita, per cui ad una traiettoria semplicemente geometrica si aggiungeva un'azione fisica. Inoltre, i l sistema aristotelico era basato prevalentemente su principi non matematici, ma fisici, come quello della tendenza della na-tura verso i l meglio, per cui essa agisce sempre in vista di un fine e non fa nulla che non abbia uno scopo,"''' o quello della superiorità degli astri e dei cieli rispetto al mondo sublunare. In Aristotele, insomma, entrano in gioco fattori piti strettamente fisici e che si discostano da un'impostazione pura-mente matematica del sistema. Inoltre, in A 8 Aristotele ricava i l numero dei motori immobili direttamente dal numero delle sfere e suUa base di de-duzioni logiche, lasciando all'astronomia i l compito di mostrare chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA è necessario che proprio quello sia i l numero dei movimenti "' e dei motori.""" A r i -stotele dice di non essere un astronomo, e dichiara la sua esitazione ad ad-dentrarsi nel campo specifico della scienza degli astri: la sua indagine rima-ne perciò ancorata alla metafisica.
L a sezione di commento dove pseudo-Alessandro parla del numero delle sfere reagenti ammesse da Aristotele (705, 27-39) è ripresa letteral-mente da Simpl., 502, 27-503, 9, con alcune piccole varianti,'"^ così come dipende dal commento di Simplicio la costruzione di cui pseudo-Alessan-dro si serve per spiegare 1074''3-4, in cui Aristotele spiega l'azione delle sfe-re reagenti. Simplicio dice che, per la comprensione del passo, è utile ripor-tare i l riassunto della spiegazione che di esso dava Sosigene.'"** Tale riassun-
('»') C f r . ivi, 101 s.
(™) C f r . De caelo, I 4, 27r30-33; II 8, 290''31; I I I I , 2 9 l ' n 3 - I 4 ; Metaph. A 8,
1074^7 ss. ("») C fr . Metaph. A 8, 1073''2-8.
(™) Cfr . zW, 1074''14-17. {'"'') S I M P L . , In De caelo, 502, 27-28:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA òei yàg \iiq EXÙTXOVC, et vai K U B ' e K Q a x o v
àuTÉQa Tcòv cpeQODaójv xàg àvEÀ,La<70iJaag, W C T X E èjtl \xèv K Q Ó V O D KOÌ tnì Aiòg
xexxÓQCJV K a 6 ' SKàxeQov O I I C T C Ò V X C D V qjeQOUCTWv X Q E Ì C elvai xàg àv8>Li<TCTOi)aag. C f r .
ps. A L E X . , In Metaph., 705,28-29: ÒEiòè K Q O ' eKaffXOV àaréga xàg àveÀuraoiiCTag (ila
kXàxxovc, 81 vai, 8| eaovxai ai xoij K Q Ó V O D K a l Aiòg àvs^tixxoDCTai; S I M P L . , 503, 2 :
xexoÓKig 08 xéxxoQEg al 'AQEOC, cfr. ps. A L E X . , 705, 32-33: xexQÓKig 6è xéxxageg
' A Q 805 ; S I M P L . , 503, 6-7: xaig yàg xr|v a8Xf|vr|v (p8QO'iJaai5 ovòkv cfr. ps. A L E X . , 705,
36-37: xaig yàg X T ) V <T8Xr|VTiv cpsgoiiaaig, wg dQTjrai, otjòèv; S I M P L . , 503, 7-8: xoijxo
K a l xov AQunoTÉXovc, eljxóvxog cfr. ps. A L E X . , 705, 38: oòxco yàg 'AQUTXOXÉX^C,
81'QT|K8V.
(™) Cfr . S I M P L . , 7K D e «6>/o, 499,16-17.
156 RITA SALIS
to comprende le pp. 499, 17-501, 21 e contiene diverse costruzioni; anche in questo caso, pseudo-Alessandro fa una specie di parafrasi del testo di Simplicio, riprendendo in modo particolare la prima costruzione e traendo dalle altre soltanto alcuni elementi.
Leggiamo in ps. Alex., 704,21-705, 6:
"La frase: 'e riportino sempre nella stessa posizione la prima sfera dell'astro sottostante' sarà evidentemente riferita ai cerchi inscritti. Siano infatti tre cerchi: uno a|3, un altro Se e il terzo ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT). Nel cerchio ^ i ] ci sia un astro, ad esempio Zeus, e sia il punto K . Siano un punto a, un punto 6, un punto , e quelli Pei]; ma non siano astri, bensì vengano considerati soltanto come dei punti e sia a, sia 6, sia , <si tro-vino> sulla medesima linea retta; lo stesso valga anche per i punti P ET ] . La sfera aP si muova verso il punto P, in modo tale che i l punto a si trovi nel punto in cui si trova P; le sfere òe e si muovano, invece, con la stessa velocità verso i punti 6! , in mo-do che i punti et] si trovino sui punti 6 . Giacché, dunque, le sfere e6 e r|^ si muo-vono verso gli stessi punti, muovendosi con pari velocità, è evidente che i l movi-mento della sfera T)£, è doppio rispetto al movimento della sfera eò: infatti, quant'è il movimento della sfera r| , tanto aggiunge ad esso il movimento della sfera e6, poi-ché si muovono verso gli stessi punti. Così, nel tempo in cui il punto E è giunto al punto 6, in quello stesso tempo il punto T|, avendo attraversato tutto il cerchio T ) ^ , giungerebbe, a sua volta, al punto T|, se la sfera ap, non avesse movimento contrario rispetto alla sfera 6E e, trascinandola sul punto P, non permettesse che quella tra-smetta alla sfera ^11 un altro movimento tale quale quello di cui essa si muove. In questo modo, ostacolando la sfera aP quella 6E , e trascinandola sul punto P, anche la sfera 6e ostacolerà quella ^T] e perciò la circonferenza conserverà sempre la stessa posizione della circonferenza ap. Quando, dunque, i l punto T) sarà giunto al punto , e quest'ultimo dove ora si trova il puntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ì], allora anche i l punto a giungerà dove ora si trova il punto P e viceversa, ed i pimti e si trovano sempre sulla stessa linea retta. Quando sorge il punto a, sorge anche il punto t, e quando, a sua volta, tramonta il punto P, allora tramonta anche il punto TI, e non sorgono né tra-montano mai prima del punto a^. Se la sfera ap e la sfera T)^ si muovessero verso gli stessi punti, accadrà la medesima cosa. Si consideri, d'altra parte, che la sfera Ò E ruota in senso contrario".
Quello che pseudo-Alessandro illustra è i l sistema piti semplice di sfe-re reagenti (diagramma 2),"" dove la sfera a(3, che è la più esterna, si muove con lo stesso movimento della sfera delle stelle fisse e in direzione opposta rispetto alla sfera òe, che è quella ad essa successiva e che regge l'astro, mentre la sfera ^r| si dovrebbe muovere con lo stesso movimento della sfera a(3. M a 1) innanzitutto l'esegeta dice che i l pianeta si trova sulla sfera ^ T ) .
(«") Metaph. A8, 1074^3-4. ("") C f r . sopra, n . 97.
I M O V I M E N T I DEI CORPI CELESTI 157
che invece è la sfera reagente;'" 2) in 704, 38-705, 8 pseudo-Alessandro sembra comunque parlare di un sistema in cui ci sono appunto due sfere che producono i l moto di un corpo celeste, che si troverebbe sulla sfera òe, e una sfera che si muove di moto contrariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CQr]), eppure la sua comprensio-ne del funzionamento delle sfere reagenti risulta imperfetta, in quanto i l movimento della sfera òe non dovrebbero essere esattamente contrario al movimento della sfera a|3 (in tal modo, infatti, semplicemente lo annulle-rebbe), ma dovrebbe essere diverso sia nella velocità sia nell'angolo del suo asse;"^ 3) un altro problema riguarda i l fatto che in 704,30-33 pseudo-Ales-sandro sembra affermare che òe e ^r| si muovono nella stessa direzione, sic-ché questi due movimenti, invece di annullarsi a vicenda, si sommano l 'un l'altro. E possibile che a causare l'errore sia stato i l fraintendimento di èjtl xà avxà nel commento di Simplicio: così in 704, 27-30 l'espressione po-trebbe essere riferita ai punti raggiunti, che sono gli stessi, ma in 704, 30-33 pseudo-Alessandro la intende come riferita alla direzione del movimento. L'errore riguarda quest'ultimo caso, in quanto sarebbe corretto dire che e e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT| giungono rispettivamente ai punti ò e ^, nonostante essi vi siano giunti ruotando ciascuno di 180°, ma dovrebbero muoversi in direzioni opposte.
L a prima delle costruzioni geometriche riportare da Simplicio è la se-guente:"^
" E s s e n d o c i due sfere o m o c e n t r i c h e , a d es. A E e Z H , e d essendo contenute
dal l 'esterno da u n ' a l t r a <sfera>, l a quale sia r i m a n e f e rma sia c i r c o n d a que l l e , m u o -
vendos i quel le al c ontrar i o l ' u n a r ispetto a l l ' a l t ra e ne l l o stesso t e m p o , c ioè c o n l a
stessa velocità, t u t t i i p u n t i ne l l a <sfera> che v iene c i r c o n d a t a si t r o v e r a n n o sempre
ne l lo stesso r a p p o r t o r ispetto a l la <sfera> che c i r c o n d a , c o m e se anche <quel la>
fosse ferma. M u o v e n d o s i in fat t i l a sfera A E c o m e d a l p u n t o A verso i l p u n t o B , se
la sfera m i n o r e Z H soltanto aiutasse a far g irare e n o n s i opponesse , s e m b r e r e b b e
che, come u n a v o l t a che i l p u n t o A è sotto i l p u n t o B , così anche i l p u n t o Z , che si
muove ins ieme al p u n t o A e ne l l o stesso t e m p o . G iacché , invece , sia si m u o v o n o i n -
sieme sia l a <sfera> Z H si o p p o n e al la <sfera> A E , tanto aggiunge m u o v e n d o s i i n -
sieme, quanto sottrae o p p o n e n d o s i , e succede che, q u a n d o i l p u n t o A è sotto i l
p u n t o B , i l p u n t o Z è sotto i l p u n t o A , c o m e era apparso d a l l ' i n i z i o . Sicché è vero
ciò che era stato propos to . R e s t a n d o d u n q u e f e r m a l a sfera A B , è ev idente c iò che è
stato esposto e [...] come, esistendo ent rambe , l a <sfera> che s i m u o v e ins i eme c o n
que l la in terna e che si o p p o n e a que l la esterna sempre neg l i stessi p u n t i h a n n o l a
('") C f r . ps. A L E X . , In Metaph., 7 0 4 , 2 4 .
(" ) In questo caso si potrebbe tuttavia giustificare pseudo-Alessandro, ammetten-do che egli abbia voluto sempHficare la spiegazione, d icendo che O movimento d i 6 E è solamente contrario a a p .
( " 0 Cfr . S I M P L . , In De caelo, 4 9 9 , 1 7 - 5 0 0 , 1 4 .
158 RITA SALIS
stessa posizione,"" né soltanto muovendosi insieme né soltanto opponendosi. Ma, se la sferazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AB si muovesse sia al contrario sia verso gli stessi punti della seconda sfe-ra AE , accadrà la stessa cosa intorno ai punti della terza sfera Z H , che si muove in-sieme alla sfera A E e allo stesso modo si oppone. Se, infatti, la sfera AB gira al con-trario e trascina con sé la sfera AE , come ad andare dal punto A al punto B , la sfera di mezzo, la stessa AE , si muoverà verso i punti contrari o verso gli stessi della sfera AB con una certa velocità verso la sfera AB , mentre verso Z H <si muoverà> nello stesso tempo, e, per il fatto di trascinare con sé la terza, fa scambiare il punto Z sot-to il punto A. Ma la terza sfera, opponendosi a sua volta, farà essere il punto Z sotto il punto A, e, avvenendo sempre queste cose, tutti i segni nella sfera Z H saranno sotto quelli della sfera AB " .
Dal confronto tra i due testi si ricava che: 1) in entrambi i casi si tratta dell'esposizione del sistema di sfere reagenti piti semplice, ma, benché Sim-plicio non dica espressamente quale sfera regge l'astro, risulta evidente nel-la sua costruzione che esso deve trovarsi sulla sfera A E e non, come dice pseudo-Alessandro, sulla sfera Z H ; 2) le tre sfere vengono denominate con le stesse lettere; 3) in pseudo-Alessandro si ritrovano delle espressioni uguali a quelle usate da Simplicio: cfr. ps. Alex., 704, 29-31 e Simpl., 499, 20-22, dove si dice che le sfere A E e Z H si muovono nello stesso tempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(laoTaxwc,, ps. Alex., 1. 29 cfr. Simpl, 1. 20) e verso gli stessi punti. Dalle successive costruzioni di Simplicio, pseudo-Alessandro ricava: 1) U concet-to che U movimento della sfera Z H è doppio rispetto a quello della sfera A E in quanto le due sfere si muovono verso gli stessi punti (ps. Alex., 704, 31-33 cfr. Simpl., 500,24-26; 2) l'ultima parte della sua spiegazione relativa al sorgere del Sole e della Luna dai diversi punti (ps. Alex., 704, 40-705, 5 cfr. Simpl., 501, 17-21).
La costruzione che pseudo-Alessandro mette in piedi è dunque un chiaro tentativo di emulare quella che si ritrova in Simplicio. Tuttavia il no-stro commentatore mostra di non avere compreso a pieno tutti i passaggi della spiegazione di Simplicio, il che denota una scarsa dimestichezza con le questioni astronomiche. Ciò è peraltro confermato dal fatto che pseudo-Alessandro non menziona i sistemi immediatamente posteriori a quello di Aristotele, vale a dire i sistemi degli eccentrici e degli epicicli, che pure do-veva avere ritrovato in Simplicio. Tale assenza nel nostro esegeta non è do-vuta al tentativo di salvare il sistema aristotelico, a differenza di quanto av-veniva in Sosigene e, attraverso di lui, in Simplicio. Nonostante, infatti, So-
{'") La lacuna nel passo rende ardua l'individuazione delle sfere in questione. L'ipotesi piii probabile sembra essere quella per cui " la <sfera> che si muove insieme con quella interna" (500, 2-3) sia la sfera AB ; la sfera interna (èvTÒg: 500, 2) dovrebbe essere la sfera Z H , infine la sfera esternazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {EKXÒC,: 500, 3) rispetto a Z H e alla quale Z H si oppone sarebbe la sfera AE .
I MOVIME NTI DE I CORPI CE LE STI 159
sigene non appoggi il sistema omocentrico, al quale rivolge esplicitamente una serie di critiche," ' egli mostra la sua devozione ad Aristotele attribuen-dogli una certa esitazione su tale teoria, che egli riteneva di rinvenire in due passi dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metaph.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 8: uno è quello in cui Aristotele, prima di esporre i siste-mi di Eudosso, Callippo e delle sfere reagenti, dice che, per dare un'idea ge-nerale della questione di quanti siano i movimenti, riporterà le opinioni di alcuni matematici, in modo da potere congetturare un numero determinato di essi, e che bisognerà affidarsi solo alle conclusioni piti rigorose di coloro che ricercano in questo campo (1073''10-17);" l'altro è quello che segue immediatamente la determinazione aristotelica del numero delle sfere, in cui viene detto che, posto che quello sia il numero delle sfere, sarà ragione-vole ammettere che tale dovrà essere anche il numero dei motori (1074''14-16)/"
La mancata menzione dei sistemi piii recenti da parte di pseudo-Ales-sandro non può certo essere interpretata in questi termini; essa è piuttosto sintomo di una scarsa conoscenza delle nozioni astronomiche.
4.2. Il problema del calcolo delle sfere
La dipendenza di pseudo-Alessandro da Simplicio si estende anche al-la sezione del suo commentario relativa alla spiegazione del noto problema del calcolo delle sfere in 1074''12-14. G ià dal II libro del De caelo sappia-mo che per Aristotele la disuguaglianza nel numero delle sfere dei pianeti e il fatto che queste non aumentassero, come vorrebbe la logica, mano a ma-no che ci si allontana dalla sfera delle stelle fisse e si procede verso il basso, costituivano un problema. Là, infatti, Aristotele pone la questione del per-ché i movimenti degli astri non vengano ad essere più complicati a mano a mano che ci si allontana dalla sfera delle stelle fisse: essendo questa dotata di un movimento assolutamente uniforme, cioè sempre uguale a se stesso e privo di qualsiasi variazione, dovrebbe invero accadere che i movimenti dei pianeti che si allontanano da essa siano via via più complicati, sino ad arri-vare al moto dei pianeti più lontani, che dovrebbe essere quello più compli-cato di tutti. Avviene, invece, che i moti del Sole e della Luna, che sono gli ultimi tra i pianeti, sono semplici ed uniformi, mentre le sfere dei pianeti in-termedi presentano un moto più complicato e irregolare. Aristotele dice che tale aporia si risolve se noi non consideriamo gli astri soltanto come cor-
(•") Cfr. ivi, 504,16-505, 27. Cfr. MORAUX2000, 343 ss. Cfr. SIMPL.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In De caelo, 505, 30-506, 3.
("') Cfr./ W, 506, 4-7. Cfr. 12, 29l'" 28-292n4.
("') Cfr./ w, 292n8 ss.
160 RITA SALIS
pi o monadi, che sono dotati di ordine ma del tutto inanimati, bensì come partecipi di attività e di vita e che lo stesso accade per il corpo umano: uno sta bene senza alcun esercizio, un altro necessita solo di brevi passeg-giate, un altro ancora ha bisogno della corsa, della lotta e degli altri esercizi fisici, ed infine ad un altro non sarà possibile raggiungere il bene, qualun-que sia la fatica alla quale questo si sottoporrà, ma apparterrà qualcosa di diverso.' ' Allo stesso modo si comportano gli astri: l'essere la cui condizio-ne è la più perfetta, vale a dire il primo Motore immobile, non ha bisogno di compiere nessuna azione per realizzare U bene;' l'essere che si trova più vi-cino di tutti gli altri alla perfezione, cioè il primo cielo, necessita soltanto di un'azione minima per giungere a conseguirla;' ' vi sono poi i pianeti che conseguono la perfezione attraverso numerosi movimenti, che si possono paragonare all'uomo, U quale compie anch'egli molteplici azioni per rag-giungere la perfezione;' " infine al Sole, alla Luna ed alla Terra si possono far corrispondere gli animali e le piante: essi compiono azioni poco nume-rose, in quanto il grado di perfezione a cui possono aspirare è minimo e de-vono perciò accontentarsi dei beni a loro accessibili.' '
In un recente articolo. Berti ha osservato a tale proposito che l'anima-zione dei corpi celesti "sembra essere per Aristotele più un'ipotesi euristica, che una certezza" ed ha rilevato che gli esseri menzionati nelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De caelo - A
Motore immobile, il primo cielo, i pianeti - hanno ciascuno un proprio fi-ne, che consiste nello stare bene, cioè nel realizzare il proprio bene median-te un'azione. A ciò Berti aggiunge che quanto Aristotele afferma in 292' 4-7, e cioè che colui che sta nella condizione migliore non necessita di alcuna azione, in quanto è lui stesso il fine, mentre l'azione richiede due cose, vale a dire il fine e ciò che è in vista del fine, autorizza a interpretare l'afferma-zione di Metaph.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 7, 1072 1-2 che il Motore immobile è un fine, nel senso che egli è fine a se stesso.' Tale esegesi risolve a mio giudizio lo spinoso problema insito nel detto passo di A 7 di come possa il fine trovarsi tra le sostanze immobili, dal momento che queste, essendo trascendenti, non possono costituire il fine raggiungibile da qualcos'altro.
Si è visto che relativamente alla Luna Aristotele adotta il sistema di Callippo senza aggiungere nessun'altra sfera, mentre ne aggiunge quattro alle cinque ammesse da Callippo per il Sole. Siccome, però, egli unisce la
('-") iw, 292''20-21: [r8TexóvTa)v...jT;Qà|ea)g Kol tw^ìg.
{' ') Cfr. ivi, 292' '24-28.
C ) Cfr./ w,292" 22-23.
(' ') Cfr.zW,292" 23-24.
(•") Cfr.zW,292»24-' ' l.
Cfr.2W,292' ' l-22.
("<•) Cfr. BE RT I 2002, 646,
(' ') Cfr. zW, 647.
I MOVIME NTI DE I CORPI CE LE STI 161
Luna e il Sole nella considerazione che questi pianeti dovrebbero avere un numero inferiore di sfere rispetto a quello degli altri, nonostante contasse nove sfere per Marte, Mercurio, Venere e per il Sole, si potrebbe pensare che Aristotele fosse in dubbio suUa aggiunta operata da CaUippo alle sfere della Luna e del Sole.' ** In A 8, infatti, subito dopo avere stabilito che il nu-mero delle sfere deve essere di cinquantacinque, Aristotele dice che, se qualcuno non volesse aggiungere alla Luna e al Sole le sfere di cui si è detto (cioè quelle aggiunte da Callippo al sistema di Eudosso), le sfere saranno in tutto quarantasette.' '' Questo passo pone seri problemi esegetici, in quanto l'operazione doveva consistere nella sottrazione, dalle cinquantacinque sfe-re ammesse da Aristotele, delle due sfere del Sole e delle due sfere della Lu-na aggiunte da Callippo, insieme alle due sfere reagenti contate da Aristote-le per il Sole:''" in tal modo, tuttavia, il risultato che si ottiene non è quaran-tasette, bensì quarantanove.
Pseudo-Alessandro " ' suggerisce tre possibili spiegazioni del calcolo delle sfere:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a) Aristotele può avere sottratto le due sfere della Luna aggiunte da Callippo più le due sfere reagenti insieme a quattro sfere della Luna, avendo scordato che, essendo la Luna l'ultimo dei pianeti, non ha bisogno che il moto delle sue sfere venga annullato; b) oppure è possibile che Aristo-tele abbia sottratto le quattro sfere reagenti del Sole più le due aggiunte al Sole e alla Luna da Callippo; c) infine, pseudo-Alessandro afferma che, come dice il peripatetico Sosigene, è meglio ritenere che l'errore sia da attri-buire ai copisti,'" piuttosto che identificare la settima e l'ottava sfera.
Questa sezione del commento di pseudo-Alessandro corrisponde let-teralmente ad una parte di gran lunga più ampia del commento di Simplicio al De caelo e Sharples ha rilevato a ragione che le parti presenti in Sim-plicio, ma assenti in pseudo-Alessandro, mostrano che Simplicio non può essere interamente dipendente da pseudo-Alessandro. Sharples aggiunge a riprova di ciò che quella che in Simplicio è un'affermazione coerente diven-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(™) Cfr. DR E Y E R 1970, 103.
(' ') Cfr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metaph. A 8,1074n2-14.
{"") In quanto, se dal Sole si eliminano le sfere aggiunte da Callippo, ne restano tre, il che implica che le sfere reagenti siano in numero di due.
("') Cfr. ps. AL E X . , In Metaph. 706, 8-15.
('" ) SH ARPLE S 2003,204, osserva giustamente che Ross (1924,393 s.) interpreta ta-le affermazione come indicante la dimenticanza da parte di Aristotele del fatto che solo due delle sfere reagenti corrispondevano alle sfere aggiunte da CaUippo, mentre le altre due dovevano contrastare 0 moto delle sfere nella teoria di Eudosso e, stranamente, pre-dilige questa alla spiegazione precedente.
('") Il quale avrebbe letto èvvéa per knxà in 1074"13. e») Cfr. S I M P L . , D e cae/ o, 503, 10-504,3.
('") Cfr. SH ARPLE S 2003,204 s. e nn. 86, 89.
162 RITA SALIS
ta sgrammaticata in pseudo-Alessandro," ' a meno che non si ammetta che in quel punto il testo di pseudo-Alessandro sia lacunoso." '
Appare sgrammaticata rispetto al testo di Simplicio "** anche la terza spiegazione che pseudo-Alessandro dà del calcolo di Aristotele, e il riferi-mento di pseudo-Alessandro all'opinione che Sosigene aveva rifiutato, cioè l'identificazione della settima sfera con l'ottava, si spiega sulla base di Sim-pl.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In De Caelo, 502 , 19-27, da dove risulta che la settima sfera è quella più interna di Saturno e che l'ottava è la prima sfera di Giove. L'affermazione, dunque, è che la settima sfera di Saturno, che è la sfera (reagente) più inter-na, si identifica con l'ottava sfera di Giove, che replica il movimento della sfera delle stelle fisse. Ma l'obiezione di Simplicio, che segue Sosigene, è che una tale operazione è stata già fatta da Aristotele, quando egli ha detto che le sfere reagenti dovevano essere tante quante sono le sfere di ciascun pianeta meno una."" Inoltre non vi sarebbe ragione che una simile soluzio-ne non si debba applicare anche ad ogni interfaccia tra la sfera reagente di un pianeta e le sfere che trasportano il pianeta successivo, per cui questo tentativo di correggere il calcolo di Aristotele, che richiedeva la sottrazione di altre due sfere, risulta essere una sovra-correzione.
5. I L PRI MAT O D E L P R I MO M O T O R E I MMO B I L E
Benché Aristotele non abbia chiarito il rapporto esistente tra il Motore immobile che è causa prima di tutto e le altre intelligenze motrici, è indub-bio che egli abbia ammesso il primato del primo Motore immobile. V i sono almeno tre luoghi in cui tale supremazia è affermata con chiarezza: in A 8, 1074''31-38, Aristotele stabilisce l'unicità del primo Motore e del cielo sulla base del seguente argomento: se ci fossero più cieli, il principio di ciascun cielo sarebbe uno per specie ma molteplice di numero. Ma che tali principi siano molteplici di numero è impossibile, in quanto ciò che è molteplice di numero ha materia. Invece l'essenza prima non ha materia, in quanto è atto. Dunque U Motore primo e immobile sarà uno nel logos e nel numero, sic-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
('«) Cfr. SIMPL.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In De caelo, 503, 21 e ps. AL E X . , In Metaph., 706, 8: fi wc,
èjtiXeXTjCTixévog in Simplicio dipende dal precedente Xéyei, mentre in pseudo-Alessan-dro non si lega a nessun costrutto grammaticale.
('") Cfr. SH ARPLE S 2003,205 s. e nn. 90 e 91.
("") fi (prjCTiv ó 2(oaiYévTi5 èniaxfiaag, pé?tTLOv elvai, q)r)ai \èyz\N TOO àgiO^iou jtaQÓga^a vozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| xi^eiv xolc, ypàcpo-uai yeYovévaL, fi xàg avxàc, É (36ó(xag KOI òySóag afpaigag itoiE Ìv: ps. AL E X . In Metaph., 706, 13-15: 2waiYévT)5 òè èitL aT riaas p é À T i o v elvai cpr|ai TOX3 àgiBnoO jtagÓQana vo^ii eiv xolc, yoàqìODai yEyovÉvai fj xàg arixàg Ip6ó[xag KOI òyòòac, acpaigag Jtoielv: SIMPL ., In De Caelo, 503, 35-504, 1.
('") Cfr. Metaph. A 8, 1073''38-1074M.
I MOVIME NTI DE I CORPI CE LE STI 163
che uno sarà anche il cielo, che è ciò che viene mosso eternamente e inces-santemente."" Inoltre, nel cap. 7 " ' Aristotele afferma che dal primo Moto-re dipendono il cielo e la natura, ed infine la parola conclusiva del libro è il famoso versozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deWIliade che asserisce che il governo di molti non è buono e che deve esserci un solo comandante.
Nel commento a A 8, pseudo-Alessandro afferma piti volte il primato del primo Motore immobile sugli altri motori immobili. In 700, 34-701, 1,
(140)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alcuni studiosi hanno ritenuto che questo passo fosse in contrasto con la dot-trina della pluralità dei motori immobili (cfr. sopra, par. 1). SH ARPL E S 2002, 8, sostiene che per riconciliare l'ammissione di una pluralità di motori immobili con 1074"31-38 bisogna ammettere che gli altri motori sono ordinati gerarchicamente: in tal modo, essi possono essere distinti anche se privi di materia e ciascuno costituisce il membro unico di specie differenti. Sharples aggiunge che si deve supporre che non esiste nessun modo in cui i motori immobili di mondi diversi potrebbero venire ordinati secondo una ge-rarchia. L L O Y D 2000, 266 s. ha suggerito che un modo di riconciliare questa parte col resto del capitolo potrebbe essere quello di ritenere che il suo argomento sia riferito al primo Motore immobile, il che sarebbe dimostrato dal rtQWxov in 1074''36 e *37: essen-do egli primo, sarà anche uno di numero e uno nelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA logos, in quanto il suo logos coinci-derà col suo essere primo. Inoltre - prosegue Lloyd - si potrebbe affermare che U senso in cui qui Aristotele intende il cielo è il primo dei tre elencati in De caelo 19, 278''9-21, cioè quello secondo il quale U cielo è il corpo naturale dell'ultima circonferenza del-l'universo, per cui Aristotele si starebbe occupando semplicemente del principio dal quale il cielo piri esterno dipende. Tuttavia, secondo Lloyd, rimarrebbero in piedi alcu-ne difficoltà: (I) il problema dell'unicità o pluralità dei cieli non riguarda la sfera delle stelle fisse, ma l'intero universo, quindi U cielo nel terzo significato di De caelo I 9. Ari-stotele ha dunque bisogno di trovare un senso in cui l'intero universo dipende da un singolo principio: tanto più, infatti, l'intero universo dipende dal primo Motore immo-bile, tanto meno gU altri motori immobili devono svolgere tale funzione, sicché sorge il problema del modo in cui, ad es., il motore immobile n. 45 dipende dal primo, se ogni cosa dipende da esso; (II) seppure Aristotele ha riferito il suo argomento sempHcemen-te al cielo più esterno e al primo Motore immobile, resta il problema del motivo per il quale non ha escluso la pluralità dei motori immobili nel resto del capitolo. E ssi, infatti, sono tutti in atto, privi di materia, ma sono 55. Lloyd suggerisce che l'affermazione in 1074''33-34 che tutto ciò che è molteplice di numero ha materia è stata interpretata dai commentatori nel senso che ciascuno dei motori immobili ha una propria specie: sicco-me la molteplicità numerica all'interno dei membri di una singola specie implica la loro materialità, se i motori immobili venissero trattati come specie separate, essi non sareb-bero soggetti al principio che ciò che è molteplice ha materia. Concordo con Sharples e Lloyd nel ritenere che, per superare la difficoltà dell'ammissione da parte di Aristotele di una pluralità di motori immobili almeno relativamente all'affermazione per cui, se ci fossero più motori, essi dovrebbero distinguersi per la materia, bisogna ammettere che questi appartengano a specie differenti. Tale differenza specifica si deve probabilmente estendere anche al Motore immobile primo, ma resta comunque inspiegato il tipo di rapporto esistente per Aristotele tra lui, che è l'ente supremo, e i motori delle sfere infe-riori.
(141) i072'^13-14.
164 RITA SALIS
egli dice che Aristotele stabilisce l'esistenza di intelligenze motrici per cia-scuno dei pianeti e, una volta determinato il numero delle sfere, mostra che tale deve essere anche il numero dei motori, in quanto ogni cosa è mossa da un motore," e aggiunge che tutte le sfere vengono ricondotte alla causa prima, la quale è un essere vivente, eterno e ottimo.
Inoltre, in 707, 12-16 pseudo-Alessandro afferma che, come il primo Motore muove il cielo, così le sfere vengono mosse dai rispettivi motori im-mobili, ognuno dei quali riceve in misura diversa perfezione e bene. Subito dopo dice che le inteUigenze motrici sono ottime, ma non allo stesso mo-do della causa prima, dalla quale esse dipendono (èzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ f ) Qt T] xa L) : le sostanze immobili si dicono ottime in quanto paragonate alle sfere che esse muovo-no, come una grandezza di dieci cubiti si dice grande non in senso assoluto, ma in quanto paragonata ad un'altra di due o di cinque cubiti; invece la cau-sa prima, che pseudo-Alessandro definisce 'intelligenza molto degna di onore'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (jtoXiJXL[j,TiTOg),"" ' è detta semplicemente ottima, come il primo cielo si dice semplicemente grande.
Commentando, infine, 1074''17 ss., in cui Aristotele mostra che ci sono tante sostanze immobili quanti sono i movimenti, pseudo-Alessandro di-ce che ogni divinità è ottima, ma non allo stesso modo della prima.
Qualcuno potrebbe pensare di utilizzare questi passi come un ulterio-re indizio in favore della tesi per cui pseudo-Alessandro è da identificare col cristiano Michele di Efeso. Sostenere ciò implicherebbe tuttavia il dovere rendere conto degli espliciti riferimenti al politeismo, contenuti nella se-conda parte del commentario, utilizzati dal Freudenthal per affermare che pseudo-Alessandro doveva essere un pagano.'" Ma né la più volte dichiara-ta supremazia del primo Motore immobile sulle altre intelligenze motrici né
C"" ) Questo è 0 principio di c ausalità, tradotto dagli Scolastici con l'asserto: " omne
quod movetur ab alio movetur" . In realtà inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metaph. A non se ne fa menzione e pseudo-
Alessandro ritiene che Aristotele rinvìi a Phys. VII 1. Cfr. ps. AL E X . , In Metaph., 688,14.
Cfr. zW, 707,16-25.
("") SH ARPLE S 2003,212 s. e n. 124 riporta che tale espressione ricorre in ps. AL E X . ,
In Metaph., 463, 34 su Z 2; 538, 29-30 su Z 17, 564, 19 su H 6, e che in 463, 35 (Z 2)
pseudo-Alessandro definisce l'intelletto primo avxoayaQòxr\c, ('bene in sé' ) , in 538, 30
lo chiama TloKvnóQì-\xog ('molto desiderato'), in 538, 35 usa ò Jto^itJiJtiVTiTog ('molto
celebrato') ed infine in 600, 26 ( 0 10) il Motore immobile è detto •ujteQOiiaLOg ovaia.
Sharples riferisce che l'uso dei termini ndkvx\,\ir\xoc„ jtoJiDriuvriTog, ariToaYaOóxrig e
tJJtegouaiog è tipico dei neoplatonici e degli autori cristiani, mentre Jto)ti)iró9T)Tog
sembra essere termine di uso distintamente cristiano, e che comunque il ricorrere di tali
espressioni in pseudo-Alessandro non è sufficiente per determinarne l' identità .
('«) Cfr. ps. AL E X ., / KMrtap/ ) . , 707, 34-35.
(" ') Questo è uno dei passi che potrebbe essere usato contro la c ristianità di pseu-
do-Alessandro. Ma valga quanto si dice sotto a tale proposito.
(™) Cfr. sopra, par. 2 e nota 36.
I MOVIME NTI DE I CORPI CE LE STI 165
i ripetuti rimandi al politeismo debbono essere considerati decisivi in ordi-ne alla soluzione del dibattito intorno all'identità dell'esegeta, perché in en-trambi i casi pseudo-Alessandro non fa altro che esplicitare quanto già af-fermato da Aristotele. Con questo non intendo negare ogni importanza alle dichiarazioni di pseudo-Alessandro in una direzione e nell'altra, ma soltan-to affermare che non si deve caricarle di un peso eccessivo.
Ritengo, dunque, che, come i riferimenti al politeismo non costituisca-no prova fondante della non cristianità di pseudo-Alessandro, allo stesso modo il fatto che l'esegeta sottolinei il primato del primo Motore immobile sulle altre intelligenze motrici non può essere considerato decisivo per la sua identificazione con Michele di Efeso.
6. CO N CL U S I O N I
All'inizio del presente lavoro, si è mostrato che il cap. 8 dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metaph. A si inserisce a pieno titolo nel contesto dell'intero libro. Ciò ha come conse-guenza che la dimostrazione dell'esistenza di una pluralità di sostanze im-mobili e la successiva determinazione del loro numero rientra nell'ambito della ricerca annunciata nel cap. 1 e sviluppata nel corso del libro.
Riguardo alla questione dell'animazione delle sfere celesti, si è visto che la posizione di pseudo-Alessandro ricalca quella del vero Alessandro nell'ammettere che le anime delle sfere sono distinte dalle sostanze immobi-li, e si è altresì evidenziato come essa non sia priva di difficoltà e contraddi-zioni.
L'ammissione esplicita del primato del Motore immobile primo da parte di pseudo-Alessandro non aggiunge nulla a quanto ritroviamo in Ari-stotele, e non contribuisce perciò a chiarire U tipo di rapporto tra il primo Motore e le altre sostanze immobili. E certo comunque che, secondo pseu-do-Alessandro, a distinguerli non sia un diverso tipo di immobilità.
La parte del commento di pseudo-Alessandro relativa alla spiegazione di una parte del sistema di Eudosso e aUa determinazione e al funzionamen-to delle sfere reagenti di Aristotele utilizza come fonte il commento di Sim-plicio al De caelo e, indirettamente, il perduto LleQi xcovzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA àveJiiTXODcrcov di Sosigene. Il confronto tra i due testi ha evidenziato una comprensione im-perfetta da parte di pseudo-Alessandro dei passi di Simplicio adoperati co-me fonte e uno scarso bagaglio di conoscenze astronomiche. La determina-zione della dipendenza di pseudo-Alessandro da Simplicio depone natural-mente a favore della tesi dell'identificazione dell'esegeta con Michele di Efeso.
Infine, a differenza di Simplicio (attraverso Sosigene), pseudo-Ales-sandro non opera nessun tipo di confronto tra il sistema aristotelico e quel-lo degli eccentrici e degli epicicli: tale mancanza non è dettata dalla volontà
166 RITA SALIS
di salvare Aristotele, quanto piuttosto dall'ignoranza dei sistemi astronomi-ci più recenti.
Il contributo di pseudo-Alessandro alla storia dell'astronomia è stato pressoché nullo: egli si è limitato a riprendere le notizie che gli occorrevano da un altro testo, e ne ha per lo più travisato i l senso nel tentativo di farne una parafrasi. In sua difesa, possiamo comunque dire che egli ha avuto i l coraggio di cercare di interpretare le spiegazioni relative ad Eudosso ed Aristotele che ritrovava in Simplicio, anziché limitarsi a riportare letteral-mente i l testo, come pure ha fatto per altre parti, che, invece, potevano ri-sultare di più facile comprensione e più semplici da interpretare. Il tentati-vo, è vero, non è riuscito, ma pseudo-Alessandro, come Aristotele, non era un astronomo.
B I B L I O G R A F I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysica commentarla, edidit H . Bonitz, Berolini 1847.
Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysica commentarla, edidit M . Hayduck, Berolini 1891.
Alexandri Aphrodisei Commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima Philo-sophia, interprete LG. Sepulveda, Venetiis 1544.
Alexandri Aphrodisei Commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima Philo-sophia, interprete LG. Sepulveda, Pariis 1536.
A C C A T T I N O P . , D O N I N I Vl^., Alessandro di Afrodisia: L'anima, Laterza, Roma-Bari 1996.
Aristotle's Metaphysics, ins Deutsche ùbertragen von Ad. Lasson, Jena 1907. Averroes TafsTr ma ba'd al-tabiat ou "Grand Commentaire de la Métaphysique
d'Aristote", ed. par M . Bouyges, 3° voli., Beyrouth, Imprimerie catholique, 1948.
BERTI E,, Aristotele: dalla dialettica alla filosofia prima, Cedam, Padova 1977. BERTI E., Da chi è amato il motore immobile? Su Aristotele, Metaph. XII 6-7,
Methexis 10 (1997), 59-82. BERTI E., Il movimento del cielo in Alessandro di Afrodisia, in A. B R A N C A C C I , La fi
losofia in età imperiale, le scuole e le tradizioni filosofiche, Bibliopolis, Napoli 2000,225-43.
BERTI E., La causalità del Motore immobile secondo Aristotele, Gregorianum 83, 4 (2002), 637-54.
BROADIE S., Que fait le premier moteur d'Aristote?, Revue philosophique de la France et de l'Éntranger, 183, (1993), 375-411.
D O N I N I Alessandro di Afrodisia e i metodi dell' esegesi filosofica, in Esegesi, parafrasi e compilazione in età tardoantica: Atti del Terzo Congresso dell'Associazione di studi tardoantichi, a cura di C. Moreschini, Napoli 1995, 107-29.
D R E Y E R J.L.E., Storia dell'astronomia da Talete a Keplero, trad. it. a cura di L . Sosio, Feltrinelli, Milano 1970.
I MOVIMENTI DEI CORl^I CELESTI 167
E B B E S E N S.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Commentators and commentanes on Aristotle's Sophistici Elenchi, Brill, Leiden 1981 (Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum, 7.3).
ELDERS L . , Aristotle's theology. A commentary in hook A of the Metaphysics, Van Gorcum, Assen 1972.
F R E U D E N T H A L J., Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexanders zur Me-taphysik des Aristoteles untersucht und iibersetzt, Abh. Berlin 1884, phil.-hist. Kl.,no 1.
G E N E Q U A N D C , Ibn Rushd's Metaphysics. A Translation with Introduction ofibn Rush's Commentary on Aristotle's Metaphysics, Book Làm, Brill, Leiden 1986.
G I L L M.L. , Aristotle on Self-Motion, in M.L . G I L L and J . G . L E N N O X eds., Self-Mo
tion from Aristotle to Newton, Princeton University Press, Princeton 1994, 15-34.
JAEGER W . , Aristotele. Prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale, ver-sione autorizzata di G . Calogero, Firenze 1960 (tit. orig.: Aristoteles. Grund-legung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923).
JAEGER W . , Aristotle: Fundamentals ofthe History of his Development, tr. R. Robin-son, Oxford, 1948^ (First German edition: Berlin 1923).
JORI A., Aristotele. Il cielo. Testo greco a fronte, Rusconi, Santarcangelo di Roma-gna 1999.
K A H N C.H. , The Prime Mover in Aristotle's Teleology, in A. G O T T H E L F , ed., Aristotle on Nature and Living Things: Studies presented to David M. Balme, Pittsburgh/Bristol 1985, 471-516. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KosMAN K., Aristotle's Prime Mover, in M . L . G I L L and J . G . L E N N O X eds., ^e//'-Mo-
tion from Aristotle to Newton, Princeton University Press, Princeton 1994, 135-153.
L L O Y D G.E.R., Metaphysics A 8, in Aristotle's Metaphysics Lambda. Symposium Aristotelicum, ed. by M . Erede and D. Charles, Clarendon Press, Oxford 2000,245-273.
LoNGO O., Aristotele. De caelo. Introduzione, testo critico, traduzione e note, San-soni, Firenze 1961.
L U N A C , Trois Etudes sur la tradition des commentaires anciens à la Métaphysique d'Aristote, Brill, Leiden 2001.
M A R T I N A., Averroes. Grand commentaire de la Métaphysique d'Aristote {TafsTr ma ba'd at-tabi'at). Livre Lam-Lambda traduit de l'arabe et annoté, "Les Belles Lettres", Paris 1984.
M E R L A N P . , Ein Simplikios-Zitat beips. Alexandros und ein Plotinus-Zitat bei Sim-plokios, Rhein. Mus. 89, (1935), 154-160.
MoRAUX P., L'Aristotelismo presso i Greci, volume II, tomo 1: Gli Aristotelici nei secoli I eli d.C, Vita e Pensiero, Milano 2000, trad. it. di: Ber Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, Zweiter band. Der Aristotelismus im I. und II. ]h. n. Chr., Walter de Gruyter, Berlin-New York 1984.
168 • RITA SALIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MoRAUX P.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Der Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, III, herausgegeben von J. Wiesner, Walter de Gruyter, Berlin-New York 2001, 423-510.
MoviA G . , Aristotele. L'anima. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione, no-te e apparati, Bompiani, Milano 2001.
P R A E C H T E R K . , recensione a CAG XXII , 2, in "Gòttingische gelehrte Anzeigen", 11,1906,882-899.
R E A L E G . , Teofrasto e la sua aporetica metafisica. Saggio di ricostruzione e di interpretazione storico-filosofica con traduzione e commento della "Metafisica", La Scuola Editrice, Brescia 1964.
R E A L E G . , Il concetto di filosofia prima e l'unità della "Metafisica" di Aristotele, con traduzione integrale e commentario della "Metafisica" di Teofrasto, Vita e Pensiero, Milano 1984''.
REALE G . , Aristotele, Metafisica. Saggio introduttivo, testo greco con traduzione a fronte e commentario. Edizione maggiore rinnovata, 3 voli., Vita e Pensiero, Milano 1993.
SALIS R . , La pluralità dei cieli e dei motori immobili secondo lo pseudo Alessandro, Edizioni A V , Cagliari 2000.
SHARPLES R.W., Alexander of Aphrodisias. Quaestiones 1.1-2.15, Duckworth, Lon-don 1992.
SHARPLES R.W., Pseudo-Alexander on Aristotle, Metaphysics A , in Alessandro di Afrodisia e la "Metafisica" di Aristotele, a cura di G . Movia, Vita e pensiero, Milano 2003, 187-218.
SHARPLES R.W., Aristotelian Theology after Aristotle, in Traditions of Theology. Studies in Hellenistic Theology, its background and aftermath, ed. by D. Ere-de and A. Laks, Brill, Leiden 2002, 1-40.
T A R A N L.,Syrianus and pseudo-Alexander' s commentary on Metaph. E - N , in P. Mo-RAUX, Aristoteles Werk und Wirkung, Walter De Gruyter, Berlin-New York 1987,215-32.
ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
IN PADOVA
35139 Padova - Via Accademia, 7 - TeL 049.655249 - Fax 049.8752696
e-mail: [email protected] - www.accademia.dei.imipd.it