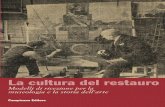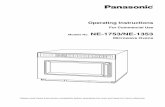Tommaso Minardi e il restauro come condizione necessaria per una storia dell'arte, 2013
Della condizione del contratto - commento artt. 1353-1361 c.c., 2009
-
Upload
universitaeuropeadiroma -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Della condizione del contratto - commento artt. 1353-1361 c.c., 2009
1919, I, 495; (14) Nuzzo, Sulla rilevabilita d’ufficio del difetto di forma convenzionale,GC 1980, I, 2239; (15) Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti,Napoli 1987; (16) Roppo, Il contratto, Milano 2000; (17) Sacco, Il contratto, Tr. Sacco,Torino 1993; (18) Scognamiglio, Sub art. 1352, Com. S.B., Bologna–Roma 1970, 449;(19) Segre, Sulla posteriore documentazione di un contratto, RDComm 1920, II, 197;(20) Venosta, La forma dei negozi preparatori e revocatori, Milano 1997; (21) Verdic-
chio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, Napoli–Roma 2002.
CAPO IIIDella condizione nel contratto
1353 Contratto condizionale
[1] Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un
singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Sommario: I. Nozione e funzione – II. L’evento dedotto in condizione – III. Tipologia– IV. Condizione e modo: differenze – V. Condizione sospensiva e condizione risolu-tiva – VI. Apponibilita – VII. Condizione unilaterale – VIII. Condizione legale – IX.Presupposizione.
I. Nozione e funzione
Con la condizione le parti subordinano l’avverarsi o il venir meno di un effetto
contrattuale ad un avvenimento futuro e incerto [Bianca C.M. (5), 509]. La dottrinageneralmente identifica con la nozione la clausola condizionale e nega che possaessere definita condizione l’evento dedotto [Maiorca (15), 273; Bianca C.M. (5),511]. Non manca, comunque, chi identifica la condizione con l’avvenimento fu-turo ed incerto al quale le parti subordinano l’efficacia o la risoluzione del con-tratto o di un singolo patto [Rescigno (18), 763; C 12.10.1993 n. 10074, FiM 1993,secondo la quale la condizione rappresenta di regola un evento esterno rispettoalla fattispecie contrattuale, non concretandosi in un fatto o atto ricompresonell’oggetto del contratto o rappresentante la funzione di esso]. Secondo altri[Falzea (13), 1], la condizionalita si articola in entrambi gli elementi sopra deli-neati, e si articola in due momenti, la clausola condizionale che fa parte delladichiarazione nel suo contenuto di volonta, e l’evento condizionante, che si col-locano fuori dalla dichiarazione, in uno spazio e in un tempo diversi. I duemomenti sarebbero, quindi, separati ma in stretto collegamento.
La collocazione della disciplina della condizione nell’alveo della disciplina gene-rale del contratto, a differenza della disciplina del Codice previgente che discipli-nava la condizione con riferimento all’obbligazione, rende chiaro che la condizio-ne attiene al contratto e non al rapporto (nel Codice previgente, invece l’art. 1156parlava di ‘‘obbligazione condizionale’’).
La condizione non riguarda la validita del contratto, ma la sua efficacia, per cui daessa dipende la produzione, il perdurare o la cessazione degli effetti del negozio
1
2
3
Art. 1353 Dei contratti in generale 702
[Barbero (3), 1097; Roppo (19), 606]. Non e attinente alla condizione il profilodell’esecuzione del contratto [Falzea (12), 228; cfr. pero, in senso diverso, Di
Majo (11), 177]. Dall’estraneita della fattispecie alla fase esecutiva discende che, incaso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non siverifichi, non e configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamen-te assunte dalle parti con il contratto, giacche l’inadempimento contrattuale everificabile solo in relazione ad un contratto efficace [C 18.3.2002 n. 3942, FiM2002, che ha affermato come, in tale ipotesi, non possa farsi luogo a risoluzioneper inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo perinadempimento dell’obbligazione prevista dall’art. 1358].
La funzione della clausola condizionale e stata individuata nel conferire rilevanzaai motivi delle parti, senza inserirli nel contenuto contrattuale [Bianca C.M. (5),510; Rescigno (18), 765; C 3.2.1993 n. 1333, FI 1993, I, 3085, nt. Lener]. Lacondizione e quindi strumento che moltiplica gli spazi dell’autonomia privata[Sacco (20), 141; Rescigno (18), 765; Roppo (19), 605]. E opinione tradizionaleche la condizione vada quindi distinta rispetto alla causa del contratto, in quantonon necessaria all’esistenza del contratto e rimessa all’atto discrezionale del con-traente [Barbero (3), 1097; in giurisprudenza, cfr. C App. Firenze 19.3.1990, AC1990, 707, nt. Bronzini]. La distinzione tra condizione ed elementi essenziali e statamessa in discussione sulla base di un’analisi concreta del contratto secondo unavisione oggettiva, che identifica gli scopi negoziali facendo riferimento alle deter-minazioni delle parti nella loro interezza [Falzea (13), 2]. Secondo quest’impo-stazione, quindi, la condizione incide sempre sulla causa del negozio [Mirabelli
(16), 232]. Piu di recente e stato osservato che anche nel Codice esiste una serie difigure nelle quali la condizione rappresenta un dato caratterizzante dal qualedipende la qualificazione della fattispecie concreta, come la vendita a prova, lavendita a rate [Costanza (9), 813] e che specialmente le promesse ex art. 1333deducono spesso in condizione la causa [Sacco (20), 140].
II. L’evento dedotto in condizione
L’evento dedotto in condizione dev’essere futuro ed incerto. Puo essere dedottoqualsiasi evento o fatto volontario (in tal caso si parla di condizione potestativa),a condizione che sia, oltre che futuro e incerto, possibile e lecito [Bianca C.M. (5),515]. Il verificarsi dell’evento futuro ed incerto dedotto dalle parti in condizioneproduce effetto automaticamente ed oggettivamente, indipendentemente cioe dauna valutazione sul comportamento della parte [C 6.9.1991 n. 9388, GI 1992, I, 1,1088]. I requisiti devono presentarsi simultaneamente all’atto della stipulazione[Maiorca (15), 284].
La futurita dell’evento indica che l’evento deve essere temporalmente successivoalla stipulazione del contratto [C 29.9.2007 n. 20591, NGCC 2008, 4, 1, 450 nt.Calice], e distingue la condizione dal presupposto [Barbero (3), 1099]. E statapero in qualche caso affermata la riferibilita della condizione ad un evento passatodi cui le parti non conoscevano l’esistenza [C 10.1.1991 n. 187; Favaro (14), 154].
4
5
6
703 Delle obbligazioni Art. 1353
L’incertezza viene generalmente intesa in senso oggettivo [C 5.1.1983 n. 9, GC1983, I, 1524, nt. Costanza; Barbero (3), 1099], ed identifica una situazione di cuinon sono noti gli sviluppi. Non manca tuttavia chi intende il requisito comesoggettivo, in quanto relativo all’opinione che le parti si erano formate sull’incer-tezza [Carresi (8), 258, nt. 140; Maiorca (15), 285]. In virtu del requisito dell’in-certezza oggettiva, si esclude che, qualunque ne sia la natura, l’evento possacostituire oggetto di obbligazione e quindi di prestazione dovuta dai contraentio da uno soltanto di essi; e con riferimento ad ogni tipo di condizione, e cioe, oltreche per le condizioni cosı dette causali, anche per quelle note come potestative emiste, in cui il verificarsi dell’evento dipende in tutto o in parte dalla volonta di(almeno) uno dei contraenti [C 5.1.1983 n. 9, cit.]. L’incertezza comporta ancheuna distinzione rispetto al termine per l’esecuzione della prestazione, che e carat-terizzato dalla certezza [C 22.3.2001 n. 4124, C 2001, 861, nt. Capilli] e cioancorche le parti, nella clausola condizionale abbiano fatto riferimento non al-l’evento in se, ma alla data del suo avverarsi, essendo anche in tal caso sufficienteil requisito dell’incertezza di questo [C 15.9.1983 n. 5575, FPad 1984, I, 214;Bianca C.M. (5), 516]. Secondo alcuni, l’incertezza dell’evento non coincide conl’improbabilita, per il semplice fatto che deve trattarsi di un’indecifrabilita prov-visoria, di modo che non puo riferirsi a situazioni considerate di difficile attuabi-lita [Maiorca (12), 285; [Costanza (9), 815]. In aderenza a detto indirizzo, ingiurisprudenza si e affermato che puo essere ottenuta la dichiarazione giudiziale diinefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione so-spensiva (o per l’avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l’esi-genza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art.1183, quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruoentro il quale l’evento previsto dalla parte si sarebbe dovuto verificare [C16.12.1991 n. 13519, GC 1992, I, 3095, nt. Coppi].
Si e affermato che i c.d. ‘‘negozi ad oggetto incerto’’, in cui dall’evento dipende ladeterminazione del bene su cui deve operare l’effetto reale o obbligatorio delnegozio, non si puo parlare di condizione, in quanto difetta il carattere dell’acci-dentalita dell’evento: per esempio, nella vendita alternativa (art. 1449) e nellavendita di cose generiche (art. 1450), la concentrazione e la specificazione costi-tuiscono un atto dovuto, per cui il carattere della incertezza non ha rilevanza;nella rimessione della determinazione all’arbitrio del terzo (art. 1349; art. 1454),l’evento della determinazione e fattore necessario al prodursi dell’effetto e quindisi e al di fuori del fenomeno condizionale [Falzea (12), 309]. La problematicadella condizione puo inoltre concorrere con quella della ‘‘determinabilita’’ dell’og-
getto negoziale ogni qualvolta venga subordinato ad un evento l’efficacia di unaparte del contenuto del negozio. Da parte di alcuni si rileva che in siffatte figure, leparti, sottoponendo a condizione soltanto alcuni elementi del contenuto negozia-le, intendano porre in forse unicamente tali elementi e non l’intero contratto, conla conseguenza che, al contrario dell’invalidita parziale ex art. 1419, dovra pre-sumersi che l’inefficacia o la risoluzione determinata dal mancato avveramentodella condizione travolgera la singola clausola e non l’intero contratto [Maiorca
(15), 289].
7
8
Art. 1353 Dei contratti in generale 704
La condizione si interseca inoltre con la figura del contratto aleatorio, quantomeno nella accezione intesa dalla dottrina maggioritaria, che fa riferimento aduna concezione ‘‘strutturale’’ dell’alea, considerando essenziale ai fini della suaconfigurabilita l’incidenza di un evento incerto sull’an o sul quantum della pre-stazione [Pino (17), 17 s.].
Secondo un orientamento, l’evento in condizione non puo identificarsi con unodegli elementi essenziali del contratto [Bianca C.M. (5), 516]. Si discute in parti-colare se possa essere dedotto come evento la prestazione contrattuale (c.d. con-dizione di adempimento): in senso negativo si pone l’orientamento tradizionale, sulrilievo che le prestazioni reciproche non possono essere dedotte in quanto lacondizione e elemento estraneo alla fattispecie negoziale ed accidentale mentregli elementi essenziali attengono all’esistenza stessa del negozio, in assenza deiquali il negozio stesso sarebbe nullo [in dottrina, Santoro Passarelli (21), 199;in giurisprudenza, C 24.6.1993 n. 7007, GI 1994, I, 1, 902, nt. Calvo; C 20.10.1972n. 3154, FiM 1972; C App. Firenze 19.3.1990, AC 1990, 707, nt. Bronzini]. Insenso positivo, e stato osservato, invece, che la condizione regola l’adempimento enon la prestazione dedotta in contratto e che andrebbe comunque ammessa per leprestazioni non essenziali [Costanza (9), 817]. Alcune sentenze hanno ammesso ladeducibilita dell’adempimento come evento condizionante, in virtu del principiodi autonomia contrattuale [C 15.11.2006 n. 24299, GI 2007, 10, 2183, nt. Boschet-
ti; C 24.11.2003 n. 17859, GC 2004, I, 935 nt. Giacobbe; C 8.8.1990 n. 8051, FiM1990; C 24.2.1983 n. 1432, FiM 1983; C 10.10.1975 n. 3229, FiM 1975]. In parti-colare, quanto alla condizione risolutiva di adempimento, e stato osservato che,stante l’effetto modificativo immediato nei confronti dei terzi della clausola con-dizionale, se ne potrebbe prospettare l’invalidita, e pertanto dovrebbe ricondursila medesima alla disciplina della clausola risolutiva espressa e del recesso, che nonsono opponibili ai terzi in assenza dei meccanismi pubblicitari [Costanza (9),817].
III. Tipologia
La condizione e causale quando il suo avverarsi o meno sfugge al controllodell’uomo e dipende da eventi naturali, potestativa (cfr. amplius art. 1355) seinvece e dipendente dal potere dell’uomo, mista se dipende da entrambi i fattori.
La condizione e positiva o negativa a seconda che implichi o meno una modificadello status quo.
La condizione e sospensiva se da essa dipende l’efficacia del contratto, risolutiva seda essa dipende la risoluzione del medesimo (cfr. amplius, infra, IV).
IV. Condizione e modo: differenze
La questione riguarda esclusivamente i negozi gratuiti, ai quali puo essere appostoun onere. Dal punto di vista concettuale, si e affermato che la differenza tracondizione e modo risiederebbe nel fatto che la prima rende incerti gli effetti tipici
9
10
11
12
13
14
705 Delle obbligazioni Art. 1353
del negozio, mentre il secondo ne aggiunge altri; inoltre, quanto alle differenze conla condizione potestativa sospensiva, solo questa avrebbe un effetto sospensivo,mentre, diversamente dalla condizione potestativa risolutiva, in caso di inadem-pimento al modo, la risoluzione non opera automaticamente ma solo ex officio econ retroattivita obbligatoria [Carnevali (7), 689]. Nella pratica, pero, risultaspesso difficile distinguere se il comportamento richiesto all’erede, al legatario oal donatario costituisca una condizione o un’obbligazione modale. A tale propo-sito, la giurisprudenza considera il problema di natura esclusivamente ermeneu-tica, che si risolve in una quaestio facti, ove cio che rileva e la sola intenzione delleparti [C 26.5.1999 n. 5122, FI 2000, I, 2289, nt. Di Ciommo (10)]. E diffusa indottrina la tesi secondo la quale, nei casi dubbi, alla luce dell’art. 1371, che imponedi interpretare la clausola nel senso meno gravoso per l’obbligato, sarebbe prefe-ribile qualificare il comportamento richiesto quale condizione, poiche il modo creaun’obbligazione in senso tecnico in capo al beneficiario della disposizione. Tutta-via, di diverso avviso e chi ritiene che in base all’art. 1371, il soggetto tutelatosarebbe il donante e non il donatario [per una summa delle diverse posizioni, v. Di
Ciommo (10), 2292 ss. In giurisprudenza v. C 11.6.2004 n. 11096, FI 2005, I, 466,nt. Marzano, NGCC 2005, I, 655, nt. Turello.
V. Condizione sospensiva e condizione risolutiva
La scelta dell’art. 1353 di richiamare sia l’effetto sospensivo che quello risolutivodella condizione differenzia il Codice attuale da quello previgente, che collocava ledue modalita in due distinte previsioni normative (artt. 1158, c. 1 e 2 e 1865).Anche per via della nuova collocazione, l’orientamento tradizionale ha conside-rato in senso unitario la condizione sospensiva e la condizione risolutiva [Barbero
(3), 1099]. Una parte della dottrina ha invece osservato che i due fenomeni sonostrutturalmente diversi: la condizione sospensiva sarebbe un fatto marginale alnegozio, perche destinato ad incidere solo sull’efficacia iniziale dell’atto, mentre lacondizione risolutiva, in quanto capace di fare venire meno l’atto, sarebbe unautonomo ed estraneo ad esso ed incidente sul diritto soggettivo e sulla sua durata[Falzea (12), 248; Rescigno (18), 763, 779]. Si e inoltre riscontrato che la disci-plina positiva contiene importanti differenze tra le due fattispecie: in particolare,l’art. 1355, che prevede la nullita della sola condizione meramente potestativasospensiva, l’art. 1356, che prevede conseguenze diverse nel caso della condizioneimpossibile, gli artt. 2655 e 2668 relativi al meccanismo di pubblicita della condi-zione; cio in connessione con una diversa funzione della condizione sospensiva erisolutiva, la prima uno strumento per definire i limiti dell’assetto contrattuale einsieme delimitare i fattori di rischio, la seconda uno strumento per regolare iconflitti che possono sorgere durante l’esecuzione [Costanza (9), 821].
In senso problematico rispetto alla concezione unitaria della condizione, si e postala questione dell’apponibilita della condizione risolutiva ai negozi traslativi. L’opi-nione della dottrina piu risalente negava l’apponibilita, sul rilievo che il regimedella condizione sarebbe incompatibile con la disciplina del trasferimento degliimmobili, ed in particolare perche lesiva rispetto ai diritti dei terzi che abbiano
15
16
Art. 1353 Dei contratti in generale 706
acquistato l’immobile sotto condizione risolutiva [Barassi (1), 91]. Si e tuttaviaritenuto che, gli effetti sfavorevoli nei confronti degli aventi causa sono previstidallo stesso Codice, che all’art. 2655 prevede l’obbligo di annotare a marginedell’atto trascritto o iscritto l’avveramento della condizione risolutiva, con cioammettendo l’apponibilita della condizione risolutiva [Rescigno (18), 763, 781].La giurisprudenza ha ammesso l’apponibilita della condizione risolutiva ai con-tratti traslativi [cfr. C 25.3.2003 n. 4346; C 15.6.1982 n. 3631, GC 1982, I, 2309; C24.4.1981 n. 2457, FiM 1981; di recente, anche C 25.3.2003 n. 4364]. Si ritengonoin genere negozi condizionati: la vendita con patto di riscatto (art. 1500), lavendita a prova (art. 1521), la vendita con riserva di proprieta (art. 1523).
Nel dubbio, secondo l’orientamento prevalente, la condizione deve essere ritenutasospensiva [Rescigno (18), 763]. In giurisprudenza si e affermato, in coerenza conle regole generali, che l’indagine del giudice del merito diretta ad accertare se uncontratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non puo essere sindacata insede di legittimita se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpre-tazione dei contratti [C 14.5.1996 n. 4483, FiM 1996; C s.l. 17.8.2000 n. 10921,FiM 2000]. Il mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando nonun’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussi-stenza dei fatti costitutivi della domanda, deve essere esaminata e verificata dalgiudice anche d’ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste dellaparte [C 15.2.2002 n. 2214, FiM 2002].
VI. Apponibilita
Tutti i negozi possono essere sottoposti a condizione, indipendentemente dal lorocontenuto, tranne quelli ai quali non e consentito apporre condizioni secondol’indicazione tassativa della legge o per volonta delle parti (c.d. actus legitimi)[C 18.11.1996 n. 10074, FiM 1996; C 20.5.1981 n. 3307, FiM 1981; in sensocontrario rispetto al principio di tassativita, Maiorca (15), 325, il quale osservache e invece necessario valutare caso per caso la configurabilita di interessi degnidi tutela giuridica, sottostanti alla condizione. In senso parzialmente diverso,Bianca C.M. (5), 510, considera i negozi familiari incompatibili, per loro natura,con la condizione]. In linea di massima si ritengono condizionabili anche i negoziunilaterali [Bianca C.M. (5), ibidem] e i meri atti giuridici, anche in virtu delrichiamo generico operato dall’art. 1324 agli atti unilaterali [Maiorca (15), ibi-dem]. Una parte della dottrina esprime pero dubbi sull’ammissibilita per gli attigiuridici [Rescigno (18), 791].
Tra i casi di non apponibilita ex lege, la proposta di rinnovazione del contratto exart. 69, c. 1, l. n. 392/1978 che richieda la rimozione del gestore di un impianto didistribuzione di carburante e la sua sostituzione previo nulla osta del locatore [TMilano 15.9.1983]. In alcuni casi, l’apposizione della condizione rende nullo l’attocome nell’accettazione e nella rinuncia all’eredita (artt. 475, c. 2, e 520) e perl’accettazione del trattario (art. 31 l. camb.). In altri casi, si applica il principio‘‘vitiatur, non viziat’’ e la condizione si considera non apposta: per es. nella girata
17
18
19
707 Delle obbligazioni Art. 1353
di titoli all’ordine (art. 2010); nel matrimonio (art. 108); nel riconoscimento delfiglio naturale (art. 257).
VII. Condizione unilaterale
Dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilita di prevedere una condizionenell’interesse esclusivo di uno dei contraenti, il quale ha cosı la facolta di rinunziarvi[anche per fatti concludenti, C 5.6.2008 n. 14938, GCM 2008, f. 6], tramutando ilcontratto da condizionato a semplice [C 17.8.1999 n. 8685, GD 1999, f. 39, 73, nt.Grisi; C 19.5.1992 n. 5975, GI 1993, I, 1, 605; C 14.12.1989 n. 5621, FiM 1989; C8.5.1976 n. 1621, FiM 1976]. La costruzione della condizione unilaterale, frequen-temente utilizzata nell’area dei trasferimenti immobiliari condizionati al rilasciodelle concessioni edilizie, e stata sottoposta a critica sulla base del fatto che, ingenere l’ordinamento non consente al titolare dell’interesse sotteso alla regola, discegliere se invocare o meno l’evento cui e subordinato l’effetto giuridico, comeper esempio accade nel caso del difetto di forma della donazione [Sacco (20), 817].E discussa la natura della figura: la tesi tradizionale ritiene che l’unilateralita noninfluisca sulla struttura del contratto – che si presenterebbe come un ordinarionegozio condizionato – e rilevi solo nella fase successiva al perfezionamento,sicche la dichiarazione di rinunzia dell’interessato costituirebbe essa stessa condi-zione di efficacia del negozio (c.d. ‘‘doppio condizionamento’’) [C 23.3.1991 n.3185, GC 1992, 1, 507, nt. Bozza]. Una tesi piu recente, anche allo scopo dipreservare il contraente che subisce la condizione, proprio in quanto l’efficaciadell’atto e legata alla scelta discrezionale dell’interessato, ha ritenuto che il con-tratto sarebbe efficace solo a seguito della dichiarazione di quest’ultimo di avva-lersi del contratto o di rinunziarvi, individuando due negozi, uno condizionato edun’opzione [C 30.10.1992 n. 11816, CG 1993, 180, nt. Carbone; T Nocera Infe-riore 20.4.2005, GM 2006, 36, nt. D’Angelo; Villani (22), 573].
In coerenza con le due tesi sopra menzionate, si snodano due diverse opinioni circala disciplina delle modalita dell’esercizio della rinuncia da parte del titolare del-l’interesse protetto dalla condizione, problema centrale della condizione unilate-rale. La giurisprudenza, seguendo la tesi del ‘‘doppio condizionamento’’ ha affer-mato che la rinuncia puo avere luogo sia prima o dopo l’avverarsi della condizione[C 23.3.1991 n. 3185, GI 1992, I, 1, 908, nt. Musy; C 13.11.1970 n. 2396] e chepossa essere manifestata tacitamente [C 17.8.1999 n. 8685, GD 1999, f. 39, 73, nt.Grisi; C 19.5.1992 n. 5975, GI 1993, I, 1, 605], anche nei contratti formali [C19.4.1982 n. 2412]. In senso parzialmente diverso, pur ricostruendo la figuranell’ambito della condizione, altri, hanno invece ritenuto che ai fini dell’opponi-bilita ai terzi sia necessario che il potere di rinuncia sia espressamente previsto (v. §22) e che lo stesso potere venga esercitato durante solo la fase di pendenza [Car-
bone P.L. (6), 283]. In aderenza alla costruzione del patto di opzione condizio-nato, invece, la dichiarazione del contraente interessato e una manifestazione divolonta necessaria per dare vita al vincolo, che deve rispettare i requisiti di formaprevisti per il contratto e deve essere esercitata entro un termine ragionevole, che,nel caso, puo essere fissato dal giudice, su istanza del soggetto ‘‘non favorito’’
20
21
Art. 1353 Dei contratti in generale 708
[Villani (22), 583; C 30.10.1982 n. 11816]. In senso parzialmente diverso rispettoa quest’ultima impostazione, si e affermato che l’inquadramento nell’ambito del-l’opzione non avrebbe ragion d’essere nel caso di condizione unilaterale risolutiva,in quanto la dichiarazione dell’interessato di non avvalersi della condizione po-trebbe leggersi come mera rinuncia al recesso, con relativa applicazione delladisciplina di cui all’art. 1373 [Costanza (9), 828].
Frequente nella giurisprudenza e l’orientamento tendente a limitare l’applicazionedella figura in questione, attraverso la richiesta di specifici elementi probatori.Secondo l’orientamento tradizionale, vige un principio di presunzione della bila-teralita dell’interesse e la figura puo ravvisarsi solo in presenza di una espressaprevisione contrattuale, giammai in base al procedimento interpretativo [C23.9.2004 n. 19146, C 2004, 449, nt. Mezzopane; C 12.6.2000 n. 7973, FiM2000; C 30.10.1992 n. 11816, CG 1993, 180, nt. Carbone]. Una parte della giuri-sprudenza, pero, afferma che l’unilateralita della condizione puo essere ricavataimplicitamente anche da una serie di elementi che nel loro complesso inducano aritenere che l’altra parte non abbia alcun interesse [C 23.9.2004 n. 19146, C 2005,449, nt. Mezzopane; C 17.8.1999 n. 8685, GD 1999, fasc. 39, 73, nt. Grisi].L’unilateralita, tuttavia, non puo desumersi dal semplice fatto che una sola delleparti puo essere interessata al verificarsi o meno dell’evento dedotto [C App.Torino 19.5.1999, GPiem 2000, 117, nt. Balzi].
Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che la pattuizione che fa dipenderedal comportamento – adempiente o meno – della parte l’effetto risolutivo delnegozio non configura una condizione meramente potestativa ed e compatibilecon la previsione di una penale (e non viene quindi configurata come clausolarisolutiva espressa), allorche le parti stabiliscano che la condizione sia posta nel-l’esclusivo interesse di uno dei contraenti (in via espressa o implicitamente), cosic-che la parte nel cui interesse e posta la condizione ha facolta di rinunziarvi (fatti-specie relativa ad una clausola che prevedeva, nell’interesse esclusivo del vitalizia-to, la risoluzione del contratto di rendita vitalizia, nel caso di mancato pagamentoda parte del vitalizzante, di due rate [C 15.11.2006, FiM 2006].
VIII. Condizione legale
Nonostante ilCodicedisciplini solo la condictio facti, dottrina e giurisprudenzahannosempre trattato anche la condizione legale, alla quale e subordinata l’efficacia delnegozio per previsione legislativa. Esempi di condizione legale sono previsti anchedal Codice, come la dichiarazione del creditore nell’art. 1237, c. 2, in tema di succes-sione del debito e l’adesione del terzo, nell’art. 1411, c. 3, in tema di contratto a favoredi terzo [C 4.2.1988 n. 1136, FiM 1988]. Dovrebbero considerarsi estranee alla no-zione quelle norme che delineano come un fenomeno condizionale eventi collegatidirettamente alla manifestazione di volonta delle parti, riconducibili alla condizionevolontaria come nel caso della sostituzione in materia testamentaria (artt. 688 ss.)[Costanza (9), 879]. Sul tema dell’autonomia logica e disciplinare rispetto alla con-dizione volontaria, la dottrina si e divisa: taluni hanno ricondotto le due figure ad un
22
23
24
709 Delle obbligazioni Art. 1353
sologenus [Falzea (13), 9]; altri hannodifferenziato le due figure sul piano costitutivoe disciplinare [Barbero (2), 126].
Sul piano applicativo, la dottrina ritiene applicabile in linea di massima la disci-plina della condizione volontaria [Bianca C.M. (5), 533], esclusi i principi dellaretroattivita (art. 1360) e della finzione di avveramento (art. 1359) [Falzea (13), 9;C 10.3.1992 n. 2875, FiM 1992]. La giurisprudenza ha piu volte affermato che lacondicio juris e presupposto della validita dell’atto e non dell’efficacia [C 30.5.1997n. 4861, CT 1997, 2670; C 12.2.1988 n. 1508, FI 1998, I, 1126, nt. Bellantuono; TNapoli 5.4.1984, DGiur 1984, 570]. L’assunto non e pero pacifico in giurispruden-za [cfr. C 12.6.2006, FiM 2006, sulla registrazione del contratto di locazione aisensi dell’art. 1, c. 346, l. n. 311/2004; C 30.5.1997 n. 4861, CT 1997, 2670,sull’autorizzazione governativa all’acquisto degli immobili da parte degli entinon riconosciuti; cfr. inoltre, in generale, C 21.5.1997 n. 4514]. Secondo T Avez-zano 10.5.1994, PQM 1994, f. 2, 52, va considerata una fattispecie di condicio jurisquella prevista dalla clausola contrattuale con la quale la validita della promessadi compravendita di un terreno viene subordinata alla condizione che la zonaottenga il riconoscimento di edificabilita dal piano regolatore in itinere. Le partipossono assumere l’evento consistente nella ‘‘condicio juris’’ alla stessa stregua diuna ‘‘condicio facti’’, assoggettandola ad una regolamentazione patrizia, senzatuttavia poterla superare o eliminare in virtu di successivi accordi o per inerzia[C 9.2.2006, FiM 2006]. Si e, infine, precisato che la registrazione del contratto dilocazione imposta dall’art. 1, comma 346, l. 30 dicembre 2004 n. 311 (c.d. finan-ziaria 2005) non costituisce requisito di validita del contratto, bensı mera condiciojuris di efficacia dello stesso, che puo intervenire ed avverarsi in momento succes-sivo alla conclusione del negozio, inducendo l’efficacia di esso con effetto ex tuncai sensi dell’art. 1360, comma 1, c.c. [T Modena 12.6.2006, ALC 2007, 1, 62].
IX. Presupposizione
Da tenere distinta rispetto alla condizione e la ‘‘presupposizione’’, istituto di estrazionepandettistica, che ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto(passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella for-mazione del loro consenso – pur inmancanza di un espresso riferimento ad essa nelleclausole contrattuali – come presupposto condizionante il negozio. La presupposi-zione, quindi, a differenza della condizione, non e esplicitatanel contratto. Secondo lagiurisprudenza [C 28.1.1995 n. 1040, FiM 1995] e parte della dottrina tale figurasarebbe stata introdotta nel nostro ordinamento come in via generale con l’art.1467 [Bianca C.M. (5), 436], e pertanto non potrebbe ritenersi una semplice ‘‘condi-zione non sviluppata’’, irrilevante in quanto motivo non inserito nel contratto, comeaffermato invece da qualche Autore [Santoro Passarelli (21), 194; cfr. Bessone–D’Angelo (4), 327]. Secondo la giurisprudenza, l’accertamento della presupposizio-ne deve essere condotto sul piano della volonta negoziale con particolare riferimentoalla funzione adempiuta dal singolo contratto e, trattandosi di accertamento di fatto,rimessoal giudice delmerito, non e censurabile in sededi legittimita [C11.2.2006,FiM2006; C 9.12.2002 n. 17534, FiM 2002].
25
26
Art. 1353 Dei contratti in generale 710
Bibliografia: (1) Barassi, Proprieta e comproprieta, Milano 1951; (2) Barbero, Con-tributo alla teoria della condizione, Milano 1937; (3) Id., Condizione, (diritto civile),NsDI, II, Torino 1959, 1096; (4) Bessone–D’Angelo, Presupposizione, EdD, XXXV,Milano 1986, 326; (5) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (6)Carbone P.L., I tanti volti della c.d. condizione unilaterale, CI 2002, 240; (7) Carne-
vali, Condizione, EdD, XXVI, Milano 1976, 686; (8) Carresi, Il contratto, Tr. Cicu–Messineo, XXI, II, t. 1, Milano 1987; (9) Costanza, I contratti in generale, a cura diGabrielli, II, Torino 1999, 811; (10) Di Ciommo, La donazione tra modus, condizionerisolutiva e «trust», FI 2000, I, 2290; (11) Di Majo, L’esecuzione del contratto, Milano1967; (12) Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano 1941; (13)Id., Condizione, (diritto civile), EGT, VII, t. 1, Roma 1988; (14) Favaro, L’art. 1359c.c. e la cosiddetta finzione di avveramento della condizione, FPad 1980, 154; (15)Maiorca, Condizione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (16) Mirabelli, Dei contrattiin generale, Com. UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232; (17) Pino, Il contratto aleatorio,Padova 1959; (18) Rescigno, Condizione (diritto vigente), EdD, VIII, Milano 1961,763; (19) Roppo, Il contratto, Tr. Iudica–Zatti, Milano 2001; (20) Sacco, Il contratto,Tr. Sacco, II, Torino 1993; (21) Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,Napoli 1977; (22) Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, RDC 1975, I,573.
1354 Condizioni illecite o impossibili
[1] E nullo il contratto al quale e apposta una condizione, sospensiva o risolutiva,
contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
[2] La condizione impossibile rende nullo il contratto se e sospensiva; se e riso-
lutiva, si ha come non apposta.
[3] Se la condizione illecita o impossibile e apposta a un patto singolo del con-
tratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi pre-
cedenti, fermo quanto e disposto dall’articolo 1419.
Sommario: I. Condizione illecita – II. Condizione impossibile.
I. Condizione illecita
Secondo l’opinione prevalente, l’illiceita (cfr. anche art. 1343) della condizione erilevante solo se riferita alla clausola e non all’evento, per cui la clausola condizio-nale potrebbe essere valida se, nonostante l’illiceita dell’evento dedotto, essa nonporti alla realizzazione di una finalita riprovevole [Sacco (6), 150; Maiorca (3),295]. Cio in quanto l’illiceita si realizzerebbe in relazione all’atteggiarsi del mec-canismo condizionale e non all’evento in se. In senso critico rispetto a quest’im-postazione, si e osservato che, in coerenza con la disciplina del motivo illecito (cfr.art. 1345), andrebbe pronunciata l’illiceita anche qualora il solo evento fosseillecito, ove questo esprimesse un interesse delle parti [Costanza (2), 833]. Secon-do Maiorca (3), 296, in tali casi, l’illiceita della condizione si rifletterebbe semprein una forma di rilevanza dei motivi illeciti.
Secondo l’orientamento prevalente, la valutazione dell’illiceita e fatta in relazionealla contrarieta alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, in
1
2
711 Delle obbligazioni Art. 1354
base ad un’applicazione pedissequa dell’art. 1343, che prevede tali criteri per lavalutazione dell’illiceita della causa, e cio proprio in virtu della sostanziale essen-zialita dell’evento condizionale [Mirabelli (4), 233] (cfr. art. 1353, I, 4). SecondoMaiorca (3), 296, invece, nei casi di contrarieta all’ordine pubblico ed al buoncostume, la valutazione dovra tenere conto della differenza strutturale tra causa econdizione.
L’illiceita della condizione va valutata al momento della stipulazione [Maiorca (3),ibidem].
II. Condizione impossibile
Il c. 2 dell’articolo in commento differenzia l’ipotesi dell’impossibilita della condi-
zione sospensiva da quella della condizione risolutiva, prevedendo, nel primo caso,la nullita del contratto, nel secondo che la condizione si considera non apposta.Secondo Bianca C.M. (1), 518, piu che di nullita dovrebbe parlarsi di inefficacia,atteso che la nullita non si concilia con la recuperabilita del contratto per volontadelle parti o della parte interessata, propria della condizione unilaterale. La ra-gione del differente trattamento nei due casi e stata spiegata evidenziando che chivuole un effetto condizionandolo ad un evento impossibile non esprimerebbe unavolonta seria, mentre nel caso della condizione risolutiva, l’impossibilita del veri-ficarsi dell’evento risolutivo, indicherebbe una volonta di definitiva stabilita deglieffetti [Costanza (2), 834; in senso critico, invece, su questa ricostruzione, Resci-
gno (5), 791].
Come per l’illiceita, anche per l’impossibilita si e posto il problema dell’attribui-bilita all’evento dedotto o alla clausola condizionale. L’opinione maggioritaria ri-ferisce l’impossibilita all’evento [Maiorca (3), 294; Mirabelli (4), 231; Rescigno
(5), 791; in giurisprudenza, cfr. C 9.2.1995 n. 1453, FiM 1995]. In senso diverso, sie osservato che i requisiti dell’evento condizionante sono gia previsti dall’art. 1353e che la norma in commento non avrebbe utilita ove riferita al solo caso di eventoimpossibile, in quanto il contratto in tale ipotesi sarebbe gia di per se privo dieffetti. L’impossibilita andrebbe quindi riferita alla clausola condizionante [Co-
stanza (2), 835].
L’impossibilita prevista dall’art. 1354 e quella originaria e quindi riferita al mo-
mento dell’apposizione al negozio [C 11.7.1964 n. 1828, FiM 1964]; mentre in casodi impossibilita sopravvenuta alla stipulazione, la condizione si considera sempli-cemente non avvenuta [C 5.1.1993 n. 63, C 1993, 147, nt. Radice]. Ne consegueche, in caso di impossibilita sopravvenuta, il debitore che e obbligato ad effettuarela sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamentesciolto dalla obbligazione dal verificarsi dell’evento dedotto in condizione [C29.1.2003 n. 1288].
Bibliografia: (1) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (2) Costan-
za, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999; (3) Maiorca, Condi-zione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (4) Mirabelli, Dei contratti in generale, Com.
3
4
5
6
Art. 1354 Dei contratti in generale 712
UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232; (5) Rescigno, Condizione (diritto vigente), EdD,VIII, Milano 1961, 763; (6) Sacco, Il contratto, Tr. Sacco, II, Torino 1993.
1355 Condizione meramente potestativa
[1] E nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a
una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta dell’alienante o,
rispettivamente, da quella del debitore.
Sommario: I. Nozione di mera potestativita e differenze rispetto alla condizione pote-stativa semplice – II. Ambito di applicazione: alienante e debitore, acquirente e credi-tore – III. Condizione risolutiva meramente potestativa.
I. Nozione di mera potestativita e differenze rispetto alla condizione potestativa
semplice
Dottrina e giurisprudenza distinguono la condizione meramente potestativa dallacondizione potestativa semplice (cfr. art. 1353, III) ed individuano nella sanzioneprevista dalla norma in commento il segno di un disvalore dell’ordinamento neiconfronti delle determinazioni arbitrarie del debitore, identificando nel concettodi mera potestativita ‘‘la negazione stessa di ogni vincolo’’ [C 23.4.1955 n. 1521;Barbero (1), 1101]. Nella pratica, la distinzione rispetto alla condizione potesta-tiva semplice non e agevole.
Secondo una prima ricostruzione, prevalente in dottrina ed incontrastata in giuri-sprudenza, che assegna alla norma una portata minimale, con la fattispecie previ-sta dall’art. 1355, non si intende sanzionare la liberta concessa alla parte nelcompiere un apprezzamento unilaterale, che e ammessa, bensı l’assenza di uninteresse rilevante nell’apprezzamento. Pertanto si deve avere riguardo all’esamedell’assetto di interessi sottostanti alla scelta, per cui la condizione meramentepotestativa e la conseguente sanzione di nullita di cui all’art. 1355 non sussistonoquando l’impegno che la parte si assume, non e rimesso al suo mero arbitrio ma e
collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativacapace di soddisfare anche il proprio interesse [C 21.5.2007 n. 11774, FiM 2007; C15.11.2006 n. 24299, FiM 2006; C 20.6.2000 n. 8390, FiM 2000; C 24.2.1983 n.1432, FiM 1983; C 25.1.1983 n. 702, FiM 1983; C 8.3.1974 n. 624, FiM 1974]. Inaltri termini, il discrimen tra le due ipotesi e dato dal fatto che, a differenza che nelcaso previsto dall’art. 1355, nella condizione potestativa semplice, la scelta tra le
due opzioni non e indifferente per la parte in questione, alla stregua di un mero sivoluero, non potendosi dubitare della piena funzionabilita della pattuizione aduno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e percio oggetto del me-desimo [C 21.7.2000 n. 9587]. In dottrina, per la decisivita dell’esame degli inte-ressi sottesi alla scelta [Rescigno (11), 795; Ferrara (7), 565, e da ultimo, Stan-
zione (13), 732]. In base a quest’indirizzo, si e ritenuto che non e configurabilecome condizione meramente potestativa: a) la clausola che condiziona il sorgeredel diritto al compenso da parte del professionista incaricato di un progetto,all’ottenimento di un finanziamento per un’opera progettata [C 21.7.2000 n.
1
2
713 Delle obbligazioni Art. 1355
9587, cit.]; b) la clausola con cui una parte si impegnava a versare all’altra la metadel prezzo ricavando dalla eventuale vendita di una casa ‘‘qualora avesse alienatola casa’’ stessa [C 25.1.1983 n. 702, cit.]; c) la clausola di un contratto di locazionecon la quale il conduttore veniva autorizzato a sublocare, purche a persona ‘‘benvista’’ dal locatore [C 1.10.1970 n. 1757, FiM 1970]; d) la clausola della polizzaassicurativa secondo cui l’assicurato, in caso di sinistro, aveva diritto di ottenereun acconto dell’indennizzo a condizione che non fosse insorta alcuna contesta-zione sull’indennizzabilita e che l’indennizzo fosse stato prevedibile nell’importodi almeno duecento milioni di lire [C 16.1.2006 n. 728, FiM 2006]; e) la clausolacon cui le parti prevedono l’adempimento o l’inadempimento di una di esse qualeevento condizionante l’efficacia del contratto sia in senso sospensivo che in sensorisolutivo [C 24.11.2003 n. 17859, C 2004, 667, nt. Besozzi, GC 2004, I, 93, nt.Giacobbe E.].
Esistono, pero, Autori che tendono ad allargare la nozione di mera potestativita edil campo di applicazione dell’art. 1355 a danno della nozione di potestativitasemplice. Secondo un’opinione, cio che conta, ai fini della configurabilita dellacondizione meramente potestativa, sarebbe la sola sussistenza di un potere deci-sionale della parte sull’efficacia del contratto, restando esclusa un’indagine sugliinteressi sottesi [Bianca C.M. (2), 521]. Di diverso avviso rispetto alla tesi preva-lente, e pure chi osserva che, ove si escludesse la mera potestativita per la presenzadi un interesse apprezzabile, si finirebbe per disapplicare di fatto l’art. 1355, inquanto un interesse e sempre ravvisabile in astratto [Carresi (3), 270]. Si osserva,altresı, che potra escludersi la mera potestativita e quindi la nullita, solo nel casoin cui l’atto di volonta dedotto in condizione sara vincolato alla valutazione di unpiano d’interessi diverso da quello del negozio [Pelosi (10), 284], oppure, secondoun’altra ipotesi ancora piu estensiva, nel caso in cui l’atto di volonta sia portatoredi un interesse specifico ‘‘degno di tutela’’ [Maiorca (9), 300].
Si e osservato che, in molti casi in cui si conferisce ad una delle parti l’arbitrioassoluto dell’attuazione del trasferimento, in realta si costituisce un vincolo preli-
minare assimilabile al contratto preliminare unilaterale o all’opzione, ma diversostrutturalmente, in quanto si tratta di un negozio gia perfetto, per cui, nel caso dicondizione meramente potestativa, la manifestazione di volonta non rileva ai finidella corretta formazione dell’atto, che va invece valutata attraverso l’esame dellaclausola condizionale [Costanza (4), 70; in senso critico riguardo all’accostamen-to tra condizione si volam e patto d’opzione, Gabrielli (8), 1315, n. 36].
II. Ambito di applicazione: alienante e debitore, acquirente e creditore
L’art. 1355 sanziona solo la nullita dell’alienazione di un diritto rimessa alla meravolonta dell’alienante e dell’assunzione di un obbligo rimessa alla volonta deldebitore; se ne e dedotto che la disposizione non puo applicarsi ai diversi casidell’alienazione e dell’assunzione dell’obbligazione dipendenti rispettivamentedalla volonta dell’acquirente e da quella del creditore [Sacco (12), 152]. Devequindi considerarsi valida, nella compravendita di beni mobili regolata, quanto
3
4
5
Art. 1355 Dei contratti in generale 714
al pagamento del prezzo, con apertura di credito documentario, l’obbligazione dipagamento assunta dalla banca, sottoposta alla condizione sospensiva della pre-sentazione alla banca stessa entro un certo tempo dei documenti relativi allavendita da parte del beneficiario [C 29.1.2003 n. 1288]. Secondo un orientamento,la nullita sarebbe applicabile solo ai casi di contratti con una sola obbligazione enon in quelli sinallagmatici, in quanto in questi ultimi la parte ha sempre uninteresse a ricevere la controprestazione [De Martini (6), 167]. Trattasi pero diorientamento disatteso dalla giurisprudenza, che applica la norma anche ai con-tratti corrispettivi [cfr. C 20.6.1990 n. 6210, GC 1990, I, 2523, che ha ravvisato lanullita della clausola con cui si imponga alla parte alla quale e indirizzata laproposta, di non esprimere prima di un certo momento la propria dichiarazionedi volonta contrattuale, eventualmente adesiva, cosı da determinare la conclusionedel contratto]. La giurisprudenza tende ad estendere la portata dell’art. 1355: C8.9.1988 n. 5099, FiM 1988, ha ritenuto che la nullita trovi applicazione anche nelcaso in cui l’efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipendaunicamente dalla mera volonta della parte che ne tragga il vantaggio principale(fattispecie di nullita di un contratto di collaborazione professionale che prevede-va l’obbligo per il lavoratore di proseguire la collaborazione dopo il periodo ditirocinio, non predeterminato dalle parti, per una durata non inferiore a taleperiodo, con l’esplicita clausola penale secondo cui in caso di inadempimentoavrebbe dovuto rimborsare al datore di lavoro quanto percepito durante il tiro-cinio stesso).
III. Condizione risolutiva meramente potestativa
Anche in base alla lettera della disposizione in commento, che sanziona solo lacondizione sospensiva e non quella risolutiva, dottrina e giurisprudenza perlopiu
concordano nell’escludere la nullita della condizione meramente potestativa risoluti-
va cfr. Rescigno (11), 796; Stanzione (15), 328; [in giurisprudenza, C 15.9.1999 n.9840, FiM 1999; C 25.1.1992 n. 812, FiM 1992, con riferimento al patto di riscattonella compravendita; C 25.1.1992 n. 812, cit., con riferimento alla clausola cheaccordi ad entrambi i contraenti il potere di far venir meno gli effetti del contratto;C 16.11.1985 n. 5631, FiM 1985]. La validita delle condizioni risolutive meramentepotestative e stata peraltro spiegata in base ad un principio di meritevolezza degliinteressi sottesi alla potestativita, Stanzione (14), 101, sulla base del principio diautonomia negoziale, Rescigno (11), 763, 794. Taluni riconducono invece la con-dizione meramente potestativa risolutiva all’istituto del recesso, nei limiti della cuidisciplina sarebbe ammissibile [Maiorca (9), 300; cfr., inoltre Costanza (5), 845].
Bibliografia: (1) Barbero, Condizione (diritto civile), NsDI, II, Torino 1959, 1096; (2)Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (3) Carresi, Il contratto, Tr.Cicu–Messineo, XXI, II, t. 1, Milano 1987; (4) Costanza, Artt. 1353–1361, Dellacondizione nel contratto, Com. S.B., Bologna–Roma 1997; (5) Id., I contratti in gene-rale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999, 811; (6) De Martini, Profili della vendita econtratto estimatorio, Milano 1950; (7) Ferrara, La condizione potestativa, RDComm1931, 565; (8) Gabrielli, La riserva di gradimento nei contratti, RTDPC 1970, 1274; (9)Maiorca, Condizione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (10) Pelosi, La proprietarisolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano 1975, 284; (11) Rescigno, Con-
6
715 Delle obbligazioni Art. 1355
dizione (diritto vigente), EdD, VIII, Milano 1961, 763; (12) Sacco, Il contratto, Tr.Sacco, II, Torino 1993; (13) Stanzione, Condizioni meramente potestative e situazionicreditorie, RaDC 1981, 732; (14) Id., Situazioni creditorie meramente potestative, Na-poli–Camerino 1982, 101; (15) Id., Condizione potestativa e finzione di avveramento,RaDC 1992, 328.
1356 Pendenza della condizione
[1] In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto puo compiere
atti conservativi.
[2] L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo, in pendenza di
questa, esercitarlo, ma l’altro contraente puo compiere atti conservativi.
Sommario: I. Nozione di pendenza – II. Aspettativa – III. Termine di pendenza – IV.Atti conservativi.
I. Nozione di pendenza
La pendenza e la fase intermedia del fenomeno condizionale, che si svolge tra ilmomento iniziale dell’apposizione della clausola condizionale e il momento finaledell’avveramento o della deficienza dell’evento condizionante, e corrisponde alperiodo in cui, pur essendo il negozio esistente ed impegnativo, non esplica i suoieffetti finali o, pur attuato, non ha raggiunto la piena permanenza degli effetti[Mirabelli (4), 239].
II. Aspettativa
L’aspettativa e la pretesa alla conservazione degli effetti eventuali derivanti dallafattispecie condizionale. In particolare, l’acquirente di un diritto sotto condizionesospensiva, oltre a poter compiere atti conservativi, puo opporre all’alienante edai terzi il titolo di acquisto, salve le regole di opponibilita [Bianca C.M. (1), 523].L’aspettativa non e, secondo i piu, un diritto bensı una posizione di attesa giuri-dicamente tutelata [Santoro Passarelli (6), 75], secondo alcuni e invece un di-ritto soggettivo trasmissibile [Falzea (3), 5]. All’aspettativa corrisponde, dall’al-tra parte una situazione di soggezione per cui grava sull’altra parte l’obbligo dinon influire negativamente sul verificarsi dell’evento condizionale [Mirabelli (4),240].
III. Termine di pendenza
La fattispecie condizionale puo anche non prevedere un termine di pendenza,decorso il quale, cessa l’efficacia della condizione. In giurisprudenza si e affermatoche puo essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contrattostesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l’avvera-mento della condizione risolutiva) senza che ricorra l’esigenza della previa fissa-zione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183, quando lo stessogiudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’eventoprevisto dalla parte si sarebbe dovuto verificare [C 27.12.1994 n. 11195, FiM 1994;
1
2
3
Art. 1356 Dei contratti in generale 716
C 16.12.1991 n. 13519, GC 1992, I, 3095, nt. Coppi]. Alcune sentenze, pero, hannoammesso la fissazione giudiziale del termine, ad istanza di parte, nel caso che iltermine stesso sia necessario in base alla natura del contratto [C 30.3.1951 n. 733,FiM 1942–1953, II, voce Obbligazioni e contratti, 2523].
IV. Atti conservativi
Gli atti conservativi cui fa riferimento la disposizione in commento sono: a) ilsequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.); b) il sequestro conservativo (art. 671c.p.c., art. 2905); c) cauzione (art. 671 c.p.c.); d) l’apposizione di sigilli (art. 752c.p.c.) nonche le misure cautelari atipiche. Il creditore sotto condizione ha anchela possibilita di esperire l’azione surrogatoria o l’azione revocatoria [Costanza
(2), 851; Natoli (5), 462]. Le norme processuali consentono inoltre l’interventodel creditore sub condicione nelle procedure esecutive immobiliari (art. 653 c.p.c.),ma non in quelle mobiliari. La legge fallimentare permette l’ammissione al passivodel credito condizionato (art. 55 l. fall.).
Bibliografia: (1) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (2) Costan-
za, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999, 811; (3) Falzea,Condizione (diritto civile), EGT, Roma 1988, VII, 1; (4) Mirabelli, Dei contratti ingenerale, Com. UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232; (5) Natoli, Della condizione nelcontratto, Libro delle obbligazioni, Com. D’Amelio–Finzi, I, Firenze 1948, 462; (6)Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1977.
1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
[1] Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo disporne
in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla
stessa condizione.
La tutela dell’aspettativa dell’altro contraente si concretizza nel momento in cui siavvera la condizione, attraverso l’ordinaria disciplina dell’opponibilita del con-tratto (ad es. trascrizione) [Bianca C.M. (1), 523]. Nonostante la formulazioneincerta della disposizione in commento, si ritiene che essa attribuisca la titolaritadel potere di disposizione sia all’acquirente di un diritto sotto condizione sospen-siva, sia all’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva [Maiorca (3), 308;cosı anche, T S.M. Capua Vetere 19.9.2000, BBTC 2001, I, 583, nt. Tardivo].Altri hanno affermato che tale regola riguarda tutte le posizioni giuridiche col-legate con il negozio condizionato, compresa quella dell’alienante che si avvan-taggia della condizione risolutiva, tant’e che l’art. 2655 prevede l’efficacia delleiscrizioni e trascrizioni gia compiute nei confronti di quest’ultimo [Mirabelli (4),245]. La seconda parte della disposizione regola l’aspetto dell’opponibilita ai terzidella condizione, prevedendo l’efficacia reale del meccanismo condizionale che,nel caso di condizione risolutiva, comporta la caducazione di tutte le vicendetraslative ricollegate alla fattispecie condizionata. La norma costituirebbe, secon-do alcuni, fondamento giuridico della deducibilita in condizione del divieto di
alienazione [Carbone P. (2), 542].
4
1
717 Delle obbligazioni Art. 1357
Bibliografia: (1) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (2) Carbone
P., Sulla deducibilita in condizione del divieto di alienazione, RdP 2004, 537; (3) Maior-
ca, Condizione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (4) Mirabelli, Dei contratti ingenerale, Com. UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232.
1358 Comportamento delle parti nello stato di pendenza
[1] Colui che si e obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospen-
siva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della
condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni del-
l’altra parte.
Sommario: I. Generalita – II. Contenuto dell’obbligo – III. Applicabilita alla condi-zione mista – IV. Casistica.
I. Generalita
Il principio espresso dalla norma costituisce un’applicazione dell’art. 1375 [Bian-
ca C.M. (2), 526]. La norma comporta l’obbligo di conservare integre le ragionidell’altro contraente, astenendosi da quanto possa pregiudicare gli interessi dellacontroparte [C 2.6.1992 n. 6676, GI 1993, I, 1, 1308; C 13.7.1984 n. 4118, FiM1984; Coll. arb. Milano 19.7.1993, C 1994, 681, nt. Mucio]. E controverso se lanorma attenga alla fase della esecuzione del contratto o ad una fase anteriore [perla prima ipotesi, Bruscuglia (3), 30; contra, nel caso della condizione sospensiva,Costanza (4), 857]. Secondo l’opinione prevalente, la violazione dell’obbligo dibuona fede da luogo a responsabilita contrattuale [C 2.6.1992 n. 6676, cit.] e legit-tima sia l’azione di risoluzione che quella di risarcimento del danno [Bianca C.M.(2), 526]; contra, per l’inammissibilita dell’azione di risoluzione nel caso di condi-zione risolutiva [Costanza (4), 858], sul rilievo che nel caso di avveramento dellacondizione, la sentenza di risoluzione sarebbe un duplicato degli effetti dellacondizione risolutiva [cfr. C 22.3.1969 n. 926, FiM 1969]. In pendenza della con-dizione sospensiva non e configurabile inadempimento, non essendo il contrattoefficace, non solo in violazione della norma in esame [C 18.2.2002 n. 3942, GC2003, I, 2227].
II. Contenuto dell’obbligo
Poiche l’obbligo di buona fede e riferito dalla norma solo all’alienante sottocondizione sospensiva ed all’acquirente sotto condizione risolutiva, si e limitatoil contenuto dell’obbligo alla sola astensione da quanto possa pregiudicare l’avve-ramento [cfr. C 6.10.1972 n. 2889; Coll. arb. Milano 19.7.1993, cit.]. L’indirizzoprevalente, pero, ritiene che l’obbligo comprenda anche comportamenti attivi [C22.3.2001 n. 4110, FiM 2001; C 13.7.1984 n. 4118, cit.; C 27.2.1980 n. 1379, FiM1980; Maiorca (5), 313; Mirabelli (6), 246, cit.]. Secondo C 22.4.2003 n. 6423,l’omissione di un’attivita in tanto puo ritenersi contraria a buona fede e costituirefonte di responsabilita, in quanto l’attivita omessa costituisca oggetto di un ob-bligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attivitadi attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista. Anche secondo la
1
2
Art. 1358 Dei contratti in generale 718
dottrina prevalente la norma consente di proteggere sia l’interesse della parte allaconservazione del bene oggetto del contratto sia l’interesse al normale e correttocompiersi della vicenda condizionale [Mirabelli (6), 246; Vitucci (10), 22. Se-condo una parte della dottrina, invece, l’art. 1358 si riferirebbe piu che alla vi-cenda condizionale in se alle aspettative [Costanza (4), 859] e precisamente aquelle sul bene oggetto del contratto da parte dell’acquirente [Natoli (7), 457;Restivo (8), 1150 ss.].
III. Applicabilita alla condizione mista
A differenza della previsione di cui all’art. 1359 (v. oltre), la giurisprudenza ritieneche la disciplina dell’art. 1358 sia applicabile al contratto sottoposto a condizione
potestativa mista. Le fattispecie in questione ricorre principalmente alla materiadegli acquisti condizionati alla concessione di provvedimenti autorizzativi pubbli-ci, in cui si tende a ridimensionare il potere discrezionale della p.a. nell’azioneamministrativa. La Cassazione ha dapprima sostenuto che il principio in questio-ne non sarebbe applicabile anche in relazione alla parte della condizione relativa alsegmento non casuale della condizione [C 22.4.2003 n. 6423, C 2003, 1096 ss., nt.Besozzi]. Successivamente, la Suprema Corte ha mutato indirizzo, affermandoche occorre valutare la conformita a buona fede nell’attuazione dell’elementopotestativo, involgendo, quindi, tale giudizio, il merito della discrezionalita am-ministrativa [C 28.7.2004 n. 14198, FiM 2004, RDC 2007, II, 93, nt. Morese, GC2005, I, 1787, nt. Costanza: nella fattispecie in questione, il Comune, nel con-tratto sottoscritto con un professionista incaricato di progettare un’opera pubbli-ca, aveva condizionato il pagamento dell’onorario all’ammissione a finanziamen-to dell’opera, omettendo di compiere l’attivita necessaria per accedere al finanzia-mento]. Tale indirizzo e stato poi confermato dalle Sezioni Unite [C s.u. 19.9.2005n. 18450, FiM 2005, NGCC 2006, I, 410, GI 2006, I, c. 1140 ss.; C 2.7.2002 n. 9568,FiM 2002; da ultimo C 10.8.2007 n. 17647, GC 2008, 10, 2204]. La dottrina haperlopiu criticato il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, ritenendoche il criterio della buona fede, in quanto valutazione comparativa di interessi inconflitto, non sia idoneo a governare un assetto di interessi in cui la prevalenza diuno di essi e gia disposta dal contratto [Restivo (8), 1146; Salanitro U. (9), 423]rimarcando la diversita strutturale e funzionale tra l’art. 1358 e l’art. 1359 [cfr.Belfiore (1), 613 ss.].
IV. Casistica
In un contratto preliminare di compravendita nel quale sia stato pattuito il diritto direcesso a favore del promissario acquirente subordinato alla condizione del mancatorilascio della concessione edilizia, la presentazione di un progetto non accoglibile inquanto contrario alla normativa vigente, costituisce inadempimento da parte delpromittente venditore per violazione dei doveri di reciproca correttezza e buona fedeche gravano sulle parti in pendenza della condizione [T Terni 9.10.1992, RGU 1993,15, nt. Palma]. Colui che si e obbligato o ha alienato un bene sotto la condizionesospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per larealizzazione delle finalita economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di
3
4
719 Delle obbligazioni Art. 1358
compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondobuona fede (art.1358), tutte le attivita che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione,in modo da non impedire che la p.a. provveda sul rilascio delle autorizzazioni con laconseguenza che deve rispondere delle conseguenzedell’inadempimentodi questa suaobbligazione contrattuale nei confronti dell’altra parte, alla quale e possibile chiederela risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti, da accertaresecondo il criterio della regolarita causale, che consente di riconoscere il danno nelcaso in cui, avuto riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si everificato l’inadempimento, debba ritenersi che la condizione avrebbe potuto avve-rarsi, essendo possibile il legittimo rilascio delle autorizzazioni amministrative conriguardo alla normativa applicabile (nella specie, trattavasi del contratto di locazionenovennale di un terreno per l’esercizio di una stazione di autonoleggio da costruire acura del conduttore, subordinato al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lacostruzione dei manufatti, in concreto mancante a causa del rifiuto del locatore disottoscrivere i documenti della relativa pratica amministrativa) [C 2.6.1992 n. 6676,cit.].
Bibliografia: (1) Belfiore, nota a C 13.4.1985, n. 2464, NGCC 1985, I, 613; (2) Bianca
C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (3) Bruscuglia, La pendenza dellacondizione e comportamento secondo buona fede, Milano 1975; (4) Costanza, I contrattiin generale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999, 811; (5) Maiorca, Condizione, DI IVciv., III, Torino 1988, 273; (6) Mirabelli, Dei contratti in generale, Com. UTET, IV, t.2, Torino 1980, 232; (7) Natoli, Della condizione nel contratto, Libro delle obbligazioni,Com. D’Amelio–Finzi, I, Firenze 1948, 462; (8) Restivo, Note critiche sul ruolo dellaregola di buona fede nella disciplina della condizione, GI 2006, I, c. 1143; (9) Salanitro
U., Contratto d’opera intellettuale e controprestazione incerta: i dubbi sulla validita dellaclausola subordinativa del compenso, e sull’applicabilita alla stessa della disciplina dellacondizione, davanti alle sezioni unite, NGCC 2006, I, 421; (10) Vitucci, Condicio est inobligatione ex lege, RDC 1998, I, 9.
1359 Avveramento della condizione
[1] La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
Sommario: I. Generalita – II. Comportamento sanzionabile – III. La fictio e la con-dizione potestativa o meramente potestativa – IV. La fictio e la condizione legale.
I. Generalita
Si tratta di norma eccezionale in quanto prevede una fictio iuris, che non e su-scettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che non puo conside-rarsi non avverata la condizione nell’opposta ipotesi dell’avveramento della con-dizione per fatto imputabile alla parte che aveva interesse all’avveramento stesso[Mirabelli (8), 251; C 16.12.1991 n. 13519, cit.].
Dibattuta e la questione del raccordo della norma con il principio di buona fede econ l’art. 1358, di cui, secondo alcuni, la finzione di avveramento costituirebbe
1
2
Art. 1359 Dei contratti in generale 720
espressione [Carresi (5), 605]. Si e pero osservato che diverso e l’oggetto delle duenorme, in quanto l’art. 1358 tutela le aspettative delle parti alla realizzazione o allanon realizzazione della condizione, mentre l’art. 1359 si riferisce ad una situazionesuccessiva [Costanza (7), 858]. Del resto, l’art. 1359 sanziona anche la semplicecondotta colposa, che quindi e valutabile secondo il diverso criterio della diligenza[Bianca C.M. (3), 527].
II. Comportamento sanzionabile
L’interpretazione corrente della norma e nel senso che rilevi qualsiasi azionedolosa o colposa della parte che impedisce il realizzarsi della condizione [Bian-
ca C.M. (3), 527; C 6.9.1991 n. 9388, GI 1992, I, 1, 1088; T Perugia 5.6.1992,cit.] e che la fattispecie non sia riscontrabile in un semplice comportamento
inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto
dal contratto o dalla legge [C 20.7.2004 n. 13457, FiM 2004; C 26.5.2003 n.8363; C 22.4.2003 n. 6423, C 2003, 1056; C 8.9.1999 n. 9511, FiM 1999; C s.l.9.8.1996 n. 7377, FiM 1996]. Parte della dottrina ha invece osservato che lanorma non consente generalizzazioni e che a seconda dei casi, l’alterazione delcorso degli eventi potra essere sanzionata solo in caso di dolo, o anche dicolpa, o addirittura a titolo di responsabilita oggettiva, ed anche di omissione,come dimostrerebbe anche l’esame della giurisprudenza, che ha in alcuni casiammesso generale rilevanza all’omissione [Sacco (10), 155 (cfr. giurisprudenzacitata alle nt. 5, 6). In giurisprudenza, per la rilevanza di qualsiasi comporta-mento, omissivo o volontario, purche contrario a buona fede cfr. C 13.7.1984n. 4118, cit.].
La norma dell’art. 1359, secondo cui la condizione del contratto si consideraavverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario al suo avveramento, non e applicabile nel caso in cui la parte tenutacondizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse al-l’avveramento di essa [C 23.4.1998 n. 4178; cosı anche C 22.4.2003 n. 6423, cheaggiunge come la condizione possa ritenersi apposta nell’interesse di una sola delleparti contraenti soltanto quando vi sia un’espressa clausola contrattuale che di-sponga in tal senso ovvero allorche – tenuto conto della situazione riscontrabile almomento della conclusione del contratto – vi sia un insieme di elementi che nelloro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altraparte non abbia alcun interesse; mentre, in mancanza, la condizione stessa deveritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti]. In senso critico versoquest’impostazione ed a favore dell’applicabilita anche ai casi di condizione bila-terale, la dottrina ha affermato che l’art. 1359 non limita l’operativita della normaalle condizioni unilaterali e che la valutazione dell’interesse deve essere operata inconcreto [Bruscuglia (4), 50; Besozzi (2), 1102; Roppo (9), 634] Secondo Carresi
(5), 608, la finzione di avveramento opererebbe solo in caso di condizione risolu-tiva e non in quella sospensiva, in quanto, in quest’ultimo caso, il comportamentodoloso o colposo di chi aveva interesse all’avveramento non potrebbe ritenersicontrario a buona fede.
3
4
721 Delle obbligazioni Art. 1359
III. La fictio e la condizione potestativa o meramente potestativa
La giurisprudenza, tranne sporadiche eccezioni [ad es. P Napoli 24.12.1982,OGL 1984, 135, nt. Toffoletto] nega che la norma in commento si applichi aicasi di condizione potestativa e mista per la parte rimessa alla volonta delcontraente [C 22.2.2005 n. 3579, FiM 2005; C 18.11.1996 n. 10074, FiM1996; C s.l. 5.6.1996 n. 5243, FiM 1996; C 7.3.1983 n. 1680, FiM 1983; C26.4.1982 n. 2583, AC 1982, 721; v. in particolare, in termini affermativi sul-l’applicabilita dell’art. 1359 alla condizione mista, per la parte casuale C22.4.2003 n. 6423, C 2003, 1096, nt. Besozzi, GC 2004, I, 2793, nt. Micari].A tale proposito, la dottrina tradizionale ha osservato che la disciplina dellafinzione di avveramento sarebbe incompatibile con la discrezionalita riservataal contraente nella condizione potestativa [Barbero (1), 1105]. Coerentementecon tale indirizzo si e ritenuto che il comportamento contrario a buona fedenelle condizioni potestative vada inquadrato nel quadro della violazione delgenerale obbligo di buona fede nell’esecuzione dei contratti, disciplinato dal-l’art. 1375 e non nella disciplina della condizione [Mirabelli (8), 253]. Unaparte della dottrina ha pero osservato che anche nel caso di condizione pote-stativa, semplice o mista, dovrebbero trovare applicazione i normali criteridella colpa e del dolo, al fine di verificare se il comportamento del contraenteavente un interesse contrario all’avveramento sia legittimo [Costanza (6),1528].
IV. La fictio e la condizione legale
Si esclude generalmente che la finzione di avveramento possa operare in relazionealla condizione legale sulla base di vari argomenti. La giurisprudenza prevalente
afferma che nella condicio juris la volonta legislativa o dell’amministrazione nonpuo essere sostituita da un equipollente e cioe dalla condotta della parte che avevainteresse contrario al verificarsi della condizione [C 5.2.1982 n. 675, FiM 1982; TNapoli 10.5.1985, GI 1985, I, 2, 513]. Secondo la dottrina, detto principio noncomporta l’irresponsabilita dell’amministrazione per l’omissione, ma solo l’inap-plicabilita dell’avveramento, per cui la p.a. potra essere condannata al risarcimen-to del danno [C 11.7.1968 n. 2444, FiM 1968; C 11.11.1967 n. 2718, FiM 1967;Mirabelli (8), 254]. In tal caso il danno andra commisurato all’interesse positivo[C 10.4.1970 n. 981, FiM 1970]. Secondo C 4.3.1987 n. 2255, FiM 1987, in caso dimancanza di visto prefettizio per l’approvazione di un contratto di appalto diopere pubbliche, a causa dell’omessa redazione del contratto formale di appalto,o della mancata trasmissione di esso alla autorita di controllo non puo trovareapplicazione la finzione legale dell’avveramento di cui all’art. 1359, che concernela condizione quale requisito convenzionale accidentale (nella specie il giudice haconsiderato applicabile l’art. 1337 e quindi ravvisabile la culpa in contrahendo dellap.a.).
Bibliografia: (1) Barbero, Condizione, (diritto civile), NsDI, II, Torino 1959, 1096;(2) Besozzi, Presupposti applicativi della finzione di avveramento della condizione, C2003, 1096; (3) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (4)Bruscuglia, La pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede,
5
6
Art. 1359 Dei contratti in generale 722
Milano 1975; (5) Carresi, Il contratto, Tr. Cicu–Messineo, XXI, II, t. 1, Milano1987; (6) Costanza, Finzione di avveramento e condizione potestativa, GC 1983, I,1528; (7) Id., I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999, 811; (8)Mirabelli, Dei contratti in generale, Com. UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232; (9)Roppo, Il contratto, Tr. Iudica–Zatti, Milano 2001; (10) Sacco, Il contratto, Tr.Sacco, II, Torino 1993.
1360 Retroattivita della condizione
[1] Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e
stato concluso il contratto, salvo che, per volonta delle parti o per la natura del
rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un
momento diverso.
[2] Se pero la condizione risolutiva e apposta a un contratto ad esecuzione conti-
nuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha
effetto riguardo alle prestazioni gia eseguite.
Sommario: I. Generalita – II. Contratti di durata.
I. Generalita
La retroattivita opera ipso jure ed erga omnes. La ratio della previsione e stataindividuata nell’esigenza di circolazione dei diritti sub condicione e di rilevanzarispetto ai terzi [Costanza (1), 872]. Le parti possono derogare al principio, manon possono disporre dell’effetto reale nei confronti dei terzi [Maiorca (2), 319].La retroattivita deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dall’art.1359 [C s.l. 9.8.1996 n. 7377, FiM 1996]. Si e osservato da parte di alcuni che ilprincipio non ha un’effettiva rilevanza pratica, anche perche sono numerose egravi le eccezioni ad esso [Pelosi (3), 140].
II. Contratti di durata
Qualora l’operativita di un contratto (nella specie: agenzia) venga subordinatadalle parti al perfezionarsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo (nellaspecie: fornitura al preponente di componenti degli impianti industriali deiquali l’agente avrebbe dovuto promuovere la vendita), il collegamento funzio-nale fra l’uno e l’altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione dinatura sospensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nellaconclusione del secondo; ne consegue che il mancato verificarsi di tale condi-zione osta a che il contratto concluso, ancorche ad esecuzione continuata operiodica, possa produrre qualsiasi effetto, restando in particolar modo inap-plicabile il disposto dell’art. 1360, c. 2, sulla salvezza delle prestazioni giaeseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva [C7.2.1985 n. 949, FiM 1985].
Bibliografia: (1) Costanza, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II, Torino 1999,811; (2) Maiorca, Condizione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (3) Pelosi, La pro-prieta risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano 1975, 284.
1
2
723 Delle obbligazioni Art. 1360
1361 Atti di amministrazione
[1] L’avveramento della condizione non pregiudica la validita degli atti di ammi-
nistrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava
l’esercizio del diritto.
[2] Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono
dovuti dal giorno in cui la condizione si e avverata.
Secondo un orientamento, che considera la norma in commento in stretta con-nessione con l’art. 1360, gli atti di amministrazione di cui alla norma in commentosarebbero quelli non pregiudizievoli dell’aspettativa della controparte, sia di ordi-naria che di straordinaria amministrazione [Mirabelli (3), 257; Maiorca (2),323], secondo un altro orientamento, l’irretroattivita non riguarderebbe gli attidi straordinaria amministrazione [Bianca C.M. (1), 531].
Quanto al secondo comma, si e ritenuto che esso non sia altro che un’applicazionedella regola del possesso di buona fede (art. 1148, con la differenza che qui ilpossessore si appropria solo dei frutti percepiti al momento dell’avveramento enon anche dei frutti separati [Mirabelli (3), 256; v. C 3.11.2005, FiM 2005].
Bibliografia: (1) Bianca C.M., Diritto civile, Il contratto, III, Milano 1987; (2) Maior-
ca, Condizione, DI IV civ., III, Torino 1988, 273; (3) Mirabelli, Dei contratti ingenerale, Com. UTET, IV, t. 2, Torino 1980, 232.
CAPO IVDell’interpretazione del contratto
1362 Intenzione dei contraenti
[1] Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune in-
tenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
[2] Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Sommario: I. Osservazioni generali – II. La comune intenzione delle parti – III.Interpretazione letterale. Il principio in claris non fit interpretatio – IV. Il comporta-mento delle parti – V. Interpretazione del testamento – VI. Casistica.
I. Osservazioni generali
La distinzione tradizionale delle clausole legali di interpretazione del contratto(artt. 1362–1371) e quella tra norme di interpretazione soggettiva (artt. 1362–1365)e norme di interpretazione oggettiva (artt. 1366–1370): il primo gruppo regola uniniziale e necessario momento dell’interpretazione ed ha per obiettivo la ricercadella volonta in concreto dei dichiaranti; il secondo presuppone che la primaricerca non abbia raggiunto un risultato positivo e che permanga, quindi, ancorail dubbio sulla dichiarazione negoziale, per cui interviene per ricostruire il signi-
1
2
1
Artt. 1361-1362 Dei contratti in generale 724