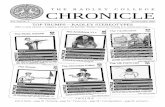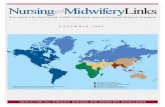CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI E CREDIT LINKS NOTES: OSCILLANDO TRA TRUST E CONTRATTO
Transcript of CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI E CREDIT LINKS NOTES: OSCILLANDO TRA TRUST E CONTRATTO
TiUStS Saggi
Cartolarizzazione dei crediti e credit linked notes: oscillando tra trust e contratto
SOMMARIO: §l. La cartolarizzazione. - §2. La cartolarizzazione: un fenomeno internazionale. - §3. La cartolarizzazione ed i flussi giuridici. - §4. L'impatto dei flussi giuridici sul legislatore: la legge 30 aprile 1999, n. 130 ed il trust mutilo. - §5. Il rapporto tra gestore ed investitori: un flusso giuridico spurio. - §6. Credi t linked notes: definizione della fattispecie. - § 7. Credit linked notes, rapporto fondamentale e tipi dell'ordinamento inglese. - §8. Loan e partnership nelle definizioni. - §9. Loan e partnership nella pratica. -§ 10. Credit linked notes: titoli che incorporano lo status di partner. - § 11. Credi t linked notes, rapporto fondamentale e tipi dell'ordinamento italiano. - § 12. Mutuo, associazione in partecipazione, contratto atipico. - § 13. Obbligazione o titolo atipico. - § 14. Il flusso giuridico puro: credit linked notes e trust.
§l. La cartolarizzazione.
Con l'emanazione della legge 30 aprile 1999, n. 130, la cartolarizzazione dei crediti, una delle più importanti innovazioni apparse negli ultimi anni sulle scene finanziarie internazionali (l), è approdata in Italia. Cartolarizzazione è il calco linguistico del termine inglese "securitization". Nel linguaggio giuridico anglosassone, "security" significa titolo destinato alla circolazione. Per istintiva deduzione, un giurista italiano potrebbe quindi essere portato a tradurre "securitization" con la locuzione "incorporazione di un credito in un titolo". Se così fosse, l'emanazione di un provvedimento legislativo in materia avrebbe realmente suscitato "much ado far nothing": il fenomeno dell'incorporazione era, infatti, già noto al nostro sistema.
Così invece non è. La cartolarizzazione è un'operazione di trasforma
zione - e non di incorporazione - di crediti in titoli. Difatti, rispetto all'incorporazione, la cartolarizzazione presenta differenze fondamentali: da un lato è attuata dal creditore, non dal debitore; dall'altro essa è uno strumento di finanziamento, non un mezzo per facilitare la circolazione di un diritto.
Ottobre 2000
di Andrea \Uri
Una volta compreso che cosa la cartolarizzazione non è, rimane da capire che cosa essa esattamente sia.
La cartolarizzazione è un'operazione unitaria sotto il profilo della causa - il finanziamento dell'impresa - ma strutturalmente complessa perché composta da una serie di negozi collegati. Il suo schema è variabile e dipende dalle esigenze delle parti coinvolte e dalle circostanze della singola operazione. Esiste, tuttavia, un common core strutturale(2) . Innanzitutto, l'impresa (''ente generatore") individua un portafoglio crediti all'interno del suo patrimonio, lo trasferisce, normalmente tramite cessione, ad un altro ente(3) (''ente gestore"), in capo al quale- vuoi per
Andrea Vicari è dottorando di ricerca in Diritto privato comparato presso l'U niversità di Palermo; l.T.P. (Harvard Law School); ).S.O. Candidate (Comell La w Schuol); avvocato e nota io nella Repubblica di San Marino. Maurizio Lupoi, Rossana Rossini , Francesca Fiorentini e Cristina Lo Surdo hanno commentato una precedente versione di questo testo e qui li ringrazio. Tutti gli errori rimasti sono imputabili solo a me.
Note
(l) Dagli economisti, la carrolarizzazione è descritta come una delle piLt moderne ed importanti innovazioni per incrementare l'efficienza dei mercati finanziari: v. P. Cooper, lnnovations: New Market Instruments, Oxford Rev. Econ. Pol'y, Winter, 1986, 16.
(2) La dottrina distingue due modelli di cartolarizzazione: quello franco· ispanico , attuato mediame il binomio fondo comune - società di gestione, e quello anglosassone, attuato mediante trust: M. Granieri - A . Renda, La securitization tra diritto ed economia, tra normativa nazio· naie e modelli stranieri , in R. Pardolesi (cur.) , La cartolarizzazione dei crediti in Italia, Milano, 1999, p. 27. In realtà, esiste un unico modello - quello anglosassone - poiché il meccanismo dei fondi non è altro che la traduzione civilistica del trust: v. M. Lupoi, Trusts, Milano, 1997, p. 5 25; R. Lener, La circolazione del medello del "trust" nel diritto conti· nentale del mercato mobiliare, Riv. Soc., 1989, 1050.
(3 ) Di primo acchito , il meccanismo di fondo dell'operazione potrebbe portare ad assimilarla ad un factoring, ma sarebbe sbagliato. Dal factoring, che pure implica la cess ione di un portafoglio crediti, la cartolarizzazio· ne si differenzia per alcuni aspetti fondamentali. Nel factoring, il cessio· nario dei crediti è un intermediario finanziario che professionalmente compra crediti; nella cartolarizzazione è un ente gestore creato ad hoc per la specifica operazione. Nel factoring, il fac tor mira a produrre per se stes· so il mass imo profitto mediante lo sconto de i crediti acquistati rispetto alloro valore d'incasso; nella carrolarizzazione, l'ente gestore non è de· stinato a produrre profitto per se stesso ma a minimizzare gli oneri fi nanziari dell'impresa che l'ha creato. Nel factoring, il costo del finanzia· mento per l'impresa è rappresentato dal costo sostenuto dal factor per raccogliere i fondi necessari all'acquisto dei titoli e dal margine di pro· fitto di quest'ultimo; nella cartolarizzazione, dal solo costo di raccolta del risparmio dagli investitori.
<(
J j
• ' l J
J
J ~ l
l
espressa norma di legge vuoi mediante il ricorso al trust - esso viene segregato; l'ente gestore quindi emette titoli negoziabili ceduti direttamente sul mercato, ed un'agenzia internazionale attribuisce loro una valutazione (rating). Il denaro raccolto dall'emissione viene trasferito all'ente generatore come corrispettivo per la cessione dei crediti, mentre, in misura corrispondente all'entità del patrimonio segregato, i titoli verranno rimborsati con i flussi finanziari generati dalla riscossione del portafoglio crediti( 4).
§2. La cartolarizzazione: un fenomeno in, temazionale.
Chi abbia osservato il funzionamento delle operazioni di cartolarizzazione sa bene come esse tendano a valicare i confini nazionali: di norma, le varie fasi che le compongono si svolgono in diversi Stati, ed i soggetti in esse coinvolti sono situati in diversi paesi(S). In questo modo viene a verificarsi ciò che si potrebbe definire "una frammentazione economica dell'operazione". Questo fenomeno è riconducibile all'esigenza di svolgere le singole fasi nel paese che dispone delle condizioni economico- finanziarie più favorevoli. Pertanto, in via esemplificativa, può avvenire che l'ente generatore sia domiciliato in uno Stato, quello gestore in un altro, gli investitori in un terzo, l'agenzia di rating in un quarto, che i titoli siano emessi in un quinto e quotati sul mercato di un sesto.
La diretta conseguenza della frammentazione economica è la frammentazione giuridica: un'operazione di cartolarizzazione internazionale non è regolata dal diritto di un unico paese, ma le sue singole fasi sono usualmente regolate dal diritto di ordinamenti diversi(6). Si possono allora avere operazioni di securitization in cui l'ente generatore dei crediti e quello gestore sono disciplinati dalla legge di due differenti Stati, in cui il diritto applicabile ai crediti ceduti dall'ente generatore è diverso da quello applicabile ai titoli emessi dall'ente gestore, in cui la legge che governa i titoli non coincide con quella che governa il rapporto fondamentale tra sottoscrittori ed ente gestore.
Di norma, la frammentazione giuridica è la conseguenza della frammentazione economica. A volte, invece, avviene il contrario. L'operazione viene frammentata economicamente e collocata in una dimensione internazionale perché è necessario frammentare l'operazione da un punto di vista giuridico.
Trusrs Saggi
Così, quando in un dato sistema giuridico mancano gli strumenti adeguati, gli operatori svolgono all'estero le fasi che non possono svolgere all'interno del proprio ordinamento. Ed allora, quando il sistema a cui appartiene l'ente generatore è privo di strumenti che permettano l'effettiva segregazione del portafoglio crediti e la sua destinazione al soddisfacimento degli investitori, l'ente gestore verrà creato all'estero; ancora, quando l'ambiente giuridico in cui è creato l'ente gestore non conosce i tipi cartolari necessari in queste operazioni, i titoli saranno emessi in uno Stato in cui essi sono già tipizzati.
§3. La cartolarizzazione ed i flussi giuridici.
Quando si ricorre alla frammentazione economica e giuridica solo per superare gli impedimenti creati dalla mancanza di regole e strutture negoziali appropriate all'interno dell'ordinamento a cui appartiene l'ente gestore, è evidente che essa rappresenti una risposta, la più immediata e apparentemente la più semplice, ad un bisogno giuridico insoddisfatto.
La frammentazione è, tuttavia, una reazione rozza e vile; una reazione più matura è quella rappresentata dalla percezione di un flusso giuridico.
Secondo la definizione di Lupoi, un flusso giuridico è "un qualsiasi dato dell'esperienza giuridica il quale, proprio di un ordinamento, sia percepito in un altro e qui introduca un elemento di squilibrio"(?) . Si comprende allora che percepire un flusso giuridico in materia di cartolarizzazione significa guardare a quei dati dell'esperienza giuridica straniera ritenuti rilevanti per colmare quelle lacune del proprio ordì-
Note
( 4) Questa operazione comporta vantaggi sia per gli acquirenti dei tiroli sia per l'impresa. Per l' impresa, rispetto ad altre operazioni di finanziamento attuate mediante la cessione di crediti, la cartolarizzazione comporta una riduzione del costo del denaro. Per gli investitori, rispetto ad operazioni d'investimento in titoli di un impresa, la carrolarizzazione riduce l'esposizione a l rischio: essi subiranno il rischio legato alla sofferenza dei titoli, non il rischio dell'impresa a cui apportano proprio denaro.
(5) Sulla storia dell'internazionalizzazione delle operazioni di securitization v. H. A. Fernandez, Globalization of Mortgage-Backed Securities , [1987] Colum. Bus. L. Rev. 357.
(6) "The distinctive feature about cross border finanancial transactions is rh e absence of a single, unitary lega l sysrem", v. M. B. Fox, The Lega l Environment of lnternational Finance: Thinking About Fundamenrals, 17 Mich J. lnt'l L. 721 (1996) 729.
(7) La teoria dei flussi giuridici è di M. Lupoi, Sistemi giuridici comparati, Genova, 2000 (ed. provv. ), pp. 46-63.
Ottobre 2000
TitiStS Saggi
namento che rappresentano un ostacolo allo sviluppo di queste operazioni. In questa prospettiva, è ovvio che l'esperienza di riferimento sia quella degli ordinamenti in cui il fenomeno cartolarizzazione ha già raggiunto un importante stadio di sviluppo, ossia quella angloamericàna.
Se è vero che il semplice "guardare" produce un flusso giuridico( 8), è altrettanto vero che l'osservazione non soddisfa il bisogno, ma si limita a suggerire soluzioni. Il bisogno viene soddisfatto solo quando dall'osservazione si produce azione e si utilizzano i dati portati dal flusso per modificare l'ordinamento: solo quando, negli ordinamenti che percepiscono il flusso, il legislatore introduce nuovi strumenti giuridici, la prassi introduce nuovi strutture negoziali, la dottrina adotta una nuova tesi, o le corti un nuovo rimedio processuale.
§4. L'impatto dei flussi giuridici sullegisla, tore: la legge 30 aprile 1999, n. 130 ed il trust mutilo.
Che i flussi giuridici legati alla cartolarizzazione abbiano prodotto una modificazione dell'ordinamento italiano appare in modo evidente dalla semplice lettura della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Si è detto che non può esserci cartolarizzazione senza segregazione.
Nell'ordinamento italiano, come nella maggior parte degli ordinamenti di civil law, vige il principio dell'unità del patrimonio, che vieta la segregazione di singoli beni all'interno del patrimonio generale del debitore al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni. Il bisogno di uno strumento che permettesse agli operatori di segregare il portafoglio crediti dal resto del patrimonio del suo titolare era quindi palese, come palese era il fatto che spettasse al legislatore colmare questa lacuna.
Nell'esperienza angloamericana, la segregazione del portafoglio crediti è ottenuta ricorrendo al trust e quindi, nel momento in cui legislatori continentali hanno guardato all'esperienza anglosassone per svolgere il loro compito, era ovvio che il trust esercitasse su di loro un fascino particolare. Al trust si sono ispirati i legislatori di Spagna, Francia e Belgio quando hanno introdotto i fondi chiusi di credito(9); al trust ha guardato il legislatore italiano quando ha dettato l'art. 3, II comma della legge 30 aprile 1999, n. 130 che stabilisce:
Ottobre 2000
"i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello [dell'ente gestore] e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei cred iti stessi".
Il flusso giuridico ha così provocato una modificazione dell'ordinamento. La portata di questa modifica è tuttavia da valutare. Leggendo questa norma con gli occhi di gran parte della dottrina continentale -quella che riduce il trust ad un patrimonio separato( l O) -si potrebbe concludere che il legislatore non si sia limitato a guardare il trust ed a introdurne un calco giuridico nel nostro ordinamento, ma lo abbia integralmente recepito. Ma così non è.
Il trust di modello inglese è molto di più di una semplice segregazione di diritti. La sua istituzione dà vita ad un insieme di fiduciary duties imposti sui trustees in favore dei beneficiarii e, soprattutto, ad un legame giuridico tra l'obbligazione in favore del beneficiario ed i diritti oggetto del trust (vincolo che fa sì che il lato passivo dell'obbligazione si trasferisca col trasferirsi dei diritti (l l) e che quella si estingua quando questi si estinguono(12)).
Note
(8) M. Lupoi, [supra, nota 7], p. 46.
(9) È ormai fatto acquisito che il fondo comune d'investimento, genere di cui il fondo chiuso di crediti è specie, rappresenti la traduzione in termini civilistici del trust, v. M. Lupoi, Trusts [supra nota 2]; R. Lener, La circolazione del modello del "trust" nel diritto continentale del mercato mobiliare [supra, nota· 2].
(10) A partire da Saleilles, ridurre il trust ad un patrimonio separato è un luogo comune tra i giuristi continentali, v. R. Saleilles, De la personalité juridique, Paris, 1922, p. 427; P. Lepaulle, Traité théorique et pratique cles trusts, Paris, 1932, p. 26; De la Nature du "Trust", 54 Journal de Droit International 966 (1927); idem, An Outsider's View Point of the Nature of Trusts, 14 Cornell L.Q. 52 (1928) 55; M. Rheinstein, Book Review, 43 Yale L.J. 1049 (1934) 1050; P. G. Jaeger, La separazione del patrimonio fiduciario, Milano, 1967, p. 213; U. Mattei, Comparative Law and Economics, Ann Harbour, 1997, p. 169; H. Hansmann & U. Mattei, The Functions of Trust Law: A Comparative and Economie Analysis, 73 N.Y.U. L.Rev. 434 (1998).
( 11) È il processo noto come following, spesso, ed erroneamente, assimilato dai civilisti al droit de suite o alla rivendicazione. Tale assimilazione è una delle cause principali della tradizionale idea che il diritto del beneficiario sia un diritto reale. In rea ltà, il following non coincide con la rivendicazione perché il beneficiario non può chiedere di riottenere il possesso, a meno che non metta fine al trust stesso. Il following è una tecnica processuale che serve solo ad identificare il debitore dell'obbligazione, che è un'obbligaz ione ambulante.
(12) L'obbligazione del trustee si estingue quando i diritti oggetto del trust si estinguano senza colpa del trustee. In modo particolarmente chiaro vedi il Restatement ofTrust (2nd)§ 204 e A.W. Scott, The Law of trusts, Boston, 1956, § 204. La regola risale a Lord Hardwicke in Jones v Jones (1750-1751) 2 Ves. Sen. 240.
j
1
J
l ~.
l l ~.
Si deve allora riconoscere che, in realtà, il legislatore abbia recepito solo l'effetto più evidente del modello inglese di trust - quello della segregazione - senza tuttavia introdurne tutta la disciplina: del caratteristico rapporto tra beneficiarii e trustee, così come del peculiare collegamento tra obbligazione e diritto del trustee, non c'è traccia nella legge 30 aprile 1999, n. 130.
Quello che emerge da questo documento legislativo è un trust mutilo.
§5. n rapporto tra gestore ed investitori: un flusso giuridico spurio.
Questa parziale adesione al flusso giuridico, unita all'assenza di una qualsiasi indicazione legislativa sulla natura dei titoli da emettere(13 ), comporta due conseguenze.
In primo luogo lascia ai giuristi il compito di completare l'opera e di definire il rapporto tra investitore ed ente gestore, tentando di riprodurre quello che nei sistemi di common law è un rapporto tra beneficiarii e trustee e quelle che sono le peculiarità dell'obbligazione imposta sul trustee. Come vedremo, questi effetti sono essenziali in un'operazione di cartolarizzazione tanto quanto la segregazione; il fatto che il legislatore li abbia trascurati non significa che essi siano trascurabili.
In secondo luogo, lascia ai pratici la più ampia libertà di scegliere i tipi negoziali e cartolari più adatti alle esigenze dei loro clienti per strutturare l'operazione di emissione, siano essi già inquadrati nell'ordinamento italiano e da questo governati, siano essi noti ai sistemi di common law e governati dal diritto straniero.
Fino ad ora, i giuristi si sono disinteressati del compito loro assegnato: nessuno ha tentato seriamente di pensare in termini civilistici il rapporto tra investitori ed ente gestore ed i titoli che quest'ultimo deve emettere. I pratici, lasciati senza guida, si sono trovati a vacillare nel buio ma, pressati dalle esigenze dei loro clienti, non si sono potuti esimere dal compiere delle scelte. Purtroppo, quando fatte alla cieca, le scelte si rivelano spesso disastrose.
La prassi si è arresa ai flussi giuridici senza analizzarli e, cosa assai pericolosa, li ha distorti. Si sono prese fattispecie cartolari ("credi t linked notes" o "notes") utilizzate nelle cartolarizzazioni svolte oltremanica mediante trusts e le si è innestate sull'impianto predisposto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130; il trust causa di emissione è stato sostituito da un contratto; titoli e contratto sono stati assoggettati al diritto inglese.
Trusrs Saggi
La sostituzione del trust con un contratto è dovuta al fatto che il ricorso ad esso non è stato più avvertito necessario. Si riteneva infatti che, prevedendo la legge stessa la segregazione del portafoglio crediti, tutti gli altri effetti del trust potessero agevolmente essere riprodotti in via contrattuale. Quale contratto di diritto italiano fosse idoneo a questo scopo, non era tuttavia chiaro. Quindi, per evitare di dover risolvere tale questione, si è fatto rinvio al diritto inglese dove una qualsiasi promessa, dotata di consideration, produce un obbligo giuridico indipendentemente dalla qualificazione del negozio in cui s'inquadra.
Così facendo, si sperava di sottrarsi alla non semplice definizione di queste nuove fattispecie alla luce del diritto italiano. Ma il momento di riflessione è solo rinviato. È rinviato fino a quando, ad esempio, si dovrà comprendere, allo scopo di iscrivere i titoli nel bilancio di eventuali sottoscrittori italiani, se essi siano partecipazioni, obbligazioni o titoli atipici, oppure se il rapporto sottostante sia un rapporto di società, di mutuo, di associazione in partecipazione o altro, onde determinarne il regime in occasione dell'insolvenza delle parti(14). A quel punto, emergeranno le difficoltà. Si dovranno definire obbligazioni e diritti in base al diritto inglese, si dovranno sussumere i rapporti giuridici nei tipi di quell'ordinamento e verificare a quali tipi italiani essi equivalgano. I problemi quindi si saranno numericamente moltiplicati.
Non solo sarà aumentato il numero delle incognite , ma anche la loro complessità. Questo perché, al momento di tipizzare le stesse notes ed il rapporto contrattuale causa della lorò emissione in base al diritto inglese(lS), non ci si potrà avvalere dell'espe-
Note
( 13) Il legislatore avrebbe deliberatamente inteso lasciare alla "fantas ia" creatrice della prass i finanziaria, la possibilità di individuare tipologie di titoli le più idonee alle operazion i da realizzare: F. Mai meri, Prime osservazioni sul disegno di legge in tema di cartolarizzazione dei crediti, Ban ca, borsa e tit. di cred., 1999, l , 244.
(14) Mi riferisco, ad esempio, alla disciplina dei rapporti giuridici preesistenti al fallimento (art. 72 della legge fallimentare) o al fallimento del socio occulto di società occulta (art. 147, II comma della legge fallimentare)
(15) Sebbene esse abbiano un legame genetico con il trust , nulla impedisce di ricorrere alle credit linked notes per incorporare i diritti nascenti da un contratto. In realtà, ciò avviene comunemente nelle operazioni di cartolarizzazione svolte in ordinamenti civilistici che hanno introdotto una legge sulla cartolarizzazion e. Essendoci una legge che assicura la segregazione del portafoglio crediti, non si utilizza il u:ust e le credit linked notes sono emesse sulla base di un rapporto conrrattuale. Quando utilizzate in operazioni svolte in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che del trust riceve solo l'effetto segregativo , le credit linked notes sono normalmente emesse in base ad un rapporto contrattuale.
Ottobre 2000
Saggi
rienza dei common lawyers. Per prima cosa, essi di rado si dedicano a sottili distinzioni concettuali, prima che i problemi concreti nascano(16). In secondo luogo, gli anglosassoni maneggiano la tecnica di tipizzazione con poca destrezza e poco si preoccupano di tipizzare(17). In terzo luogo, essi non si sono mai confrontati con questo genere di problema. Nel loro sistema, le credit linked notes sono utilizzate per incorporare i diritti nascenti da un trust e, quasi mai, sono emesse in base ad un contratto.
Tentare di mettere ordine in questa situazione confusa sarà allora compito del comparatista. Egli dovrà, innanzitutto, comprendere il flusso giuridico, evidenziarne il quadro di riferimento nell'ordinamento d'origine e valutare il risultato delle modificazioni a cui è stato sottoposto. Sarà poi necessario comprendere se il bisogno che lo ha chiamato è effettivo o semplicemente putativo, se il flusso possa essere metabolizzato, riconducendolo a strutture già esistenti del nostro ordinamento, o se sia realmente necessario ricorrere a negozi e titoli disciplinati dal diritto inglese. In tal caso egli dovrà valutare se la via imboccata fino ad ora sia quella più appropriata.
A tale analisi verranno dedicate le pagine che seguono.
§6. Credit linked notes: definizione della fattispecie.
Le credit linked notes sono titoli destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro a termine e di una remunerazione, normalmente periodica (a seconda dei casi, un interesse fisso, un interesse variabile indicizzato, o una partecipazione agli utili dell'operazione di cartolarizzazione).
La peculiarità di tali titoli sta nel forte legame esistente tra l'obbligazione di rimborso dell'emittente ed il portafoglio crediti oggetto di cartolarizzazione(18), legame che emerge in tutte le clausole che caratterizzano l'allestimento di questi titoli.
In primo luogo, esiste un obbligo di rimborso anticipato · condizionato al verificarsi di determinati eventi (credi t events), indici di possibile sofferenza ed inesigibilità dei crediti di riferimento (ad esempio, la sospensione dei pagamenti da parte dei debitori). All'accadere di questi eventi è subordinato anche il venir meno dell'obbligo di corrispondere gli interessi.
I titoli contengono poi alcune clausole che mirano a creare un legame antologico tra obbligazione in-
Ottobre 2000
corporata e crediti di riferimento. Le emissioni di questi valori mobiliari si caratterizzano per il frazionamento in diverse classi. Tranne una, tutte le classi contengono una clausola di subordinazione, con la quale si stabilisce la postergazione delle pretese dei portatori sui flussi finanziari generati dal portafoglio crediti a quelle di tutti gli altri titolari di notes non ugualmente subordinati( 19).
Si crea, in questo modo, un ordine di priorità nella ripartizione delle somme effettivamente riscosse e si proroga altresì la scadenza per quella parte del debito che non può essere immediatamente estinto. Infine, nel momento in cui la possibile sofferenza dei crediti diviene effettiva inesigibilità- e quindi diviene certo che non tutti i titoli possano essere rimbor-
Note
(16) V. R. Pound, What is Common Law7, in AA.VV., The Future of the Common Law, Cambridge, 1937, 3, a p. 18. ("The common law lawyer habitually looks at things in the concrete, not in abstract and puts his faith in experience rather than abstractions ... !t is the frame of mind behind the surefooted Anglo-Saxon ha bit of things as they arise instead of anticipating them by abstract formulas"); L. Cooper, The Common La w and the Ci vi l La w- A Scot's View, 63 Harv. L. Rev. 468 (1950) 470 ("A civilian system differs from a common law system much as rationalism differs from empirism or deduction from induction [ ... ]. The instinct of a civilian is to systematise. The working rule of the common lawyer is solvitur ambulando").
(17) V. G . De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, pp. 35-42. Sebbene si debba riconoscere che "la tipizzazione e/o qualificazione quale strumento di identificazione della normativa applicabile ad un fenomeno pur non specificatamente regolato dalla legge è un'operazione caratteristica soprattutto dei sistemi di civil la w" (così S. M. Carbone & A. D'Angelo, Cooperazione tra imprese e appalto internazionale, Milano, 1991, p. 20) occorre anche aggiungere che, a volte, anche i common lawyers sono costretti a tipizzare. Mentre i giuristi continentali tipizzano non solo per rendere applicabile la disciplina privatistica riservata dalla legge a quel fenomeno e risolvere i conflitti d'interesse tra le parti ma anche per rendere applicabile le norme tributarie, fallimentari, amministrative che presuppongono l'esistenza di rapporti giuridici inquadrabili in determinati tipi contrattuali, i common lawyers tipizzano solo a questo secondo fine. Non si può quindi dire che, in generale, i giuristi angloamericani non tipizzino, anche essi lo fanno, ma lo fanno meno frequentemente e, aggiungerei, con minor finezza. Dunque, è tipizzare un'attività tipica dei civilisti per risolvere i conflitti d'interesse tra le parti contrattuali, ma non è, in generale, attività loro esclusiva.
(18) Quesri titoli sono inclusi nella categoria dei "credit derivatives": v. F. Caputo N assetti, I contratti derivati di credito, Milano, 1998, p. 377.
(19) Al fine di garantire un alto rating da parte delle agenzie incaricate di questo servizio ed indurre il pubblico a sottoscrivere le credit linked notes, occorre prevedere un potenziamento del credito. Occorre, cioè, fornire strumenti per rassicurare gli investitori che un'eventuale sofferenza del portafoglio crediti non si rifletta sui loro diritti. Per fare ciò, la clausola di postergazione o subordinazione, tramite la quale alcuni sottoscrittori accettano di postergare le proprie pretese a quelle di tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati, è lo strumento più adatto. L'ente generatore od una società a questo collegata sottoscrive i titoli postergati creando un cuscinetto su cui si scaricano per prime le eventuali sofferenze del portafoglio. I sottoscrittori terzi hanno così una maggior tutela.
J t
J
i
sati con le somme generate dai crediti - è previsto che l'obbligazione di rimborso si estingua per quella parte del prestito che rimarrebbe, altrimenti, insoddisfatta( 20).
Le clausole in questione fanno emergere in modo piuttosto evidente il fatto che questi titoli sono creati per incorporare i diritti n ascenti da un trust(21).
Esse richiedono un'analisi particolare quando, invece, i titoli sono emessi in base ad un contratto.
In questo caso, anche se in modo non facilmente riconoscibile, tali clausole pattuiscono la partecipazione degli investitori alle perdite dell'operazione di cartolarizzazione. Infatti, bisogna tener presente che la somma raccolta dall'emissione dei titoli, che è quindi quella da rimborsare, corrisponde al prezzo pagato dall'ente gestore per acquis tare il portafoglio crediti. Pertanto, affermare che le obbligazioni pecuniarie incorporate nei titoli si estinguono se i flussi finanziari generati dalla riscossione del portafoglio crediti sono insufficienti per soddisfarle significa stabilire, in sostanza, che il diritto al rimborso del capitale si estingue se i crediti di riferimento non generano un flusso pari alloro valore d'acquisto o, in altre parole, se la differenza tra il loro valore d'incasso e quello d'acquisto è negativa. Poiché tale differenza non è altro che la perdita de ll'ente gestore nell'operazione di cartolarizzazione, è evidente che la clausola in questione pattuisce l'estinzione dell'obbligazione di restituzione quando l'operazione risulta in una perdita.
§ 7. Credi t linked notes, rapporto fonda ..
Trusts Saggi
che contratti di credito tipici (loan) o atipici. La common law, infatti, è priva di quei tipi intermedi tra mutuo ( loan) e società (partnership) che il nostro diritto conosce come associazione in partecipazione e cointeressenza impropria. La silent partnership, comunemente ritenuta l'equivalente di un'associazione in partecipazione, non è altro che una partnership , e produce gli effetti giuridici di una società senza personalità giuridica(22); mentre il profit partecipating loan, comunemente ritenuto l'equivalente di una cointeressenza impropria ( un'associazione in partecipazione senza partecipazione alle perdite), non è altro che un loan e produce gli effetti giuridici di un mutuo. Pertanto, per comprendere la natura del rapporto sottostante alle credit linked notes, div iene essenziale tracciare la linea che separa il contratto di partnership da quelli di cred ito, il cui prototipo è il loan. Questi contratti sono evidentemente differenti e facilmente distinguibili in teoria, ma è tutt'altro che agevole distinguerli nella pratica.
§8. Loan e partnership nelle definizioni.
Le differenze nascono già a livello di definizione dei due tipi. Il contratto di loan of money è descritto come
"a contract whereby one person lends or agrees to !end a su m of money to another, in consideration of a promise express or implied to repay that sum on demand, or at a fixed or determinable future time, or condit ionally upon an event which is bound to happen, with or without interest"(23 ),
mentale e tipi dell'ordinamento inglese. Note
Compresa la portata di queste clausole, occorre ora comprenderne la rilevanza per la qualificazione del rapporto sottostante, quando questo sia, come è avvenuto per le cartolarizzazioni fino ad ora svolte in Italia, un contratto di diritto inglese.
A primo acchito, l'allestimento illustrato sopra porterebbe, in diritto italiano, a ricondurre il rapporto fondamentale vuoi al mutuo, vuoi all'associazione in partecipazione, vuoi ad un contratto di finanziamento atipico.
Ben diverse sono le conclusioni quando sia il diritto inglese ad essere applicabile.
In diritto inglese, l'allestimento dei titoli colloca il rapporto sottostante in una vasta area che comprende sia contratti associativ i (partnership)
(20) E così si pattuisce che "if the net proceeds of the realization of, or enforcement with respect to, the credit portfolio are not sufficient to make all payments due in respect to the Notes, the issuer shall be under no obligation to pay, and the other assets of the issuer will not be available forche payment of any shotfall. Accordingly, ali claims in respect of any shartfall shall be estinguished and the N otesholders shall have no further d ai m against the issuer in respect t o su c h unpaid amounts". A volte si ricorre ad una clausola formalmente diversa, ma sostanzialmente identica: "CLN's are payable only to the extent that the cash flow from the credit portfolio are available for distribution to holders of each class of C redi t Linked Notes".
( 21 ) V. nota 12.
(22) Un silent o dormant partner è semplicemente un partner che "takes no acri ve part in the management of the business", C. D. Drake , Law of Partnership, London, 1983, p. 55; E. R. Hardly lvamy, Underhill's Principles of the La w of Partnership, London, 1986, p. 9.
(23) J. Chitty, The La w of Contracts, London, 1999, Il, p. 700. Sul contratto di loan vedi anche R. Burgess , La w of Loans and Borrowing, London, 1989.
Ottobre 2000
Saggi
mentre la partnership è definita come
"the relation which subsists between _persons carrying on a business in common with a view ot profits"(24 ).
Differente è la fonte che ha prodotto le due defi~ nizioni: la dottrina per illoan, la legge per la partner~ ship. Differente è il loro ruolo: la definizione di loan ha una rilevanza giuridica limitata - ricondurre un contratto al tipo delloan non comporta effetti giuri~ dici particolari(25) -la definizione di partnership ha invece un'importanza notevole - ricondurre un con~ tratto ad una partnership significa imporre su una par~ te la responsabilità illimitata per le obbligazioni as~ sunte verso terzi dall'altra e comporta l'applicazione al rapporto delle norme del Partnership Act 1890 in~ glese non espressamente derogate dalle parti. Dissi~
mile, inoltre, è la tecnica definitoria: illoan è defini~ to tramite una descrizione della fattispecie negoziale, la partnership mediante un riferimento al rapporto che nasce dal contratto(26).
Mentre gli elementi essenziali di un loan emergo~ no chiaramente dalla definizione, quelli di una part~ nership no: occorre quindi identificarli comprenden~ do cosa significhi "persons carrying on a business in common with a view of profits".
La section 2 del Partnership Act 1890 fornisce un qualche indizio, stabilendo che:
"in determining whether a partnership does or does not exist, regard shall be had to the following rules: (l) joint tenancy, tenancy in common,. joint propertyl common property or part ownershtp ooes not ot ttse f create a partnership as to anything so held or owned, whether the tenants or owners do or do not share any profits made by the use thereof. (2) The sharing of gross retums does not of itself create a parrnership, wl:lether the persons sharing such retums have or ha ve nota joint or common righr or interest in any property from which or from the use of which the returns are derived. (3) The receipt by a persan of a share of the profits of a business is prima facie evidence that he is a partner in the business, but receipt of such a share, or of a payment contingent on or varying with the profits of a business, does not of itself make him a partner in the business; and in particular- (a) The receipt by a person of a debt or other liquidated amount by instalments or otherwise out of the accruing profits of a business does not of itself make him a r.artner in the business or liable as such; (b) A contract far the remuneration of a servant or agent of a person engaged in a business by a share of the profits ot the business does not of itself make the servant or agent a partner in the business or liable as such; [omissis] (d) The advance of money by way of loan to a person engaged or about to engage in any business on a contrae t with that person that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits, or shall receive a share of the profits arisin_g from
·carrying on the business, does not of itself make the lender a partner with the person or r.ersons carrying on the business or liable as such. Provided that the contract is in writing, and signed by or on behalf of all the parties thereto; (e) A person receiving by way of annuity or otherwise a portion of the profits of a business in consideration of the sale by him of the goodwill of the busi-
Ottobre 2000
ness is no t by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such".
Con questa disposizione, il legislatore ha voluto fornire all'interprete una guida per determinare quali clausole contrattuali non originano di per sé un rapporto di partnership, ma ben si comprende che egli abbia voluto lasciare alla giurisprudenza il compito di determinare la fattispecie della partnership. La mancata definizione legislativa dei tratti distintivi della partnership ha dato origine ad una notevole incertezza applicativa, tanto che determinare se nei fatti esista o meno si è dimostrato essere "the most tormented and heavily litigated area of partnership law"(27).
Come sarebbe naturale per gli ordinamenti di common law, la giurisprudenza ha sempre affrontato la questione con una serie di sentenze fortemente legate ai fatti(28) . Spettava alla dottrina individuare da queste gli elementi distintivi del tipo, ma essa, non molto allenata a questo tipo di operazioni, non lo ha fatto. Si è semplicemente limitata a riportare in modo sistematico le varie decisioni su specifiche clausole che rendono un contratto una partnership, senza avventurarsi nella costruzione di un modello astratto.
§9. Loan e partnership nella pratica.
L'individuazione di tutti i tratti distintivi della partnership è un compito che supera l'economia e gli scopi di questo lavoro. Io mi limiterò ad individuare l'elemento o gli elementi essenziali che permettono di distinguere questo contratto dalloan, prototipo dei contratti di credito, perché qui interessa principal-
Note
(24) Section 1(1) del Partnership Act 1890.
(25) J. Chitty, The Law ofContracts [supra, nota 23], § 3157 ("whether a particular transaction is, or is not a loan, will often ha ve little significance per se, it will be contractual in nature and will tale effect according to the intentions of the parties however the contract may be classified").
(26) "Although the act does not say so the partnership relation arises from contract, express or implied", C. D. Drake, Law of Partnership [supra, nota 22], a p. 28.
(27)]. Crane & A . Bromberg, Law ofPartnership, St. Paul, 1968, p. 32. Quest'affermazione formulata dalla dottrina americana è perfettamente applicabile anche alla situazione inglese.
(28) La distinzione tra sentenze-principio, sentenze-regola, sentenze-caso è di M. Lupoi, L'interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?, Contr. e lmpr., 1999, 234.
T l
j J 1
1 l
"l
.J l
l .. l
1
l l
mente comprendere se il rapporto sottostante alle credit linked notes sia una partnership od un contratto di credito.
Un elemento di discriminazione tra questi negozi non può essere considerato l'attribuzione di un capitale alla controparte, la quale può impiegarlo nel suo interesse e deve restituirlo alla scadenza. L'attribuzione di un capitale è infatti un elemento costante del loan of money e può, seppur non debba, essere anche un elemento della partnership. Può essere elemento proprio della partnership ed è elemento proprio del loan of money, in quanto in quest'ultimo contratto l'attribuzione di un capitale è elemento costante, mentre nella partnership il capitale può essere sostituito da apporti di altra natura, quali il lavoro, il godimento di un bene o addirittura non essere presente(29).
Un fattore di differenziazione fra i due tipi non si può nemmeno cercare nella forma del corrispettivo: la partecipazione agli utili può essere benissimo pattuita nel contratto di loan(30) ed è naturale in quello di partnership; una remunerazione fissa è perfettamente compatibile con il contratto di partnership(31) e quindi, naturale per illoan, può essere pattuita anche in una partnership(32).
Non molto indicativa è la presenza del potere di gestione: possono infatti esistere partners privi del potere di gestione(33) e possono esistere lenders con potere di gestione(34 ).
Altrettànto irrilevante è l'esistenza di un fondo comune: esso manca sempre nel loan ma può, a volte, mancare anche nella partnership(35).
Molto più significativa è la presenza di una clausola di partecipazione alle perdite. Questa è stata determinante per distinguere loan e partnership nel leading case Pooley v Driver(36). Quando un contratto con il nomen di partnership prevede un apporto in denaro e le parti pattuiscono espressamente la totale esclusione dalla partecipazione alle perdite anche entro il limite dell'apporto, il contratto non è più una partnership ma un loan(37).Viceversa, se, in un contratto con il nomen di loan, le parti stabiliscono che il diritto dellender di ottenere la restituzione del capitale si estingue al verificarsi di perdite del borrower, il contratto non è più un loan ma diviene una partnership(38). Si deve allora concludere che, quando il diritto al rimborso del capitale è incondizionato si avrà un loan(39), mentre quando è condizionato risolutivamente al verificarsi di perdite in capo al debitore, si avrà una partnership( 40).
Saggi
§ 10. Credit linked notes: titoli che incor.porano lo status di partner.
Si è detto sopra come l'allestimento dei titoli faccia partecipare gli investitori alle perdite dell 'operazione di cartolarizzazione, condizionando risolutivamente il diritto al rimborso all'esistenza di perdite in capo al debitore. Poiché una partnership può esistere anche in relazione ad un singolo affare(41), è allora evidente che, quando le notes siano emesse sulla ba-
Note
(29) Può esistere un partner "w ho puts nothing in- neither capitai, nor skill nor anything else": così Pooley v Driver (1 877) 5 Ch.D. 458, per )essei M. R. , a p. 473.
(30) Badeley v Consolidateci Bank (1 888) 38 Ch.D. 238; Re Young, ex parte )ones [1896] 2 Q.B. 484.
(31) Stekel v Ellice [1 973]1 ALI ER 465; [1 973]1 WLR 191.
(32) Con particolare chiarezza N. Lindley, Treatise on the Law ofPartnership , London, 1984, p. 199.
(33 ) N. Lindley, Treatise on the Law of Partnership [supra, nota 32], a p. 475.; "contro! has nothing whatever to do with the existence or nonexistence of a partnership". Nel dirit to della provincia canadese dell'Alberta, v. Volzke Construction Ltd. v Westlock Foods Ltd . [1986] W.W.R. 668 (Can. Alta. ).
(34) N . Lindley, Treatise on the Law of Partnership [supra, nota 32], a p. 96. ("where the advance is in truth one of loan pure and simple, the fac t that the lender is to ha ve the management of the business does not necessarly make him a partner").
(35) Formont v Coupland (1 824) 2 Bing. 170; George Hall & Son v Platt [1 954] T. R. 331. N. Lindley, Treatise on the Law of Partnership [supra, nota 32], a p. 96 ("it is not essenrial to the existence of partnership that there shall be any joint capitai or stock").
(36) (1 877) 5 Ch. D. 458.
(3 7) N . Lindley, Treatise on the Law of Partnership [supra, nota 32], p. 95 .
(38) N . Lindley, Treatise on the Law of Partnership [supra, nota 32], p. 96.
(39) Lord Devii n ha espressamente sottolineato l'importanza dell'obbligo di restituzione dell'apporto come elemento essenziale delloan: Chow Yooing Hong v Choong Fah Rubber Manufactory [1962] A.C. 209, a p. 215; v. anche Neilson v Stewart 1990 S.L.T. 346 ("it is implied in every contract of loan that the lender is entitled to repayment of the money" ). Anche in dottrina quest' idea è diffusa: Lindley afferma espressamente che nel contratto di loan "the money lent is to be repaid intact, and the only risk run is the insolvency of the borrower" (N. Lindley, Treatise on the Law ofPartnership [supra, nota 32], a p. 113 ).
(40) "In considering whether there is a bona fide loan the practitioner must remember that a necessary consequences of a loan is a personalliability on the borrower's part to repay it. An arrangement by which a lender is only to be repaid out of the business can therefore never be a loan but must be a partnership": così E. R Hardy lvany, Underhill 's Principi es of the La w of Partnership [supra, nota 22], p. 11.
(41) Mann v d'Archy [1 968] 2 A LI. E.R. 172.
Ottobre 2000
Saggi
se di un contratto retto dal diritto inglese, questo sia una partnership. Questi titoli sono allora partecipazioni e vanno iscritti nel bilancio di eventuali acquirenti come tali(42). Inoltre, essi incorporano lo status di partner, con i relativi obblighi, e non un semplice diritto nascente da un contratto di finanziamento. In questo modo, gli investitori si troveranno in una posizione per loro indesiderata: dovranno, infatti, rispondere delle obbligazioni contratte dall'ente gestore nello svolgimento dell'operazione.
È ovvio che questo abbia un impatto notevole sul successo di un'operazione di cartolarizzazione e possa essere fonte di responsabilità per chi abbia causato tale situazione.
Ed allora si dovranno pensare delle alternative per il futuro.
La prima, ed apparentemente la più semplice, alternativa è quella di sottrarre titoli e rapporto fondamentale al diritto inglese e farli governare dal diritto italiano( 43 ). Per fare ciò, si deve comprendere se la stessa struttura negoziale e cartolare possa essere ottenuta ricorrendo agli strumenti del nostro diritto.
§ 11. Credit linked notes, rapporto fonda.mentale e tipi dell'ordinamento italiano.
Affrontiamo ora la questione se le credit linked notes ed il rapporto sottostante possano essere metabolizzati dal nostro ordinamento ed essere ricondotti ai tipi del codice( 44).
La poca dottrina che si è occupata del problema non ha raggiunto un accordo.
Ritenendo che il meccanismo contrattuale relativo alla restituzione delle notes influenzi solamente la certezza della prestazione d'interessi e che, sebbene la renda variabile, non la renda incerta, vi è chi ha affermato che sarebbe possibile emettere questi titoli sotto forma di obbligazioni e ricondurre il rapporto sottostante ad un mutuo perché lo schema del mutuo presuppone la sola certezza dell'an, non necessariamente del quantum del diritto alta remunerazione ( 45 ). Al contrario, vi è chi esclude che le credit linked notes siano riconducibili ad obbligazioni ed il rapporto sottostante ad un mutuo; ritenendo che la responsabilità limitata dell'ente gestore, il quale risponderebbe delle proprie obbligazioni solo con parte del proprio patrimonio ("limited recourse"( 46) ), sia incompatibile con lo schema del mutuo e delle obbligazioni. Secondo questa dottrina i titoli apparterrebbero alla categoria dei derivati di credito - cate-
Ottobre 2000
goria di dubbio significato giuridico, a dir la verità -ed il rapporto sottostante sarebbe un contratto atipico(47) .
È evidente che la questione meriti un'ulteriore riflessione.
Infatti, coloro che sostengono la compatibilità delle credit linked notes con i profili tipologici delle obbligazioni e del mutuo, concentrandosi sulla certezza dell'an del diritto alla remunerazione, dimenticano che il mutuo oneroso è caratterizzato non solo dalla certezza dell'an del diritto alla remunerazione ma anche dalla certezza dell'an del diritto di rimborso del taritundem, che invece nelle notes è tutt'altro che certo.
Invece, coloro che negano la compatibilità delle credit linked notes con i tipi dell'obbligazione e del mutuo a causa della responsabilità limitata del debitore dimenticano che nella legge 30 aprile 1999, n. 130 non c'è nessuna norma che limiti la responsabilità dell'ente gestore e deroghi al principio stabilito dall'art. 2740 cod. civ. nei confronti degli investitori. Vero è che l'art. 3 stabilisce che sul portafoglio crediti non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli(48), ma sembra impro-
Note
(42) Poco importa se la fattispecie che in diritto inglese dà origine ad una partnership è differente da quella che in diritto italiano dà origine ad una società, poiché è il diritto inglese a dover qualificare il rapporto sot· tostante ed a dettarne la disciplina.
(43) La semplice partecipazione alle perdite non è sufficiente in diritto ita liano a dar vita ad una società: v. G . Ferri, Diritto commerciale, Torino, 1980, p. 243.
( 44) È nota la tradizionale tendenza dei giuristi a definire, interpretare e regolare nuovi fenomeni secondo nozioni e tipologie conosciute e consolidate: v. G. De N ova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; R. Sacco, A utonomia contrattuale e tipi, Riv. trim. dir. proc. c iv., 1966, 785.
(45) F. Caputo Nasetti, I contratti derivati di credito [supra, nota 18], pp. 77-79.
(46) In diritto inglese il concetto di limited recourse indica il fenomeno della responsabilità limitata. N ella letteratura di quei civilisti che vogliono avvicinare il diritto straniero senza conoscenza dei fondamenti della comparazione, spesso si utilizza questo termine per indicare un fenomeno diverso: l'estinzione dell'obbligazione. La confusione è eviden· te: obbligazione e responsabilità, sebbene congiunti, sono due fenomeni diversi.
(47) C. Ruccellai, La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, Giur. comm., 1999, 411, a pp. 413-41 5.
( 48) Questa disposizione stabilisce che "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della soc ietà e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi".
l ~
' l l l ' l
i }
J l
t ]
j
prio concludere che questa disposizione stabilisca la responsabilità limitata dell'ente gestore nei confronti dei portatori dei titoli. Questa norma impedisce agli altri creditori del gestore di soddisfarsi sul portafoglio crediti, ma non impedisce ai portatori dei titoli di soddisfarsi sul patrimonio generale dello stesso. La responsabilità limitata, dunque, esiste nei confronti degli altri creditori personali dell'ente gestore, non nei confronti dei portatori dei titoli(49). Infine, chi n ega la compatibilità delle credit linked notes con i tipi dell'obbligazione e del mutuo, a causa della responsabilità limitata del debitore, dimentica anche che la responsabilità limitata - qualora realmente esistesse - appartiene alla sfera della disciplina, e non a quella della fattispecie, ed è perciò irrilevante per il processo di tipizzazione(SO).
Compreso ciò, ben si intuisce che il problema di qualificazione delle credit linked notes e del rapporto loro sottostante dipende dalla confusione esistente sui tratti caratterizzanti il mutuo e l'obbligazione e su quelli che li differenziano dai tipi contigui.
§ 12. Mutuo, associazione in partecipazio .. ne, contratto atipico.
Per quanto riguarda il rapporto fondamentale, abbiamo anticipato sopra che questo potrebbe essere ricondotto ad un'area che comprende mutuo, associazione in partecipazion e e contratti di finanziamento atipici. Prima di espungerlo dal novero dei contratti tipici, occorre, tuttavia, verificare se esso non possa effettivamente essere ricondotto al mutuo o all'associazione in partecipazion e .
Pochi dubbi esistono sul fatto che questi due tipi vadano differenziati( 51), molte incertezze, invece, esistono sul come farlo . Tra i tanti criteri distintivi indicati dalla dottrina(52) è difficile trovarne uno che permetta di ascrivere con certezza il rapporto in questione all'uno o all' altro tipo. Conviene quindi abbandon are le sovrastrutture dottrinali e tentare di risolvere la questione con spirito vergine.
L'art. 1813 cod. civ. stabilisce che "il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità d i danaro e cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie"; l'art. 2549 cod. civ. definisce l'associazione come il contratto con cui "l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli u.tili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".
Trusts S a ggi
Dalla lettura delle norme appare evidente che l'attribuzione di un capitale alla controparte è compatibile sia con il mutuo che con l'associazione in partecipazione. Questo elemento è q'uindi irrilevante per il processo di tipizzazione del rapporto causa di emissione delle credit linked notes(53). La presenza o l'assenza di un obbligo incondizionato di restituzione è, invece, molto più significativa: sono incompatibili con lo schema legale del mutuo le clausole che prevedono che il mutuatario sarà tenuto a restituire la somma mutuata solo non verificandosi un detenninato evento( 54); sono invece compatibili con l'asso-
Note
( 49) Se, invece, la dottrina c itata ritenesse che esiste una responsabilità limitata per il fatto che l'allestimento dei titoli prevede che il diri tto al rimborso si est ingue quando i flu ssi generati dai cred iti sono insuffi cien ti a soddisfare i portatori dei titoli, il fraintendimento sarebbe ancora maggiore: la clausola in questione stabilisce l'estinzione dell 'obbligazione non la responsabilità limi tata.
(50) Un cenno in questo senso si trova già in S . Pugliatti, Gli istitut i del diritto civile, Milano, 1943 , p. 303 .
(51) G . Sbisà, Certificati Immobiliari, Banca, borsa e tit. di cred., 1979, l, 498.
(5 2) "Il modo reale del perfezionamento del mutuo è estraneo al processo di formazione dell'associazione in partecipazione; il mutuo può essere gratuito mentre, nell'associazione in partecipazione, l'attribuzione di ut ili non può mancare, anche se in concreto l'associato non ne venga a percepire o debba corrispondere perdite; l'apporto nell'associazione in partecipazione può avere per oggetto cose fungibili , come deve averlo il mutuo, e può consistere pure in un'obbligazione di garanzia o in prestazione di lavoro; l'obbligazione di interess i può essere in misura fissa, mentre nell'associazione in partecipazione l'associato ha, nell 'attribuzione degli utili, un vantaggio variabile; l'obbligazione di restituzione dei fungibili dati dall'associato non comporta, come nel mutuo, la restituzione del tantundem integrale, ove si siano avute perdite; l'obbligo di restituzione, nell'associazione in partecipazione, non comporta la restituzione dello stesso genere; la commisurazione degli interess i ad una quota degli utili di un affare o di un'attività economica non è sempre partuita in contemplazione di un obbligo di destinare a quell'affare le cose mutuate, anche se tale destinazione è motivo determinante per entrambe le parti; quando v'è associazione v'è anche obbligo di collaborazione per il conseguimento dello scopo per il quale fu costituita, obbligo mancante nel mutuo": v. M. Fragali, Del mutuo, Bologna-Roma, 1966, pp. 316-317. Ritenendo, contrariamente all'opinione dominante, l'associazione non un contratto di credito ma un contratto associativo, altra dottrina aggiunge che "mentre il contratto di associazione appartiene alla categoria dei contratti di collaborazione, il contratto [mutuo] appartiene a quelli di scambio. Si può quindi ravv isare, subiettivamente una diversità di intento, obbiettivamente una d iversità di causa o fu nzione che si risolve in una diversità di disciplina": v. E. Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1994, pp. 282-283.
(53) Questo è riconosciuto anche dalla Suprema Corte: "il mutuo e l'associazione in partecipazione hanno comune l'elemento di un apporto economico da parte di un soggetto ad un altro, ma si differenziano per il corrispettivo (che nel mutuo è costituito normalmente da un compenso commisurato in una percentuale d'interessi e nell'associazione della partecipazione agli utili de ll' impresa) e, rispettivamente, per l'esclusione o meno dell 'alea della perdita dell 'apporto": Cass. C iv. l giugno 1964, n . 1368, Giust . civ. 1964, l, 2293 .
(54) V. A. Luminoso, I Contratti tipici e atipici, Milano, 1995, vol. l, p. 709.
Ottobre 2000
Saggi
ciazione in partecipazione queste clausole se, come indicato dall'art. 2549 cod. civ., questo evento consiste nel verificarsi di perdite in un affare o in un'impresa del debitore. Poiché l'obbligo di rimborso delle credit linked notes è condizionato risolutivamente, è evidente che, qualora si decidesse di emettere questi titoli in base ad un contratto di diritto italiano, questo non potrebbe essere un mutuo. Si potrebbe, in teoria, tentare di ricorrere ad un'associazione in partecipazione, dato che l'evento dedotto nella condizione è proprio il verificarsi di perdite in un affare. Per poter fare ciò, sarebbe comunque necessario pattuire che la remunerazione corrisposta ai portatori dei titoli sia costituita da una partecipazione agli utili. Anche se così fosse, non si potrebbe però essere certi di rientrare nello schema dell'associazione in partecipazione. Secondo parte della dottrina, infatti, il tipo legale non sarebbe compatibile con l'emissione ed il collocamento di titoli che documentino la "posizione" di associato( 55). Qualora non si potesse utilizzare lo schema dell'associazione in partecipazione, non rimarrebbe - il che è, a mio avviso, l'ipotesi più plausibile - che l'alternativa del contratto atipico ("il prestito a tutto rischio")(56). È ovvio che, in questo caso, ci si troverebbe a doverne valutare la validità: si dovrà determinare se sia diretto a realizzare interessi degni di tutela, come stabilito dall'art. 13 22 cod. civ., II comma, e se abbia una causa. Questo tema esula dall'economia di questo lavoro, ma si deve ricordare che, dalle poche pronunce che si sono occupate della validità di questo tipo di contratti, non è possibile affermare con sicurezza che i prestiti a tutto rischio siano sempre contratti validi.
Le sentenze in materia sono sentenze-caso, fortemente legate ai fatti, dalle quali non è possibile trarre nessuna regola ienerale che permetta di stabilire in anticipo la validità di un tale contratto(57). L'incertezza legata a questa ipotesi getta delle ombre su tutta l'operazione di cartolarizzazione. La stabilità dell'apporto degli investitori verrebbe messa in dubbio se, una volta giunti di fronte al giudice, egli dovesse decidere che il contratto è nullo. Questo, ovviamente, avrebbe conseguenze patrimoniali negative sia sull'ente generatore sia su quello gestore e comporterebbe çomunque l'attribuzione di un basso rating da parte delle società incaricate di tale servizio.
§ 13. Obbligazione o titolo atipico.
L'allestimento delle credit linked notes non solo
Ottobre 2000
porta ad espungere il rapporto sottostante dal novero dei contratti tipici, ma anche a rendere impossibile ricondurre i titoli stessi al tipo dell'obbligazione. Infatti, sebbene parte della dottrina ritenga che, a seguito dell'introduzione delle obbligazioni irredimibili e subordinate nel testo unico in materia bancaria e creditizia(58), il tipo dell'obbligazione debba essere ricostruito ormai come "forma giuridica" atta alla
Note
(55) V. M. Ghidini, L'associazione in partecipazione, Milano, 1956, pp. 204 ss.; V. Libonati, I problemi dell'inquadramento giuridico delle fattispecie esaminate, con particolare riguardo alle accettazioni, in V. Libonati & G. Visentini (cur.), Operazioni anomale di finanziamento con emissione di titoli, Milano, 1980, p. 27; F. Santoni, L'associazione in partecipazione, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, p. 535; G. De Ferra, voce "Associazione in partecipazione I) Diritto Commerciale", Enc. Giur., Roma, 1988, vol. 3, p. 3.
(56) Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un contratto con apporto di capitali e con corrispettivo fisso in cui l'obbligazione di restituzione è sottoposta a condizione risolutiva o sospensiva sia un contratto atipico ("il prestito a tutto rischio"): A. Luminoso, I Contratti tipici e atipici [supra, nota 54].
(57) La sentenza della Cassazione, Sezione III civile, 6 giugno 1967, n. 1248, Foro it., 1968, I, 1058, rappresenta uno dei pochi precedenti nel vigore del codice del1942. Di fronte ad un contratto nel quale un soggetto apporta ad un altro un tapitale e pattuisce che, verifi candosi la permuta di alcuni terreni e la successiva costruzione di un aeroporto su di essi, avrebbe ricevuto una maggiorazione del tasso di interessi ed un compenso una tantum, mentre, non verificandosi, avrebbe perduto il diritto di ottenere il rimborso delle somme apportate, la Suprema Corte decide che "l'accordo, che si risolve in un prestito a tutto rischio, per cui il mutuante si pone volontariamente nell'alternativa di riavere la somma mutuata con diritto ad un interesse elevato ed ad un premio in conseguenza della realizzazione molto probabile d'un affare vantaggioso, ovvero di perdere la somma in caso di sfavorevole congiuntura è espressione lecita dell'autonomia contrattuale, a norma dell'art. 1322 c.c., non urtando contro alcuna norma imperativa; senza dire che il mutuante, anche indipendentemente dalla possibilità di lucrare interessi in misura superiore a quella legale, può avere pur sempre un apprezzabile interesse a finanziare un'opera di grande rilievo, com'è un nuovo aeroporto, a cui possano ricollegarsi ulteriori possibilità d'affari e di ingenti guadagni, assumendosi anche il rischio di perdere il capitale mutuato, ove l'opera non possa essere realizzata. Ma la sentenza impugnata non può censurarsi neppure per aver ritenuto nel caso in esame la bilateralità dell'alea, perché se il [l'attore] si esponeva al rischio di perdere il capitale in caso di mancata permuta, anche [il convenuto] correva l'alea di dover pagare per diversi anni interessi superiori a normalmente realizzabili, qonché di un compenso forfetario, pure l'eventualità che non potesse ritrarre dalla permuta, a causa di onerose contingenze, il vistoso profitto che ~i era ripromesso, il che era pur sempre possibile, e non solo in astratto". E allora ovvio che i due elementi che hanno influenzato la decisione in favore della validità del patto, sono l'interesse dei finanziatori alla realizzazione dell'affare, il tasso di rendimento più elevato della norma, la corresponsione di compenso forfetario al realizzarsi dell'affare. Nel caso delle credit linked notes, a me sembra, gli investitori non ricavano nessun vantaggio diretto dal fatto che l'operazione di cartolarizzazione vada a buon fine o produca utili (ricavano svantaggi nel momento in cui non va a buon fine , ma non vantaggi nel momento in cui essa termina con un successo); essi, inoltre, non ricevono nessun corrispettivo particolare quando l'operazione produce utili (escluso, ovviamente il caso in cui siano remunerati con una partecipazione agli utili).
(58) Art. 12, VII comma del D. Lgsl. l settembre 1993, n. 385.
ì
i
J i J j ~ l
l
l ~
cartolarizzaz ione di pres titi, del tutto "neutra" rispetto alla qualificazione del rapporto sottostante, della quale in ultima analisi costituisce il solo vestimentum(59), non si deve dimenticare che la struttura dell'obbligazione presuppone sempre un obbligo di restituzione del capitale( 60). Gli stessi prestiti irredimibili, più che per la loro durata perpetua, che tale in realtà non è( 61), si caratterizzano per il solo fatto che "in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remuneraz ione nella misura necessaria ad evitare il più possibile l'insorgere di perdite"(62). Ed è allora evidente che, anche per questi titoli, sebbene incerta possa essere la remunerazione, certo comunque rimane il diritto al rimborso. Poiché, nelle notes, il diritto al rimborso è invece tutt'altro che certo, si deve concludere che esse non possano essere ricondotte al tipo dell'obbligazione e vadano considerate titoli atipici.
§ 14. Il flusso giuridico puro: credi t linked notes e trust.
L'analisi svolta in queste pagine h a fatto emergere alcuni dati importanti.
Per prima cosa, si è compreso come il bisogno che ha chiamato il flusso giuridico "credit linked notes" sia un bisogno effettivo: emettere i titoli in base ad un contratto regolato dal diritto italiano comporta incertezze che rappresentano un ostacolo importante alla buona riuscita dell'operazione di cartolarizzazione.
In secondo luogo, si è compreso che il flusso giuridico, così come modificato dalla prass i, a cui si è fatto ricorso per soddisfare questo bisogno, causa squilibri notevoli. Pericoloso è ricorrere a contratti di diritto inglese che mirino a sostituire il trust - componente essenziale dell'operazione di emissione nell'esperienza angloamericana- tentando di riprodurne contrattualmente la struttura dell'obbligazione: il rischio che una corte riscontri l'esistenza di una partnership tra ente gestòre ed investitori rappresenta un disincentivo addirittura maggiore dell'incertezza legata alla soluzione del contratto di diritto italiano.
Ed allora non rimane che riportare il flusso alla sua purezza, depurandolo degli inconvenienti che la sua manipolazione ha creato.
Ciò significa- e forse questa è la più logica e conveniente soluzione- percepire le credit linked notes assieme al rapporto sottostante da cui esse nascono nei sistemi angloamericani: il trust( 63).
Sul portafoglio crediti si istituirà un trust, non
Trusts Saggi
tanto allo scopo di segregare i beni( 64 ), ma al fine di creare un'obbligazione i cui destini sono legati ai destini dei crediti di riferimento. I sottoscrittori apporteranno del denaro all 'ente gestore ed, in cambio, riceveranno certificati che incorporano i diritti di un beneficiario del trust. Nessuna delle clausole che caratterizzano i titoli potrà trasformare il rapporto sottostante in partnership, perché il rapporto in base al quale esse sono emesse non è contrattuale.
Il ricorso al trust permetterà anche di offrire una maggior tutela agli investitori contro manovre fraudolente sul portafoglio crediti. Supponiamo, infatti, che l'ente gestore si accorga, dopo averlo trasferito, che il portafoglio crediti aveva un valore superiore al corrispettivo pattuito per la cessione all'ente gestore, vuoi per un'imprecisa valutazione iniziale, vuoi per l'avverarsi di condizioni economiche che migliorino notevolmente le possibilità di incasso. Poiché, di norma, l'ente generatore controlla direttamente o indirettamente l'ente gestore, può ben avvenire che, alfine di recuperare questo maggior valore, si deliberi una fusione tra ente gestore ed ente generatore. Cosa avverrà allora al portafoglio crediti? L'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n . 130 stabilisce la sua separazione dal patrimonio dell'ente gestore: ma quando l'ente gestore sia assorbito dall'ente generatore sarà possibile evitare che i creditori chirografari di quest'ultimo propongano azioni su di esso? Il ricorso al trust permetterà di mantenere la segregazione anche in assenza di un'esplicita presa di posizione della legge.
Note
(59) D. Galletti, "Elasticità" della fattispec ie obbligazionaria: profili tipologici delle nuove obbligaz ioni bancarie, Banca, borsa e tit. di cred., 1997, I, 239, a p. 267.
(60) Art. 2413 , IV co. cod. c iv ..
(61) La loro durata perpetua, in realtà, coincide, tutt'al più, con la vita de ll 'emittente: v. G. B. Portale, Prestiti subordinati e prestiti irredimibili, Banca, borsa e tit. di cred., 1996, l, l, 3 .
(62) Istruzioni di vigilanza de lla Banca d'Italia, XII, p.7.
( 63) È ormai acquisito da dottrina e giurisprudenza che sia possibile costituire in Ita lia trust interni: per tutti Trib. Lucca, 23 settembre 1997, Foro i t ., 1998, c. 2008. In dottrina, sul d ibatto riguardante il "trust interno" il classico rimane M. Lupo i [supra nota 2]; per una presentazione aggiornata delle posizioni dottrinali e della prassi giurisprudenziale v. L. Ragazzini, Trust "interno" e ordinamento giuridico italiano, Riv. not., 1999, 279.
( 64) Il ricorso al trust è, invece, necessario per ottenere la segregazione dei titoli e de lle somme riscosse quando l'attività di riscossione sia affi data dall'ente gestore a soggetti terzi, vedi A. Frignani, Trust e cartolarizzazione, in questa Rivista, 2000, 19 , e F. Maimeri, Il trust nelle operazioni bancarie. La cartolarizzazione dei crediti, ivi , 329.
Ottobre 2000
TIDSfS Saggi
Supponiamo, invece, che l'ente generatore pianifichi di frodare gli inve~titori e decida di alienare il portafoglio crediti ad una società collegata ad un valore inferiore a quello di presunto incasso. In questo modo, la somma disponibile per rimborsare i titoli sarà inferiore a quella che sarebbe stata disponibile se si fosse atteso l'incasso. In assenza di un trust, poche saranno le tutele offerte agli investitori: nessuna disposizione contenuta nella legge 30 aprile 1999, n . 130 potrà impedire questa operazione(65), la responsabilità dell'ente gestore si dimostrerà essere una magra soddisfazione (avendo l'ente gestore come scopo esclusivo la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, esso è sottocapitalizzato e quindi il patrimonio sui cui soddisfarsi è pressoché nullo), e la re-
Ottobre 2000
vocatoria apparirà un rimedio diffìcile ad attenersi. Il ricorso al trust, invece, garantirà agli investitori una valida tutela, grazie ai rimedi posti a tutela dei beneficiarii nei confronti dei terzi.
Nota
(65) L' art. l della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando stabilisce che "la presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cess ione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri , individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: [omissis]; b)le somme corrisposte dal debitore e dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diri tti incorporati ne i titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione", definisce la fa ttispecie per l'applicazione del legge, ma non detta nessuna disciplina. Questa disposizione, quindi, non determina l'inalienabilità dei credit i.