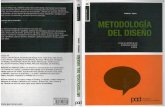Profili evolutivi del principio fraus omnia corrumpit tra «contratto in frode al terzo» e...
Transcript of Profili evolutivi del principio fraus omnia corrumpit tra «contratto in frode al terzo» e...
Sommario: 1. Inquadramento del problema. – 2. La categoria della frode al terzo ele sue differenti declinazioni. – 3. Dall’approccio strutturale al profilo funzionale delfenomeno: frode diretta «al terzo» ed effetto riflesso dannoso «verso i terzi». – 4. Ilprincipio fraus omnia corrumpit e i suoi rapporti con la figura dell’abuso del diritto.– 5. Segue: la frode al terzo in caso di abuso del tipo contrattuale e uso indiretto delnegozio giuridico. – 6. Segue: l’abuso della libertà di condurre trattative e il dovereex fide bona di non ledere i terzi. – 7. La portata applicativa del brocardo fraus om-nia corrumpit nell’ordinamento italiano e in quelli stranieri. – 8. «Contratto in frodeal terzo» e nullità ex art. 1345 c.c. (per motivo illecito – contrario all’ordine pubblicoe al buon costume – comune e determinante): rapporti con l’azione pauliana e di si-mulazione. – 9. «Contratto in danno di terzi» (valido ma non meritevole) e rimediorisarcitorio. – 10. «Contratto in frode al terzo» e violazione di una norma impera-tiva: verso la coincidenza tra frode alla legge e frode al terzo. La natura dell’interesseleso quale possibile criterio discretivo tra nullità e risarcimento. Cenni al fenomenodell’elusione tributaria: abuso fiscale, non meritevolezza dell’atto elusivo e rimediodell’inopponibilità. – 11. Frode al terzo e «giusto rimedio civile». Profili evolutivi epluralità di funzioni del principio fraus omnia corrumpit nel nostro attuale ordina-mento: da concetto giuridico autonomo, a categoria esplicativa di altri fenomeni giu-ridici rilevanti, a meccanismo correttivo nell’applicazione delle norme codicistiche. Ri-flessi sulla teoria delle fonti nel diritto privato.
1. La questione del contratto stipulato in frode al terzo e ai terzi portaall’attenzione una variegata, seppur esigua casistica, fatta oggetto nel tempodi accurate analisi da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza. Sitratta, per richiamare soltanto alcune delle fattispecie coinvolte, della dop-pia alienazione immobiliare, della violazione della prelazione legale o vo-lontaria, della locazione stipulata dall’usufruttuario in danno al nudo pro-prietario, del pegno di titoli costituito con un terzo e finalizzato ad arre-care pregiudizio ai creditori fallimentari, del concordato preventivo stipu-lato da alcuni creditori del fallito in pregiudizio di altri creditori e dun-que lesivo della par condicio creditorum, della responsabilità extracontrat-tuale derivante dall’impossibilità di agire in revocatoria ordinaria.
Sebbene le singole ipotesi in questione siano state ricostruite con grandeattenzione, è però mancato finora uno sforzo teso ad uno studio organicoe sistematico del problema della frode al terzo/verso i terzi e della tutela
Profili evolutivi del principio fraus omnia corrumpit tra «contratto in frode al terzo» e «contratto in danno di terzi»
di quest’ultimo/i. La complessità dell’indagine, d’altra parte, impone unarevisione critica di numerosi profili tra loro connessi, che muovono dal-l’attuale portata applicativa del principio generale fraus omnia corrumpitanche in relazione al suo rapporto con la figura dell’abuso del diritto, allaesatta individuazione della nozione e della funzione della categoria dellafrode, ai rapporti tra frode al terzo e frode alla legge, alla questione dellaflessibilità dei rimedi civili esperibili da parte del terzo/i in quanto corre-lati agli interessi di volta in volta rilevanti nel caso concreto.
2. Occorre preliminarmente rilevare, peraltro, che l’aspetto della tuteladel terzo/i, nel caso di interferenze sfavorevoli nella sua sfera giuridica de-rivanti dalla altrui contrattazione, risulta alquanto controverso poiché lafrode al terzo/i presenta un campo di indagine irregolare: se da un lato èpossibile in qualche modo tentare una ricostruzione del fenomeno in esame(al fine di differenziarlo da ipotesi limitrofe, come quella del contratto coneffetti onerosi per i terzi), dall’altro lato riesce piú difficile individuare ana-liticamente la tutela del terzo/i.
A ciò si aggiunga che maggiore concentrazione la nostra dottrina haprofuso nell’individuazione dei caratteri fondamentali della frode alla legge,della frode ai creditori, dell’illiceità dei motivi o di altri istituti collegati,che non in uno studio sistematico della frode al terzo/i. L’assenza di unadefinizione normativa del fenomeno, l’eterogeneità dell’oggetto di studioe la scarna produzione giurisprudenziale, il piú delle volte riferibile a casispecifici, hanno indotto piuttosto a dire ciò che la frode al terzo/i non è,senza al contempo delineare chiaramente e organicamente i caratteri e ladisciplina della categoria in indagine.
Gli studi condotti in passato sotto la vigenza del codice del 1865 – dataluni anche diretti a negare la configurabilità della categoria della frodeal terzo/i in nome della non superabilità del principio di relatività del ne-gozio1 – si limitano ad un approccio volontaristico, ricollegando il dannoarrecato al terzo (o a terzi determinati) prevalentemente alla volontà delleparti contraenti2. In vero, le prime teorizzazioni presentano il merito diaver contribuito alla diretta individuazione delle caratteristiche principalidell’interferenza negoziale sfavorevole verso i terzi: un accordo tra piú per-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 713
1 L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano (1948), rist., Napoli,2011, p. 689.
2 A. Sraffa, Contratto a danno di terzi, in Riv. dir. comm., 1903, I, p. 453 (in polemicareplica: S. Perozzi, Ancora sui contratti a danno di terzi, ivi, 1904, I, p. 64 ss.); L. Lordi, Con-tratti a danno di terzi e danno recato da terzi ad un contraente, ivi, 1937, II, p. 481 ss.
sone (parti), un danno ad un’altra persona (terzo), un nesso causale tral’uno e l’altro3.
Ben presto – nella prospettiva di superare il profilo meramente volon-taristico – ci si è resi però conto dell’esistenza di ipotesi legislative le quali«sanciscono l’effetto dannoso che da [determinati] contratti il terzo ricevee deve subire»4. Il dato che accomuna tali ipotesi si rintraccia nella circo-stanza che nessuna di esse si riferisce all’intento illecito dei contraenti,bensí alle conseguenze dannose che dal contratto derivano. Il legislatorestesso, pertanto, in questi casi ha scisso la qualificazione degli effetti sfa-vorevoli ai terzi dal presupposto della volontarietà, per attribuire rilevanzaanche a quegli effetti i quali, a prescindere dalla volontà delle parti, con-seguono in ogni caso al contratto5.
Rispetto al ricorrere di uno scopo diretto di ledere «il terzo», nell’i-potesi di effetto dannoso indiretto verso «i terzi», differenti risultano leconseguenze giuridiche sul fronte della tutela azionabile. Nella prima ipo-tesi (della frode diretta ad un terzo determinato), si potrebbe discorreredi contratto illecito, sia in quanto ricorrano i presupposti previsti dall’art.1345 c.c., sia in quanto l’illiceità colpisce la causa stessa del negozio. Ildanno costituisce dunque oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti, conconseguente nullità dello stesso. Il terzo potrà instare per l’accertamentodella nullità del contratto per illiceità, per cui gli compete azione, in quantointeressato sebbene non contraente (art. 1421 c.c.), nonché per l’ulteriorerisarcimento del danno o per la restituzione. Il terzo avrà l’onere di pro-vare il nesso causale tra il contratto ed il danno da lui subíto6. Nella se-conda ipotesi (dell’effetto dannoso indiretto verso i terzi), si fa riferimento,invece, agli effetti prodotti dal contratto e alla dannosità degli stessi: il ne-gozio è lecito e pienamente valido, ma comporta in qualche modo la le-sione o la compressione di interessi di particolari categorie di soggetti. Il
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi714
3 Discorre, all’uopo, di «rapporto fondamentale comune» M. Ferrara Santamaria, I con-tratti a danno dei terzi, Napoli, 1939, p. 27.
4 M. Ferrara Santamaria, o.c., p. 12. 5 Si tratta del c.d. effetto dannoso riflesso: v., sul punto, P. Perlingieri, Dei modi di estin-
zione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Art. 1230-1259, in Comm. c.c. Scialoja e Branca,Bologna-Roma, 1975, p. 28, il quale richiama anzitutto la classica ipotesi del diritto potestativo;già E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. Vassalli, XV, Torino, 1960,p. 268, individuava una categoria di terzi normalmente «indifferenti», la cui posizione è com-patibile con gli effetti del negozio, ma che sono legittimati a reagire quando siano lesi dai me-desimi effetti. V., altresí, C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 1ª ed., Milano, 1984,p. 541.
6 M. Ferrara Santamaria, I contratti a danno dei terzi, cit., p. 101; F. Messineo, Con-tratto nei rapporti con il terzo, in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 198.
danno al terzo può verificarsi di fatto, in quanto la situazione prodottariesce oggettivamente dannosa, ovvero può derivare, sempre di riflesso, dalcollegamento dei rapporti esistenti tra una delle parti e il terzo7: al terzospetterà rispettivamente azione di responsabilità extracontrattuale e azionedi responsabilità contrattuale contro il soggetto al quale è legato. L’illiceitàdel comportamento deriverà dunque dalla combinazione dell’accordo indanno al terzo e dal fatto dannoso che in esecuzione di quell’accordo siè procurato. Si ponga mente, per esempio, al campo del diritto societario:la società in nome collettivo che sia danneggiata dall’attività concorren-ziale di un socio può esperire un’azione di risarcimento del danno (2301c.c.), e cosí per l’amministratore di una società per azioni (2390 c.c.).
Ulteriori conferme possono trarsi con riguardo ai contratti di agenziae di mediazione. Si pensi al caso dell’agente, terzo rispetto al contrattoconcluso tra il proponente ed il cliente, ma legato al proponente dal con-tratto di agenzia. Se il proponente ed il cliente concludono il contratto di-rettamente senza il suo intervento, quindi in suo danno, perché non glisarà dovuta la provvigione, l’agente potrà esperire azione di responsabilitàcontrattuale contro il proponente e non azione di responsabilità extra-contrattuale. La stessa ipotesi si avrebbe nel caso di c.d. rifiuto sistema-tico del proponente di concludere i contratti promossi dall’agente8. In si-mile prospettiva si inscrive anche l’ipotesi della c.d. frode al mediatore, os-sia quel comportamento o quell’insieme di iniziative poste in essere daiclienti del mediatore con il proposito malizioso di negargli il compenso,cioè di eludere la corresponsione della provvigione, anche quando l’affaresia stato validamente concluso per effetto dell’opera dell’intermediario. Nonè raro che le parti, infatti, messe in relazione dal mediatore, revochino l’in-carico allo stesso, simulando l’abbandono dell’affare che, successivamente,concludono tra di loro, oppure proseguendo da sole le trattative. L’ipo-tesi di frode piú frequente si realizza quando, indipendentemente dall’e-sercizio della facoltà di recesso, viene negata e posta in discussione, neisuoi elementi soggettivi e oggettivi, la conclusione dell’affare. Opportuna-mente, in tali evenienze, la giurisprudenza attribuisce egualmente il diritto
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 715
7 F. Messineo, o.c., p. 197 ss.; A. Giovene, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino,1917, p. 221.
8 Cfr. Cass., 18 dicembre 1985, n. 6475, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1650: nel caso di rifiutosistematico (e ingiustificato) del preponente di accettare gli affari proposti dall’agente questi nonha diritto alla provvigione (che spetta solo nel caso di affari che abbiano avuto regolare esecu-zione, ex art. 1748 c.c., oppure che, conclusi, non siano stati eseguiti per causa imputabile alpreponente, secondo quanto disposto dall’art. 1749 c.c.); tuttavia, in caso di rifiuto sistematicoe pregiudiziale del preponente di dar corso alle proposte dell’agente, questi avrà il diritto al ri-sarcimento dei danni e, ricorrendone i presupposti, alla risoluzione del contratto di agenzia.
alla provvigione del mediatore, riconoscendosi che lo stesso, in quantoterzo rispetto al contratto concluso per effetto del suo intervento, è am-messo a provare con testimoni l’esistenza del contratto, come fatto sto-rico, al solo fine al domandare la corresponsione della provvigione, an-corché si verta in tema di negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam9.
Anche la piú recente prassi della contrattazione con i consumatori haarricchito il novero delle ipotesi nelle quali la mera proiezione effettualeconnessa all’esecuzione del negozio può rivelarsi indirettamente dannosaper i soggetti estranei al contratto: si pensi alla vicenda dei consumatorilesi «a valle» dall’esecuzione di un’intesa (contratto) anticoncorrenziale il-lecita assunta «a monte» dalle imprese colluse10. In questa prospettiva, evi-dentemente connessa alla propagazione degli effetti del negozio, lo svan-taggio per i terzi può cogliersi soltanto in chiave funzionale, ossia guar-dando al concreto assetto di interessi, per verificare se i soggetti abbianoo meno il diritto di ledere l’altrui sfera giuridica e in che cosa si concretitale lesione e interferenza. Nel medesimo contesto applicativo viene in ri-lievo l’ormai noto caso Courage: la Corte di giustizia, in deroga al prin-cipio dell’in pari causa, ha accordato il risarcimento del danno ad un ge-store di pub il quale, in base ad una clausola impostagli dalla contropartein attuazione di un’intesa vietata, stipulata con un terzo, aveva dovuto pa-gare le forniture di birra ad un prezzo superiore rispetto a quello prati-cato dal terzo sul mercato11.
3. Ne deriva che la ricostruzione della frode al terzo andrebbe rivistain chiave di interpretazione evolutiva, poiché il contratto con effetti sfa-vorevoli verso i terzi non può essere riguardato esclusivamente in una pro-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi716
9 Cfr. Cass., 16 giugno 1992, n. 7400, in Rep. Foro it., 1992, voce Mediazione, n. 15. Inogni caso l’agente potrà avvalersi anche del c.d. foglio di visita il quale, pur non costituendoun impegno contrattualmente vincolante o riconoscimento di debito, configura una dichiara-zione di scienza decisamente utile per agevolare la prova della mediazione, quando sia la stessaparte che ha compilato il foglio di visita a concludere, anche se tramite un prestanome, il con-tratto con il cliente dell’agenzia.
10 Il caso è esaminato da Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, I, c.1014 ss. In dottrina, relativamente al settore delle intese antitrust e dei loro riflessi sui contratti«a valle» stipulati con i consumatori, discorrono di «contratti in danno di terzi» V. Buono-core, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006, pp. 28 ss., 44 s.; A.M. Azzaro,Intese restrittive della concorrenza e (contr)atti in danno del consumatore, in Riv. dir. comm.,2003, II, p. 341; F. Longobucco, Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nellacontrattazione “a valle”, Napoli, 2009, p. 41 ss.
11 Il caso è analizzato da Corte giust., 20 settembre 2001, C-453/99, Courage Ltd. c. Crehan,in Foro it., 2002, IV, c. 75 ss. Annovera l’ipotesi in questione nella categoria del «contratto adanno di terzi» L. Bertino, Le trattative prenegoziali e i terzi, Milano, 2009, p. 15.
spettiva strutturale, e dunque con riferimento alla volontà diretta delle partidi ledere le situazioni giuridiche delle quali il terzo sia titolare, ma deveessere altresí considerato nel piú ampio contesto concreto nel quale si in-serisce. Ciò al fine di verificare se esso di fatto comprime interessi che –a prescindere dalla volontà dei contraenti – arrechino un qualche pregiu-dizio ai soggetti non contraenti. Questi interessi potrebbero essere cioèsforniti di qualsivoglia forma di tutela nell’ottica di una lettura meramentestrutturale della fattispecie concreta. Si pensi, come già accennato, al campo– uno dei terreni di elezione sotto tale aspetto – del rapporto tra regola-mento sociale e regolamento parasociale, il quale crea una fitta rete di re-lazioni reciproche tra i soggetti interessati, con notevoli difficoltà inter-pretative per quanti si accingono ad un procedimento di qualificazionedelle relative situazioni12.
Se ciò è vero, la fattispecie della frode al terzo/i è suscettibile di po-tersi scomporre in diverse ipotesi applicative. Da un lato, infatti, assumerilievo il «contratto in frode al terzo», in quanto preordinato direttamentea ledere le ragioni di un terzo determinato. Dall’altro, viceversa, viene inevidenza il «contratto in danno dei terzi e di terzi», perché non si trattadi terzi singolarmente considerati e individualmente presi in considera-zione dal contratto, al quale si può far risalire il concetto di scopo, bensídi terzi che generalmente possono essere danneggiati dal contratto a pre-scindere dalla intenzionalità dei contraenti, cui si può ricondurre il con-cetto di conseguenza. Tale convincimento trae conferma altresí dal rilevoche il danno ai terzi, come da taluni posto in rilevo, «può derivare in baseal semplice fatto che un contratto, da altri stipulato, si presenta incompa-tibile con la posizione del terzo e ciò nel senso che tra la posizione ri-vendicata da una delle parti del contratto e quella del terzo vi è inconci-liabilità. Diverso è invece il caso in cui il terzo non rivendica alcuna po-sizione incompatibile con il contratto ma solo un danno a lui prodottodall’esecuzione e/o meglio dalla cattiva o malaccorta esecuzione del con-tratto da altri stipulato»13. Condivisibilmente dunque la piú recente dot-trina14, nell’indagare i rapporti tra frode alla legge e frode al terzo, ha in-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 717
12 Per talune esemplificazioni nel settore del diritto societario v. R. Manco, Patti paraso-ciali intersocietari: profili di un’indagine, in Ann. Fac. econ. Benevento, 11, Napoli, 2006, p. 77,la quale rileva che i patti parasociali non possono essere di fatto in danno dell’interesse comunedella società; i soci non possono esercitare attività concorrenti (art. 2301 c.c.); l’acquisto di azioniproprie è concluso in danno alla società e ai creditori.
13 In tali termini si esprime A. di Majo, La protezione del terzo tra contratto e torto, inEur. dir. priv., 2000, p. 3.
14 V. Velluzzi, Il contratto in frode al terzo: individuazione della fattispecie e rapporti conla frode alla legge, in Rass. dir. civ., 2004, p. 202 ss.
dividuato tre diverse specie di contratto in frode al terzo lato sensu in-teso: a) contratto in frode al terzo in senso stretto, quando per mezzo delcontratto le parti eludono, aggirano, la situazione soggettiva di cui è tito-lare il terzo, situazione conferita al terzo da una norma imperativa [ov-vero stipulano il contratto al solo fine di danneggiare un terzo determi-nato (arg. ex art. 1345 c.c.)]; b) contratto in danno al terzo, se il contrattoè, in ragione della sua conclusione, strumento produttivo di un danno in-giusto ai terzi; c) fattispecie complessa produttiva di danno, ove il dannoai terzi è determinato non soltanto dalla conclusione del contratto, ma an-che da un’attività ulteriore (si pensi, da ultimo, proprio al caso, indietrorichiamato, della contrattazione «a valle» esecutiva di un’intesa vietata dallalegge antitrust).
4. La rilevanza del profilo funzionale e teleologico nella ricostruzionedella categoria della frode ai terzi emerge altresí in quelle opinioni che,secondo una lettura maggiormente aderente ai valori dell’ordinamento, ac-costano la frode ai terzi al profilo dell’abuso del diritto. In questa dire-zione si è sostenuta, infatti, l’inammissibilità che i contraenti sconfininodal proprio diritto, ossia abusino della loro autonomia privata, stipulandoil contratto non per uno scopo di propria utilità ma esclusivamente perrecare danno ai terzi15. Si avrebbe cosí un’ipotesi di abuso del diritto.
Maggiormente misurata è, in vero, la tesi la quale, ferma restando l’e-sigenza di non spostare sul terreno meramente soggettivo i confini dell’a-buso del diritto, identifica nel dolo il presupposto legale (talora applicatoanche in via giudiziale) che in determinate fattispecie apre la via all’accer-tamento sull’abuso. In tali ipotesi – come quella della concorrenza sleale,dell’informazione di cortesia, della doppia alienazione immobiliare, del-l’induzione all’inadempimento – il principio fraus omnia corrumpit (per ilquale il contratto fraudolento rimane privo di effetti tra le parti e verso iterzi) offrirebbe accesso ad una verifica in termini di abuso del diritto ba-sata sulla regola oggettiva della correttezza16. Del pari, risultano ancóra piúincisive quelle posizioni opportunamente protese ad identificare il concettodi frode con quello di mala fede in senso oggettivo e di scorrettezza17.
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi718
15 Sui rapporti tra il brocardo richiamato nel testo e la figura dell’abuso del diritto v., inparticolare, L. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, II, Le fonti, Milano, 1964, p. 196.
16 E. Navarretta, Il danno non iure e l’abuso del diritto, in Dir. civ. Lipari e Rescigno,coordinato da A. Zoppini, IV, Attuazione e tutela dei diritti, III, La responsabilità e il danno,Milano, 2009, p. 261 ss.
17 Sulla portata della massima fraus omnia corrumpit è d’obbligo il richiamo al noto saggiodi L. Carraro, Valore attuale della massima “fraus omnia corrumpit”, in Riv. trim., 1949, p.782 ss.; piú recentemente, anche, F. Di Marzio (a cura di), Illiceità, immeritevolezza, nullità:
Non sembra invece cogliere nel segno, al fine di interrompere ogni le-game tra frode e abuso, l’obiezione che i soggetti autori del negozio o ilsoggetto che esercita la situazione giuridica soggettiva lesiva dell’altrui di-ritto è comunque a ciò legittimato da una norma, sí che risulterebbe con-traddittoria la qualificazione della stessa situazione in termini di abuso delproprio diritto18. Si tratta di una risalente obiezione già sollevata e argi-nata dalla dottrina francese degli inizi del novecento19. Può infatti osser-varsi che l’abuso del diritto, come ormai acquisito al dibattito dottrinale20,consiste proprio in un esercizio controfunzionale della situazione (pur)astrattamente attribuita al titolare dalla norma giuridica. E, peraltro, pro-prio in ragione della recente valorizzazione, per opera della giurisprudenzadi legittimità della figura in discorso21, non è mancato chi ha piú netta-mente individuato nel principio fraus omnia corrumpit proprio una diretta«espressione del generale divieto dell’abuso del diritto»22.
5. La riconduzione del tema della frode ai terzi alla nozione dell’abusodel diritto legittima altresí l’applicazione giurisprudenziale della categoriain questione anche nella direzione di paralizzare l’abuso del tipo contrat-tuale e l’uso indiretto del negozio giuridico entrambi vólti a ledere, daparte dei contraenti, le prerogative di un terzo determinato. Merita con-divisione e apprezzamento, sotto questo aspetto, una recente pronuncia dimerito, che ha sancito la configurabilità del «contratto a danno di terzo»anche quando i contraenti ricorrano ad un legittimo uso negoziale per un
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 719
aspetti problematici dell’invalidità contrattuale, Napoli, 2004, p. 145 s.; da ultimo, M. Rizzuti,Il contratto in danno di terzi, in Giur. it., 2011, p. 1804 ss.
18 R. Manco, Patti parasociali intersocietari, cit., p. 74. Nello stesso senso propende, piú re-centemente, M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass., 18 settembre 2009, n.20106), in Riv. dir. civ., 2010, p. 158 ss.: l’a. configura l’abuso come un «non senso logico»,giacché l’esercizio di un proprio diritto non può essere contemporaneamente un abuso del di-ritto stesso.
19 L. Josserand, L’abus du droit, Paris, 1905; Id., De l’esprit des droits et de leur relativité.Théorie dite de l’abus du droit, Paris, 1927.
20 Per tale impostazione v. F. Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, in Contr.impr., 2011, p. 311 ss.; A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ.prev., 2010, p. 354 ss.; G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilitàdelle condotte elusive, Napoli, 2012, passim; E. Giorgini, Recesso ad nutum secondo ragione-volezza, in Rass. dir. civ., 2010, p. 586 ss. Contra, nel senso che il sindacato ex fide bona nondovrebbe attenere allo scopo per il quale il diritto è esercitato e, dunque, non avrebbe nulla ache vedere con l’abuso del diritto, G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del di-ritto, in Contratti, 2010, p. 22 ss.
21 Il riferimento è al noto caso Renault deciso da Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, inForo it., 2010, I, c. 85. Per maggiori ragguagli v. infra, retro, note 18 e 20.
22 M. Rizzuti, Il contratto in danno di terzi, cit., p. 1804.
illegittimo fine privato, come accade per esempio allorché si simuli unacessione di azienda per superare la necessità del consenso del contraenteceduto nello schema della cessione del contratto. Il contraente del pattoillecito – a pena di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – non può farvalere contro l’altro contraente i danni che abbia subíto in conseguenzadella legittima reazione del terzo (a detrimento del quale il contratto erapreordinato), posto che comune era l’intento fraudolento e che il falli-mento dell’intera operazione negoziale non dipende da una delle parti delcontratto ma dalla tutela accordata al terzo23.
Si pensi inoltre, per richiamare ancóra la casistica in tema di contrattodi mediazione, all’ipotesi, non infrequente, nella quale le parti, al fine dievitare di corrispondere la provvigione al mediatore, simulano di porre inessere un contratto diverso da quello inizialmente richiesto al mediatore(locazione in luogo di compravendita, contratto di società in luogo di con-tratto di mutuo). In tale evenienza, caratterizzata da una differenza for-male tra l’affare intermediato e quello concluso, potendosi e dovendosi le-gittimamente presumere una condotta maliziosa delle parti diretta a elu-dere il diritto del mediatore alla provvigione, quest’ultimo diritto dovrebbepermanere, sussistendo anche il nesso causale tra l’intervento del mede-simo mediatore e la conclusione effettiva dell’affare. Cosí, per esempio, ildiritto alla provvigione sorge anche quando l’affare, per il quale l’opera diintermediazione è stata prestata, sia concluso solo in parte, come nel casonel quale, in luogo di una vendita di azienda, venga conclusa soltanto lavendita di alcuni beni immobili della stessa.
Non mancano, in vero, situazioni piú complesse che hanno condottola giurisprudenza ad assumere decisioni contrastanti. In passato, per esem-pio, si è giunti ad affermare che il mediatore incaricato di procurare lavendita di un immobile ha diritto al compenso anche se l’operazione vengaeffettuata, con l’acquirente da lui procurato, mediante la cessione delleazioni o delle quote della società venditrice24, anziché mediante una com-pravendita dell’immobile. La piú recente giurisprudenza, tuttavia, ha as-sunto sul punto un contrario indirizzo e poco condivisibilmente, attra-verso un’argomentazione prevalentemente formalista, ha negato al media-tore il diritto alla provvigione. Nel caso concreto, il cliente intenzionatoad alienare un immobile tramite l’agente immobiliare era una s.r.l., men-tre la cessione delle quote è stata attuata dai tre soci: per questo tipo dioperazione è stata negata la provvigione. Si è precisato, infatti, che l’affareconcluso (cessione delle quote) è una figura giuridica completamente di-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi720
23 Trib. Varese, 15 giugno 2010, in www.ilcaso.it.24 Cass., 25 ottobre 1991, n. 11384, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 1059 ss.
versa dalla compravendita, anche se nelle quote è compreso l’immobileche, conseguentemente, viene alienato assieme alle quote e, quindi, vienemeno il nesso di causalità tra l’attività del professionista e la conclusionedell’affare stesso. Ad ogni modo, secondo i giudici di legittimità, anchevolendo considerare come identiche, dal punto di vista del risultato eco-nomico, l’alienazione dell’immobile attuata tramite contratto di compra-vendita rispetto a quella realizzata mediante la cessione delle quote sociali,ulteriore ostacolo al riconoscimento del diritto alla provvigione è la di-versità del soggetto venditore (i tre soci) rispetto a quello con cui inter-viene il rapporto di mediazione originario (la s.r.l.)25.
6. Il profilo della tutela dei terzi estranei al contratto si impone anchein presenza di una trattativa scorretta (ossia abusiva) di una parte versol’altra. L’individuazione della nozione di parte nella responsabilità pre-contrattuale e dell’àmbito soggettivo dell’art. 1337 c.c. hanno indotto se-gnatamente la dottrina a studiare l’ipotesi dell’abuso della libertà di con-durre trattative, fino a configurare un esplicito dovere ex fide bona di nonledere i terzi26. Per lungo tempo, infatti, l’art. 1337 c.c. è stato interpre-tato riferendosi alle sole parti del contratto, con la conseguenza di rite-nerlo non applicabile anche ai terzi danneggiati dalle trattative condottetra le altre parti. Sulla base di tale ultimo convincimento, si è ritenuto, adesempio, che, nella vendita di bene altrui, il proprietario del bene dan-neggiato durante la fase di formazione, alla quale è estraneo, non potrebbedomandare il risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.27. Cosí il mandata-rio incaricato dello svolgimento delle sole trattative, che receda senza giu-stificato motivo ma dopo aver creato un affidamento nella controparte,non potrebbe essere ritenuto responsabile ex art. 1337 c.c., non essendoparte del futuro contratto28. Malgrado queste posizioni di chiusura, partedella nostra dottrina risulta oggi opportunamente propensa ad estenderel’applicazione dell’art. 1337 c.c. anche ai casi nei quali il soggetto passivodell’illecito precontrattuale sia un terzo estraneo alla trattativa29. Tale opi-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 721
25 Cass., 28 giugno 2001, n. 8850, in Rep. Foro it., 2001, voce Mediazione, n. 27. 26 Si rinvia, in argomento, al piú recente lavoro di L. Bertino, Le trattative prenegoziali,
cit., spec. p. 92 ss. 27 L’ipotesi è delineata da P. Gallo, Responsabilità precontrattuale: la fattispecie, in Riv. dir.
civ., 2004, I, p. 323 ss.28 Cass., 4 marzo 2002, n. 3103, in Studium iuris, 2002, p. 1126 ss.29 V., in particolare, P. Gallo, Responsabilità precontrattuale, cit., p. 323; G.B. Portale,
Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, in Banca borsa tit. cred., 1982, I, p.22. Prende atto della «moderna tendenza ad allargare il campo» dell’art. 1337 c.c. F. Benatti,Culpa in contrahendo, in Contr. impr., 1987, p. 287 ss., il quale, tuttavia, reputa eccessivo esten-
nione trae conforto anche dalla piú recente riforma del diritto tedesco delleobbligazioni e, segnatamente, dal § 311, comma 3, BGB, secondo il qualel’obbligo di correttezza può sorgere anche nei confronti dei terzi che nondebbono diventare parti del rapporto obbligatorio30. Con la conseguenza,ai fini di quanto rileva nella presente analisi, che l’effetto indiretto dan-noso, piú dietro teorizzato, può conseguire non soltanto alla stipulazionedel negozio, ma altresí alla fase delle mere trattative negoziali.
7. Un’ulteriore questione si appunta sulla persistente attualità del ri-chiamato brocardo fraus omnia corrumpit ai fini della declaratoria dellanullità dell’atto realizzato in spregio agli interessi di un terzo o dei terzi(la fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert; fraud cor-rupts everything). Già la piú risalente dottrina ha avuto modo di rilevarecome il principio in parola di ormai lontana origine, contrariamente allasua notevole penetrazione negli altri ordinamenti, non ha ricevuto fre-quente applicazione nel nostro sistema normativo31. Come è noto, infatti,una maggiore sensibilità per le esigenze di ordine morale nei rapporti giu-ridici e una spiccata libertà interpretativa hanno condotto la giurisprudenzadi altri Stati, in particolare di quello francese, a risultati profondamentediversi da quelli raggiunti nel nostro ordinamento. Pertanto, non è sfug-gito ai nostri autori, già in tempi passati, che «il magistrato francese [che]si trovi di fronte a un comportamento fraudolento, […] reagisce o accer-tando una responsabilità a carico del suo autore, oppure, e piú frequen-temente, negando ad esso ogni efficacia giuridica»32. A ben vedere, però,i giudici francesi continuano ancóra a fare frequente uso dell’adagio frausomnia corrumpit o della formula equivalente la fraude fait exception à tou-tes les règles piú per omaggio alla tradizione che non per applicare unprincipio giuridico, del quale non viene delineato con puntualità il conte-nuto33. In ragione di quanto esposto, è ancóra frequentemente sostenuta
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi722
dere l’applicazione dell’art. 1337 c.c. «a chi non interviene in alcun modo nelle trattative» (p.300 s.).
30 Per un primo commento v. D. Medicus, Bürgerliches Recht, München, 2004, p. 141 s.31 L. Carraro, Valore attuale, cit., p. 783. Oltre al citato contributo di Carraro, sulla ap-
plicazione del brocardo in discorso, v. già anche N. Coviello, Sulla sospensione della prescri-zione fra persone giuridiche e amministratori, in Giur. it., 1934, I, c. 142; A. Trabucchi, Il dolonella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, pp. 106, 343 ss.
32 L. Carraro, o.c., p. 784. 33 Valga qui il rinvio sul tema a F. Gorphe, Le principe de la bonne foi, Paris, Dalloz, 1928,
p. 77; H. Roland e L. Boyer, Adages du droit français, Paris, Litec, 1992, p. 288 ss.; N. Ront-chevsky, L’effet de l’obligation, Paris, Economica, 1998, spec. cap. II; J. Vidal, Essai d’une théo-rie générale de la fraude en droit français. Le principe fraus omnia corrumpit, Thèse, Toulouse,Dalloz, 1957, passim.
in Francia la soluzione, altresí mutuata da taluna dottrina italiana, di ipo-tizzare l’eliminazione del secondo negozio lesivo in tema di doppia alie-nazione immobiliare34, ovvero di consentire costantemente al prelaziona-rio pretermesso di domandare l’annullamento del contratto fra soggettopassivo della prelazione e terzo acquirente, in caso di concert frauduleuxdi costoro ai danni del preferito stesso35.
Neppure in Francia, ad ogni modo, può dirsi definitivamente sopito ildibattito sul tema. Gli autori piú moderni hanno infatti avviato una ri-flessione critica in merito alla portata del principio fraus omnia corrumpitin ordine sia all’esatta individuazione dei confini della frode, sia alla con-seguenza giuridica derivante dalla sua applicazione: nullità (nullité abso-lue), annullabilità (nullité relative), inefficacia (inopposabilité)36. Peraltro,non manca poi una diffusa consapevolezza del tema in questione anchenei Paesi di Common law, con particolare riferimento all’opera di siste-matizzazione del tort of inducing breach of contract e del tort of interfe-rence with contract, peraltro fatti oggetto di accurate analisi anche da partedella nostra dottrina37.
8. Si è dunque osservato che in altri ordinamenti l’applicazione del prin-cipio fraus omnia corrumpit – diretta ad invalidare il contratto tra le partie verso il terzo/i – ha assunto una portata molto piú incisiva rispetto aquanto parallelamente verificatosi in Italia.
Non può tuttavia escludersi a priori l’esperibilità (anche) nel nostro or-dinamento dell’azione di nullità. Ciò dovrebbe ritenersi possibile quandorisulta acclarata dalle evidenze processuali e dalle prove espletate la direttavolontà delle parti di frodare il terzo. Si può giustificare, in quest’ottica,il ricorso alla nullità per motivo illecito (perché contrario all’ordine pub-blico o al buon costume) comune e determinante (art. 1345 c.c.).
In effetti già la dottrina, chiamata a pronunciarsi su talune ipotesi ap-plicative, ha concluso per l’illiceità del negozio38. Per esemplificare, in tema
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 723
34 In particolare da F. Ziccardi, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, p. 256 ss. 35 Riferimenti alla giurisprudenza francese sul contratto in frode al terzo prelazionario si ri-
trovano esplicitati in G. Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984, p. 183, nota 75. 36 F. Terré, Ph. Simler e Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Paris, Dalloz, 1999,
p. 499. 37 B. Gardella Tedeschi, L’interferenza del terzo nei rapporti contrattuali, Milano, 2008,
p. 86 ss. 38 Cosí, in tema di contratto di boicottaggio (prima dell’introduzione della legislazione an-
titrust), fa leva sul motivo illecito comune e determinante nella frode al terzo F. Galgano, Di-ritto civile e commerciale, 4a ed., Padova, 2004, p. 361; v., già, L. Carraro, Valore attuale, cit.,p. 789 s., il quale riconosce che l’intenzionalità del comportamento a danno di altri può assur-
di doppia alienazione immobiliare, riguardo ad un caso nel quale la frodeera stata attuata ai danni dell’acquirente di un immobile per mezzo di unaseconda alienazione «affrettatamente trascritta», si è inizialmente sostenutada parte di un’ormai risalente giurisprudenza la tesi dell’illiceità ex art.1345 c.c. del secondo contratto39. Tale soluzione è rimasta isolata perchéoggi, come è noto, la questione della doppia trascrizione è stata oggettodi numerose pronunce di legittimità e di merito che sono propense ad in-quadrare la fattispecie in questione nell’àmbito della responsabilità extra-contrattuale, piuttosto che soffermarsi sull’astratta illiceità della secondastipulazione40.
Anche nel caso della locazione conclusa dall’usufruttuario in frode alnudo proprietario l’orientamento dominante dell’attuale giurisprudenza ènel senso di escludere l’ipotesi della nullità della locazione41. Si rileva in-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi724
gere a motivo illecito – in quanto contrario al buon costume – che, se comune ad entrambe leparti, comporta la nullità del contratto; recentemente, anche, V. Velluzzi, Il contratto in frodeal terzo, cit., p. 203.
39 L. Carraro, o.c., p. 790, ed ivi il richiamo alla posizione espressa da Trib. Foggia, 11giugno 1948.
40 Per maggiori riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza v. D. Poletti, Dalla lesionedel credito alla responsabilità extracontrattuale da contratto, in Contr. impr., 1987, p. 135 ss. Indiversa prospettiva rispetto a quella risarcitoria v. B. Troisi, Appunti sul contratto a danno diterzi, in Rass. dir. civ., 2008, p. 727 ss. (ora in Id., Il contratto a danno di terzi e altri saggi,Napoli, 2008, p. 269 ss.), che fa leva sullo strumento dell’azione di simulazione atta a consen-tire al terzo di far dichiarare la simulazione relativa di una vendita obbligatoria (il secondo ne-gozio) efficace soltanto inter partes.
41 Tra le prime decisioni del caso in esame cfr. App. Milano, 9 agosto 1955, in Foro it., 1956,I, c. 1370 ss.: il nudo proprietario frodato dalla locazione dell’usufruttuario può esperire azionerevocatoria. Diversamente Cass., 31 agosto 1966, n. 2300, ivi, 1967, c. 52 ss., e, piú recente-mente, Trib. Parma, 23 giugno 1999, in Giur. merito, 2000, p. 10 ss., stabiliscono che è risolu-bile il contratto di locazione concluso dall’usufruttuario in frode alle ragioni del proprietario.Ammettono oggi, in via dominante, la validità della locazione stipulata dall’usufruttuario, sulpresupposto che il nostro ordinamento non prevede la nullità del contratto di affitto stipulatodall’usufruttuario in frode dei diritti del nudo proprietario, Cass., 20 marzo 2008, n. 7485, inCorr. giur., 2008, p. 1592 ss.; Cass., 25 luglio 2003, n. 11561, in Guida dir., 2003, 35, p. 70 ss.Propende per tale indirizzo giurisprudenziale, da ultimo, A. Quaranta, La durata delle loca-zioni concluse dall’usufruttuario tra funzione sociale della proprietà, principio solidaristico e at-tuazione del diritto all’abitazione, in Rass. dir. civ., 2012, p. 234 ss. In senso conforme, nell’e-scludere la nullità del contratto lesivo della prelazione legale accordata al terzo, Cass., Sez. un.,25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, p. 181 ss., e, già prima, Cass., 16 luglio 1981,n. 3905, in Rep. Foro it., 1981, voce Contratto in genere, n. 250; Cass., 24 ottobre 1983, n. 6239,ivi, 1983, voce cit., n. 290. Recentemente è stata altresí esclusa la nullità del pegno di titoli co-stituito con un terzo e finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori fallimentari da Cass., 4ottobre 2010, n. 20576, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 1288. È stata altresí dichiarata l’inefficaciae l’inopponibilità ai terzi (a fronte della nullità sancita in appello) del concordato preventivo sti-pulato soltanto da alcuni creditori del fallito in danno degli altri e, dunque, lesivo della par con-dicio creditorum da Cass., 14 aprile 2011, n. 8541, in Guida dir., 2011, n. 20, p. 56 ss.
fatti, il piú delle volte, che la stipulazione della locazione non rientra nelleipotesi legalmente previste dall’art. 1344 c.c. (di frode alla legge), ovverodall’art. 1015 c.c. (dell’abuso di usufrutto inteso come causa di estinzionedella situazione reale in caso di alienazione, deterioramento o perimentodel bene costituito in usufrutto). Pertanto, il contratto di locazione, in ap-plicazione dell’art. 999 c.c. (a sua volta riecheggiante la regola dell’art. 1599c.c., secondo la quale empio non tollit locatum), viene considerato piena-mente valido ed efficace, sul presupposto, da un lato, che non è configu-rabile un’ipotesi di invalidità dello stesso per motivo illecito comune e de-terminante, e che, dall’altro lato, la frode al terzo, diversamente dalla frodealla legge, non è sanzionata con la nullità da alcuna norma imperativa dilegge. La locazione stipulata da parte dell’usufruttuario è infatti astratta-mente ammessa nel nostro ordinamento ed è opponibile al proprietariodel bene purché risultante da atto scritto avente data certa anteriore allacessazione dell’usufrutto. Tuttavia, estinto l’usufrutto, il contratto di loca-zione può spiegare i suoi effetti per un periodo di massimo di cinque annidalla cessazione dell’usufrutto ovvero, in caso di estinzione per scadenzadel termine pattuito, per l’anno successivo (art. 999 c.c.). Attraverso talenorma pertanto, ad avviso della giurisprudenza, il legislatore avrebbe in-teso prevedere le condizioni affinché il contratto di locazione stipulato dal-l’usufruttuario sia opponibile al nudo proprietario. Con la conseguenza,come poc’anzi osservato, del diniego di rilevanza dell’art. 1345 c.c. e del-l’inesistenza, in presenza di uno strumento di tutela specifico (appuntoquello introdotto dall’art. 999 c.c.), di un principio normativo generale ditutela dei terzi contro gli atti eventualmente realizzati in loro frode.
La configurabilità di un’azione di nullità del contratto in frode al terzonudo proprietario è stata peraltro fatta oggetto di differenti critiche anchein dottrina. Quella principale è avanzata da chi evidenzia che il nostro co-dice ha previsto già specifici strumenti – fra cui in particolare l’azione re-vocatoria ordinaria e l’azione di simulazione – a favore di taluni terzi eche «l’utilità di siffatti strumenti […] verrebbe ictu oculi azzerata laddovesi scorgesse un addentellato normativo invocabile, in via generale, per per-venire alla demolizione di qualsivoglia intesa di segno emulativo»42.
In vero, la questione si riduce propriamente a quella di verificare se lasoluzione della nullità per illiceità dei motivi ex art. 1345 c.c., come in-dietro evocata, possa risultare in qualche modo piú adeguata rispetto aquella della inopponibilità o dell’inefficacia. Quanto al rapporto tra revo-catoria e nullità ex art. 1345 c.c. è innegabile l’evidente differenza di pre-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 725
42 Cosí si esprime F. Caringella, Frode ai terzi e prelazione, in Corr. giur., 1994, p. 184.
supposti. Mentre infatti, per l’azione di nullità ex art. 1345 c.c., è richie-sto che le parti abbiano concluso il contratto esclusivamente per arrecarepregiudizio ad un terzo, per la revoca degli atti onerosi si ritiene suffi-ciente che il contraente sia meramente consapevole del pregiudizio arre-cato al terzo-creditore (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.), con un conseguentenotevole alleggerimento dell’onere della prova. Tale sgravio dal punto divista probatorio è giustificato dalle differenti conseguenze del rimedio of-ferto: l’azione pauliana è preordinata ad una dichiarazione di inefficacianei confronti del creditore che agisce, mentre l’azione ex art. 1345 c.c. perilliceità dei motivi comporta la ben piú incisiva declaratoria di nullità delcontratto. La stessa dottrina, proprio con riferimento al caso prima ac-cennato della locazione dell’usufruttuario, ha rilevato, già in passato, che«il proprietario non si trova affatto nella stessa situazione di un creditore,perché nulla legittima questa assimilazione assolutamente empirica e scor-retta: il proprietario non è proprio in nulla creditore dell’usufruttuario,non ha alcuna prestazione da pretendere»43.
L’esistenza di azioni differenti a tutela dei terzi è suffragata anche datalune pronunce della giurisprudenza di merito: per esempio, il Tribunaledi Vasto, chiamato a decidere sulla validità di un contratto concluso dalliquidatore di una società «per eludere l’applicazione di una norma impe-rativa o frutto di un esclusivo motivo illecito», ha rimarcato che il socionon è creditore attuale della società e che pertanto non potrà proporrel’azione ex art. 2901 c.c. (la quale presuppone la validità dell’atto), bensíquella di nullità ai sensi dell’art. 1345 c.c.44. In tema di revocatoria falli-mentare, inoltre, la Corte d’appello di Brescia ha statuito che «trascorsoil periodo di consolidamento di 10 giorni, la revocatoria dell’ipoteca puòavvenire solo se: a) il negozio di mutuo fondiario garantito da ipoteca èsimulato; b) il negozio di mutuo fondiario garantito è nullo perché infrode alla legge o per motivo illecito ex art. 1345 c.c.»45.
Analoghe considerazioni si possono formulare con riferimento ai rap-porti tra l’azione di nullità del contratto in frode al terzo e l’azione di si-mulazione: come è noto, la simulazione è un istituto neutro dal punto divista dei fini perseguiti dalle parti, che possono essere leciti o illeciti, inbase a quanto emerge anche dal disposto dell’art. 1417 c.c., il quale am-mette senza limiti la prova per testi della simulazione tra le parti allorchéè diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. D’altro canto, l’i-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi726
43 Il rilievo è di A. Tabet, Le locazioni dell’usufruttuario in frode del proprietario, in Foroit., 1956, I, c. 1371 ss.
44 Trib. Vasto, 15 gennaio 1996, in Temi rom., 1996, p. 390 ss. 45 App. Brescia, 9 febbraio 1994, in Vita not., 1994, p. 1224 ss.
nefficacia del contratto simulato fra le parti, di cui all’art. 1414, comma 1,c.c., sia che la si intenda come nullità, ovvero come inefficacia in sensostretto, trova la sua ragione nell’accordo simulatorio, che è diretto a farapparire l’avvenuta conclusione di un contratto in realtà non voluto, men-tre il negozio in frode al terzo è caratterizzato dalla reale e comune vo-lontà delle parti contraenti di pregiudicare i diritti di un terzo46.
Preso pertanto atto della diversità di ratio e di presupposti tra l’azionedi nullità per illiceità dei motivi ex art. 1345 c.c. e l’azione pauliana e disimulazione, può ritenersi che i tre rimedi sono disomogenei fra di loroe che la soluzione della nullità può essere praticata quando risulta, nel casoconcreto, che le parti del contratto hanno concluso il contratto esclusiva-mente per frodare in via diretta le ragioni di un terzo determinato. Di-versamente ci si dovrà orientare in altra direzione, per esempio esplorandola possibilità che il terzo possa agire contro le parti per ottenere il risar-cimento del danno.
9. Tale ultimo convincimento si legittima, da un lato, in un sistema nelquale la categoria del «contratto a danno di terzi» ha subíto, come indie-tro già osservato, una deviazione in senso funzionale rispetto alla sua tra-dizionale concezione (unicamente) strutturale e volontaristica, dall’altro invirtú del clima di imperante sensibilità verso il tema dell’abuso del diritto.Questa sensibilità è dimostrata da chi, per esempio, ha accostato il «con-tratto in danno di terzi» alla nozione di immeritevolezza: in tal caso, ilcontratto, pur valido, risulterebbe abusivo nei confronti dei terzi, sull’as-sunto che la categoria della meritevolezza potrebbe essere rivitalizzata an-che con riguardo ai contratti tipici per «discriminare tra gli innumerevolimovimenti dell’autonomia privata quelli che, pur non invalidati dal legi-slatore, sono inefficaci o causa di responsabilità nei confronti dei terzi pre-giudicati nei loro interessi»47.
Del pari si colloca nella medesima prospettiva la riconduzione del fattostipulatorio (valido) al rango di elemento costitutivo di una fattispecie il-lecita, operando la qualifica dell’invalidità su un piano diverso da quellodell’illiceità48. Invalidità e illiceità dunque non coincidono: l’atto valido puòentrare nella fattispecie normativa di illiceità49.
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 727
46 In eguale prospettiva v. L. Castelli, Il contratto dell’usufruttuario in frode al nudo pro-prietario, in Corr. giur., 2008, p. 1595.
47 Cosí F. Di Marzio, Illiceità, immeritevolezza, nullità, cit., p. 139 ss. Appare invece piúscettico verso un appiglio al concetto di meritevolezza V. Velluzzi, Il contratto in frode alterzo, cit., p. 203 s.
48 Già in tal senso, proprio con riguardo al tema specifico della frode al terzo, L. Carraro,Valore attuale, cit., p. 797 ss.
La figura del «contratto a danno di terzi» può dunque delinearsi an-che in presenza di un valido contratto, poiché le obbligazioni che da essodiscendono possono venire eseguite non correttamente o pregiudicando iterzi50. Non sembra infatti revocabile in dubbio che assai raramente le partistipulano un contratto al solo fine di recare pregiudizio ad un terzo de-terminato, ma che la stipulazione determina, semmai e piú spesso, sem-plicemente un danno riflesso ai terzi (rispetto alla vera finalità dei con-traenti di ottenere comunque un qualche vantaggio personale). Cosí il con-tratto non potrebbe, in questa circostanza, essere ritenuto nullo ex art.1345 c.c., in quanto le parti non lo avrebbero concluso esclusivamente(come richiesto letteralmente dalla norma) per frodare il terzo, bensí perottenere in ogni caso un profitto a danno di soggetti terzi. Dimostratal’ingiustizia della lesione, il nesso di causalità e la consapevolezza del dannoarrecato al terzo, quest’ultimo avrebbe diritto al risarcimento da valutarsinon soltanto economicamente, ma anche in termini di perdita di chancedal punto di vista giuridico51. L’assenza di qualsiasi colpa delle parti nellalesione degli interessi del terzo potrebbe peraltro legittimare, come è statoanche suggerito, possibili forme di tutela compensativa connessa ad atti-vità lecita dannosa52. Non può certo nascondersi la difficoltà per l’inter-prete di distinguere, caso per caso, stipulazioni idonee a legittimare, sulpiano oggettivo e soggettivo, un illecito ex art. 2043 c.c. rispetto a situa-zioni immuni da ogni censurabilità sul fronte della colpevolezza e del-l’antigiuridicità. Parametro dirimente, in ausilio dell’interprete, potrebbeessere allora quello della correttezza della condotta assunta dalle parti, cosíriportato dal tradizionale campo dei rapporti obbligatori a quello della re-sponsabilità da atto illecito53.
D’altronde, ritornando al caso ormai noto della locazione conclusa dal-l’usufruttuario in danno del nudo proprietario, non si è mancato di rile-vare come, salvo che sia configurabile una frode diretta al terzo, la quale
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi728
49 Concordemente, su tale profilo, v. N. Irti, Concetto giuridico di “comportamento” e in-validità dell’atto, in Riv. trim., 2005, p. 1053 ss.; L. Lonardo, Ordine pubblico e illiceità delcontratto, Napoli, 1994, p. 375 ss.; G. Villa, Contratto e violazione di norme imperative, Mi-lano, 1993, p. 8 ss.; G. Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale Una incerta distinzionesul piano degli effetti, Napoli, 2003, p. 12 ss.; P. Femia, Nomenclatura del contratto o istitu-zione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione, in G. Gitti e G. Villa (acura di), Il terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, Bologna, 2008,p. 273.
50 L. Bertino, Le trattative prenegoziali, cit., p. 15. 51 P. Perlingieri, Dei modi di estinzione, cit., p. 156. 52 R. Manco, Patti parasociali intersocietari, cit., p. 79. 53 Si raccoglie lo spunto di D. Poletti, Responsabilità extracontrattuale da contratto e ina-
dempimento del subcontratto, in Danno resp., 1999, p. 905.
legittimerebbe la nullità per illiceità dei motivi (art. 1345 c.c.), la soluzionepiú piana risulta quella del ricorso, in presenza di tutti i suoi presuppo-sti, alla tutela aquiliana. Quest’ultima consente il risarcimento del dannoarrecato al nudo proprietario, ma al contempo, in assenza di riferimentinormativi in grado di rendere per una qualche ragione inefficace il con-tratto (come la descritta tutela ex art. 1345 c.c.), lascia in vita la locazione54.L’applicazione dell’art. 999 c.c. non può fungere in definitiva da ostacoloa riconoscere e a risarcire eventuali danni che il nudo proprietario di fattosubisca indirettamente dalla locazione stipulata dall’usufruttuario. Infatti,lo sviluppo dei traffici commerciali che connota l’odierna realtà econo-mico-giuridica fa sí che oggi le esigenze di tutela, alle quali il codice del1942 appresta svariati rimedi, si sono rivelate piú preganti e bisognose digaranzie ulteriori. In ragione di un’interpretazione evolutiva delle normecodicistiche, non sembra che la soluzione adottata in giurisprudenza55 – dilasciare completamente privo di tutela il nudo proprietario se non nell’i-potesi eccezionale della nullità ex art. 1345 c.c. – possa essere condivisa apieno, poiché non può escludersi a priori la possibilità di accordare unatutela per equivalente (alternativa alla nullità tranciante e ferma restandola validità della locazione), in grado di riequilibrare quantomeno dall’e-sterno del contratto il rapporto tra le parti e i terzi.
L’attuale orientamento limitativo della giurisprudenza56, teso a conce-pire la frode al terzo unicamente quale strumento di invalidazione del con-tratto in presenza di un motivo illecito comune e determinate, poggia per-tanto su una premessa viziata: quella di istituire un pregiudiziale paralle-lismo, anche sul piano delle conseguenze giuridiche (id est, la nullità del-l’atto), tra l’ipotesi della frode al terzo e quella della frode alla legge (que-st’ultima espressamente codificata ex art. 1344 c.c. e sanzionata sempre conla nullità del contratto). Viceversa, occorre prendere atto che la frode alterzo, oltre a poter determinare eccezionalmente la nullità del contrattonell’ipotesi ex art. 1345 c.c., piú spesso (come nel caso dell’effetto dan-noso indiretto) finisce per imporsi non soltanto nella sua naturale com-ponente psicologica, ma altresí sul piano oggettivo dei comportamenti ediventa dunque esplicativa del concetto di abuso di diritto. In questi casi,certamente piú frequenti rispetto a quello dell’illiceità del contratto permotivo illecito comune e determinante, l’abuso assurge ad una tecnica ar-gomentativa per sindacare quelle stipulazioni nelle quali non si può di-scorrere di mera liceità, né di illiceità in senso proprio, ma piú corretta-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 729
54 V., da ultimo, V. Velluzzi, Il contratto in frode al terzo, cit., p. 197, nota 31. 55 Cfr. supra, nota 41. 56 Cfr. supra, nota 41.
mente di non meritevolezza del comportamento o del diritto, come eser-citato o posto in essere (a danno dei terzi)57.
10. Diversa è l’ulteriore evenienza in presenza della quale il contratto,da un lato, è inequivocabilmente diretto a frodare il terzo, dall’altro lato,a realizzare (anche) una frode alla legge ex art. 1344 c.c. Il che, per in-ciso, richiama l’attenzione sul profilo piú generale della tendenziale so-vrapposizione che oggi va realizzandosi tra il motivo illecito – perché con-trario a norma imperativa, ordine pubblico e buon costume – e la causaillecita, tradizionalmente insita nel concetto di frode alla legge, specie inconsiderazione della teoria della causa in concreto recentemente tornataall’attenzione della giurisprudenza58.
Si pensi per esempio al caso, ancóra con riferimento alla nota fattispe-cie della locazione stipulata dall’usufruttuario in frode al nudo proprieta-rio, nel quale l’usufruttuario-locatore abbia pattuito con il conduttore uncanone assolutamente modesto, se non irrisorio e privo di utilità effettivaper il locatore stesso. Il corrispettivo della locazione configura certamenteun patto pregiudizievole per il proprietario, creditore di tale importo unavolta sopraggiunta la consolidazione dell’usufrutto59. Tuttavia, non vi è chinon vede che, se da una parte la locazione stipulata dall’usufruttuario iden-tifica un’operazione complessa, non supportata da interessi oggettivamenteapprezzabili, bensí preordinata a ledere le ragioni del terzo nudo pro-prietario, dall’altra parte, essa è al contempo diretta a svuotare di conte-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi730
57 Da ultimo, in tal senso, G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario, cit., p. 17 s. 58 Tanto piú il concetto di causa si intende in concreto tanto piú si avvicinerà a quello dei
motivi, che si riferiscono proprio allo scopo pratico ed individuale perseguito dal soggetto in-teressato: M. Ambrosoli, Il motivo tra vizi del consenso e causa del contratto, in Contratti,1995, p. 362 ss. La definizione di motivo evidenziata è di A. Torrente e P. Schlesinger, Ma-nuale di diritto privato, 27a ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2011, p. 570 ss. V.,anche, M. Bessone, Causa tipica e motivo del contratto, dogmi di teoria generale, orientamentidella giurisprudenza, in Riv. trim., 1979, p. 1098 ss. In giurisprudenza definisce la causa in con-creto non già come «mera ed astratta funzione economico sociale del negozio, bensí come sin-tesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individualedel singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermorestando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delleparti», Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Rass. dir. civ., 2008, p. 564 ss., con nota di F. Rossi,La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte;cfr., piú recentemente, Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Foro it., 2009, I, c. 214 ss., secondola quale «posto che l’impossibilità dell’esecuzione nel contratto di viaggio “tutto compreso” èda valutarsi in relazione all’interesse da soddisfare del creditore turista, l’inutilizzabilità della pre-stazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta».
59 Il patto è appunto ritenuto «in danno di terzi» da L. Bertino, Le trattative prenego-ziali, cit., p. 15.
nuto la tutela apprestata dall’art. 999 c.c. in favore del proprietario. Que-st’ultima disposizione assume infatti la ratio di contemperare gli interessidel proprietario del bene e quelli del conduttore, sí che la locazione aprezzo vile, prima ancóra che in frode al terzo, risulta (anche) in frodealla legge, rectius, ad una norma imperativa (essendo l’art. 999 c.c. non de-rogabile né dall’usufruttuario né dal conduttore)60.
Quest’ultima osservazione risulta vieppiú confortata, sotto il profilo si-stematico e in appoggio all’interpretazione costituzionalmente orientata,dalla disparità di trattamento – certamente non legittima dal punto di vi-sta costituzionale ex art. 3 cost. – che verrebbe a determinarsi tra l’art.999 c.c. e l’art. 2923, comma 3, c.c., secondo il quale l’acquirente di unimmobile, a séguito di esecuzione forzata, non è tenuto a rispettare la lo-cazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giustoprezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Si pensi altresí al di-sposto dell’art. 1606 c.c., per il quale nei casi in cui il diritto del locatoresulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui con-cluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frodee non eccedano il triennio.
Ne discende che l’orientamento ormai tralatizio e prevalentemente for-malista della validità della locazione conclusa nel mero rispetto dei det-tami dell’art. 999 c.c. deve essere rivisitato non soltanto nell’ottica di pre-venire frodi a danno del proprietario (come richiesto espressamente anchedall’art. 1606 c.c.), ma altresí nella prospettiva di arginare eventuali svan-taggi economico-patrimoniali lesivi per lo stesso (come prevede lo stessoart. 2923, comma 3, c.c.). In altri termini, il bilanciamento compiuto exante dal legislatore nell’art. 999 c.c. tra gli artt. 3 e 42 cost. – spesso ad-dotto dalla giurisprudenza per escludere ogni altro strumento di tutela infavore del terzo che non sia direttamente riconducibile a quello eccezio-nale dell’illiceità del motivo comune e determinante ex art. 1345 c.c. – do-vrebbe invece potersi ogni volta rinnovare nel caso concreto, al fine di ve-rificare, ex post e nell’opportuna sede giudiziale, se la frode al terzo ab-bia realizzato, anche e prima ancóra, una frode alla legge.
Analoga situazione si verifica, tra l’altro, nel caso della c.d. cintura di
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 731
60 In giurisprudenza, ritiene nulla la locazione stipulata dall’usufruttuario a prezzo vile, Trib.Parma, 23 giugno 1999, cit. (nella specie, il novantunenne usufruttuario di un fondo rustico, de-ceduto poco dopo il contratto impugnato dal proprietario del fondo, l’aveva affittato per la du-rata di venti anni e per un canone apparso esiguo). In senso contrario è, invece, Trib. Foggia,26 giugno 2002, in Rep. Foro it., 2002, voce Usufrutto, n. 4, secondo il quale la tutela del nudoproprietario non può estendersi alla contestazione di clausole contrattuali quali quelle afferentiall’ammontare del canone o alle modalità del suo pagamento anticipato.
castità61, ossia della riserva di proprietà, in favore del proprietario alienantee senza una minima utilità economica a vantaggio del disponente, di un’e-sigua porzione di terreno atta a far venire meno il requisito della conti-guità tra il fondo oggetto di compravendita ed il fondo di pertinenza delvicino coltivatore diretto, e quindi, per l’effetto, il presupposto base perl’esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultimo. Sí che, purein quest’ultima evenienza, il carattere legale della prelazione potrebbe le-gittimare il ricorso alla declaratoria di frode alla legge della complessivaoperazione (e di qui l’esercizio del diritto di riscatto). Ulteriori vicendestipulatorie frequenti nella prassi potrebbero subire la medesima sorte giu-ridica: la creazione di un rapporto (preliminare) di affitto con l’aspiranteacquirente strumentale alla conclusione di un contratto (definitivo) di com-pravendita in favore del concessionario, al fine di eludere il diritto di pre-lazione del confinante; ancóra, il ricorso ad accordi trilateri relativi allapreventiva rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione ed al diritto diproroga da parte dell’affittuario contro la corresponsione di una congruabuona uscita per impedire la prelazione del confinante. Quanto osservatotrova peraltro conforto in un recente studio della dottrina teso ad inda-gare le reciproche connessioni tra «contratto in frode alla legge» e «con-tratto in frode al terzo», quantomeno nei casi nei quali la posizione giu-ridica del terzo può essere ricondotta nell’àmbito della ratio della normaimperativa che deve essere necessariamente determinata in connessione conl’art. 1344 c.c.62.
Inoltre, secondo taluni – considerato che la norma imperativa è postaa tutela di un interesse pubblico dell’ordinamento giuridico – il criteriodiscretivo tra invalidità e risarcimento potrebbe rintracciarsi anche nella ti-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi732
61 Con particolare riferimento alla vicenda della c.d. cintura di castità e ad altre fattispecieelusive del diritto di prelazione legale v. G. Romano, Un caso di simulazione per escludere ildiritto di prelazione, in Mondo agricolo, n. 48 del 7 dicembre 1980; S. Piccinini, Simulazionee «cinture di castità», in Foro it., 1981, I, c. 1628; R. Gammarota, Frode alla legge in materiadi prelazione agraria e reazione all’ordinamento, in Giur. it., 1992, I, c. 960 ss. In giurispru-denza si rinvia a Cass., 17 ottobre 1989, n. 4152, in Foro it., 1990, I, c. 2255 ss. (ripristino deldiritto di riscatto per violazione di norma imperativa); Cass., 27 luglio 1990, n. 7579, in Giur.it., 1992, I, c. 960 ss.; Cass., 19 dicembre 1980, n. 6562, in Foro it., 1981, I, c. 1628 ss.; Cass.,Sez. un., 25 marzo 1988, n. 2582, ivi, 1988, I, c. 1510 ss.; Cass., 15 dicembre 1980, n. 6504, ivi,1981, I, c. 1913.
62 V. Velluzzi, Il contratto in frode al terzo, cit., p. 221 ss. Nella stessa direzione v. pre-cedentemente, anche, A. Princigalli, Individuazione di beni immobili e realizzazione di inte-ressi meritevoli di tutela. La prelazione del proprietario confinante, in Nuovo dir. agr., 1978, p.562; D. Bellantuono, La nozione di terreni in materia di prelazione agraria: la posizione dellesezioni unite della cassazione, in Foro it., 1988, I, c. 1510 ss.; G. Moscardini, Frode e simula-zione in tema di prelazione, in M.P. Ragionieri (a cura di), La prelazione agraria, Viterbo,1996, p. 79 ss.
pologia di interesse leso63: cosí, se accanto all’interesse individuale del terzo,venga violato contestualmente un interesse pubblico, ovvero un principiodel nostro ordine pubblico costituzionale, potrebbe legittimarsi la nullitàdel contratto. Viceversa, là dove sia compresso dall’altrui stipulazione esclu-sivamente un interesse individuale dei terzi, questi ultimi potrebbero agireunicamente in via risarcitoria ex art. 2043 c.c. Coerentemente con tale as-sunto, si è ritenuto illecito il contratto in frode al fisco per violazione de-gli artt. 2 e 53 cost.64.
Tuttavia, sebbene il profilo della natura dell’interesse leso (pubblico oprivato) possa fungere, al livello generale, da discrimen tra nullità e risar-cimento, non sembra che questa opzione ermeneutica sia estensibile sic etsimpliciter anche al fenomeno, poc’anzi evocato, dell’elusione tributaria. Lanullità, infatti, appare un rimedio inadeguato sia se si tiene conto della na-tura delle norme tributarie, sia alla luce dei criteri di proporzionalità e diragionevolezza, i quali impongono anche di considerare le conseguenzegiuridiche di un’eventuale pronuncia di nullità65. Da un lato, pertanto, nonè possibile discorrere, in caso di frode al fisco, di nullità civilistica del ne-gozio, per difetto di causa o frode alla legge66. Dall’altro lato, va evitatala sovrapposizione tra abuso e simulazione, pur proposta da una partedella stessa dottrina civilistica anche recente67, in quanto essa può gene-rare confusione e sovrapposizione di concetti ontologicamente distinti, an-che con riferimento alle conseguenze ed ai rimedi (si pensi all’inefficaciadella simulazione tra le parti, ex art. 1414 c.c., ed agli effetti della simula-zione rispetto ai terzi, ex art. 1415 c.c.). Sarebbe, infatti, come sovrapporreil negozio in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.), di per sé reale ed illecito,alla simulazione, la quale implica un negozio fittizio e non rappresentanecessariamente il mezzo per eludere l’applicazione di una norma impe-rativa o per frodare i creditori68.
Si può viceversa convenire, in tal caso, con l’opinione che, proprio fa-cendo leva sulla nozione di immeritevolezza dell’atto già indietro richia-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 733
63 F. Di Marzio, La nullità del contratto, 2a ed., Padova, 2008, p. 640. 64 F. Di Marzio, o.l.u.c.65 G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario, cit., p. 69 ss. 66 G. Perlingieri, o.u.c., p. 64, il quale richiama testualmente A. Auricchio, La simula-
zione nel negozio giuridico (1957), rist. Napoli, 1978, p. 58: il negozio o le condotte foriere diabuso «sono reali ed effettive, ma tuttavia carenti di primarie ragioni economiche extrafiscali edin quanto tali si presentano come “anomale”, ed essenzialmente o esclusivamente dirette, attra-verso l’aggiramento o lo sviamento della normativa tributaria, ad ottenere vantaggi d’impostache l’ordinamento disapprova», mentre il negozio simulato è «un negozio privo di volontà».
67 A. Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir.comm., 2009, p. 403 ss.
68 G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario, cit., p. 65.
mata, ribadisce, coerentemente con i piú recenti e oramai consolidati orien-tamenti della Corte di Cassazione69, che il divieto generale di abuso con-duce all’inopponibilità fiscale delle operazioni. E ciò in stretta aderenzacon le finalità dell’ordinamento tributario il quale, come confermato dal-l’art. 37 bis, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non ha interessea vietare tali operazioni ma soltanto a considerarle irrilevanti ai fini fiscali.«Del resto l’“anomalia” delle operazioni realizzate e la finalità principaleod esclusiva di risparmio d’imposta sono elementi normalmente estraneialla fisiologica portata precettiva delle leggi tributarie d’imposizione, sí chele condotte abusive non sono mai contra legem ma semplicemente su-scettibili di sottrarre materia imponibile attraverso comportamenti contraria buona fede»70.
11. Muovendo dunque su un piano di teoria generale si trae conferma,in conclusione, che – ferma restando l’opportunità, già posta in luce inpassato, del necessario equilibrio tra esigenza della certezza del diritto erepressione del comportamento fraudolento71 – la frode al terzo/i può pre-sentare un concreto assetto di interessi, il quale ora giustifica la tutela ex-tracontrattuale, ora quella contrattuale (per esempio, in virtú di una pree-sistente relazione tra le parti), ora quella, ben piú intensa, della nullità/inef-ficacia, ovvero dell’inopponibilità al terzo (quest’ultima integrante, in vero,una forma di tutela generale del terzo idonea ad evitare soltanto gli effettigiuridicamente dannosi, ma non ad arginare, per esempio, i pregiudizi difatto)72, e, ancóra, dell’estinzione degli effetti (si pensi all’ipotesi del tuttopeculiare, in tema di contratto di fideiussione, specificatamente disciplinatadall’art. 1956 c.c.73) e dell’annullabilità (si ponga mente al caso, ex art. 1394
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi734
69 Cfr., da ultimo, Cass., Sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, in Corr. giur., 2011, p. 322,con nota di V. Carbone, Ristrutturazione societaria di gruppo e vantaggio fiscale.
70 Cosí G. Perlingieri, o.u.c., p. 79 (corsivo originale).71 Sulla necessità di sistematizzare il fenomeno della frode al terzo bilanciando certezza del
diritto e repressione della frode v., segnatamente, L. Carraro, Valore attuale, cit., p. 785. 72 In ordine alla tutela del terzo, per il richiamo alla flessibilità dei rimedi esperibili, v., per
tutti, M. Franzoni, Degli effetti del contratto, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, Artt. 1372-1373,Milano, 1998, p. 1109 ss.
73 L. Bertino, Le trattative prenegoziali, cit., p. 109. In giurisprudenza si è rilevato che,nell’àmbito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente e a tutela del terzo fideius-sore, «la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porretermine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’e-sposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse delfideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuoleperdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede»: cfr.
c.c., del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto d’interesse conil rappresentato quando il conflitto è conosciuto o riconoscibile da partedel terzo74). Anche per il fenomeno in esame vale dunque il monito, oggilargamente condiviso in dottrina, della massima flessibilità del rimedioconformato agli interessi rilevanti e specifici del caso concreto75. Pertanto,l’antico brocardo fraus omnia corrumpit finisce per perdere la sua origi-naria e assoluta valenza destituiva della validità degli atti conclusi con frodeal terzo/i, e va incontro oggi a nuove declinazioni che non sempre coin-cidono con l’esito propriamente invalidatorio ma, come proposto, pene-trano nel diverso territorio dell’immeritevolezza degli atti, legittimandopiuttosto altre tipologie di soluzioni rimediali.
Sotto ulteriore profilo, l’indagine fin qui condotta contribuisce a porrein evidenza la pluralità di funzioni che lo stesso principio fraus omnia cor-rumpit, con particolare attenzione alle ragioni del terzo o dei terzi noncontraenti, può di volta in volta assumere nel nostro attuale ordinamento.
In talune ipotesi, la frode al terzo/i opera, cioè, come concetto giuri-dico autonomo (si pensi al caso, piú spesso, se non unicamente, conside-rato dalla nostra giurisprudenza, della nullità del contratto per motivo il-lecito comune e determinante ex art. 1345 c.c.). In altre ipotesi, essa trovacoincidenza con la frode alla legge (art. 1344 c.c.). In altre ipotesi, ancóra,la denunciata portata evolutiva del principio fraus omnia corrumpit inducea chiarire che detto principio può assumere una funzione (meramente)esplicativa di altri fenomeni giuridici rilevanti, come quello dell’abuso deldiritto, quando, per esempio, la frode al terzo/i risulta correlata princi-palmente alla scorrettezza oggettiva dei comportamenti. Questa situazionedetermina (non già l’illiceità, bensí) l’immeritevolezza dell’atto, poiché ilrapporto creato dalle parti contraenti riesce giuridicamente o oggettiva-mente dannoso per i terzi. Il principio fraus omnia corrumpit poi, in ul-teriori altri casi, è destinato a fungere da meccanismo correttivo della por-tata delle stesse norme civilistiche. Per esempio, in questa prospettiva e alfine di mitigarne il rigore, l’applicazione dell’art. 999 c.c., come piú su ipo-tizzato in base ad un’interpretazione sistematica, dovrebbe essere condi-
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 735
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21730, in Rep. Foro it., 2010, voce Fideiussione e mandato di credito,n. 23.
74 Cfr., in giurisprudenza, Cass., 26 settembre 2005, n. 18792, in Rep. Foro it., 2005, voceRappresentanza nei contratti, n. 9, nella quale si rileva che «sussiste conflitto di interessi tra rap-presentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibilicon quelli del rappresentato, cosicché all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante odal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato».
75 Tra i riferimenti piú recenti v. P. Perlingieri, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, inGiusto proc. civ., 2011, p. 1 ss.
zionata all’assenza di frode effettiva nei confronti del nudo proprietario ealla pattuizione tra usufruttuario e conduttore di un canone equo. Del parie sempre per esemplificare, l’antico principio prior in tempore potior iniure, presente in varie sedi dal nostro codice civile, non dovrebbe trovareapplicazione in caso di frode al terzo/i e, dunque, quando il ricorso a taleprincipio giuridico diventa oggetto di evidenti speculazioni76. In quest’ul-tima circostanza, la frode al terzo/i è suscettibile di assumere nuove po-tenzialità proprio nel sistema generale delle fonti nel diritto privato, es-sendo in grado di neutralizzare l’applicazione funzionalmente sbilanciatadelle stesse norme codicistiche quando detta applicazione determina inconcreto esiti interpretativi irragionevoli per la tutela degli interessi delterzo/i.
Francesco Longobucco
Abstract
Il saggio analizza l’attuale portata applicativa della categoria della frode al terzointesa sia quale frode diretta «al terzo», sia – in chiave funzionale – quale effettoriflesso dannoso «verso i terzi». Sí che l’applicazione dell’antico brocardo frausomnia corrumpit determina propriamente la nullità ex art. 1345 c.c. (per motivoillecito – contrario all’ordine pubblico e al buon costume – comune e determi-nante), o per diretta coincidenza della frode alla legge con la frode al terzo (art.1344 c.c.), soltanto in caso di «contratto in frode al terzo». Mentre, nella diffe-rente ipotesi di «contratto in danno di terzi» (valido ma non meritevole), do-vrebbe trovare applicazione il rimedio risarcitorio ovvero quello dell’inopponibi-lità. L’idea di fondo è pertanto di associare alla frode al terzo, di volta in volta,il «giusto rimedio civile». Si riscoprono in tal modo rilevanti profili evolutivi euna pluralità di funzioni del principio fraus omnia corrumpit nel nostro attualeordinamento, principio che muove da concetto giuridico autonomo, a categoriaesplicativa di altri fenomeni giuridici rilevanti, a meccanismo correttivo nell’ap-plicazione delle norme codicistiche, dunque con evidenti riflessi sulla teoria dellefonti nel diritto privato.
This paper analyzes the case of contracts to the detriment of a third partyand the problem of a modern application of the ancient maxim fraus omnia cor-
Rassegna di diritto civile 3/2012 / Saggi736
76 Per alcune considerazioni in tal senso v. M. Galli, Sui nomi di dominio in internet, inRass. dir. civ., 2006, p. 667, il quale rileva – con riferimento al settore dei nomi di dominio –che il principio tradizionale della priorità cronologica (first come first served) potrebbe essereoggetto di abuso, sí che là dove la preventiva registrazione del dominio abbia avuto soltanto fi-nalità speculative, chi ha effettuato la registrazione sarà obbligato a trasferire il diritto all’usodel dominio medesimo al soggetto (frodato) legittimato. Nello stesso senso militano le rifles-sioni di A. Bizzarro, Sul superamento del principio di tassatività della trascrizione, ivi, 2010,p. 927 s.
rumpit. Under the author’s perspective, only when the contractors fraud is di-rectly against third parties, it is possible to invoke the nullity of the contract bothin the sense of art. 1345 Code Civil (that is in the case of a contract for illegaland contrary to public order/morality purpose), and in the sense of art. 1344Code Civil (because of the possible coincidence of fraud against civil law andfraud to the detriment of third parties). On the contrary, when the contractorsfraud is only indirectly against third parties, the contract itself might be consid-ered valid but not enforceable (towards third parties), or alternatively a source ofthe contractor’s civil liability (in favour of the damaged third parties). Thereforeit should be necessary to choose the most appropriate civil remedy, case by case,in order to protect the innocent third parties. In this way the issue justifies themodern functions of the mentioned principle fraus omnia corrumpit in our cur-rent civil law system. In fact this principle sometimes might be intended as anindependent legal concept, some other times as a correlated concept to differentlegal categories, some other times as a corrective equitable mechanism in the ap-plication of Civil Code articles, with a clear impact on the sources of Private positive Law.
Francesco Longobucco / Fraus omnia corrumpit 737