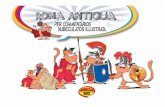Anpassungsstrategien lateinamerikanischer Roma-/Zigeunergruppen
Nuove ricerche su Cereatae Marianae (Casamari, Frosinone), in Atti del Convegno, Terzo Incontro di...
Transcript of Nuove ricerche su Cereatae Marianae (Casamari, Frosinone), in Atti del Convegno, Terzo Incontro di...
*ryN',\
' F t i É ' f
@ WA"#t
# ffit fFfi
!"lti:i .,_dtp.d"tdú
I
,,. i1,.., 'Irtí,iit-ií, l.'
itl.t,,.l:. .;ittil
OtZvT rsc rrrcoToaulufrlNsffryl
"1, ,q.
fíii:,:
,lt:l
NSJNTUdOSiVT{EO.IQnJS g IuOAVT
Nuove ricerche su Cereatae Marianae (Casamari. Frosinone)
Maria Romana Picuti
larea archeologica oggetto di questa presentazione èsfafa poftafa alla luce, fortuitamente, nel corso dei la-vori di scavo per la realuzazione di una rampa per di-sabili, lungo il lato sinistro della scala di accesso allachiesa dell'abbazia di Casamari. in provincia di Frosi-none (fig. 1, 6). I-indagine archeologica, che ha presoil via il 1l settembre 2004, è stata portata a termine, do-po varie interruzioni, solo nel mese di febbraio 2005:lenotizie della presente relazione possono considerarsi,al momento, del tutto preliminari'.
7. Lo scauo
La zona indagata, prima dell'inizio dei lavori, era oc-cupata da un'aiuola delimitata da un muro d'epocamoderna rcaltzzato, presumibilmente, nel 7912, almo-mento del completamento dei lavori ùla gradinata diaccesso alla chiesa (fig.2)'.
Le strutture romane della porzione settentrionaledell'area sono state, in parte, uttfizzate come puntod'appoggio per il muro perimetrale del cimitero, pre-sumibilmente a partire dal Settecento, quando la zonavenne prescelta quale luogo di sepoltura dalla comu-nità monastica di Casamant. Tutfa la oorzione meri-dionale, invece, era già stata interess utu duuntaglio perla rcalizzazione di una struttura, presumibilmente d'e-poca medievale, a sua volta obliterata a seguito della sistemazione della scala moderna che ancora oggi si ve-de.larea dell'aiuola è stata a sua volta sconvolta dalloscavo per la posa in opera di un largo canale di cemen-to, intorno agli anni Cinquanta del Novecentoa, quan-do vennero tagliate alcune strutture murarie, un pavi-mento in cocciopesto e la relativa sttatigrafia archeolo-gica. Lo scavo ha portato alla luce parte di tre ambien-ti contigui (fi4g.3-a) '. Quello cenrrale, I'ambíente 2, èchiuso verso nord da un muro con orientamenro esr-o-vest (USM 1), che presenta un paramento murario piut-tosto irregolare, con grandi blocchi di calcare squadra-ti, dalla superficie rifnita a gradina e probabilmente diriufillazo, posti in opera insieme a pietrame informe dimodeste dimensioni e a scaglie di calcare (figg. 3-5)'.Verso est esso è stato prolungato di circa cm 6,5, al mo-mento della realizzazione di una struttura muraria di-sposta perpendicolarmente (usu z); questa presenta unandamento nord-sud edè realvzata a piccoli blocchi di
calcare informi e ciottoli lesati insieme da malta di co-lore rosat. È stata riportatala luce in pessimo stato diconservazion., perèhé completamentè tagliata, nellaparte centrale, dal canale di cemento. Nella porzionemeridionale se ne conserva un blocco squadraìo, ma aldi 1à di esso appare di nuovo lacunosa, a causa dell'al-largamento della scala moderna. Sia la struttura setten-trionale, sia quella orientale conservano resti della de-corazione ad intonaco, che, nei tratti meglio conserva-ti, raggiunge l'altezza di m 1'.
Lambiente ha il pavimento in cocciooesto formatoda una superficie ben rilinita di colore roiso, che nrisu-ra cm 6 di spessore (frammenti fittili triturati, sabbia ecalce), e da due strati di prepanzione. Il primo, che rag-giunge lo spessore di cm 12, è realnzato con sassolini di
297
Fig 1 Casamari. Pianta dellabbazia (Archiutlo sur)
colore giallo, il secondo, che misura cm9 ca.,con ghiaia,frammenti ceramici e sabbia mescolati a calce. Per larca)nzazione del piano pavimentale è stato preventíva-mente steso uno strato di scaslie di calcare e di terra ar-gillosa compatta, la cui profondità aumenta considere-volmente da est verso ovest, colmando il dislivello delpiano sottostante, una roccia naturale, calcaîea, che pre-senta in superficie delle probabfi tracce di lavorazione,forse relative a un precedente piano di frequentazioneantico. Il pavimento e lo strato di livellamenro sono sra-ti completamente strappati, verso ovest, al momentodella messa in opera del canale recente e, nella porzionemeridionale, quando venne rea)uzato il muro dell'aiuo-la. Per questo motivo nulla rimane della struttura mura-ria che chiudeva l'ambiente verso sud e si conserva soloqualche centimetro di quella nord-sud che delimitavaI'ambiente verso ovest. Questa, che presenta uno spes-sore modesto, è formata da una muratura mista di ciot-toli e piccoli blocchi dí calcare; è stara rcahzzataal di so-
MARIA ROMANA PICUTI
pra del pavimento in cocciopesto e appoggiata al murosettentrionale (uslt 4, figg. 3-4 e 6) u; nella circosranza,per favorire la coesione tra le due strutture, venne inci-sa la superficie pittorica del muro. Appare evidente chevenne rcalvzata in un secondo momento, con l'intentodi ricavare due stanze dalla suddivisione di un ambien-te più ampio, come prova, tral'alto,l'assenza dell'into-naco, che decorava invece l'altra struttura.
Nell'ambiente 1 il muro nord (uslr t) conserva laparte inferiore di una finestra; essa è stata scavata soloin parte perché posta sul limite dell'area di scavo e al Idi sotto del muro dell'attuale camposanto'.. In tale s1ambiente la stratigrafia archeologi.uìi .onr.ruava solo rilungo una sottile striscia di terreno risparmiata lungo ela parete nord; qui infatti, aJ di sopra dèila pavimenia- frzione in cocciopesto) erano ben riconoscibili i tre stra- Dti che riempirono l'ambiente dopo il suo abbandono: ddal basso in alto, è stato possibile riconoscere il crollodel tetto e della decorazione pittorica, con tegole, cop-pi e frammenti d'intonaco, cui si sovrappon.va rrn àl-tro crollo d'intonaci, presumibilmente relativo allapate alta dei muri perimetrali. La presenza di unaconsistente quantità d'argilla compatta tra i due stratitestimonia I'accumularsi di terra e I'esoosizione asli a-genti atmosferici dell'area nell'inrervailo di tempó in-tercorso tra \a formazione del primo e del seèondocrollo. IJ n' analo ga sequenza stra iigrafica è s rata indivi-duata all'interno dell'ambiente centrale, anch'essaconservata nell'unica fascia di terreno addossata al mu-ro nord. Tale situazione lascia supporre che i due vani,sebbene separati da un muro àiúamezzo, abbiano su-bito il crollo del tetto nel medesimo momento.
Anche le strutture murarie dell'ambiente J. cuelloorientale, sono state in buona parte distrutte dal pas-saggio della tubatura recenre. [l muro nord-sud, che lodivide dal vano centrale (usnr Z), si lega a una strurtu-ra muraria con una tessitura mist4a piccoli blocchi dicalcare e tegole che ha un orientamento est-ovest (uSM3, figg.l-4) ". Essa, dopo un metro, s'interrompe e gi-n, ad angolo retto, in direzione nord, verso la zona at-tualmente occupata dal cimitero; dopo cm l0 ca., lastruttura, in pessimo stato di conservazione, forma dinuovo un angolo retto e riprende l'andamento est-o-vest12. Entrambe [e struttuie supersriri appaiono rive-stite dal medesimo strato d'intonaco di cui, a tratti, siconserva esclusivamente la prepa razione. La presenzadi un ulteriore strato di pittura lungo il muro òcciden-tale testimonia, forse, una precedente fase decorativa.
ID
uaîa
SI
n(
Cí
pidip1
fIl
pimspuf
Gcoscrlogr(zicln
t .cll
fe
sta
rca
m(@
inco.penerices(fe1n \ò L I
cia
Fz,g 2 Area dell'interuento di scauo
-1:ù\-
Fig 3 Planimetria generale dell'area di scauo
298
Fig 4 Sezione ,t+
dell'into- I
nserva lavata solocavo e alt. In talevava sololta lungoI'v'lmenta-
i tre stra-randono:: il crollo;ole, cop-:va un al-rtivo allaa di :unadue strati'ne agli a-empo ln-secondo
rta indivi-anch'essaafaalmu-due vani,,biano su--o.3, quello
: dal pas-ud, che lora struttu-rlocchi di)vest (usMrmpe e gi-azon at-30 ca., la, forma dinto est-o-,iono rive-a tratti, sir presenzar occiden-[ecorativa.
'IA PICUTI NUOVE RICERCHE SU CEREATAE MARIANAE (CASAMARI, FROSINONE)
ral murocostanza,nne incilente cheI'intentoambien-
to a forma di doppio gradino e rivestito da una maltarosa mista a polvere di tufo; nonostante le ridottissimedimensioni del tratto scavato, è evidente che esso si ri-ferisce alla sistemazione di una canaletta antica formata da coppi (fig. 3) '6. Per la sua rcalizzazione sem-bra che sia stato tagliato il crollo degli intonací; se co-sì fosse si avrebbe la prova che I'opera ài canalizza-zione è stata rcalizzata in un'eooca successiva all'ab-bandono e al crollo delle struìture dell'ambiente o-rientale. IJimportanza archeologica dell'area del cimi-tero risultava già, da un documento d'archivio, in cuisi fa menzione del rinvenimento di alcune srrurruremurarie, di pavimenti antichi e di una colonna fittileformata da mattoni di forma triangolare, certamentela prosecuzione dell'edificio appena descritto ". La se-gnalazione del ritrovamento della colonna fa pensare,presumibilmente, all'esis tenza diuno spazio porticatoo forse a un peristílio; non è escluso, tra I'altro, chefosse proprio su questo spazio aperto che si affaccias-se la finestra individuata lungo la parete dell'ambien-te occidentale (ambiente 1).
In definitiva il cattivo stato di conservazione dellestrutture riportate alla luce, per i danni subiti in epocaantica e recente, e la limitata arnpiezza dell'area d'in-dagine, costretta tra I'attuale cimitero e la scala mo-derna, non permettono di avanzaîeipotesi esaustive u-ttliallaricostruzione topografíca della zona. Ciò non dimeno tale intervento di scavo riveste una notevole im-poîtanza, anche in considerazione del fatto che costi-tuisce la prima occasione in cui ritrovamenti archeolo-gici dell'abbazia cistercense di Casamari vengono do-cumentati con criteri scientifici.
2 CercataeMarianae. La storia e i ritrouamenti
Labbazia, come noto, sorse sui resti di Cereatae Ma-ridrcae",la città romana che, stando alla testimonianzadi Plutarco, in preceden za era stata uno àei pagi di Ar-pinum e il luogo in cui nacque Caio Mario'u. E proba-bile che un centro urbano vero e proprio sia sorto so-lo a seguito della raggiunta indipendenza arnministra-tiva, awenuta in un momento imprecisabile, ma certa-mente da collocare prima del règno dell'imperarore,Augusto'.. Dal Liber coloniarum ús'ita inoltre che,durante il periodo augusteo, Cereatae Marianae subì u-na nuova fondazione per opera di Druso Cesare, figliodel futuro imperatore Tiberío, il quale ne divise le ter-re tra i militari del suo esercito". Il nome antico di Ce-reatae è attestato da alcune iscrizioni; in una di questeviene nominato urì ( s e)uir Cerea [tinorurz:] ", frlrn'ulttuun cambiavalute, nummularius Cereatinor(um)", e inun'aftra ancora un benefattore, di cui è andato perdu-to iì nome, definito [pa]ter o [ma]ter Cereatiztorum'a.IJaggettivo Marianae, con cui viene nominata in Plinioil vecchío, venne aggiunto, probabilmente, in un se-condo momento, in omaggio al più illustre dei suoi cit-tadini". Questo compare in un'iscrizione più tarda,
Figg 5 6 Ambiente 2 e ambienti 1-2
A differenza degli ambienti descritti, quesro ci ha re-stituito parte del crollo, all'interno del quale sono sratiriportati a1la luce numerosi frammenti di tegole, coppie intonaci. Al momento non è sraro possibile ripulire iframmenti della decorazione parietale. anche se a unaprima verifica appaiono conservare consistenti traccedella superfície pittorica.
All'interno di tale strato è stato ritrovato un asse dibronzo di età tiberiana che reca sul dritto la scittaDi-uus Augustus Pater e 1a testa di Augusto rudiata rivoltaa sinistra, mentre, sul retto, la scritta Prouiderct(ia) elanffigvazione di un altare con ulati S(enatuù C(on-sulto),\a cui datazione si colloca nell'arco di tempo cheva dalzz-23 al;o d.C. ". Nel medesimo strato eiano i-noltre contenuti numerosi frammenti relativi a cerami-ca da dispensa e da fuoco, con pentole a tesa anche dipiccole dimensioni e tegami a orlo rientrantela, paretidi anfore ed esemplari molto frammentari di coppe apareti sottili 1', tutti databfi a partire dal sec. r d.C.
Nella porzione occidentale dell'ambiente, dopo larimozione del crollo, una concentrazione di blocchi dipietra calcarea di media grandezza, tegole e coppi,mattonelle rettangolari appartenenri a un pavimento aspicatum e blocchetti di tufo, potrebbe far pensare aun accumulo volontario di materiale da costruzione.Gli strati appena descritti poggiavano sopra un pianocompatto ài preparuzione formato da calce bianca me-scolata a sassolini e a mi frammenti di cocciooesto al-1o stato polveriforme. Esso era ben conservato nel sag-gio all'interno del cimitero (fig. 3), mentre, nella por-zione lungo la scala, è stato individuato solo a tratti ein sezione, lungo il limite settentrionale dello scavo. Aldi sotto ftgurava inoltre uno strato lenticolare di cene-re che, a sua volta, poggiava su di un altro di terra mi-sta a polvere di tufo; al loro interno sono stati ritrovatiframmenti ossei e fittfi bruciati, ghiaia e due fram-menti di ceramica aDareÍi sottfi.
Nel saggio all'intèrno del cimitero è staro riportaroin luce un nucleo di calce frammentario, rcalizzatocon un impasto in tutto simile a quello del piano ap-pena descritto (fig. 3). Il cattivo stato di conservazio-ne e la limitata porzione di scavo non permettono diricostruirne lafotma e il rivestimento, anche se non siesclude che possa essere relativo a un bancone, oppu-re a una struttura di tipo analogo, che poggiava sopralaprcparazione. Al fondo della stratigrafia appena de-scritta è stato individuato un piano uniforme di roc-cia, che, nell'angolo nord-est, presso la scala, è taglia-
299
dedicata a Felice Vittorio dal senato locale, l'ordo Ce-reatinorum Marianorum, nel corso del sec. rV-V d.C. %.
Per quanto riguarda, invece, il toponimo Casamariè noto fin da epoca medievale etramanda, chiaramen-te, il ricordo dell'origine cereatina di Caio Mario".
Nella scelta del luogo deve aver giocato un ruolo diprimo piano la sua collocazione all'aftezza deII'attraversamento del torrente Amaseno e lungo un importanteitinerario, un'antica strada che metteva in comunica-zionelaviaLatina con il nodo stradale di Sora, con lavalle Roveto ela zona del Fucino". I1 ritrovamento, nelgiardino della biblioteca e nell'attuale parcheggio, diframmenti di sime architettoniche strisilate e diointeche risalgono al sec. ttt a.C., nonché di due piedi in ter-racotta2e. Dermettono d'iootizzarcl'esistenza di un luo-go di cdtò e costituisconò h testimonianzaarcheologi-ca più antica del luogo, probabilmente precedente allastessa fase urbana del centro. Della città rimane ben oo-co, perché i ritrovamenti di strutture e materiali antichisono awenuti semore fortuitamente nel corso d'inter-venti di restauro alcomplesso abbaziale o a seguito dilavori agricoli. Nuovi dati sono stati aggiunti di recentealle nostre conoscenze gtazie a17a parziale trascrizionedellaCronaca deLL'abbazia. un resoconto nel quale i mo-naci annotano i principali awenimenti dell'anno; diparticolare interesse, ai nostri fini, sono risultati queipassi in cui si segnalano i ritrovamenti di strutture anti-che o quelli in cui si parla drttasformazioni architetto-niche apportate al complesso abbaziale'0.
Negli ultimi anni, un notevole passo in avanti versola valorizzazione del patrimonio archeologico di Ce-reatae Marianae è stato comDiuto con la sistemazionedel tratto di strada ro-*, conservato nel siardinodella biblioteca (fig. 1, 10) e dell'area attorno I pont.romano sul torrente Amaseno (fig. 1, 1)r1. Un notevo-le sforzo inoltre ha richiesto il riordino e I'inventaria-zione del materiale archeologico conservato pressol'abbazia e l'apertura al pubblico del nuovo allesti-mento museale, inaugurato nel luglio 200332.
I'larca in esame è attualmente prospiciente al corti-le esterno delT'abbazia. una zona comDresa tra la chie-
MARIA ROMANA PICUTI
sa e I'ingresso, dove i ritrovamenti di manufatti' e diedifici antichi hanno permesso di localizzare il forodell'antica Cereatae Marianae (fig. 1, 5). Confermereb-be tale rdenttficazione il ritrovamento, in tempi diver-si, di quattro basi, probabílmente utlizzate come so-stegno di altrettante statue ra. In particolare, una diquelle iscritte venne posta, intorno alla fine del sec. Ia.C.,in onore di Caio Mario".
Secondo la testimonianza dr alcuni documenti con-servati nell'archivio di Casamari. inoltre. le colonne an-tiche attualmente ricostruite nell'aiuola posta dí frontealla chiesa vennero alla luce nel 1856, a seguito dei lavo-ri di livellamento del piazzale'n. E probabile che unaparte di questi rocchi debba essere attribuita alla co-struzione della orima chiesa di Casamari. ouella bene-dettina del sec. ù, cui vanno probabilmente iiferiti quel-li privi di scanalaturer'. Gli altri, quelli scanalati, po-trebbero invece essere riferiti a un orecedente edificioromano. La Cronaca del Cartario, urta narrazione dellastoria del monastero dalle origini fino al l222,ttamandainoltre che, al momento deTTafondazione del primo edi-ficio sacro, alcuní uomini provenienti dalla vicina Vero-li si stabilirono sul luogo dove sorgeva "un tempio de-dicato al dio Marte"'u. Se non abbiamo fondati motiviper prendere per buona la dedica di un tempio aMar-te, sembra tuttavia plausibile lalocalnzazione di un pre-cedente luogo di culto nei pressi della basilica attuale,stante la sua posizione dominante rispetto alla topogra-f:r-de1l'areae alla continuità di uso delTazonadella chie-sa. Da qui, infatti, proviene una dedica sacra in onore díSerapide, nota dalla tradizione manoscritta'u e inoltre u-na base iscritta, di piccole dímensioni, in cui viene no-minato il dio Mercudooo e una oiccola statua femminilein marmo raffigurante un tipo & giovanep eplopborosu',che sono probabilmente da identificare con delle offer-te votive. Stando alla Cronaca.inoltre. nel corso desli an-ni Settanta del Novecento, alcuntlavori effettuati al disotto del piano pavimentale della chiesa per Ia rcalnza-zione dell'impianto di riscaldamento hanno rioortato al-la luce, all'allezzadell'incrocio del transetto cón h nava-ta centrale, una struttura muraria, un pavimento e unacanaletta con un tratto di un tubo di piombo posto al-I'interno di un canale di tegoleo'; essi permettono d'ipo-tizzarclaDresenza di edifici romani nel ounto in cui sor-se 1a chieia medievale (hg.I,12).
Sull'altro lato del piazzale tracce di un edificio co-lonnato sono state individuate ne1, 1926, tra l'ingressoàell'abbazia e la sala parrocchiale, a destra dell'íngressoe a due metri al di sotto del piano di calpestio (fry.1,3);di esso rimane la testimonianza divna colonna rimonta-ta su quello che, al momento della scoperta, venne i-dentificato con un gradino antico. Nella sala parroc-chiale. nel t95t. sono inoltre tornate alla luce delle strut-ture murarie e un tratto di lastricato formato da srandiblocchi rettangolari di pietra locale (fig. r, 4)o'. Questodoveva essere circondato da cunette di scolo, di cui so-no stati ritrovati tre lastroni, che connotano il ritrova-mento come la paimentazione di un'area estema, pro-
btrpI'p
dplaBSI
cl
tisi1I
f(pS (
siz1r(SZ
lr
sid
sic(bqa.\aIT
laIT
ni
len(
si,c(efSC
dr
Fit17f
Fig 7 Struttura muraria d'epoca posteriore
t00
\A PICUTI
rtti' e di:e il foroermereb-rpi diver-come so-:, una didel sec. I
renti con-Ionne an-di fronte, dei lavo-: che unaa alfa co-:lla bene-eriti quel-ralati, po-:e edificioione dellaftamandarrimo edi-:ina Vero-:mpío de-ati motivirio a Mar-di un pre-:a atluale,r topogra-Cella chie-r onore di:inoltre u-uene no-femminile'aphoroso',
lelle offer-o degli an-tuati al dia rca lnza-portato al-ln la nava-)nto e unal posto al-ono d'ipo-in cui sor-
dificio co-l'ingresso
:ll'ingressor (fig. 1, 3);a rimonta-l, venne i-Lla parroc-delle strut-, da grandia1. Questo, di cui so-, il ritrova-terna, pfo-
NUOVE RICERCHE SU CEREATAE MARIANAE (CASAMARI, FROSINONE)
babilmente di tipo pubblico. Nel corso degli scavi effet-tuati all'interno dei locali attualmente adibiti a ufficiopostale e durante lavori nei pressi del casale esterno al-l'abbazia è stato possibile accertare che I'area lastricataproseguiva ben oltre il limite della sala parrocchialeo'.
Nel tg:z inoltre Giorgio Gullini, della Soprinten-denza alle Antichità di Roma I, effettuò dei sondaggipreventivi nelfa zona del giardino della biblioteca. Dal-7a rclazione, consefvata presso la Soprintendenza per iBeni Archeologici del Lazio, risulta che in tale occa-sione venne riportata alla luce la strada basolata concrepidine che ancora oggi si vede (fig. 1, 10)45. La con-tiguità topografica tra questa e il lastricato rende plau-sibile I'ipotesi che quest'ultímo costituisse un allarga-mento della via nel suo tratto urbano, con 1o scopo diformare una piazza monumentale al centro dell,a zonapubblica della città. In quella stessa occasione venneroscoDerti un muro in ooera incerta e due strutture chesí còngiungevano ad angolo acuto. Poiché nella rela-zione di scavo si dice che su una di esse poggiava il mu-ro di recinzione moderno, è probabile che questa pos-sa trovarsi nelle immediatevicinanze di un altro muroindividuato nel corso delt996,in occasione di lavori disistemazione del giardino, quando venne documentatadalla competente Soprintendenza (fig. 1, 8)'".
Negli uffici della biblioteca dell'abbazia è inoltre vi-sibile. dopo il recente restauro, un pavimento a mosai-co con un disegno geometrico a rombi neri su fondobiancott; esso venne riportato alla luce negli anni Cin-quanta del Novecento ed è databile alla fine del sec. ta.C. (fig.1, 7). Nulla rimane delle strutture murarie re-lative a tale piano pavimentale, anche se un muro ro-mano è stato scoperto nel locale attiguo, nel corso deilavori di ristrutturazione del tgS6 (fig.t, 9). Il ritrova-mento, nella stessa area, di un'iscrizione che ricorda u-na scbola" e di un'altra relativa al collegio professiona-le dei fabri tignarioruman rende probabile l'attribuzio-ne degli ambienti alla sede di tale associazione.
Nel corso degli scavi condotti da Gullini, in occa-sione dell'allargamento del parcheggio, nelJ,a zonacompresa tîaIa s:'rada e il torrente Amaseno venneroeffettuate dieci trincee parallele, che portarono allascoperta di alcune strutture murarie, di una fognatura,di un pavimento con lastre di terracotta e di una va-
Fig 8 Scala della chiesa nella sua ueste settecentesca (fine sec. xIX,Archiuio de ll' Abbazia di Casamari)
schetta di cocciopesto, dei quali purtroppo non rima-ne alcun rilievo (fig. 1, 13)'0.
Dalfa Cronaca di Casarnari apprendiamo inoltreche, presso I'ingresso principale del monastero, a po-chi metri dai luoghi appena descritti, vennero indivi-duati alcuni piccoli ambienti contigui, i quali, per lapresenza di due grandi contenitori, di anfore e di unpiccolo gruzzoTo di monete, vennero identificati dagliscopritori con delle tabernae (fig. 1, 2)'1. Essi venneroportati alla luce am5 o 6 di profondità, nel 1940, quan-do si decise di arretrare il muro di contenimento Dres-so I'entrata delf'abbazia. In tale occasione si rinvenne-ro anche due statue in marmo di modeste dimensioni,che figurano, insieme agli altri oggetri, in un disegno e-laborato dall'autore della Crorcacat'.
Altre strutture murarie, lastricati e alcuni rocchi dicolonne si ritrovarono nella zona tral'insresso dell'ab-bazia eil ponte sull'Amaseno, durante i lavori che l'in-gegnere Fortunato Mattei diresse, nel 1854, in occasio-ne dell'apertura della strada moderna'.
Di particolare interesse il riffovamento di alcuni am-bienti iomani individuati .nelt95z.nel corso di lavori diristrutturazione nella zona compresaúala cucina e il re-fettorio (fig. 1, 11). La loro p."rèrrn non venne allora se-gnalata alla competente Soprintendenza, cosicché di es-si non rimane alcuna documentazione, se si escludequanto viene riferito nelTa Cronaca. Da questa appren-díamo che si rinvennero un pavimento, due strutturemurarie con la relativa decoruzione pittorica ad affrescoe una costruzione rotonda per la disribuzione delle ac-que in due vasche; essi furóno allora attribuiti a un edi-ficio termale d'epoca romanato. La zona risulta aftuaf-mente inglobata all'interno della cucina e della scala diaccesso che dalla portineria conduce al chiostro e non èpiù visibíle; dell'edificio antico rimangono solo due fo-to, di cui urra relativa a r.m pavimento in cocciopesto contesserine bianche di calcare tt e rm'altra relativa allestrutture esterne. Non si esclude che appartenessero al-lo stesso complesso i muri di fondazione rinvenuti, nelcorso del 1960, lungo il lato meridionale del chiostro'6.
Dal quadro così delineato risulta evidente quantosia difficile ricostruire Ia forma urbana e il reticolo via-rio del centro antico. Lunico elemento certo è che sliedifici si disponevano su più livelli lungo il fianco dè1-,la colLina, così come si è riscontrato sulla base dei po-chi edifici ancora paruialmente in vista o grazie alle te-stimoníanze d'archivio. Confermano ouesta iootesi igrandi blocchi di pietra squadrati che iono stati riuri-lizzati nelfe strutture del monastero medievale e, inparticolare, nel muro settentrionale del chiostro, chesembrerebbero poter provenire da opere di tenazza-mento d'epoca romana. Nel suo insieme il centro nondovette avere un grande sviluppo planimetrico, comelasciano intendere i ritrovamenti di tombe romane al-f interno della clausura monastica o nelle sue imme-diate vicinanzett, mentre sembra probabile che fosse-ro soprar,wissute forme di aggregazione di tipo sparsonel territorio: pagi e uici, tnsediamenti rustici e ville".
30r
r
3. La strutturd romana postclassica
Per concludere bisogna ricordare che l'area indagata èstata interessata, Iungo il margine meridionale delloscavo, dal passaggio di un muro dall'andamento leg-germente divergente rispetto alle strutture d'epoca ro-mana (usu 5, figg. ) e 1)". Lungo la fronte nord, essopresenta un paramento esterno in conci squadrati, didimensioni regolari e posizionati a fascia, mentre, sullato opposto, in luogo della facciavista, figura un riem-pimento con materiale formato da blocchi, squadrati enon, di varie dimensioni; alcuni dei conci della fronte,disposti per testa, servivano di legatura tra la fronte e í1nucleo. Nella zona inferiore, non a vista, la regolaritàdei filari si oerde e si riscontra I'inserzione di alcuni cu-nei dí pietra e di frammenti di tegole. Il muro è sortoal di sopra della canaletfa realizzata nel piano rocciosodell'ambiente orientale (fig. l) ed è stato in partesmontato al momento della realizzazione della scalamoderna. Attualmente si trova al di sotto della scala diaccesso alla chiesa e, per questo motivo, è stato inda-gato solo in parte.
MARIA ROMANA PICUTI
Il trattamento delle superfici, simile a quello uti-Iizzato per i blocchi della chiesa e il suo orientamen-to, che punta sull'asse del pilastro settentrionale del-l'edificio sacro, lasciano supporre che si tratti di unastruttura medievale in rapporto con la chiesa60; vistala sua collocazione non si esclude che oossa trattarsidel muro di spalla della scalinata originaria, quellad'epoca medievale. In origine questa occupava infat-ti tutta I'ampiezza della facciata (fig. 8)6', ma fu mo-dificata, nel corso del Settecento, quando venne li-miÍ.ata alla campata centrale del pronao della chiesae racchiusa tra due ampi spazi verdiu'. Nel tqtz infi-ne, dopo alcuni anni di lavoro, terminò il ripristinodella scalinata secondo il modello originario e i gra-dini vennero prolungati fino a comprendere le trecampate della faccíata della chiesa; l'edificio sacro haallora assunto l'aspetto definitivo con íl quale è giun-to fino ai nostri siorni6'.
MARTA ROMANA PICUTi
, ,C, ' C, o (
74, 'T, U C
Cacel, ,7,"/
, U I
pe, ' S) z
Gi15t
" IIa',coè sforCct t (
denupiitoLE
macol,OL
dot t c
n.t n c
del
ve(ablscaqu(darchidar184sprborgrcdipr(191melucnortfa
na,nelm€, ' S1 8 l -
t t c
89;, o l
19(o r I
t4-,, r (
CC\
stasefcotolt
ch,InC
taz
Note
'I lavori di scavo sono stati eseguiti sotto la direzione scientificadi S. Gatti (sear-), che ringrazro per aver permesso la pubblica-zione di queste note e peiauer fàcilitato i] mio lavoro^di studiosu Cereatae Marianae. Un sentito ringraziamento va inoltre allaCongregazione del Sacro Ordine Cisiercense di Casamari e, inpart icolare. al l 'abate padre S. Buttarazzi. a l .adre F. Farina e a pa-dre A. Coratt i . Al lo scavo he col laborato V. Chiappini, la cartacatastale dell'abbazia è stata aggiornata da G. Trojà (se,tr-), i rilievi dell'area di scavo sono stati eseguiti da L. Trigona e rielabo-rati da V Cruciani.' Cassoni 1927 , 29.
1 r .'Questo serv iva a convog l ia re le acque p iovane proven ien t i da l -l'area del colJegio e dal Fianco nord della chiesa verso il piazzalcdel1'abbazia.'Larea indagata ba raggiunto una lunghezza massima di m 11 erttTa r îÈ,nezza ot ).oAmbiente 1: alt. m 1,02; lungh. m 2,40. Ambiente 2: a1r. m I,2O;lungh.m,3.La lunghezza totale misurabi le è di m t,70, 1o spess.mlsurabile e dr cm 25.
to a esso.t'D / Dlvuslucusrus pA'tER.Tesf^ di Augusto ndiata a sin., a /PROy:DENT. Altare con ai lati sc. Zecca: Roma. Per la datazione sí
vedano: R1C r, 99, 81 (círca 22/23101 d.C.);.rNR t, 1, 182-790,771-236 (22/Dto ? dc.)" Si segnalano pentole a tesa (sec. t d.C. metà sec. I d.C.), ollea orlo estroflesso (tarda età repubblicana - età flavia) e un fram-mento di scodella a orlo estrofTesso in terra sigillata italica (cfr.,4-/ lanlc lc)85, ì85-186, forma xtt, sec. t d.C.).
'6Del fondo è stato índividuato un copDo e f inizio dí un secon-do, mentre nulla rimane della copertuià.'' Cassoni 19t8, t6-rl: <De Bobus Relazioni Miscellane a - Artico-lo scritto dalla mano de1 Sis. Fortunato Mattei che diresse i la-vori della strada presso Casàmari nel t8i4-it, ms. Biblioteca delComune di Veroli: Verso l'attuale camposanto si rinvenne un a-vanzo di fabbricato con tenacissimo laìtricato ed un residuo dicolonna rotonda, alta forse un metro e mezzo, fatta in mattorii atriangolo formatí, al qual fabbricato distintamente sí nconoscevaessere state aggiunte e sovrapposte mura dí diversa costruzione;quel fabbricaiò sembrava pròlungarsi di sotto íl muro dell'attua-le camposanto ed orto contiguo [...]>; cfr. Cata.Llr 1980,96-91 .ttSu Casamari: Farina - Fornari 1983; Farina Fornari 1987. SuCereatae Marianae'. Garrucct 1851, 10-15; Hùlsen 1889, 1969; Cas-soni 1918; Manciní 1927, 66-71; Mazzarino 1971,299J271 Catalli1.976-17, 2$-258; Cancellieri 19i6-i7 , 58,69; Catallí 1980, 8l-112;Rizzello 1980, B-51 , 165-17J; Giannetti 1982; Beranger 198.{, XV-xx; Coarelli 1984,238-240; Solin 1988,94-99;Kaiava - Aronen -S o l i n 1 , r 8 9 , l 0 ì - l I 8 : . F o r t i n i l q q 4 , t 0 2 - t 0 r .1'PIut. Mar.3.to Cereatae infatti non viene mai citato come centro indioendentencgl i scri t t i di Cicerone. che essenJo Jí orígine arpinate dovevaben conoscere Ia situazione della zona. menffe fisura in Strabo-ne (v, l, 10); cfr. Coarellí r98t,D8; Solin 1988, 98, nora 21: ultimianni di Cesare o periodo triumvirale." Lib. Col.,2l l ed. K. Lackmann.
302
IANA PICUTI
quello uti-flentamen-ionale del-'atti di unaesauo; vistasa trattafslria, quellapavainfat-ma fu mo-r venne li-ella chiesaI tgtz infi-ripristino
rio e i gra-lere le treio sacro haale è giun-
TANA PICUN
1.82-190, 17r-
n d.C.), ol le) e un fram-.ahca (cfr. A-
?colàzlone a: . t d . C . e n e licolare si se-rssimazione,generaÌmen-oecofazl0nei con cafenano e con de-lell'età clau-
Ji un secon-
rea - Artico-diresse i la-iblioteca delvenne un a-n residuo diin mattoni anconoscevacostruaone;o dell'attua-J0,96-91 .ari t987. Su), 7969; Cas--327; Catalli980,83-112;er 1984, XV-- Aronen -
rdipendentenate dovevaa in Srabo-ta 21: ultimi
NUOVE RICERCHE SU CEREATAE MARIANAE (CASAMARI. FROSINONE)
" er x, 51 7l ; Cassoni 1918, 73 -i 4, n. v." ctL x, 5689; Cassoni 1918, 71, n. rv"Cassoní 1918, 86, n. XLIX; Mancini 1921,70; Panciera 1967, r-54 ."Pln. nat, lnl ,61'u oL x, 5787; ILS, 6289; Garrucci 1851, 1r-12; De Persiis 1878, 6-7 ;Cassoni 19 18, 20, 7 2, n. rr, foto dopo 3 6; P ancier a 1967, 5 0; Can-cellieri r97 6-17, 58; Giannetti 1982: $ -4j , n. 11." Farina - Fornari 7987 , 56, not^ 4." Aurigemma 1911, 491 -553 ; Catalli tgSO, 105 -112." Cancellieri 197 6 -7 7, 62 - 63 ; C atalli 1 980, 1 00.
lavori sono stati diretti da padre A. Coratti. Il proqetto scientifi-co è stato curato dalla sortoscrirra. mentre il piogftto espositivoè stato realizzato a cura di M. Mastroianní. E itatò finanzrato confondi della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone e dellaCongregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari.
scavi occasionali giacché essi si sono ripetutí con una certa fre-quenza dalJa metà del sec. scorso ad oggi a cagione dei contirui a-dattamenti del suolo prospiciente I'entrata
-del monastero o la
chiesa, del restauro deivecóhi muri e della necessirà di aprire fon-damenta a nuove costruzione. Tali lavori eseguiti a intervalli, nelI8$, 1855 -1856-1870-1890-1894 -19r2-r9t7 -1918... Nel 1856 nellospíanare il suolo dinanzrla chiesa e il monastero si rínvennero ab-bondanti torsi di colonne scanalate e poste con qualche ordine, ungrosso anello d'oro con piera verde, lastricati e hura sovrapposredi diversa costruzione. due iscrizioní di sommo interessei inter-pretate una dall'Aurigemma nel "Notizie desli Scavi" fas. II. ann.1912 el'aItra dal Mommsen che I'inserì nelZ.r.r. al n.5780. Nu-
menti di colonne e una statuetta acefala...>>." Scaccia Scarafoni 1951, 1 1-t5; Farina - Fornari 1987, j6-57"Cfr. Farina - Fornari 1981, 10." ur x, 5-1, 80; Cassoní 19 18, i 9, n. xxrr; Gíannetti 1982, 3 0 -3 r, n. 4,89; Rizzello 1984b,28.'o Aurigemma 1912, 60-6I; Cassoni 1918, 17 -78, n. XVr; Panciera1967,51-52"Aurígemma 1910,)I4; Cassoni 1918, 87-88, n. 1; Giannetti 1982,147 Faina - Fornari 1987,54.
momento della scoperta non venne rcalizzata alcuna documen-tazione ed attualmente non sono più visibili.
o) Cronaca di Casamari: <1951, lO_aprile. Oggi sono state gettate lefondamenta del secondo muro dela sala òàrocchiale ché sta sor-gendo lungo la strada dal casale al fabbrièato della nuova farma-
"Cancell ier i 1976-77,61, n. 1, 3,î ig.a; Catal l i tqso, 92,n.);Gian-netti 1982, 165 , [rg. a4 .
metri 7 di profondità si trovò una bellissima anforetta in rerra-cotta gialla a 4 manichi e in ottimo stato. Ha rotto solo uno deíTanichi superiori. A 20 metri dí distanza dall'ingresso si trovò: 1.Un bellissimo doliun interracotta rossa tutto iniero. Le lastre va-
'u Cronaca di Casamari: <49i2, 76 aprile... Nel lavoro di restauro
303
to pavimento e il muro maestro della costruzione cistercense èstato trovato un aitro muro. nel lato sud del oavimento è statotrovato un muro massiccio dello spessore di uÀ metro e sessantacentimetri... 7952,2 gr:ugno. Nel.faie l.o sterro.per la nuova cuci-na a ctrca un metro e mezzo dal vecchio livello del terraoíeno èstato ritrovato un bagno ove sí accedeva.con quattro scalini; vi-cino ne[a parte esterna fu trovato un pavimento romano con in-tonaco su terra, anche quello doveva essere un bagno pubblicoper uomini, quello presentemente ritrovato dovrebbe essere sta-
parte esterna verso la porteria. Questa iscrizione sarà conservatanel museo... L952,2L giugno. Nella nuova e futura cucina è statotrovato ques(oggi tn pezzo di pavimento in mosaico di píetruz-ze bianche. E stara trovata anche una iscrizione frammentaria.Nel sito dove fu trovato il pavimento in mosaico, di cuí al giorno16 aprile del corrente anno, è stata trovata una costruzione ro-tonda che doveva servire da deposito di acqua per alimentaredue vasche da bagno. poste ai duè lat i di derra cosiruzione. Que-sto complesso di bagni pubblici verrà a rimanere sotto i1 piane-rottolo di accesso al chiostro verso il lato occidentale, che anco-ra è chiuso, nello spazio tra i due fabbricatí del chiostro e delnuovo retettoflo...>>." Una parte del pavimento in cocciopesto, che nella Cronaca víe-ne definito a mosaico, fu allora asportata e ilserita in un riquadrodi cemento e ora è conservata tîa i materiali del museo; una fotodí questo frammento è stata pubblicata in Giannetti 1982,167.'n Cronaat di Casamari: <1960, 19 dicembre Scavando nel chiostroper rinnovare il pavimento sul lato della sala capitolare, sono sra-te r invenute del le tombe romane con dentro del le ossa e reci-pienti (piccoli) di terracotta. Sul lato opposto alla chiesa (chio-stro), un mese fa, sono state rinvenute, fondamenta di case ro-mane>>tt Nella clausura abbaziale si ricorda il ritrovamento di numerosetombe alla cappuccina, sia presso il campo sportivo del collegio,sia nella visnàè nel fruttetò. Un altro cònsiitente nucleo veineportato allà luce, nel sec. XIX, nei pressi del ponte romano sultorrente Amaseno. Cfr. Cancellieri 1976-77 , 62, nn t,5 e 1,6; Ca-talli tqao, 97-98; Giannetti 1982, 12; Rizzello 1985, 60, n. 150" Si veda, a questo proposito, l'esempio della villa romana in lo-calità Pagliaro Murato, i cui resti sono ancora visibili, a poca di-stanza dàIl'abbazia. lunso il fianco di una collina coltivaia a uli-vi: Rizzello 1984a, 409-434."Alt. m I, l0l lungh. m 4.401 spess. dei f i lar i cm 40- e-.no Sulle tecniche costruttive medievali nel Lazio Meridionale, siveda Fiorani 1996.' Per una visione del l 'area prima del le trasformazioni seuecenre-sche. si veda la stampa pubblicata in Rondinini l7O7.7q: cfr. Fa-r ina - Fornari 1q87, 71, f ig. I L'Cfr. A. Canepone, La sàalinata della chiesa dell'abbazia di Casa-mari. Storia di-un carattere forte, semplice, rigoroso, relazione sto-rica allegata al progetto di restauro della scalínata e delle aree e-sterne (2001). di cui è in preparazione la pubblicazione; respon-sabile tecnico del progetto-P. Abbondaìza, ditta appaltairiceImoresa costruzioni Nicoletti Loreto di Sora.u'Cassoni 1,921 , 29. Agli inizi del Novecento l'area del piazzalenon era ancora pavimentata e l'aiuola centrale era circondata daun muretto moderno costruito con i rocchi delle colonne anti-che, gli stessi che in seguito furono collocati nell'aiuola di fronteal la chiesa. Risale al lé:2 la sisremazione del la pavimentazionedel piazzale con rivestimento a sampietdni e f impianto di coni-fere nelle aiuole: Farina - Fornari 1981,87.
MARIA ROMANA PICUTI
Bibliografia
Atlante 1985: EAA, Atlante delle forme ceramiche. tt. Ceramica fineromand nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo irnpero),Roma.AunrcEulta S. 1910: "Cerearae Marianae (Casamari)", NS, 113-111.Aulrcelrm S. tgtt: "Configurazíone stradale della regione soranain epoca romana" ,n Studi in onore di Cesare Baronio, Perugia,491-55).ALrucpum S. t9r2: " (Cercatae Marianae). Iscrizione inedita", NS,60-61.BnneNcEn E.M. 1984: "Viaggio attraverso í musei e le raccolte pri-vate della provincia di Frosinone", inserto speciale La Prouincia diFrosinorce l-4, 1984, XV-XXCaNcst-lmnr M. 1976-77t "Contributo per una carta archeologicadella media Valle del Liri", in La media ualle del Liri. Dal passalo alfuturo attrauerso t).1 presente, BIAL 9, 1-2,58-69.CassoNt M. t9t8: Casamari o I'antico Cereate Mariano Breue stu-dio arch eo lo gico- s torico, Yer o\..CassoNI M. tgzl: Breue Sillope Storica di Casamari, Soru.Caral-lI F. t9l6-ii: "La collizíone numismatica del Museo del-I' Abb azia di Cas amari (f\) ", An nI s t I t N u m xxr:r'-xxv, 2 1 1 -25 8Careru F. 1980: "Cereatae Marianae", in xv Anniuersario della fondazione del c.qx (Ani del convegno), Roma, 8l-112.Coa-nrllr F. 1982: Lazio, Roma - Bari.Cronaca del Cartario: ms Archivio dell'Abbazia di Casaman.Cronaca dz Casatnari: ms. Archivio dell'Abbazia di Casamari.Dr, BENEor,tTt L. s.d.: Notizie raccohe per interesse storico, ms. Ar-chivio dell'Abb azia di Casamari.DE Pr,nss L. ta78: La badia di Casamari nel suo doppio aspetto mo-numentale e storico, Roma.FalrNe F. - FonNaru B. t9g7: Larchitettura cistercense e l'abbazia diCasamari, Casamarí.Faruxa F. - FonNeru B 1981 : Storia e documenti dell'abbazia di Ca-s am ari, 70) 6-1152, Casaman.Ftorau D. 1996: Tecnicbe costruttiue murarie medieuali. Il Laziomeridionale,Roma.Fonrrm P. D94: s.v. "Cereatae Marianae", n EAA, ri Suppl., rt,r02-t03.Fuscrerur E.M. 1918: Piccola puida del monumento nazionale diCasamari, Casamari.GanRucct A. t85t: "I Cereatini Mariani scoDerti ove ora è Casa-man",Bu||Inst ,10-15.GnNNEtn A. tgSZ: Il museo archeolopico di Casamari (CereataeMarianae), CasamariHUI-srN CH t889: "Cereatae", in RE, rrr, c. t969.Kaleve M. - Aar.oNEN J. - Sor-rN H. t989: "Arratus, a New EpithetofJupiter: cIL x, 5119 Reconsidered" , Chiron,19, 103 -1 18.MeNCtNr G. tgzI: "Casamari. Scoperta {i una fossa votiva in loca-lità Antéra. Silloge epigrafica", Ni, 6e-zt.Mazzar.rxo S. t9z+: "Sulla poÌitica triburaria di Valentíniano r (aproposito di un'epigrafe da Casamari)", tn Antico, fardoanhl.co ed e-ra costantiniana, Baú, 299 421 .
Rtzzprro M. 1980: I santuari della media ualle del Lni, tv-r sec a C.Depositi uotiui e rinuenimenti di: Arce-Arpino-Atina-Bouille-Canne-to-Casaluieri-Ceprano-Colli-Sctra-Veroli, Sora, B -57, 165 -11 3.kzznwo M. 1984a: "Lavila romana di Pagliaro Murato (Veroli)",in Lunartlo Romano. Ville e parchi nel Lazio. Roma. 409-'114.Rvzr.rro M. tgg+b: I cuhi orientali nella media ualle delLiri,Sora.Í \ tLL I :LL IJ , tv l . l vó ) : V laDUl la Oe l te r r l to r lo SOranO m epoca roma-na in relazione a necropoli e a sepolture", Latium 2,D-r00.RoNolNrNt F. ll07: Monasterii Sanctae Mariae et Sanctorum fohan-nis et Pauli de Casamario breuis historia,Roma.Sceccre Scanaroxr C. tgit: "Documenri inediti relativi ai pri-mordi benedettini della Badia di Casamari", BSRSPatria I, t-20..tNR l, 1: Sylloge Nummorum Romanorum Italia Milano CtatlcheRaccolte Nurnismatiche.I,7. Augustus - Tiberius, Milano 1990.Sourv H. 1988: "Ricerche epigrafiche in Ciociaria", Epigraphica 50,91-99.
304