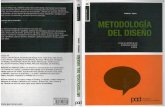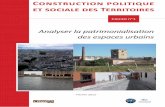La prova del pregiudizio non patrimoniale attraverso le presunzioni
Il danno patrimoniale nel 'iudicium empti'
Transcript of Il danno patrimoniale nel 'iudicium empti'
Sommario: 1. Introduzione. L’id quod interest quale misura del risarcimento deldanno. – 2. Il contenuto della condanna pecuniaria per mancata consegnadella cosa. – 3. La quantificazione dell’id quod interest a seguito di evizione. –4. Presenza di vizi occulti e assenza di qualità nella res empta. La duttilità del-l’interesse. – 5. Profili problematici nella determinazione dell’interesse del cre-ditore alla luce di C. 7.47.1 pr.-2. – 6. Osservazioni conclusive.
1. Introduzione. L’ ‘ id quod interest’ quale misura del risarcimento deldanno.
È noto che la struttura della condemnatio formulare assume unaconfigurazione diversa in base al tipo di actio nella quale è inserita.Mentre nelle formule con condemnatio certae pecuniae è già individua-to l’ammontare della pretesa e della condanna, alla cui quantificazio-ne non concorre il giudice, in quelle con condemnatio incerta spetta acostui procedervi, facendo applicazione del criterio suggerito dallaformula.
Così, nelle actiones in personam con intentio e condemnatio incer-tae il giudice è chiamato a tradurre in denaro (eius) il quidquid ob eamrem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet; nelle formu-le con intentio certa non espressa in denaro, invece, la condanna è li-mitata al quanti ea res est/erit/fuit e consiste in una somma pari al va-lore della res rispettivamente al momento della litis aestimatio, dellapronuncia della sentenza, o in un momento antecedente alla litis con-testatio, di volta in volta specificato1.
1 Accanto alle azioni al quanti ea res e al quidquid ... eius, si ricordano alcune azio-
A partire dallo studio condotto da Siber2, è stata individuata unacesura netta tra le costruzioni formulari delle due condemnationes, lequali avrebbero ambiti applicativi ben distinti e determinerebberospecifiche conseguenze sull’ammontare del risarcimento del danno3.L’allusione al quanti ea res est/erit/fuit imporrebbe di elaborare unacondanna pecuniaria, alla cui quantificazione si perviene ricorrendo adati obiettivi (come il valore di mercato della cosa).
Diversamente, le azioni con quidquid ... eius permetterebbero diplasmare una condanna maggiormente aderente al caso esaminato,con un adeguamento della stima della res all’interesse del creditore,realizzando un risarcimento soggettivo.
Sebbene nella formulazione della condemnatio testè commentatanon compaia il verbo interesse, né similari, il riferimento ad esso –
ni penali in bonum et aequum conceptae, con condanna in quantum bonum aequum iu-dici videbitur. Taluno ha ipotizzato l’esistenza di azioni particolari (come l’a. de rationi-bus edendis), la cui condemnatio avrebbe espressamente previsto il quanti actoris interest/interfuerit/interfuit: sul punto, si sofferma Beretta, che contesta l’ipotesi ricostruttivaavanzata in particolare da A.F. Rudorff e da O. Lenel (cfr. P. Beretta, Le formule in‘ id quod interest’, in SDHI, III, 1937, 419). Cfr. C.A. Cannata, Profilo istituzionale delprocesso privato romano, II. Il processo formulare, Torino, 1982, 104 per la ricostruzionedelle presunte formule contenti il riferimento al quanti actoris interest, e nt. 29 per la bi-bliografia.
2 Cfr. H. Siber, Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung, II. RömischesPrivatrecht, Berlin, 1928, 241 ss.
3 La tesi del Siber, per ciò che attiene alla fisiologica incompatibilità tra la previ-sione formulare del quanti ea res e il conseguimento dell’id quod interest, è stata preci-sata da Kaser, il quale ha individuato alcuni giudizi nei quali viene attribuito l’interessedel creditore pur in presenza di condemnatio in quanti ea res est (cfr., a riguardo, la mo-nografia di M. Kaser, ‘Quanti ea res est’: Studien zur Methode der Litisästimation imklassischen römischen Recht, München, 1935, passim) e ridimensionata, almeno in par-te, da Voci, che si sofferma su alcune «ipotesi, in cui la formula in q.e.r.e. attribuiscel’id quod interest, e ipotesi, in cui la formula in quidquid ... condemnato attribuisce lamera aestimatio rei», con ciò dimostrando che «il contenuto del risarcimento non èsempre un effetto del congegno formulare» (P. Voci, Risarcimento del danno e processoformulare nel diritto romano, Milano, 1938, rispettivamente 6 e 3). Si veda, altresì, Pa-stori, che, sulla scia di Kaser e di Voci, rinviene dei casi (come l’actio exhibendum) daiquali emerge la necessità di attenuare la rigida costruzione prospettata da Siber: il rigo-re del tenore formale verrebbe superato quando dall’applicazione del criterio formularederiverebbe una discrepanza con il rapporto sostanziale (cfr. F. Pastori, Concetto estruttura della obbligazione nel diritto romano, Milano, 1971, 243-256). Per un’efficacesintesi delle principali teorie sul risarcimento del danno e sulla sua quantificazione (Si-ber, Honsell, Kaser, Voci, Medicus, Mommsen), cfr. S. Tafaro, La ‘ interpretatio’ ai‘verba quanti ea res est’ nella giurisprudenza romana. L’analisi di Ulpiano, Napoli, 1980,8-14.
332 MIRIAM PADOVAN
meglio noto come id quod interest creditoris – emerge nei passi neiquali i giuristi disquisiscono delle azioni nel quidquid ... eius e deidanni che all’esito del giudizio trovano ristoro.
Trattasi di un criterio ostico, il cui procedimento di liquidazionepuò essere desunto solo in via ipotetica, appurata «la totale carenza difonti esplicite in proposito» 4.
L’assenza di passi a riguardo è, secondo diversi autori, fisiologica.La stima del danno sarebbe percepita come una mera quaestio facti,riservata all’esame del iudex, rispetto alla quale poco avrebbero potutodire i prudentes, essendo intimamente condizionata dalle circostanzedel caso concreto provate apud iudicem. In tal senso, si esprimonoconcordemente Honsell e Medicus, quest’ultimo citando testualmen-te il passo di Paolo, 5 ad Sab. D. 50.17.24, nel quale il giurista affer-ma quatenus cuius intersit, in facto, non in iure consistit 5.
Medicus, in particolare, ritiene che «il ricorso all’id quod interestnon significasse altro che il potere attribuito al giudice di procederesecondo la propria personale valutazione in aggiunta a criteri oggetti-vi ... o, eventualmente, in mancanza di essi» 6.
Il fatto, poi, che l’espressione id quod interest, pur entrata nel lin-guaggio comune, compaia solo in un passo delle Istituzioni di Gaiosarebbe inspiegabile se si «fosse trattato di un principio direttivo perla determinazione dell’ammontare della prestazione» 7. Più che funge-re da criterio di liquidazione alternativo al quanti ea res est/erit/fuit, sa-
4 F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’ alla costruzione della cd. ‘Differenzhypothese’ad opera di Friedrich Mommsen, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di M.Talamanca, a cura di L. Garofalo, II, Padova, 2011, 491.
5 A tal proposito, cfr. D. Medicus, ‘Id quod interest’. Studien zum römischen Rechtdes Schadensersatzes, Köln - Graz, 1962, 333 ss., nonché H. Honsell, ‘Quod interest’im ‘bonae-fidei-iudicium’. Studien zum römischen Schadensersatzrecht, München, 1969,174 ss. Honsell, pur critico nei confronti di Medicus, perché quest’ultimo collega l’idquod interest a grandezze determinate, concorda con il fatto che la stima del danno èmateria che esula dall’attenzione dei giuristi ed è rimessa direttamente alla libera valuta-zione del giudice (cfr. H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 174 s.; S. Tafaro, Recensione aH. Honsell, ‘Quod interest’, cit., in Index, II, 1971, 360; G. Provera, Recensione a H.Honsell, ‘Quod interest’, cit., in SDHI, XXXVII, 1971, 464).
6 F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 491, che sintetizza il pensiero dell’auto-re tedesco.
7 A. Burdese, Recensione a D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., in A. Burdese,Recensioni e commenti. Sessant’anni di letture romanistiche, Padova, 2009, 205 s., a com-mento della tesi di Medicus.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 333
rebbe lo strumento che consente al giudice di godere di maggiore li-bertà nella stima del danno, senza essere rigidamente vincolato a unaregola di calcolo, per meglio rispondere alle esigenze del caso 8: per-tanto, la sua determinazione sarebbe, «nella procedura formulare ro-mana, per lo più rimessa alle valutazioni individuali del singolo giudi-ce» 9.
Quanti, al contrario, reputano che l’id quod interest, pur sfuggen-do a predeterminazioni, sia una questione di diritto, un canone tec-nico-giuridico, di cui i prudentes non possono che essersi occupati inmodo approfondito, si soffermano sui passi tramandatici nel Dige-sto, dedicati all’inadempimento del debitore. Sebbene tali brani – co-me vedremo nel presente contributo esaminandone alcuni in materiadi emptio venditio – nulla dicano sull’ammontare della condanna,forniscono di volta in volta indicazione di talune ripercussioni patri-moniali escluse dal risarcimento e di altre comprese10 e nella dimen-sione casistica emerge il contenuto dell’id quod interest. È plausibile,poi, che negli stessi testi sia «cad[uto] il riferimento all’aestimatio perl’intervento dei Compilatori impegnati ad eliminare l’antiqua prolixi-tas ... e non più interessati alla casistica classica, data la nuova e diffe-rente posizione, e i diversi poteri, del iudex nella procedura per cogni-tionem» e che per una ragione analoga altri passi siano «stati omes-si» 11.
La tesi, avanzata da Tafaro, pare condivisibile, se si considera chein età giustinianea la plasmabilità del menzionato criterio non è più
8 Cfr. S. Tafaro, La ‘ interpretatio’, cit., 18, il quale specifica che il criterio dell’idquod interest non è nato né come una «regola di conto», né come un ‘escamotage’ perconferire al giudice arbitrio decisionale nella liquidazione del danno, e acquisisce il con-tenuto che il giudice pronuncia attraverso la condanna, alla quale perviene dopo unoscrupoloso accertamento delle obbligazioni inadempiute. L’autore si chiede se l’applica-zione casistica dell’id quod interest abbia condotto all’elaborazione di «costanti catego-riali» (18) e conclude che è stato lo strumento più duttile nelle mani dei giuristi, attra-verso il quale sono giunti a sviluppi giuridici interessanti e non limitati alla quantifica-zione della condanna (220).
9 Cfr. F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 491, a commento della posizione diZimmermann.
10 Cfr. S. Tafaro, La ‘ interpretatio’, cit., 18 s., con la bibliografia richiamata allentt. 25-28.
11 S. Tafaro, Recensione a H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 367 e nt. 26. L’auto-re, a titolo esemplificativo, ricorda i casi affrontati da Giavoleno (7 ex Cass. D. 19.1.18)e Ulpiano (32 ad ed. D. 19.1.13 e 17).
334 MIRIAM PADOVAN
percepita come un valore aggiunto, bensì come una fonte di eccessivoe incontrollato potere del giudicante, tanto che l’imperatore sceglieràdi predeterminare il limite massimo che i giudici avrebbero dovuto ri-spettare nel quantificare il danno.
Il rischio sotteso all’id quod interest è, infatti, pur sempre incom-bente, poiché qualsiasi pregiudizio, la cui manifestazione sia cronolo-gicamente successiva all’inadempimento del debitore, potrebbe essereattribuito alla responsabilità di costui. Conferendo una stima pecu-niaria rapportata all’interesse soggettivo del creditore, si potrebbe rite-nere che tale criterio sia un ‘escamotage’, attraverso il quale il giudicemodula la stima del danno, svincolandosi da quanto effettivamentepatito a livello patrimoniale12, per lasciare spazio a considerazioni di
12 In tal senso, appare emblematico Paul. 47 ad ed. D. 39.2.3: Damnum et damna-tio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt. Per Fiori, che commenta itermini damnum e condemnatio, «la damnatio, ossia la ‘determinazione del detrimentopatrimoniale (damnum)’, diviene con-demnatio: il giudice non si limita a determinare ildamnum, ma con il suo atto porta a compimento un processo che era già iniziato primadel suo giudizio, e precisamente al momento della litis contestatio» (R. Fiori, ‘Ea resagatur’, Milano, 2003, 182). Tra i sostenitori della risarcibilità dei soli danni patrimo-niali, cfr. S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, II, Milano, 1947, 156; P. Bonfan-te, Corso di diritto romano, IV. Le obbligazioni, Milano, 1979, 417, per il quale «il ca-rattere meramente economico della lesione è del resto pur esso dai Romani affermatonella definizione stessa del damnum: deminutio o ademptio patrimonii ... L’effetto del-l’inadempimento di un’obbligazione è il puro risarcimento, la pura prestazione della reiaestimatio o ... l’id quod interest». Quest’ultimo, che pur consente di liquidare il dannovalutando caso per caso i pregiudizi patiti dal creditore insoddisfatto, non permette,quindi, al giudice di stimare l’‘affectionswerth’, ossia il valore affettivo che assume la resper il creditore. A tal proposito, cfr. F. Mommsen, Beiträge zum Obligationenrecht, II.Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, 1855, 214 ss. Diverge, invece, la tesi di R.von Jhering, Ein Rechtsgutachten, betreffend die Gäubahn, in Jherings Jahrbücher,XVIII, 1880, passim, a critica del quale si espone A. Marchi, Il risarcimento del dannomorale secondo il diritto romano, in BIDR, XVI, 1904, 208 s. Mentre «Jhering addussetutta una serie di testi per dimostrare ... che il giudice romano nella vera rei aestimatiovalutava l’affectus, verecondia, pietas, voluptas, amoenitas, incommoditas» e «che l’espres-sione id quod interest non significò il solo interesse pecuniario, ma qualunque interessetutelato dal diritto», Marchi controbatte puntualmente, concludendo che «la modernateoria del risarcimento del danno morale non trova un precedente nel diritto romano»(A. Marchi, Il risarcimento, cit., 208 s.). L’autore dedica un intero capitolo alle azionidi buona fede (255-282), rispetto alle quali la quantificazione della condanna in epocaclassica «comprende solo il danno patrimoniale, benché il giudice avesse poteri di granlunga più estesi che nelle altre azioni»; ciò «risulta dal complesso dei testi esaminati ...ed è anche in armonia con la condemnatio delle formule relative a tali azioni perché laparola eius, che in esse serve appunto ad indicare l’oggetto della condanna (eius condem-na), altro non è che un genitivo di prezzo, che corrisponde in sostanza al quanti ea res
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 335
carattere affettivo e morale, con un aggravio ingiustificato della sen-tenza a scapito del convenuto. Se così fosse, la condanna assolverebbea una duplice funzione: in parte, destinata a tenere indenne il credito-re dai pregiudizi patrimoniali e, in altra parte, diretta a tradurre in de-naro gli interessi personali non economici – quali l’affectio creditoris –alterando, del tutto arbitrariamente, nell’ambito dei contratti sinal-lagmatici, l’originario equilibrio fra le prestazioni perseguito dalleparti.
La tesi che, più di ogni altra, ha semplificato l’individuazione deldanno patrimoniale calcolato in base all’id quod interest, partendodall’analisi della casistica romana, è stata elaborata da FriedrichMommsen13. L’autore, nella celebre ‘Differenztheorie’ o ‘Differen-zhypothese’, ha «ridotto il problema dell’estensione del risarcimentoad una mera operazione matematica» 14, sottraendo la consistenza pa-trimoniale reale del creditore a seguito dell’inadempimento alla situa-zione ipotetica di cui avrebbe goduto se fosse stata eseguita la presta-zione.
Come hanno efficacemente evidenziato Cannata15 e Procchi16, la‘Differenztheorie’«ha bisogno di precisazioni e correttivi che solo lacasistica pratica può indicare» 17 e presenta i limiti consueti delle tesidella pandettistica e della dogmatica moderna, le quali cercano di ri-condurre ad unità il concetto di id quod interest, quando «nell’espe-rienza romana la determinazione dell’ammontare del risarcimento diun siffatto interesse varia comunque sensibilmente a seconda delle pe-culiarità della singola actio e dei suoi specifici impieghi» e «non vi è ...identità di vedute circa le modalità con le quali lo iudex avrebbe datocorso alla valutazione concreta e soggettiva dell’interesse dell’attore» 18.
est delle altre formule» (279). Si segnala, infine, il recentissimo contributo di P. Ziliot-to, Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano, Alessandria,2012. Sui medesimi temi, della stessa autrice, all’interno di questo volume, è pubblica-to l’articolo Il danno non patrimoniale nella sentenza del giudice privato, 387 ss.
13 Cfr. F. Mommsen, Zur Lehre, cit., passim.14 F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 484. Dell’impiego del vocabolo ‘diffe-
renza’ nella sua accezione aritmetica mommseniana tratta anche C.A. Cannata, L’ina-dempimento delle obbligazioni, Padova, 2008, 14 s.
15 Cfr. C.A. Cannata, L’inadempimento, cit., 15.16 Cfr. F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 489 s.17 C.A. Cannata, L’inadempimento, cit., 15.18 F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 489 s.
336 MIRIAM PADOVAN
La necessità di trattare la questione dell’id quod interest, avendoriguardo alla specifica azione e al tenore della formula e «prescinden-do da una aprioristica accettazione di distinzioni concettuali modernequali quelle tra interesse positivo e negativo, materiale e immateriale,danno emergente e lucro cessante», è invocata da Burdese19. Tale cri-terio è fisiologicamente più duttile rispetto a quello dell’obiettiva ae-stimatio rei, nel quale è scrupolosamente individuata la base sulla qua-le modulare la condanna, e, per sua stessa conformazione, è in costan-te metamorfosi, simile ad una veste che il giudice abilmente cuce in-torno alla singola fattispecie. Pertanto, la casistica classica non puòche essere altrettanto «multiforme, varia e non riducibile a schemi fis-si e mnemonici» 20.
In altre parole, la questione dell’id quod interest «non è risolutadai romani per via di schemi rigidi né in modo uniforme: non solo sidistinguono i singoli rapporti e le diverse prestazioni, ma si considerala diversa struttura della formula, i diversi elementi che ciascun rap-porto concreto» ha, «presentando per ciascun caso una soluzione cheappare giusta ed opportuna, senza assurgere a formulazioni generali»,«poiché i rapporti sono così diversi e le situazioni così varie da rende-re difficile o pericolosa una formulazione generale» 21.
La complessità della materia emerge con dirompente evidenza finda una superficiale lettura dei passi del Digesto in tema di giudizi distretto diritto e di buona fede e rende opportuno circoscrivere il cam-
19 A. Burdese, Recensione a D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 203 s. Burdese,nel recensire l’opera di Medicus, riconosce all’autore il merito di aver impostato corret-tamente la ricerca, senza cercare di rinvenire nelle soluzioni dei prudentes dei principiassoluti e valevoli in ogni giudizio. Grazie a tale metodo di lavoro, Medicus ravvisa al-meno quattro significati dell’espressione id quod interest, utilizzata per indicare la diffe-renza tra due grandezze note; la ripartizione fra più soggetti legittimati all’esercizio dellamedesima actio; la presenza di una prestazione aggiuntiva rispetto alla principale; o an-cora, in termini più generali, tutto quanto l’attore può pretendere dal convenuto.
20 G.G. Archi, Corso di diritto romano, I. Le obbligazioni, Firenze, 1957, 42, ilquale, in tema di valutazione del danno, non si astiene dal notare che la complessa casi-stica è prova delle divergenze di interpretazione fra i giuristi. L’autore prosegue con-trapponendo il metodo della giurisprudenza classica all’impostazione giustinianea: ilprimo rifugge dalle classificazioni e la seconda abbisogna di categorie semplici legislati-vamente prefissate. Un esempio di intervento giustinianeo, frutto della nuova concezio-ne del diritto e del ruolo del giudice, è la costituzione del 531, C. 7.47.1, di cui si diràoltre.
21 B. Biondi, Il diritto romano, Bologna, 1957, 446.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 337
po di indagine alle azioni di buona fede e, in particolare, all’actioempti.
Vero è che alcune indicazioni di carattere generale potrebbero de-rivare dall’analisi di un passo del giurista Paolo, D. 46.8.13 pr. 22, nelquale, trattando di un’azione di stretto diritto – un’actio incerti ex sti-pulatu avente ad oggetto una cautio de rato –, concorrono a comporreil risarcimento sia la perdita subita dal creditore che il mancato gua-dagno.
Poiché la costruzione formulare dell’actio incerti ex stipulatu 23 è inparte analoga all’actio empti, entrambe con condanna tendenzialmen-te all’id quod interest, è imprescindibile verificare se nei giudizi dibuona fede si pervenga a una stima analoga a quella affermata esplici-tamente solo per talune azioni stricti iuris in D. 46.8.13 pr.
Ad una prima lettura, le soluzioni giurisprudenziali rinvenibili inmateria di actio empti continuano a sembrare prive di coerenza siste-matica e riluttanti alle classificazioni concettuali 24 di interesse positi-
22 Paul. 76 ad ed. D. 46.8.13 pr.: Si commissa est stipulatio ratam rem dominumhabiturum, in tantum competit, in quantum mea interfuit, id est quantum mihi abestquantumque lucrari potui. Di id quod interest come comprensivo, oltre che della perditasubita, del lucro cessante parla anche Giustiniano in C. 7.47.1.2.
23 C. AQUILIUS IUDEX ESTO. QUOD AULUS AGERIUS DE NUMERIO NE-GIDIO INCERTUM STIPULATUS EST CUIUS REI DIES FUIT, QUIDQUID OBEAM REM NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DARE FACERE OPORTET,EIUS C. AQUILIUS IUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DUMTA-XAT SESTERTIUM X MILIA CONDEMNATO; SI NON PARET ABSOLVITO (D.Mantovani, Le formule del processo privato romano, Padova, 1999, 50, n. 25. Cfr.,inoltre, O. Lenel, Das ‘Edictum perpetuum’. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung,Leipzig, 1927, 151 ss. per le diverse ipotesi ricostruttive).
24 Emblematiche le parole di Voci, il quale individua come «problema essenzialedella condanna nell’id quod interest non quello della sua estensione, sì bene del suo con-tenuto. I punti, che a questo proposito occorre esaminare, sono i seguenti: a) se l’idquod int. comprenda solo il danno emergente, o pure il lucro cessante; b) se comprendal’interesse positivo, oltre che il negativo; c) fino a qual punto un danno sia da conside-rare risarcibile: cioè, dove sia da porre l’interruzione del nesso di causalità tra atto illeci-to e danno; d) se l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o ignoranza) influisca su la mi-sura del risarcimento; e) a quale momento si debba riferire la stima operata dal iudex.Vale a dire, una volta stabilito in generale il contenuto dell’id quod int., si deve vederecome esso sia ab esteriori limitato in riguardo al nesso causale o al tempo della stima: ese, infine, possa essere quantitativamente diminuito quando dell’atto illecito non siacausa il dolo» (P. Voci, Risarcimento, cit., 62 s.). L’entità della sentenza di condannavaria in relazione all’oggetto dell’obbligazione dedotta in giudizio e al concreto accerta-mento condotto dal giudice nei iudicia bonae fidei. I giuristi, «servendosi degli strumen-
338 MIRIAM PADOVAN
vo e negativo, danno emergente e lucro cessante25, danno diretto eindiretto. Non solo a seconda della formula muta il contenuto dellacondanna, ma stime di danno disuguali possono conseguire pur al-l’esito vittorioso della medesima azione, poiché l’«interesse del credi-tore (id quod interest) ... è variamente inteso nelle diverse ipotesi» 26.
Per evitare una ricerca viziata dai medesimi limiti della pandetti-stica, si seguirà un’impostazione casistica per cogliere più agevolmen-te se, in base al contenuto della singola prestazione inadempiuta e/oscorrettamente adempiuta dal venditore convenuto, il giudice, purvincolato dai dettami formulari, operasse una stima del danno cali-brata grazie alla duttilità dell’id quod interest e risultante – a titoloesemplificativo – dal bilanciamento delle obbligazioni o dalla sua ade-sione ad una certa scuola di pensiero, senza tuttavia scadere in arbi-trio decisionale.
L’actio empti si rivela uno strumento processuale emblematico perquanto attiene alla liquidazione dell’interesse del creditore. Poiché è
ti offerti dalla flessibilità del iudicium bonae fidei per la soluzione dei delicati problemidi tutela degli equilibri di interessi delle parti contrattuali, problemi che prima di esseredommatici, sono ovviamente pratici e concreti, riescono ad individuare non solo criteridecisionali che, pur essendo differenziati in relazione alla diversità delle situazioni, sicompongono in un sistema internamente logico e coerente, ma anche a formulare, co-me esplicazioni della tutela della buona fede contrattuale, i principi portanti in materiadi interdipendenza delle obbligazioni e di equilibrio delle prestazioni che ancora oggiregolano questa materia» (L. Vacca, Ancora sull’estensione dell’ambito di applicazionedell’ ‘actio empti’ in età classica, in Iura, XLV, 1994, 71, la quale aggiunge come sia «in-dubbio che la concreta articolazione casistica delle soluzioni giurisprudenziali rendeestremamente complesso il processo di elaborazione dommatica, che pure indubbia-mente vi sottende»). Circa la bona fides come criterio di interdipendenza delle obbliga-zioni nei contratti a prestazioni corrispettive, cfr. R. Fiori, ‘Bona fides’. Formazione, ese-cuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda), in Mo-delli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, a cura di R. Fiori, IV, Napoli,2011, 161 ss.
25 Nel prosieguo, verranno utilizzate le espressioni improprie, ormai entrate nellinguaggio comune, di ‘lucro cessante’ e ‘danno emergente’ come sinonimi rispettiva-mente di mancato guadagno e perdita subita. Si rimanda, però, alle osservazioni criti-che e alle avvertenze esposte da C.A. Cannata, L’inadempimento, cit., 18.
26 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1957, 390. Il contenu-to dell’actio empti «veniva variamente determinato dai giuristi nell’ambito delle implica-zioni processuali della rilevanza della buona fede contrattuale» e «poteva portare ad unacondanna alla restituzione del prezzo ... ovvero ... alla condanna al risarcimento deldanno subito dal compratore in buona fede», a seconda della presenza di dolo o colpanel venditore, o di sua assenza (L. Vacca, Ancora sull’estensione, cit., 36).
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 339
volta a fornire tutela al compratore innanzi a molteplici tipologie diinadempimento, inesatto adempimento e a fatti che privano l’acqui-rente della res, consente allo studioso di indagare la ratio che porta ilgiurista a prediligere la soluzione ipotizzata, evitando di trasformarein principi astratti quanto di più materiale vi sia: il danno come pre-giudizio, perdita, ripercussione economica sul patrimonio del singolocreditore.
Deve essere altresì appurato in che modo i peculiari poteri, deiquali il giudice privato dispone nella fase d’accertamento dell’intentioex fide bona, si ripercuotono nella determinazione della condanna.Nella costruzione formulare dell’actio empti il quidquid ... ex fide bonaè connesso alla condemnatio (eius ... condemnato) e la maggiore discre-zionalità del giudice nel valutare quanto il convenuto avrebbe dovutodare e/o fare ex fide bona esplica inevitabilmente i suoi effetti praticianche al momento della stima pecuniaria della condanna27.
Infatti, «il convenuto, allorché nella formula accetta di pagare unasomma corrispondente a tutto ciò che in virtù del rapporto si debbapagare ex fide bona ... legittima il giudice a quantificare una sommadiversa da quella che quest’ultimo avrebbe individuato sulla base delsemplice oportere, direttamente discendente dal contenuto espressodel negozio» 28.
27 Cfr. A. Carcaterra, Intorno ai ‘bonae fidei iudicia’, Napoli, 1964, 37 s. e 73.La bona fides «indica il criterio, in base al quale il iudex è tenuto (e non già abbia discre-zionalità) a valutare il quidquid, il dare, il facere e lo stesso oportere» (73). L’autore dedi-ca un intero capitolo all’officium iudicis (80-118), definito da Gaio liberum, non perchédiscrezionale, ma perché vi è una latitudine di indagine più ampia dei fatti, nel ricercaree nell’attuare l’effettivo risultato pratico voluto dalle parti attraverso il negozio richia-mato nella formula (85 e 98): è «libertà da un rigore formale della litis contestatio» (89),che si traduce anche nella valutazione del quantum (111). Per la determinazione discre-zionale dell’an e del quantum della condanna nei iudicia bonae fidei, cfr. L. Vacca, Iprecedenti e i responsi dei giuristi, in Lo stile delle sentenze e l’utilizzazione dei precedenti.Profili storico-comparatistici, Seminario ARISTEC (Perugia, 25-26 giugno 1999), a curadi L. Vacca, Torino, 2000, 40, e C.A. Cannata, ‘Bona fides’ e strutture processuali, in Ilruolo della buona fede oggettiva, I, cit., 259 s., dove si legge che «il iudex di un iudiciumbonae fidei è liberum rispetto alla formula ed al suo tenore», una libertà che provienedalla formula, poiché è da questa «che il giudice trae i suoi poteri». Si tratta di un pote-re discrezionale, che «conoscerà certo dei limiti», ma la cui ampiezza è indubbia e «la ra-gione risiede nel fatto che il criterio della buona fede ha carattere casistico e dimensionerelativa» (260).
28 R. Fiori, ‘Fides’ e ‘bona fides’. Gerarchia sociale e categorie giuridiche, in Modelliteorici e metodologici nella storia del diritto privato, a cura di R. Fiori, III, Napoli, 2008,
340 MIRIAM PADOVAN
La bona fides appare la fonte della maggiore libertà del giudicantee al contempo, se correttamente intesa ed applicata, la migliore garan-zia contro esiti irragionevoli, benché potenzialmente prospettabili inassenza di precise indicazioni circa il contenuto dell’id quod interest.
2. Il contenuto della condanna pecuniaria per mancata consegna dellacosa.
Dal contratto consensuale di compravendita si generano obbliga-zioni in capo a entrambe le parti 29. Mentre il compratore è tenuto atrasferire la proprietà del denaro, pecunia numerata, rappresentante ilprezzo d’acquisto della merx 30, il venditore deve consegnare all’acqui-
258. Nella stessa direzione, precedentemente, M. Talamanca, La ‘bona fides’ nei giuri-sti romani: «Leerformel» e valori dell’ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettivanell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studiin onore di A. Burdese, a cura di L. Garofalo, IV, Padova, 2003, 43, e L. Franchini,Osservazioni in merito alla recezione nel ‘ ius civile’ dei ‘ iudicia bonae fidei’, in ‘Actio inrem’ e ‘actio in personam’, II, cit., 193 s. e nt. 220. Franchini tratta dell’«ampio poterediscrezionale» conferito dalla formula di buona fede al giudice, il quale avrebbe assolto«al meglio ad un simile officium grazie all’ausilio di giuristi ben parati» (195); la giuri-sprudenza giunge poi a enucleare una vasta disciplina di dettaglio dell’oportere ex fidebona, «di cui la buona fede imponeva oggettivamente l’osservanza» (199 s.).
29 Per un’esposizione completa delle obbligazioni nascenti in capo al venditore e alcompratore, qui solo accennate, si vedano – in ambito enciclopedico – i contributi diM. Talamanca, voce Vendita in generale (diritto romano), in Enc. dir., XLVI, Milano,1993, 303-475; A. Burdese, voce Vendita (diritto romano), in Noviss. dig. it., XX, To-rino, 1975, 496-500; S. Romano, voce Vendita nel diritto romano, in Dig. disc. priv. -Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 715-722. Tra le monografie, cfr. C. Longo, Corso di di-ritto romano, La compra-vendita, Milano, 1944, 206-235; V. Arangio-Ruiz, La com-pravendita in diritto romano, I, Napoli, 1956, 149-204; M. Talamanca, Vendita e tra-sferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Inter-nazionale Pisa - Viareggio - Lucca, a cura di L. Vacca, II, Milano, 1991; S.A. Cristaldi,Il contenuto dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell’età imperiale, Mila-no, 2007. Quanto allo studio della compravendita, con particolare attenzione alla sinal-lagmaticità delle prestazioni, cfr. A. Rodeghiero, In tema di sinallagma funzionale nellacompravendita romana classica, in BIDR, CI-CII, 1998-1999, 551-576; La compraven-dita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, I-II,Padova, 2007; S. Viaro, Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano,Padova, 2011, 21-272.
30 Deve, altresì, versare gli interessi, se il pagamento viene effettuato oltre il termi-ne convenzionalmente stabilito dai contraenti o, in ogni caso, successivamente alla con-segna della cosa. Gli interessi decorrono dal dies pretii solvendi, o dal momento in cui
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 341
rente la merx e fargli conseguire l’habere licere, ossia il pacifico godi-mento della cosa31.
Qualora il venditor si renda inadempiente, il magistrato concedeall’emptor l’actio empti, la cui formula risulta essere così costruita32:
C. AQUILIUS IUDEX ESTO. QUOD AULUS AGERIUS DENUMERIO NEGIDIO HOMINEM EMIT, QUA DE RE AGI-TUR, QUIDQUID OB EAM REM NUMERIUM NEGIDIUMAULO AGERIO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA,EIUS C. AQUILIUS IUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULOAGERIO CONDEMNATO. SI NON PARET ABSOLVITO.
Di fronte ad essa, il giudice svolge una duplice funzione. Prelimi-narmente, accerta cosa il convenuto fosse tenuto a dare e/o fare ex fidebona, onde verificare la presenza di eventuali prestazioni rimaste ina-dempiute. Infine, qualora sussista un inadempimento imputabile, èchiamato a condannare il debitore33.
La fase apud iudicem è destinata a sfociare in una sentenza di asso-luzione o di condanna del convenuto e il contenuto della condannarappresenta l’estrinsecazione dei poteri, dei quali il giudice disponeper quanto attiene alla liquidazione del danno.
Le prime informazioni relative ai criteri di commisurazione pecu-
l’acquirente ha ricevuto la res: in tal senso, Ulp. 32 ad. ed. D. 19.1.13.20. La loro quan-tificazione sarebbe rimessa al giudice sulla base dei poteri attribuiti dalla formula ex fidebona dell’actio venditi. Cfr., in tema di interessi, V. Arangio-Ruiz, La compravendita,cit., 202.
31 Per le opportune precisazioni, v. il paragrafo successivo La quantificazione del-l’ ‘ id quod interest’ a seguito di evizione.
32 Cfr. M. Marrone, Istituzioni di Diritto Romano, Palermo, 2006, 84; per le di-verse ipotesi ricostruttive e i passi che vengono in rilievo, O. Lenel, Das ‘Edictum’, cit.,299 e D. Mantovani, Le formule, cit., 53 n. 32, ntt. 121-126.
33 Nei iudicia bonae fidei la prima valutazione effettuata dal giudice «si riferisce al-l’accertamento della causa petendi: serve a stabilire, cioè se l’actio sia fondata o no. E talevalutazione non va confusa con l’altra, che il giudice dovrà eventualmente operare perstabilire l’ammontare (sempre pecuniario) della condanna, cioè la valutazione implicatadalla condemnatio ... Pensiamo per esempio che [l’intentio del iudicium bonae fidei] sianella formula di un’actio empti, e nella relativa valutazione il giudice stabilisca che ilquidquid dovuto da NN sia che egli consegni al compratore la cosa venduta: per con-dannare NN ad una somma di denaro a favore di AA il giudice dovrà valutare di nuo-vo, per tradurre in danaro l’interesse di AA a quella mancata consegna» (C.A. Canna-ta, Profilo, II, cit., 82). Cfr., altresì, G.G. Archi, Corso, I, cit., 67.
342 MIRIAM PADOVAN
niaria del danno cagionato dalla mancata consegna della res sono rica-vabili dall’incipit del libro diciannovesimo del Digesto:
Ulp. 28 ad Sab. D. 19.1.1 pr.: Si res vendita non tradatur, in idquod interest agitur, hoc est quod rem habere interest emptoris: hocautem interdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res valetvel empta est.
Riferisce Ulpiano che l’attore, agendo mediante l’actio empti, con-segue l’id quod interest, ossia la misura del suo interesse ad habere rem.
Pur di dubbia genuinità secondo Medicus34 e Beseler35, il fram-mento conserverebbe un nucleo classico, riscontrabile in tutti i iudi-cia bonae fidei: la commisurazione della sentenza a ciò che il compra-tore avrebbe avuto se la res fosse entrata nella sua pacifica disponibili-tà.
Quanto esposto da Ulpiano, in altre parole, evoca il concetto diinteresse positivo moderno, «intendendosi ... la differenza fra lo statopatrimoniale che il creditore godrebbe se il contratto fosse andato abuon fine e quello nel quale effettivamente si trova per fatto imputa-bile al debitore» 36.
34 Cfr. D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 29.35 Cfr. G. Beseler, Einzelne Stellen, in ZSS, XLVII, 1927, 328.36 Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 229. La distinzione teorica tra
interesse positivo e negativo è estranea alla giurisprudenza romana: tuttavia, poiché neicasi trattati dai giuristi viene in rilievo la stima del concreto e personale interesse dell’at-tore all’esatto adempimento, il giudice per quantificare il danno valuterà la consistenzapatrimoniale della quale avrebbe goduto il compratore se le obbligazioni avessero trova-to fisiologica esecuzione. Lo stesso autore, pur specificando che la giurisprudenza tal-volta oscilla tra i criteri di interesse positivo e negativo elaborati dai moderni a partiredall’analisi dei testi, conclude che «in ogni tempo preval[e] la considerazione dell’inte-resse positivo», del «vantaggio economico che il creditore avrebbe potuto trarre dal con-tratto esattamente adempiuto» (V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., 390). Conforme è latesi esposta da E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1961, 510 s.Per M. Talamanca, Istituzioni, cit., 312 e 658, «è nei iudicia bonae fidei che si affermail principio per cui la litis aestimatio deve corrispondere all’id quod interest, l’interessedell’attore all’adempimento (interesse positivo). Nella sua più ampia formulazione, taleinteresse viene calcolato confrontando quella che sarebbe stata la situazione patrimonia-le dell’attore nel caso di esatto adempimento e quella in cui attualmente si trova in se-guito all’inadempimento» (658). Cfr., anche, T. dalla Massara, Garanzia per evizionee interdipendenza delle obbligazioni, in La compravendita, II, cit., 293 e nt. 60, dove,trattando della stipulatio habere licere, la cui formula contiene quidquid ... oportet, con-
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 343
Soffermandosi sulla prima parte del brano, sembrerebbe che ilgiurista intenda far coincidere l’interesse con il prezzo di vendita dellares, il valore di scambio che il compratore è stato disposto a versareper ottenere la cosa, e, pertanto, solo a questo alluderebbe l’espressio-ne rem habere interest emptoris.
Basta proseguire nella lettura del passo per comprendere che l’idquod interest non è necessariamente riducibile né al pretium rei, né alvalore oggettivo della cosa37.
Infatti, la res nel patrimonio dell’acquirente potrebbe valere di piùdel pretium. Si supponga che oggetto della compravendita sia l’ultimoelemento mancante all’acquirente per completare una collezione: lares va ad accrescere notevolmente la preziosità degli altri beni di cui ilcompratore è già in possesso, e, tuttavia, da sola mantiene un valoreeconomico inferiore rispetto a quello acquisito dalla collezione per ef-fetto della sua presenza. Se l’oggetto non viene consegnato al compra-tore, costui non subisce un pregiudizio limitato al prezzo o all’obietti-va aestimatio, ma pari alla differenza tra la consistenza del suo patri-monio a seguito della mancata traditio e quanto avrebbe avuto se il be-ne fosse entrato nella sua disponibilità: l’accrescimento di valore dell’in-tera collezione rappresenta l’interesse del collezionista ad habere rem.
Il prezzo di vendita appare il primo addendo della sentenza dicondanna, quel minimo imprescindibile che il giudice privato avreb-be in ogni caso attribuito al creditore a seguito dell’altrui inadempi-mento38. Se l’acquirente avesse comprato la cosa ad un prezzo più al-
clude che la condanna diretta all’id quod interest «mira alla realizzazione dell’interesseche (in termini moderni) potremmo definire positivo».
37 A commento del passo, cfr. B. Biondi, Lezioni di diritto romano. Obbligazioni,Catania, 1932, 140, per il quale «nei iudicia bonae fidei la condemnatio può andare an-che oltre l’obbiettiva aestimatio della prestazione, inquantoché tien conto dell’interessedel creditore ad avere la prestazione». La tensione tra interesse e valore, tra obiettiva ae-stimatio rei, pretium, quanti ea res est (erit/fuit) e id quod interest, è stata recentementeanalizzata da C. Schieder, Interesse und Sachwert. Zur Konkurrenz zweier Grundbegriffedes römischen Rechts, Göttingen, 2011. Nella monografia, vengono richiamate le princi-pali tesi – citate anche nel presente contributo – in materia di interesse: in particolarequelle di Medicus, di Honsell (25 s.) e di Mommsen (35-38).
38 Cfr. D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 29. L’autore non ritiene che il criteriodell’id quod interest sia contrapposto al quanti ea res est (erit/fuit), identificando nel pri-mo un criterio soggettivo di stima del danno e nel secondo un’obiettiva aestimatio dellares. In entrambi i casi, la valutazione del danno sarebbe effettuata attenendosi a datipredeterminati (primo fra tutti il pretium), tuttavia il richiamo all’id quod interest svin-
344 MIRIAM PADOVAN
to dell’obiettiva aestimatio, pur potendo procurarsela ad un importoinferiore; o se, nel frattempo, il prezzo di mercato fosse sceso, così chesi avrebbe modo di reperire lo stesso bene ad una cifra minore rispet-to a quella pattuita nel contratto, la condanna dovrebbe quanto menogarantire il rimborso integrale del prezzo.
L’ammontare del danno può, infatti, corrispondere alla mera di-minuzione patrimoniale patita dall’acquirente e coincidere con ilprezzo, qualora l’interesse ad avere la cosa sia equivalente a questo: aseguito della condanna si ripristina di fatto la situazione patrimonialeantecedente alla conclusione del contratto e alla dazione del prezzo.
Al contrario, l’ammontare della condanna è superiore al prezzose, ad esempio, per effetto dell’inadempimento, il compratore si ren-de a sua volta inadempiente verso terzi e, in conseguenza di ciò, subi-sce un’ulteriore deminutio patrimonii.
Una prima lettura del passo ulpianeo, poi, può sollevare dubbicirca la rilevanza dell’eventuale lucro cessante ai fini del calcolo dellacondanna.
Le parole di Ulpiano sembrano circoscrivere l’id quod interest almero spostamento patrimoniale della res dal venditore al compratore,con la preclusione di qualsiasi altra valutazione dipendente da unaeventuale rivendita vantaggiosa del bene.
Tuttavia, la fattispecie analizzata da Ulpiano si presta ad una dif-ferente lettura. L’interesse ad avere la res nel proprio patrimonio de-nota l’unità di misura del danno che nell’id quod plerumque accidit ilcompratore patisce a seguito della mancata consegna della cosa daparte del venditore. Nella stima ipotizzata non è preso in considera-zione quanto l’acquirente insoddisfatto avrebbe eventualmente otte-nuto per mezzo della vendita della res, poiché si presuppone che co-stui non sia un uomo d’affari, che acquista per commerciare, bensìper tenere la cosa nella sua disponibilità 39.
colerebbe il giudice da una precisa regola di calcolo (cfr. A. Burdese, Recensione a D.Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 205). Per l’assoluta inconciliabilità tra il criterio obiet-tivo del pretium e quello dell’id quod interest si veda Honsell: dall’esito vittorioso del-l’actio empti l’attore avrebbe ottenuto sempre una quantità di denaro superiore al prez-zo d’acquisto della res (cfr. S. Tafaro, Recensione a H. Honsell, ‘Quod interest’, cit.,360).
39 È questa l’interpretazione fornita da Medicus, secondo il quale Ulpiano suppo-ne come normale la coincidenza tra il prezzo di vendita e l’id quod interest, poiché sta
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 345
Per valutare l’incidenza del lucro cessante, le fonti sono state a lun-go interrogate, data la presenza di alcune soluzioni che non collimano conaltre e che non consentono, almeno apparentemente, di dare una rispo-sta univoca. Quid iuris se al primo contratto di compravendita ne sia se-guito un altro, dove il compratore originario assume le vesti di vendito-re della stessa res, ad un prezzo maggiore rispetto a quello d’acquisto?
Un caso in cui si prospetta in termini negativi la risarcibilità delmancato guadagno è trattato da Paolo in
Paul. 33 ad ed. D. 19.1.21.3: Cum per venditorem steterit, quo mi-nus rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quaemodo circa ipsam rem consistit: neque enim si potuit ex vino putanegotiari et lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam sitriticum emerit et ob eam rem, quod non sit traditum, familia eiusfame laboraverit: nam pretium tritici, non servorum fame necato-rum consequitur. Nec maior fit obligatio, quod tardius agitur,quamvis crescat, si vinum hodie pluris sit, merito, quia sive datumesset, haberem emptor, sive non, quoniam saltem hodie dandum estquod iam olim dari oportuit.
Si dovrebbe allora concludere che la precedente soluzione ulpia-nea – secondo la quale con l’actio empti si ottiene la stima dell’interes-se ad avere la cosa, ossia il risarcimento del danno immediatamentepercepibile nel patrimonio dell’attore – non sia condizionata dallaqualifica dell’acquirente quale mero consumatore, ma dai principi ge-nerali dell’ordinamento romano, che non avrebbero mai contemplatola rifusione del danno indiretto e del lucro cessante. L’interesse giuri-dicamente rilevante si esaurirebbe all’interno del binomio res-patri-monio dell’acquirente e l’utilitas creditoris sarebbe «limitata alla stessacosa che forma il contenuto dell’obbligazione, e quindi in sostanzanon va oltre il valore obbiettivo della cosa» 40.
affrontando il caso tipico del compratore che avrebbe tenuto la cosa per sé (cfr. D. Me-dicus, ‘Id quod interest’, cit., 30; H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 13 ss. e S. Tafaro,Recensione a H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 362, con le critiche esposte da Honsell aMedicus). A tale proposito, cfr. anche F. Haymann, Haftung für unmittelbaren undmittelbaren Schaden beim Kauf, in Studi in onore di P. Bonfante, II, Milano, 1930, 454e 458.
40 Così, «nel caso di vino o grano venduto e non consegnato per colpa del vendi-
346 MIRIAM PADOVAN
Tuttavia, la conclusione appare, ancora una volta, affrettata e, aben vedere, non supportata da dati testuali.
In D. 19.1.21.3, infatti, vengono affrontate due diverse fattispe-cie, che meritano di essere trattate separatamente, essendo espressio-ne di una diversa ratio, pur avendo come comune denominatore l’uti-litas circa ipsam rem quale misura degli interessi stimati nella condan-na.
Nel primo caso, l’attore è l’acquirente di una certa quantità di vi-no, che non gli viene consegnata dal venditore. Mediante l’esperi-mento dell’actio empti, nella soluzione ipotetica formulata da Paolo,l’attore ottiene l’equivalente del mero danno emergente, mentre ilguadagno che egli avrebbe ottenuto da un successivo affare è elemen-to escluso dal risarcimento.
Tale esito, come constatabile dall’esame di molteplici passi re-lativi sia ad azioni di stretto diritto che di buona fede 41, appa-re inaccettabile ed è «contraddett[o] da tutte le leggi romane, com-presa questa stessa legge che non limita il risarcimento al solo pre-tium vini ... ma afferma che omnis utilitas emptoris in aestimationemvenit» 42.
L’ampiezza formulare e il nesso tra demonstratio, intentio e con-demnatio permettono al giudice di quantificare la condanna, avendocome dato predeterminato nell’ammontare il pretium. Tuttavia, se ildanno si dovesse intendere come il corrispettivo della vendita, nonavrebbe senso che i giuristi avessero interpretato il quidquid ... eius in
tore, non si terrà conto di quello che il compratore avrebbe potuto guadagnare riven-dendo il vino, e neppure il prezzo dei servi che sono morti di fame qualora il comprato-re si proponeva di alimentarli col grano comprato» (B. Biondi, Lezioni, cit., 139). Sulmedesimo caso, approfonditamente si soffermano É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, München, 1997, 191ss.; B. Kupisch, ‘Id quod interest’ bei Nichterfüllung und Verzug des Verkäufers. (Pomp.D. 19, 1, 3, 3 und Paul. D. 19, 1, 21, 3), in TR, XLIII, 1975, passim; F. Haymann,Haftung, cit., 450 ss. e 459; H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 7 ss. (con analisi delleposizioni di Haymann, Mommsen e Medicus), 11 (con richiami a Pringsheim e Aran-gio-Ruiz). Per le problematiche inerenti alla risarcibilità del danno indiretto, si veda an-che F. Pulitano, ‘De eo quod certo loco’. Studi sul luogo convenzionale dell’adempimentonel diritto romano, Milano, 2009, 300 s.
41 A mero titolo esemplificativo, cfr. Ulp. 32 ad ed. D. 19.1.11.18, Paul. 12 ad ed.D. 4.6.27, Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.1.3, Ulp. 27 ad ed. D. 13.4.2.8, Ulp. 69 ad ed. D.43.16.1.41, C. 7.47.
42 P. Bonfante, Corso, cit., 429.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 347
termini di id quod interest: riferimento che, al contrario, non si ri-scontra normalmente nelle azioni in quanti ea res est/erit/fuit.
Vi è poi un’altra ragione che porta ad escludere una limitazionedel risarcimento al solo danno emergente: la formula dell’actio emptipone in capo al giudice il potere di dare contenuto concreto al darefacere oportet ex fide bona e di trasformare in surrogato pecuniario leripercussioni dell’inadempimento.
Qualora esistesse un limite prefissato alla stima del danno, l’am-piezza di tale potere si manifesterebbe nella sola fase d’accertamento,mentre per quel che concerne la quantificazione della condanna alcu-ne conseguenze dell’inadempimento rimarrebbero inevitabilmenteprive di ristoro.
Invero, la lettura della formula suggerisce che la fase di verificadell’oportere ex fide bona sia direttamente connessa a quella decisoria43
e non contempla che si realizzi un divario tra l’an debeatur, il qui-dquid ... oportet, l’imperativo rivolto dal magistrato al giudice (eius iu-dex ... condemnato) e il quantum debeatur, che tende all’interesse del-l’attore.
Del resto, la prima parola posta ad apertura della condemnatio èeius, il quale riprende il pronome relativo indefinito in posizione pro-lettica (quidquid) dell’intentio 44.
Usando le parole di Cannata, la formula può essere così parafrasa-ta: «‘(stabilito che qualcosa NN deve dare ad AA) tu giudice condan-na NN per quel che deve’. Il computo, che il giudice doveva eseguire,era in queste azioni riferito all’id quod Ai Ai interest, nel senso (grosso
43 Cfr. C.A. Cannata, Profilo, II, cit., 98, dove afferma che «il tipo di condemna-tio e il tipo di intentio, che la precede, sono l’una in funzione dell’altra; infatti la con-demnatio imponeva al giudice un’operazione che, consistendo nella pronunzia risolutivadel processo, dipendeva dall’accertamento da lui stesso effettuato circa l’esistenza e laconsistenza della pretesa dell’attore».
44 Per Carcaterra, la presenza del quidquid nei giudizi di buona fede è significativa,perché «esso va oltre ogni riferimento temporale, il giudice è già condotto per via diuna interpretazione ed esplicitazione dei verba formulae a superare i vincoli formali etemporali della litis contestatio ... la formula prescrive che la decisione debba essere ispi-rata e governata dalla buona fede. Anche qui il iudex farà ricorso alla interpretatio, unainterpretatio plenior, più viva, che vada dunque allo spirito, ai fini sostanziali (delle pa-role usate nella formula, e quindi) del iudicium stesso» (A. Carcaterra, Intorno ai ‘bo-nae fidei iudicia’, cit., 88 s.) e ottempera «all’imperativo della formula a lui diretto, inte-pretandolo alla stregua dei termini e dei fini della formula stessa» e condannerà all’equi-valente monetario del quidquid ex fide bona (139).
348 MIRIAM PADOVAN
modo, almeno) che il giudice apprezzava in danaro l’interesse dell’at-tore alle prestazioni dovutegli dal convenuto, e condannava costui atale somma» 45, precisamente «tradu[cendo] in denaro ... il risultato diquell’accertamento, che egli ha già compiuto in relazione all’inten-tio» 46.
Per dare piena attuazione alla formula, il giudice deve condannareil convenuto nei limiti dell’interesse del creditore ad avere le presta-zioni rimaste inadempiute, quantificando eventualmente i danni in-diretti, purché eziologicamente connessi e provati 47.
Dall’applicazione di tale principio, discende che, nella vicenda af-frontata da Paolo in D. 19.1.21.3, l’ipotetico compratore di vinoavrebbe potuto ottenere, oltre al denaro versato, l’equivalente di ciòdi cui si sarebbe arricchito per effetto degli affari che avrebbe fruttuo-samente concluso con quella stessa merce.
Paolo, invece, perviene ad una diversa conclusione e circoscrivegli interessi oggetto di ristoro ai soli che corrispondono ad un’utilitascirca ipsam rem, escludendo il lucro cessante: circostanza che ha in-dotto i commentatori ad intendere tale voce come un’utilitas extra
45 C.A. Cannata, Profilo, II, cit., 104, circa la correlazione tra le diverse parti for-mulari. Secondo Provera, la conclusione è, tra l’altro, del tutto conforme al dettato for-mulare, poiché «il giudice era costretto a valutare in denaro il quidquid ... ex fide bona,tenendo conto perciò necessariamente del personale e concreto interesse del creditoreall’esatto adempimento della prestazione indicata nell’intentio della formula» (G. Pro-vera, Recensione a H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 465).
46 C.A. Cannata, Profilo, II, cit., 101, per il quale l’entità della condanna è «unaliquidazione, una pecuniaria aestimatio, come dice Gaio: il giudice deve stabilire la sum-ma della sentenza di condanna, il che significa precisamente tradurre in denaro – secon-do determinati criteri – il risultato di quell’accertamento, che egli ha già compiuto inrelazione all’intentio». Così, anche Biondi, secondo cui «la perpetuatio obligationis im-porta che l’obbligazione continua a sussistere nel senso che, al posto della prestazionedovuta e che non può più essere eseguita, subentra l’obbligo di pagare una somma didenaro ... corrispondente all’interesse pecuniario del creditore ad avere la prestazioneche non ha ricevuto» (B. Biondi, Il diritto, cit., 450 s.). La formula, infatti, «ordina algiudice di condannare a un quidquid, e non al valore limitato della (nuda) res; e di va-lutare tutto il rapporto» (A. Carcaterra, Intorno ai ‘bonae fidei iudicia’, cit., 140).Concordemente, R. Fiori, ‘Bona fides’, cit., 150 s.
47 Cfr. B. Biondi, Il diritto, cit., 450 s., che individua nei giudizi di buona fede ilcampo all’interno del quale è stata elaborata la dottrina generale del risarcimento, allacui quantificazione il giudice perviene attraverso una «più vasta latitudine di poteri, siaquanto alla esistenza dell’oportere sia quanto alla valutazione pecuniaria di esso», poten-do «anche tener conto del cosiddetto danno indiretto o mediato».
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 349
rem 48, alla stregua di un’entità estranea alla teoria del risarcimentoelaborata dai prudentes romani.
Se è vero che il mancato guadagno presuppone, oltre all’inadem-pimento del debitore, il concorso di altre circostanze – in questo caso,un’ulteriore vicenda contrattuale o obbligatoria, rispetto alla quale ildebitore convenuto è terzo estraneo –, e, quindi, è necessaria un’at-tenta analisi in merito alla sussistenza del nesso causale tra l’inadem-pimento originario e gli eventi dannosi 49, ciò non significa che rap-presenti una componente di danno preclusa all’analisi del giudice.
48 L’espressione extra rem è stata elaborata dai commentatori in contrapposizioneai danni risarcibili, che da Paolo sono denominati circa ipsam rem.
49 Per la risarcibilità sia delle perdite subite che del mancato guadagno, cfr. S. Pe-rozzi, Istituzioni, cit., 166, per il quale il danno non è «soltanto quel tanto di cui per ilfatto dannoso il patrimonio attuale è diminuito (danno emergente), ma anche quel tan-to di cui senza il fatto dannoso sarebbe stato aumentato (lucro cessante)». Cfr. F. Mom-msen, Zur Lehre, cit., 143 e 173 ss. e B. Windscheid, Diritto delle pandette, II, Tori-no, 1925, 43 s., per i quali il mancato guadagno è la componente più difficilmente ac-certabile in giudizio, poiché la prova del nesso causale è più ardua e in sua assenza ilgiudice dovrà limitare la stima del danno alla sola perdita subita. La stessa difficoltà èstata colta, tra i molti, da M. Talamanca, Istituzioni, cit., 658, secondo il quale «neiiudicia bonae fidei i giuristi adattano, in via casistica, il principio alle particolarità delcaso concreto e sono molto prudenti nella valutazione del mancato guadagno» ed «èdifficile cogliere precise linee di tendenza» (658). V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit.,390, dopo aver fatto presente che sono «più incerti ... i limiti in cui la giurisprudenzaha compreso nell’id quod interest, accanto al danno emergente, anche il lucro cessante»,nota che «i giuristi si arrestano, nel valutare il danno, alle conseguenze dannose che di-rettamente e normalmente derivano dall’inadempimento», senza giungere «a quelle in-dirette o peculiari del singolo creditore». Non ha dubbi sulla risarcibilità, nell’ambitodei iudicia bonae fidei, del lucro cessante Honsell, il quale, pur consapevole che astratta-mente l’id quod interest avrebbe potuto condurre a stime eccessive, non essendoci dei li-miti predeterminati, ritiene che la sua corretta applicazione avrebbe scongiurato questopericolo, poiché «caso per caso, “ermittelte die als Ausgleich für die Interesseverletzungzu zahlende Geldsumme in freier Beweiswürdigung und nach freiem Ermessen”» (G.Provera, Recensione a H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 464, che cita testualmente H.Honsell, ‘Quod interest’, cit., 175). Per Below, che esclude in età classica una generaleresponsabilità da lucro cessante tanto per gli illeciti contrattuali quanto per gli aquilia-ni, la medesima è pacificamente ammessa nel caso di vittorioso esperimento dell’actioempti a seguito di evizione della res o di mancata consegna (cfr. G. Impallomeni, Re-censione a K.H. Below, Die Haftung für ‘ lucrum cessans’ im römischen Recht, München,1964, in Iura, XVI, 1965, 230). Non concorda, invece, Pastori, che si serve dell’actio exempto esperita a seguito di evizione quale esempio di azione la cui formula, pur con in-tentio incerta solitamente diretta a far conseguire all’attore l’id quod interest, «procacciaal compratore solo la restituzione del prezzo» (F. Pastori, Concetto, cit., 244). Pastori,tuttavia, non supporta la sua conclusione con riferimenti testuali, pertanto risulta diffi-cile coglierne il vero significato.
350 MIRIAM PADOVAN
La contraddittorietà tra la soluzione paolina – non risarcibilità dellucro cessante –, la liquidazione dell’id quod interest e la correlazionetra intentio e condemnatio formulari, risulta ad un’attenta analisi soloapparente.
Invero, il giurista testualmente afferma che colui che ha acquista-to il vino potuit negotiari, ma nulla conferma che lo abbia fatto.L’espressione fa presumere che Paolo abbia elaborato un’ipotetica sti-ma del danno lamentato da un soggetto qualsiasi, che avrebbe potutoottenere un guadagno da altri negozi, ma del quale, nel caso specifico,non vi è prova.
La conclusione è, del resto, coerente con l’impostazione casisticadel diritto romano. Infatti, «una giurisprudenza concreta come quellaromana tiene conto solo delle utilità, che effettivamente sono venutea mancare, non anche di quelle eventuali od incerte, che il comprato-re avrebbe potuto conseguire» 50.
Qualora in giudizio l’acquirente fornisca prova di avere conclusoaltri negozi con quel vino, dai quali egli avrebbe ricavato dell’altro da-naro, otterrebbe altresì l’equivalente del lucro cessante, accertato ilnesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato51.
50 G.G. Archi, Corso, I, cit., 40. Alla stessa conclusione perviene C.A. Cannata,L’inadempimento, cit., 24, per il quale «queste soluzioni erano legate al fatto che quelche nei relativi casi si doveva e non è stato fornito era una certa cosa, per cui il valoredel risarcimento» va «calcolato come valore che essa avrebbe nel patrimonio del com-pratore, e questo può comprendere anche, per così dire, la potenzialità economica di es-sa»; tuttavia, «non risulta corretto farvi rientrare guadagni ipotetici considerandoli comeguadagni mancati e convertire queste entità astratte in elementi concreti del valore dellacosa stessa». Lo stesso principio si riscontra specularmente in sede di esperimento del-l’actio venditi. Riferisce Ermogeniano che, qualora l’acquirente non abbia pagato il pre-tium al venditore, costui otterrà non omne omnino, quod venditor mora non facta conse-qui potuit, veluti si negotiator fuit et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quaererepotuit (Ermog. 2 iuris epit. D. 18.6.20). Nel caso di indisponibilità del denaro, la provadel danno da mancato reinvestimento è ardua, se non ‘diabolica’. Il denaro, infatti, èun bene fungibile e si presume che il venditore ne abbia a disposizione dell’altro da im-piegare nei suoi affari.
51 Concordemente P. Bonfante, Corso, cit., 429: «la connessione è puramenteipotetica; che se fosse per avventura dimostrabile nel caso concreto noi crediamo cheanche un simile danno dovrebbe esser risarcito». Cfr., inoltre, H. Honsell, ‘Quod in-terest’, cit., cap. I, per il quale la valutazione dell’interesse comprende, in linea di mas-sima, anche i guadagni non realizzatisi, non esaurendosi nel prezzo pagato per l’acqui-sto della res, né nell’obiettiva aestimatio, e trova una sicura conferma nel già menziona-to frammento paolino D. 46.8.13 pr. L’unica eccezione alla risarcibilità del lucro ces-sante è, per Honsell, costituita dalla vendita di derrate, poiché, essendo beni facilmente
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 351
Ingiusto sarebbe, poi, che si condannasse il venditore non solonei limiti dell’interesse del compratore al perfetto adempimento, maanche al maggior valore che la merce ha nel frattempo raggiunto percircostanze che non si sarebbero verificate se fosse intervenuta la cor-retta traditio rei. Se la res nec tradita è uno schiavo con annesso pe-culio, l’interesse è dato dal valore dello schiavo e dall’entità del pe-culio.
Nel caso in cui il venditore manometta lo schiavo (res empta) ecostui investa autonomamente il peculio in sua disponibilità acqui-stando delle res, il compratore, esperendo l’actio empti, non otterràl’equivalente delle cose in aggiunta a quello del servo e del peculio. ÈMarcello a svelare la contraddizione nella quale è caduto Giuliano, ar-rivando ad attribuire al compratore anche gli acquisti fatti dal libertodopo la manomissione52.
Affinché sussista l’utilitas circa ipsam rem, è sufficiente che sia di-mostrata la dipendenza tra la mancata consegna della cosa e il pregiu-dizio sofferto dal creditore. Tuttavia, mentre per la perdita patrimo-niale il nesso causale è di immediata evidenza, coincidendo, quantomeno, con l’aestimatio rei nec traditae, il mancato guadagno potrebbe
procurabili, il compratore dovrebbe immediatamente attivarsi per reperirne altri allostesso prezzo di mercato, pertanto il danno viene fatto coincidere con il valore di mer-cato. Se nel frattempo il prezzo delle provviste fosse salito, la condanna del venditoreinadempiente non sarebbe limitata al prezzo pagato, ma al maggior valore che il com-pratore investe per ottenere dell’altra merce. Honsell stesso aveva colto in D. 19.1.21.3un’ipotesi che contrasta con il principio da lui sostenuto, poiché Paolo parla di omnisutilitas emptoris in aestimationem venit. Nonostante l’espressione faccia pensare alla ri-sarcibilità di ogni interesse patrimoniale – indifferentemente costituito da perdite subi-te o mancati guadagni – il giureconsulto poi la esclude. L’autore individua una con-traddizione insanabile tra il presupposto (tutte le utilità sono risarcibili) e la soluzione(non risarcibilità del maggior guadagno e della ulteriore perdita), che proverebbe lanon genuinità del passo. Infatti, considerato il tentativo da parte di Giustiniano di ela-borare una disciplina unitaria del risarcimento del danno, stabilendo tassativamentedei criteri di stima che mettessero fine al potere discrezionale dei giudici, per l’autore èragionevole ipotizzare che l’originaria soluzione prevedesse la risarcibilità anche di queidanni e sia stata poi alterata (cfr. G. Provera, Recensione a H. Honsell, ‘Quod inte-rest’, cit., 453 s.).
52 Cfr. Iul. 13 dig. D. 19.1.23: Si quis servum, quem cum peculio vendiderat, manu-miserit, non solum peculii nomine, quod servus habuit tempore quo manumittebatur, sed eteorum, quae postea adquirit, tenetur et praeterea cavere debet, quidquid ex hereditate liber-ti ad eum pervenerit, restitutu iri. Marcellus notat: illa praestare venditor ex empto debet,quae haberet emptor, si homo manumissus non esset: non continebuntur igitur, quae, si ma-numissus non fuit, adquisiturus non esset.
352 MIRIAM PADOVAN
essere determinato da fatti la cui connessione con l’inadempimento siregge «su di un filo tenue e artificioso» 53.
Attraverso le considerazioni preliminari svolte, risulta facilitata lacomprensione della ratio sottesa al secondo caso descritto da Paul. 33ad ed. in D. 19.1.21.3, nel quale il limite alla risarcibilità, questa vol-ta, riguarda non tanto il mancato guadagno, bensì un’ulteriore dimi-nuzione del patrimonio del compratore conseguente alla mancata da-zione della cosa da parte del venditore.
Acquirente insoddisfatto è un pater familias, al quale non vieneconsegnato il grano, che subisce la perdita di alcuni suoi servi decedu-ti per inedia, in quanto privi della derrata che avrebbe consentito lorodi nutrirsi. All’esito di un eventuale giudizio da compera esperito daldominus acquirente, il giurista esclude che il valore degli schiavi mortirappresenti una voce risarcibile, pur essendo un pregiudizio realizza-tosi.
Se non mi inganno, la soluzione proposta, più che essere indicedell’esclusione della risarcibilità dei danni indiretti e estrinseci rispet-to alla prestazione, sembra dipendere dall’assenza di effettiva connes-sione tra l’inadempimento del venditore (causa) e la morte delle resmancipi (effetto): il legame tra i due eventi è meramente cronologi-co e il primo si riduce a un ruolo marginale rispetto all’evento dan-noso, che, per prodursi, implica la presenza di una serie di fattoricapaci di escludere l’imputabilità della morte degli schiavi al vendi-tore54.
53 P. Bonfante, Corso, cit., 429.54 L’accertamento del nesso causale tra inadempimento e danno è sempre necessa-
rio. Il rigore con il quale il giudice privato è chiamato a quantificare il risarcimento èespressione del fatto che il creditore va tenuto «interamente indenne dal pregiudizio chedall’inadempimento gli è derivato» e «nel contempo, non deve risultarne che il credito-re profitti della situazione, non solo propriamente lucrandone, ma anche solo gravandoil debitore di perdite o di rischi che non gli toccano» (C.A. Cannata, L’inadempimento,cit., 26). Ne consegue, ad esempio, che il creditore, il quale, pur potendo limitare (onon aggravare) il danno patrimoniale, si astenga colposamente dal fare quanto è nellesue disponibilità, agendo in giudizio con l’actio empti, non otterrà quella parte di dannoche avrebbe potuto evitare. Se un soggetto acquista uno schiavo, che commette un fur-to, il compratore, agendo contro il venditore reticente sul vizio, non sarà ristorato ditutto ciò che ha dovuto pagare, ma solo di quel minimo con cui poteva liberarsi (Ulp.32 ad ed. D. 19.1.11.12). Pertanto, «se il furto è di notevole entità, egli non otterrà cheil valore dello schiavo, perché con la consegna (noxae deditio) dello schiavo poteva libe-rarsi» (P. Bonfante, Corso, cit., 436 s.); lo stesso accade se il compratore subisce l’evi-
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 353
In particolare, si deve immaginare che la salute e le condizioni fi-siche dei servi fossero già precarie per una gestione errata delle provvi-ste alimentari. È rinvenibile a monte un comportamento contrario al-la diligenza del buon padre di famiglia, addebitabile esclusivamente aldominus-emptor, il quale ha fatto dipendere la sopravvivenza deglischiavi da una fornitura di grano.
Inoltre, appurato l’inadempimento del venditore, il pater avrebbedovuto attivarsi immediatamente al fine di reperire altro cibo e, se nelfrattempo i prezzi di mercato fossero saliti, il giudice avrebbe condan-nato il venditore alla maggior somma impiegata dal compratore perprocurarsi la merce55.
La tesi esposta non è, tuttavia, pacificamente ammessa. Vi è chicontesta la genuinità dell’intero passo, ritenendolo il risultato di mol-teplici interpolazioni operate dai compilatori giustinianei, i quali, in-tenzionati a limitare la discrezionalità del giudice nella determinazio-ne dell’interesse del creditore, avrebbero introdotto l’ingiusta restri-zione della risarcibilità del danno diretto emergente56.
Pur essendo vero che in età giustinianea l’id quod interest subiscerestrizioni nell’ammontare consentito, sono propensa a credere chenella versione genuina del passo Paolo pervenisse alla medesima con-clusione tramandataci dai compilatori per quanto concerne gli acqui-renti di vino e di grano.
La non risarcibilità del mancato guadagno (compratore di vino)sembra giustificata dall’assenza di prova della rivendita della merce.Se il giudice privato avesse potuto pronunciare una condanna conte-nente qualsiasi lucro ipoteticamente prospettabile, essa sarebbe stataespressione dell’incontrollato arbitrio del giudicante, con elusionedella finalità della clausola ex fide bona e dell’id quod interest, che im-
zione dello schiavo, per non aver esperito l’actio Publiciana, mentre avrebbe potutousucapire (Paul. 5 quaest. D. 19.1.45.1). Se, invece, il venditore è in dolo, dovrà essererisarcito il danno integrale.
55 Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 234.56 Cfr. F. Haymann, Haftung, cit., 450, il quale presume che nel testo paolino
originario venissero riconosciuti ampi poteri al giudice, tali da permettergli di valutarequalsiasi danno cagionabile dalla mancata consegna della res, con stime spropositate.Dubbi sono sollevati anche da Honsell (cfr. H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 7 ss. Sulpunto, si veda quanto esposto da G. Provera, Recensione a H. Honsell, ‘Quod inte-rest’, cit., 453 s.).
354 MIRIAM PADOVAN
pone di valutare l’interesse concretamente esistente tra la res e il sin-golo creditore.
Per quanto riguarda la presenza di danni ulteriori subìti dal credi-tore, quando il nesso causale tra inadempimento e danno viene menoo intervengono fattori che di per sé avrebbero influito negativamentesul patrimonio del creditore, la stima della condanna non potrà risto-rare anche tali pregiudizi, perché non sono connessi eziologicamenteal comportamento del convenuto57: tale è la ratio che sostiene il se-condo caso affrontato da Paolo (mancata consegna del grano e succes-siva morte per inedia degli schiavi) 58.
3. La quantificazione dell’ ‘ id quod interest’ a seguito di evizione.
Prima di affrontare specificamente la modalità di quantificazionedel danno a seguito di vittorioso esperimento dell’actio empti da partedel compratore per l’evizione della res, è opportuno ripercorrere le fasiche hanno condotto a considerare inerente al contratto consensualedi emptio venditio tale tutela.
È, infatti, pacificamente riconosciuto in dottrina che il ricorso al-l’azione contrattuale a seguito di evizione della cosa sia solamente«l’ultimo stadio di una lunga evoluzione, che si compie in un’età rela-tivamente avanzata» 59.
57 Il dovere in capo al iudex di accertare il nesso causale tra inadempimento (e cat-tivo adempimento) e danno è comune a tutti i iudicia bonae fidei, per una ragione diequità sostanziale tra i contraenti. Emblematico è, in tema di actio mandati, Paul. 32 aded. D. 17.1.26.6, dove si prospetta il caso del mandatario che, recandosi in un luogoper portare a termine l’affare, si ammala e sostiene delle spese mediche, o è vittima diun furto o di un naufragio, così che si trova spogliato dei suoi averi. In entrambe le ipo-tesi esiste un pregiudizio patrimoniale e l’occasione durante la quale gli eventi dannosisono accaduti è l’espletamento del mandato; tuttavia, la causa dei fatti dannosi è da rin-venirsi nel caso, o in comportamenti dolosi di soggetti terzi: quindi, il giudice nella sti-ma della condanna non ne potrà tenere conto. Per un’analisi dell’actio mandati e deipregiudizi risarcibili attraverso il vittorioso esperimento della stessa, si rimanda a V.Arangio-Ruiz, Il mandato in diritto romano, Napoli, 1949, 166 s.
58 Condivide quest’opinione Ratti, per il quale le soluzioni contenute in Paul. 33ad ed. D. 19.1.21.3 sono esatta espressione del pensiero classico; la risarcibilità è esclusa«perché non si riconosce esistente il nesso causale» tra inadempimento e pregiudiziosofferto (U. Ratti, Il risarcimento del danno nel diritto giustinianeo, in BIDR, XL, 1932,195 e nt. 2).
59 V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 310. V. anche E. Volterra, Istitu-
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 355
Originariamente la tutela dell’evizione era assicurata solo dal regi-me dell’auctoritas nel caso di mancipatio 60 e da eventuali stipulatio-nes 61, strumenti volontari ai quali le parti avrebbero potuto discrezio-
zioni, cit., 503; B. Biondi, Lezioni, cit., 276, che definisce oscure alcune fasi dell’evolu-zione e «certo ... che fino al I sec. dell’Impero la responsabilità per evizione non è insitanella vendita».
60 Nell’epoca della sola vendita a effetti reali, qualora oggetto del negozio fosse sta-ta una res mancipi, attraverso l’auctoritas, il mancipio dans avrebbe dovuto prestare assi-stenza processuale all’acquirente convenuto in giudizio dal terzo, che avesse agito in ri-vendica della cosa. Qualora il mancipio dans si fosse rifiutato e, in ogni caso, se l’esitodel giudizio fosse sfavorevole al mancipio accipiens, quest’ultimo tramite l’actio auctori-tatis avrebbe ottenuto il pagamento del doppio del pretium dall’alienante. Per quantoriguarda le res nec mancipi, invece, il cui trasferimento avveniva con semplice traditio, ilcompratore per garantirsi contro l’evizione avrebbe dovuto ricorrere ad apposita stipula-tio, la cui previsione era rimessa alla discrezionalità delle parti: in sua mancanza, nulla il‘compratore’ avrebbe potuto pretendere dal ‘venditore’. La responsabilità per evizionenon trovava, infatti, origine nella traditio (né, poi, nella compravendita), ma era esternae funzionale alla traditio.
61 Le tipologie di stipulazioni, delle quali siamo a conoscenza, sono la s. haberelicere, s. duplae e simplae. La prima, apposta ad una traditio di res nec mancipi (o, suc-cessivamente, connessa a una compravendita consensuale: cfr., recentemente, G. Gui-da, La tutela del compratore in caso di evizione fra garanzia e responsabilità. Soluzionigiurisprudenziali romane e problemi teorici attuali, Napoli, 2013, 70 e nt. 31, con esa-me della dottrina tradizionale), avrebbe consentito al compratore di agire per l’id quodinterest, «mira[ndo] alla realizzazione dell’interesse che (in termini moderni) potrem-mo definire positivo» (T. dalla Massara, Garanzia, cit., 293, al quale si rimanda in-tegralmente per uno studio sul percorso storico qui solo accennato. Negli stessi termi-ni, cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 341). La stipulazione più diffusa èla s. duplae, con la quale il compratore evitto avrebbe potuto conseguire il doppio delprezzo pagato (cfr. G. Guida, La tutela, cit., 76 e nt. 54). Le fonti tramandano anchel’esistenza di una s. simplae, diretta all’equivalente del prezzo (non all’id quod interest,come invece avverrà grazie all’esperimento dell’actio empti). Non vi sono elementi cer-ti che consentono di collocare temporalmente le diverse forme di stipulationes: in par-ticolare, in dottrina sussistono opinioni discordanti circa la progressione cronologicadella s. habere licere rispetto alla s. duplae con riguardo all’emptio venditio. Due sonogli indirizzi interpretativi: vi è chi sostiene che sia più recente la s. duplae, poiché rap-presenterebbe una sorta di evoluzione di tutte le stipulazioni di garanzia conosciute.Infatti, conterrebbe i peculiari vantaggi di ciascuna stipulazione, essendo volta ad otte-nere il doppio (come nel regime dell’auctoritas); potendo intervenire accanto al vendi-tore un terzo quale garante (come nella satisdatio secundum mancipium) e fissando co-me criterio per il riconoscimento dell’avvenuta evizione il venir meno dell’haberelicere, presuppone l’esistenza della stipulatio habere licere (cfr. V. Arangio-Ruiz, Lacompravendita, cit., 341 s.; M. Talamanca, voce Vendita, cit., 391; T. dalla Massa-ra, Garanzia, cit., 294, che affronta la questione in termini problematici e non giun-ge a collocare con certezza la s. habere licere prima della s. duplae). Pare, invece, prefe-ribile aderire alla tesi di quanti individuano nella s. habere licere la forma più recentedi garanzia apposta all’emptio venditio. Infatti, pur potendo concretamente condurre
356 MIRIAM PADOVAN
nalmente ricorrere nel concludere una traditio o una vendita consen-suale.
Con lo svilupparsi dell’emptio venditio e con l’elaborazione giuri-sprudenziale intorno al concetto di fides e bona fides, si inizia a diffon-dere l’idea che, pur in assenza di apposita obligatio in forma stipulato-ria, il compratore non fosse privo di tutela62.
ad una somma risarcitoria inferiore rispetto a quella conseguibile grazie alla s. duplae,mira all’id quod interest, criterio sviluppatosi successivamente al quanti ea res est/erit/fuit. La s. duplae, invece, permette al compratore di ottenere il doppio del prezzo pat-tuito, un multiplo dell’aestimatio condotta dalle parti in sede di stipulazione del con-tratto, rimanendo preclusa qualsiasi considerazione inerente all’interesse del comprato-re (cfr. P.F. Girard, Études historiques sur la formation du système de la garantie d’évic-tion en droit romain, in Mélanges de droit romain, II. Droit privé et procédure, Paris,1923, 100 ss.; implicitamente, E. Betti, Istituzioni di diritto romano, II, Padova,1960, 207 s. Per G. Guida, La tutela, cit., 76 nt. 54, ad un primo stadio in cui la s.duplae è diretta a far conseguire al compratore il doppio del prezzo, ne segue un se-condo, nel quale la stipulatio sarebbe funzionale alla corresponsione dell’id quod inte-rest. Guida fornisce due spiegazioni plausibili e alternative alla correlazione tra s.duplae e id quod interest: l’una, per la quale sarebbe avvenuta una commistione tra ac-tio empti e actio ex stipulatu; l’altra, che coglie nell’associazione tra id quod interest e s.duplae un uso atecnico, per indicare solamente una maggiore modulazione della som-ma conseguibile dal compratore, il quale, in progresso di tempo, avrebbe potuto otte-nere anche le spese sostenute per il miglioramento del bene). Circa il regime del-l’auctoritas e delle tre stipulationes, si rimanda, tra le molte, alle considerazioni di V.Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 309-345; B. Biondi, Lezioni, cit., 276-279; R.Ortu, Garanzia, cit., 313 ss.; nonché T. dalla Massara, Per una ricostruzione dellestrutture dell’evizione, in Studi in onore di A. Metro, a cura di C. Russo Ruggeri, II,Milano, 2010, 103-107 e Id., Garanzia, cit., 286-297 (che, in apertura del contribu-to, cita un’esaustiva bibliografia dedicata all’evizione: 279 nt. 1). Sulla s. duplae, cfr.L. Franchini, Osservazioni, cit., 209 nt. 275.
62 Cfr. R. Ortu, Garanzia per evizione: ‘ stipulatio habere licere’ e ‘ stipulatio du-plae’, in La compravendita, II, cit., 316 s., a commento del passo di Paolo (32 ad ed.)tramandatoci in D. 19.1.4 pr.-1, nel quale, fra le obbligazioni del venditore, il giuristainserisce quella dell’ob evictionem se obligare. Il motivo è che «in progresso di tempo siritenne che non rispondesse alla buona fede, e quindi non fosse conforme al contrattoconsensuale di compravendita, il fatto che il venditore non avesse compiuto una diqueste stipulazioni. Si ammise pertanto che, se esse fossero mancate, il compratore po-tesse intentare l’actio empti contro il venditore ... Da questo sistema, realizzato nell’am-bito dell’attività giudiziaria del pretore, si sviluppò il concetto che, in caso di evizione,il compratore potesse ... agire con l’actio empti per ottenere il risarcimento, indipen-dentemente dal[la] ... stipulazione» (E. Volterra, Istituzioni, cit., 503). Nella primafase, l’azione contrattuale in assenza di stipulationes «svolgerebbe una funzione in uncerto senso di supplenza» (L. Vacca, Ancora sull’estensione, cit., 35). Per T. dalla
Massara, Garanzia, cit., 282, i fattori fondamentali del processo evolutivo sono darinvenirsi nel principio di buona fede e nell’attenzione alla «relazione tra la funzionedel contratto e la sua struttura». Viene ad esistenza una garanzia «agganciata in modo
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 357
L’azione contrattuale viene percepita, dapprima, come il mezzonaturale attraverso il quale l’acquirente evitto avrebbe ricevuto tutelacontro i comportamenti dolosi del venditore, per poi operare a pre-scindere dallo stato soggettivo di costui, per il fatto oggettivo dell’evi-zione63.
Ad un primo stadio in cui l’actio empti permetteva all’acquirentedi imporre al venditore l’assunzione dell’obbligazione nella forma del-la stipulatio habere licere o duplae, è ipotizzabile che ne sia seguito unopiù maturo, reso possibile attraverso un’interpretazione orientata alladimensione sinallagmatica dell’emptio venditio e estensiva delle obbli-gazioni ad essa inerenti, fra le quali quella relativa all’evizione (a me-no che le parti non avessero espressamente concluso un pactum denon prestanda evictione 64).
È proprio la formulazione dell’actio empti, con condemnatio diret-ta all’id quod interest, a garantire «un ristabilimento dell’equilibrio si-nallagmatico tra le prestazioni», venuto meno ogni qualvolta sia inter-venuta l’evizione65.
Il testo principale che rileva a questi fini è
Paul. 5 quaest. D. 19.1.43: ... De sumptibus vero, quos in erudien-dum hominem emptor fecit, videndum est: nam empti iudicium ad
diretto al contratto: solo a questo punto, in effetti, la garanzia per l’evizione può dirsielemento naturale dell’emptio venditio» (306). Per A. Carcaterra, Intorno ai ‘bonaefidei iudicia’, cit., 76 s., si assiste al tipico fenomeno della prassi che diventa ius. Infat-ti, «poiché quelle stipulationes erano divenute d’uso corrente, si finì per non compierlepiù e per ritenerle assorbite nell’atto stesso della vendita: la (stipulazione di) garanziadiventa naturale negotii» (76 s.). Cfr., altresì, L. Franchini, Osservazioni, cit., 196 nt.229, 209 s.
63 Cfr. T. dalla Massara, Garanzia, cit., 298 e V. Arangio-Ruiz, La compraven-dita, cit., 346 ss.
64 Guarino fa risalire alla «seconda metà del periodo classico» la «convinzione ge-nerale che, allo scopo di evitare ogni responsabilità per evizione, [altrimenti natural-mente nascente dal contratto di compravendita] non vi fosse per il venditore altro rime-dio che un provvedimento di governo, oppure un esplicito patto col compratore» (A.Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 1957, 516).
65 Cfr., ancora, T. dalla Massara, Garanzia, cit., 307, che conclude che «al ter-mine di una lunga evoluzione, la giurisprudenza romana più matura giunse a costrui-re il regime della garanzia per l’evizione, nel contesto dell’emptio venditio, proprio sul-la base di un rapporto, dialogico e articolato, tra il principio della buona fede, da un la-to, e la struttura del sinallagma, dall’altro». Conforme L. Vacca, Ancora sull’estensione,cit., 36.
358 MIRIAM PADOVAN
eam quoque speciem sufficere existimo: non enim pretium continettantum, sed omne quod interest emptoris servum non evinci. Plane siin tantum pretium excedisse proponas, ut non sit cogitatum a vendi-tore de tanta summa (veluti si ponas agitatorem postea factum velpantomimum evictum esse eum, qui minimo veniit pretio), iniquumvidetur in magnam quantitatem obligari venditorem.
Paolo, dopo aver affrontato una delicata questione che intrecciaprofili di diritto ereditario all’actio empti 66, si sofferma sull’entità del-la condanna del venditore per l’evizione subita dal compratore.
È quest’ultima parte ad assumere particolare rilevanza ai fini dellanostra indagine, poiché le esemplificazioni e le argomentazioni svoltedal giurista rappresentano una guida per l’interprete che voglia com-prendere se l’id quod interest sia essenzialmente un criterio quantitati-vo e qualitativo dal contenuto predeterminato e invariabile – almenoper quel che concerne l’actio empti – e di quali poteri usufruisca ilgiudice per stabilirlo.
Già nel paragrafo precedente, si è sostenuta la tendenziale risarci-bilità dei danni, diretti o indiretti, purché non presunti e non cagio-nati da fattori che prescindono dall’inadempimento della prestazioneoriginaria.
Paolo, in D. 19.1.43, sta disquisendo dell’evizione di uno schia-vo, che nel frattempo era stato educato dall’acquirente, che aveva sop-portato le relative spese e si chiede entro quali limiti venga ristoratol’emptor all’esito del giudizio da compera. È evidente che il danno su-bìto dallo stesso non equivale al mero prezzo d’acquisto della res man-cipi, a favore della quale successivamente sono state destinate delle ri-sorse economiche, allo scopo di aumentarne il valore, le prestazioni ele possibilità di impiego.
Applicando a tale vicenda il criterio di calcolo emerso in materiadi mancata consegna della cosa acquistata, si intuisce facilmente la so-
66 Per un commento della prima parte del passo F. Haymann, Haftung, cit., 445;H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 42 ss., 51 ss.; S. Tafaro, ‘Ius hominum causa consti-tutum’. Un diritto a misura d’uomo, Napoli, 2009, 197-200; Id., Brevi riflessioni su buo-na fede e contratti. Relazione presentata ne Il seminario en el Caribe ‘Derecho romano y la-tinidad: identidad e integración latinoamericana y caribeña’ (La Habana - Cuba, 12-14febbraio 2004), in Diritto @ Storia, III, 2004, par. IV; G. Guida, La tutela, cit., 129 ss.e nt. 62.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 359
luzione prospettata da Paolo. Poiché il iudicium empti non enim pre-tium continet tantum, sed omne quo interest emptoris servum non evinci,la condanna è espressione delle spese che l’emptor ha sostenuto permigliorare la formazione dello schiavo.
Il giurista, tuttavia, è consapevole che il principio della risarcibili-tà dell’interesse del singolo attore avrebbe condotto a stime di dannonon ragionevoli se interpretato in modo del tutto discrezionale dalgiudice, senza calibrarlo sulla fonte dell’obbligazione inadempiuta(contratto di compravendita) e senza chiedersi se la condanna finaleavesse l’effetto di alterare lo scambio iniziale e l’assetto di interessi esi-stente al momento della conclusione del contratto.
Gli esiti inaccettabili, conseguenti ad un’errata applicazione del-l’id quod interest, sono esemplificati da Paolo, sempre all’interno diD. 19.1.43.
Uno schiavo, privo di doti peculiari e acquistato al prezzo di mer-cato, viene addestrato in modo specifico dal compratore, per impie-garlo come auriga o attore.
L’emptor, quindi, del tutto casualmente, sceglie di investire moltodenaro su quel servo, il quale si rivela un buon pantomimo (o coc-chiere) e acquisisce un valore esponenzialmente superiore rispetto alprezzo originario.
Avvenuta l’evizione dello schiavo ed esperita l’actio empti, il giu-dice si pronuncerebbe in modo iniquo se, nel tradurre in denaro l’idquod interest, liquidasse nella condanna l’ingente dispiego di risorseeconomiche, il mancato guadagno del compratore (che non può piùimpiegare lo schiavo evitto negli spettacoli o come auriga) e l’au-mento di valore raggiunto grazie alle nuove competenze infungibilidella res mancipi, non prospettabile quando si è conclusa la vendita.Paolo contiene la risarcibilità del danno entro le spese e nei limi-ti dell’aumento di valore ipotizzabili al momento della stipula delcontratto, prevedibili in quanto espressione dell’id quod plerumqueaccidit.
Diversa sarebbe la stima della condanna se il compratore avesseacquistato quel servo su suggerimento del venditore perché già predi-sposto a fare l’auriga o l’attore. Dal momento genetico del negozio, ilvenditore è conscio che l’uso futuro della res sarà diverso da quelloconsueto e implicitamente assume il rischio del maggior valore e dellespese che il compratore sosterrà fino all’evizione.
360 MIRIAM PADOVAN
Vi è chi dubita della genuinità del passo67, paventando che sia af-fetto da molteplici interpolazioni giustinianee, e propone di espunge-re le proposizioni plane si ... de tanta summa e iniquum ... venditorem,poiché espressione di un principio che non apparterrebbe ad alcungiurista dell’età classica.
Seguendo tale ricostruzione, nel calcolo della condanna dovrebbe-ro conteggiarsi tutte le spese affrontate dall’emptor, indipendentemen-te dalla prevedibilità dell’impiego della res e dall’esponenziale diffe-renza tra il prezzo d’acquisto e l’interesse, mentre la limitazione agliinvestimenti ragionevoli e ipotizzabili sarebbe sorta in epoca postclas-sica.
Tuttavia, vi sono almeno «due considerazioni che fanno forte-mente dubitare della proposta ricostruzione del fr. 43: ... l’esser pre-sentati ex abrupto ... due casi nei quali il venditore dello schiavo evittorisponderebbe di un aumento di valore del mille e forse più per cen-to; e dal punto di vista dell’equità il peso enorme che verrebbe a rap-presentare per il venditore una semplice alzata di testa del comprato-re, che essendo padrone di tanti schiavi avrebbe scelto proprio quelloper specializzazioni così eccezionali ... resta vero che nessun contraen-te dovrebbe esser chiamato a rispondere di eventi per lui del tutto ca-suali e verificabili una volta su mille; ... in linea di equità è umanoche ci si rivolti contro l’idea che da una onesta contrattazione possasorgere un rischio così sproporzionato» 68.
Infatti, se è vero che la condemnatio del iudicium empti ha comecriterio quantitativo l’id quod interest, nel quale è contenuta anche la
67 E. Albertario, Studi di diritto romano, III, Milano, 1936, 43 ss. V. anche F.Haymann, Haftung, cit., 449 nt. 20. Per U. Ratti, Il risarcimento, cit., 191, D.19.1.43 è interpolato nella parte in cui «esclude il risarcimento integrale del danno nel-l’ipotesi di evizione subita dal compratore dopo miglioramenti straordinari e impreve-dibili della cosa». Secondo l’autore, il carattere dell’imprevedibilità del danno ha fattoingresso in materia di risarcimento per inadempimento contrattuale a partire dall’etàbizantina, fornendo un criterio di decisione a favore del debitore non in dolo (191 s.).Bonfante, non ritenendo compatibile che prima Paolo commisuri il risarcimento all’in-teresse del compratore – e non al valore oggettivo della cosa –, e poi lo circoscriva allaprevedibilità, colloca il limite tra quelli introdotti nel diritto giustinianeo (cfr. P. Bon-fante, Corso, cit., 442). Per la genuinità dell’intero passo, cfr. D. Medicus, ‘Id quodinterest’, cit., 82 s.; S. Tafaro, C. 7.47.1: Giustiniano e i limiti alla condanna del debito-re, in L’usura ieri ed oggi. Atti del convegno (Foggia, 7-8 aprile 1995), a cura di S. Tafaro,Bari, 1997, 220.
68 V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 236.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 361
spesa per istruire lo schiavo, «ragioni di equità ... impongono di limi-tare la estensione della condemnatio; così nel caso testé presentato simette in rilievo la iniquità che in magnam quantitatem obligari vendi-torem» 69.
La soluzione proposta in D. 19.1.43 sembra, pertanto, l’esattaapplicazione del principio di buona fede da parte del giudice in fasedi accertamento delle obbligazioni inadempiute, «in considerazionedi un bilanciamento ponderato degli interessi ... coinvolti» 70 e esplicai suoi effetti al momento della stima pecuniaria del danno, conside-rata l’intima connessione tra intentio e condemnatio, di cui si è giàdetto.
È il canone della buona fede e la correlazione formulare tra ilquidquid ... dare facere oportet ex fide bona e l’eius ... condemnato ascongiurare che la liquidazione dell’id quod interest conduca a stimeeccessive. Il giudice, nel determinare l’interesse e il danno, ha unospazio di libertà, ma mai di arbitrio, poiché deve mantenere l’atten-zione «per il singolo agente, che ha diritto ad essere tutelato nelle sueaspettative in base ad un criterio di ‘normalità’ di previsioni ed aspet-tative: diversamente sarebbe non tutelato, bensì ‘schiacciato’ dal di-ritto» 71.
Alla fattispecie paolina in esame, i compilatori hanno fatto segui-re due passi, rispettivamente attribuiti ad Africano e a Paolo, chesembrano integrare le ragioni delle limitazioni al risarcimento deldanno ed esplicitare l’ammontare massimo della condanna pecunia-ria:
69 B. Biondi, Lezioni, cit., 141.70 S. Tafaro, Brevi riflessioni, cit., par. V, per il quale «sembra ... che i giuristi ro-
mani siano pervenuti a considerare le intenzioni dei contraenti in un ambito di prevedi-bilità, conseguente alla natura e alle modalità della negoziazione; escludendo ogni rilie-vo per ciò che fosse imprevedibile o, comunque, non pensabile ed accettabile (se noto)al momento del negozio». Un cardine dell’interpretazione del concetto di buona fede«restò l’ancoraggio alla volontà dei contraenti, in relazione a quello che realmente ave-vano inteso stabilire fra di loro. Ma la buona fede consentiva di andare oltre e di inter-pretare i rapporti in modo dinamico, cioè non solo in relazione di ciò che si era voluto,ma anche addirittura in prospezione di quanto si sarebbe voluto se si fossero conosciutetutte le circostanze ed in particolare quelle verificatesi in un tempo successivo alla con-trazione del vincolo obbligatorio». La medesima tesi è contenuta in S. Tafaro, ‘Ius ho-minum causa constitutum’, cit., 202 s.
71 S. Tafaro, Brevi riflessioni, cit., par. V.
362 MIRIAM PADOVAN
Afr. 8 quaest. D. 19.1.44: (cum et forte idem mediocrium faculta-tium sit: et non ultra duplum periculum subire eum oportet)
Paul. 5 quaest. D. 19.1.45 pr.: Idque et Iulianum agitasse Africanusrefert: quod iustum est: sicut minuitur praestatio, si servus deteriorapud emptorem effectus sit, cum evincitur.
La conclusione del fr. 43, con il risarcimento delle spese affron-tate dal venditore evitto, nella misura in cui siano prevedibili e pro-spettabili, è avvalorata nel fr. 44 dal fatto che il venditore potreb-be non godere di un patrimonio ingente, e, in ogni caso, non sareb-be opportuno che costui sopportasse un periculum eccedente il dop-pio.
Il fr. 44 contiene, per lo meno, due tratti problematici, che riaf-fioreranno nel corso della presente trattazione a proposito della costi-tuzione imperiale del 531, con la quale Giustiniano sancisce che l’idquod interest non possa portare ad una condanna superiore al doppiodella prestazione originaria.
Ipotizzando per un momento che la sequenza di D. 19.1.43-45sia espressione del pensiero autentico di Giuliano, Africano e Paolo, ilfr. 44 lascia non specificato se i prudentes calcolassero il non ultra du-plum rispetto al pretium della res empta evitta, o rispetto al valore del-la cosa, già inteso come interesse dell’acquirente, il quale ben potreb-be divergere72.
A supporto della prima ipotesi, vi è, da un lato, nel fr. 43 l’esclu-sione dal risarcimento di quelle voci di spesa che determinano un ac-crescimento di valore della res del tutto spropositato rispetto al prez-zo d’acquisto, che funge da unità di misura sulla quale calcolare ilcontenuto massimo della condanna. Dall’altro, la similitudine con lacostituzione giustinianea, il cui intento consiste nell’introdurre un li-mite certo alla quantificazione del danno, basandosi sul valore dellaprestazione oggettivamente previsto e esplicitato nel contratto: il pre-tium 73.
72 Cfr. C. Schieder, Interesse, cit., 35 ss.73 Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 235 ss.; D. Medicus, ‘Id quod
interest’, cit., 88 ss. e 288 s. La seconda interpretazione non è stata avvalorata dalladottrina. Neppure sembra rinvenibile un cenno in F.M. De Robertis, La disciplina
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 363
Il secondo aspetto dibattuto della sequenza esaminata attiene allagenuinità del fr. 44. Sono, infatti, incline a ritenere che sia stato og-getto di un’interpolazione bizantina (alla luce di C. 7.47.1) o, quantomeno, che sia stata operata una contrazione del pensiero originario diAfricano74. È sufficiente per ora anticipare che è proprio l’assenza diuna predeterminazione dell’id quod actoris interest a indurre Giusti-niano a sancire il non ultra duplum 75. Inoltre, la finalità dell’id quodinterest, in età classica, è quella di garantire una condanna calibratasul singolo caso esaminato, avendo riguardo alla clausola ex fide bona,alla costruzione formulare e all’equilibrio delle prestazioni, che mal siconcilierebbe con un ammontare predefinito.
Diversamente, secondo Tafaro, il passo è da ritenersi genuino,poiché non avrebbe senso che i compilatori giustinianei avessero in-terrotto «il brano di Paolo con l’intromissione del breve frammentodi Africano», se costui «non fosse stato l’effettivo autore del richiamoal duplum» 76: infatti, ben avrebbero potuto modificare direttamente ilpasso paolino, ivi inserendo il non ultra duplum 77. Per l’autore, l’esi-genza di questo «tetto di salvaguardia» sarebbe sorta nei «giuristi delPrincipato», «preoccupati che le richieste di risarcimento non risultas-sero smodate e fuori di ogni ragionevolezza» 78.
della responsabilità contrattuale nel sistema della compilazione giustinianea, III, Bari,1966, 621 e nt. 36, che pur se ne occupa con riguardo a un problema del tutto diver-so rispetto a quello in nostro esame, nel valutare quanto il venditore potesse chiedereper le spese relative alla conservazione e al ragionevole miglioramento della cosa. Cfr.,infatti, quanto chiaramente esposto dallo stesso autore in Id., ‘ Quanti res est –Id quod interest’ nel sistema della grande compilazione, in SDHI, XXXII, 1966, 122nt. 42, che verrà analizzato nel prosieguo e che dà ulteriore supporto alla prima tesiesposta.
74 Di opinione opposta è Tafaro (cfr. S. Tafaro, C. 7.47.1, cit., 221).75 Su ciò ci si soffermerà all’interno del paragrafo dedicato al regime giusti-
nianeo.76 S. Tafaro, C. 7.47.1, cit., 220 nt. 12, che riprende la tesi sostenuta da K.H.
Schindler, Justinians Haltung zur klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seinerKontroversen entscheidenden Konstitutionen, Köln - Graz, 1966, 262 s.
77 Cfr. S. Tafaro, ‘Ius hominum causa constitutum’, cit., 201.78 S. Tafaro, C. 7.47.1, cit., 221 e nt. 13. Giustiniano avrebbe solo esteso, attra-
verso la costituzione imperiale, quanto i prudentes avevano già elaborato in materia diemptio venditio, avendo come paradigma la stipulatio duplae.
364 MIRIAM PADOVAN
4. Presenza di vizi occulti e assenza di qualità nella ‘res empta’. La dut-tilità dell’interesse.
Com’è accaduto in materia di evizione79, la legittimazione del-l’acquirente ad esperire l’actio empti per eventuali vizi presenti nellares empta è il risultato di un percorso interpretativo del contenuto del-l’emptio venditio e della bona fides 80 e, in parte, analogico ed estensivodelle tutele riconosciute dagli edili curuli nelle vendite di schiavi e dianimali 81.
79 Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 353. L’autore rifiuta, però, itentativi di quanti hanno voluto forzatamente considerare le due evoluzioni come iden-tiche. Mantiene, inoltre, distinto il sistema civilistico (353-361) dal diritto edilizio(361-394), approdando poi alle innovazioni giustinianee (394-399).
80 Cfr. L. Vacca, I precedenti, cit., 40.81 Originariamente, dal contratto di compravendita non si generava in capo al
venditore l’obbligo di risarcire eventuali danni cagionati al compratore da vizi occultidella cosa. Tuttavia, si è diffuso, fin da tempi antichi, l’uso di concludere apposita sti-pulatio, in assenza della quale il venditore non avrebbe potuto essere condannato né peril minor valore della cosa, né per ulteriori perdite cagionate al compratore a causa dellares viziata (cfr., ad esempio, B. Biondi, Lezioni, cit., 280 e A. Guarino, Diritto, cit.,517). Un elemento che ha portato a considerare quale naturale obligatio la responsabili-tà per vizi occulti è la disciplina che gradualmente gli edili curuli stavano elaborando inmateria di vendita di animali e schiavi nei pubblici mercati con la prescrizione nell’edit-to dei comportamenti che i venditori avrebbero dovuto osservare, pena l’assoggettabili-tà all’actio redhibitoria e all’actio aestimatoria. Gravava in capo ad essi l’obbligo di pale-sare i difetti degli schiavi e dei capi di bestiame in vendita e, qualora avessero omesso ladenunzia o la res fosse risultata affetta da un vizio non dichiarato, il compratore con laredhibitoria – da esperirsi entro sei mesi dalla vendita – avrebbe ottenuto la risoluzionedella vendita e con l’aestimatoria – da esperirsi entro un anno dalla vendita – una defal-cazione del prezzo. Successivamente, tra la fine dell’età preclassica e l’inizio dell’età clas-sica, è iniziato il processo per il quale il venditore avrebbe dovuto rispondere dei vizidolosamente taciuti a prescindere da stipulatio, poiché il dolo è contrario alla bona fidesdi cui il contratto di compravendita è espressione (cfr., sul punto, A. Guarino, Diritto,cit., 517). Secondo Letizia Vacca, la quale riporta recenti studi condotti in materia, apartire dall’età adrianea, l’actio empti sarebbe stata esperibile anche contro il venditoreignorans a prescindere da apposita stipulazione (cfr. L. Vacca, Ancora sull’estensione,cit., 60). Per la dottrina più risalente, invece, il venditore in buona fede avrebbe potutoessere convenuto solo con un’actio ex stipulatu (se si fosse, cioè, espressamente obbliga-to: cfr. D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 128 ss.; H. Honsell, ‘Quod interest’, cit.,83 ss.; R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the CivilianTradition, Cape Town - Wetton - Johannesburg, 1990, 305 ss.). In età classica, puòconsiderarsi ormai compiuto il processo di estensione dell’obbligazione per vizi in ogniemptio venditio, pur in difetto di stipulatio (cfr. B. Biondi, Lezioni, cit., 282). Tra imolti contributi sul tema, si segnala L. Garofalo, Studi sull’azione redibitoria, Padova,2000; L. Manna, ‘Actio redhibitoria’ e responsabilità per i vizi della cosa nell’editto ‘de
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 365
Nel caso di esperimento dell’actio empti per i vizi occulti della res,l’indagine relativa al danno patrimoniale e alle modalità di liquidazio-ne si complica ulteriormente, intersecandosi con considerazioni inmerito all’ignoranza scusabile o alla consapevolezza dell’esistenza delvizio in capo al venditore, all’eventuale reticenza nella fase di conclu-sione del negozio, alla dichiarazione circa le qualità della cosa, al-l’espressa previsione di garanzia per vizi o di esonero del venditore eall’influenza delle diverse scuole di pensiero, alle quali avrebbe potutoaderire il giudice.
Un passo ulpianeo che ha fatto discutere e che, per taluni, è il ri-sultato della rielaborazione giustinianea è
Ulp. 32 ad ed. D. 19.1.13 pr.: Iulianus libro quinto decimo inter eum,qui sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemna-tione ex empto: ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum ven-didit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestatu-rum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem: si vero sciensreticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptioneemptor traxerit, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt,aedium aestimationem, sive pecora contagione morbosi pecoris perierunt,quod interfuit idonea venisse erit praestandum 82.
Giuliano, di cui Ulpiano riferisce il pensiero, ipotizza che oggettodi compravendita sia del bestiame malato, che provoca la morte percontagio degli altri animali già nella disponibilità del compratore; odel legno tarlato, che viene posto a sostegno di una casa, della qualedetermina il crollo, non essendo idoneo a reggerne il peso.
mancipiis vendundis’, Milano, 1994; N. Donadio, Responsabilità del venditore per i vizidella ‘res empta’: a proposito di D. 19.1.13.1 (Ulp. 32 ad ed.), in Index, XXXIII, 2005,481-511; Ead., Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale, in Kaufen nachRominischem Recht, a cura di E. Jakab e W. Ernst, Berlino, 2008, 61-82; Ead., Qualitàpromesse e qualità essenziali della ‘res vendita’: il diverso limite tra la responsabilità per‘reticentia’ e quella per ‘dicta promissave’ nel diritto edilizio o nel ‘ ius civile’, in TSDP,III, 2010.
82 Oltre alla bibliografia a commento del passo contenuta nelle note successive,cfr. quella presente in D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 128 ss. ntt. 1-7, nonché inN. Donadio, Garanzia, cit., 67 nt. 14 e in G. Rossetti, Interdipendenza delle obbliga-zioni e ‘risoluzione’ della ‘emptio venditio’: alcune soluzioni casistiche della giurisprudenzaclassica, in La compravendita, II, cit., 17 nt. 27, 21 nt. 36.
366 MIRIAM PADOVAN
In entrambi i casi, all’acquirente spetta la facoltà di esperire l’actioex empto, tuttavia il quantum debeatur e le voci risarcibili subisconodelle variazioni a seconda che il venditore conoscesse l’esistenza delvizio83.
Il giudice, se dovesse appurare l’ignoranza del venditore circa iconnotati del bene e la fondatezza delle pretese dell’attore, pronunzie-rà una condanna pari alla differenza tra ciò che il compratore ha pa-gato (il prezzo) e il valore della res viziata, senza poter accrescere lacondanna stimando il gregge morto a causa del pecus vitiosum, nél’edificio crollato per le travi difettose84.
Apparentemente, si tratta di una applicazione generalizzata, sindall’età classica, del regime dell’actio empti in funzione aestimatoria 85
83 Sul punto, cfr. R.J. Pothier - A. Bazzarini, Le Pandette di Giustiniano, II,Prato, 1833, 761; H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 83 ss.; F.M. De Robertis, La di-sciplina, cit., 643 s. Secondo De Robertis, il passo è particolarmente significativo perindividuare «il senso e la portata della distinzione» tra venditore in buona fede e vendi-tore in mala fede: trattasi di una «questione concernente esclusivamente il problema delrisarcimento del danno», che veniva «rapportato al puro valore della cosa» (con il vendi-tore ignorans), «mentre si estendeva all’omnis utilitas ... nella ipotesi di inadempimentodoloso». De Robertis analizza altri casi di res viziata – quali D. 18.1.45, circa la venditadi aurichalcum pro auro o di vestimenta interpola pro novis, e D. 19.1.21.3 (già visto su-pra) –, nei quali i giuristi stimano il risarcimento modulandolo in base alla consapevo-lezza del venditore circa l’esistenza del vizio. Sui passi D. 19.1.13 e D. 19.1.21.3, da ul-timi, si segnalano L. Vacca, Garanzia e responsabilità. Concetti romani e dogmatiche at-tuali, Padova, 2010, 59 e, soprattutto, 97-102; É. Jakab, ‘Praedicere’, cit., 191 ss.; L.Solidoro, ‘... Si vero sciens reticuit et emptorem decepit...’ (D. 19.1.13 pr.): ‘vizi di fatto’,‘vizi di diritto’ e reticenza del venditore, in Aa. Vv., ‘Fides Humanitas Ius’. Studi in onoredi L. Labruna, VIII, Napoli, 2007, 5269 ss.; Ead., Gli obblighi di informazione a caricodel venditore. Origini storiche e prospettive attuali, Napoli, 2007, 85 s. e nt. 68; F. Proc-chi, ‘Licet emptio non teneat’. All’origine delle moderne teoriche sulla cd. ‘culpa in con-trahendo’, Padova, 2012, 100 s. (dove accenna alle riflessioni dei glossatori e alla ratioche giustificherebbe il principio secondo il quale il venditore avrebbe risposto anche deivizi che non conosceva, ma che avrebbe dovuto conoscere) e 206 s.; Id., ‘Dolus’ e ‘culpain contrahendo’ nella compravendita. Considerazioni in tema di sinallagma genetico, in Lacompravendita, I, cit., 215 s.; G. Guida, La tutela, cit., 131 s.
84 Cfr. L. Vacca, Ancora sull’estensione, cit., 60, per la quale è «opinione prevalen-te della dottrina più recente che, almeno a partire dalla giurisprudenza adrianea, l’actioempti fosse esperibile dal compratore di buona fede anche nei confronti del dominusignorans. Il testo che maggiormente rileva nell’ottica delle nostre osservazioni è indub-biamente D. 19.1.13 pr.»; Ead., Garanzia, cit., 297; Ead., Sul rischio del locatore nella‘ locatio conductio rei’, in Studi per G. Nicosia, I, Milano, 2007, 327.
85 Cfr. W. Kunkel, D. 19.1.13 pr.-2, in ZSS, XLVI, 1926, 286 ss. L’aestimatoriaconduceva ad una condanna da calcolarsi sottraendo al valore obiettivo della cosa – sein ottimo stato – il minor valore del bene, a nulla rilevando gli ulteriori pregiudizi patiti
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 367
al venditore di buona fede. A una rapida lettura, sembra che solo inpresenza di dolo il venditore sia tenuto a risarcire anche i danni indi-retti 86, mentre in sua assenza il giudice dovrebbe fare applicazionenon tanto dell’id quod interest, quanto del criterio obiettivo del quantiea res est, condannando solamente al minor valore della res.
La conclusione, tuttavia, sembra viziata da un’errata interpreta-zione delle parole ulpianee e non tiene conto delle differenze struttu-rali e sostanziali tra l’actio empti e l’aestimatoria. Infatti, il contenutodella sentenza di condanna del venditore di buona fede per i vizi dellacosa è al quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem.
Il ruolo del giudice nella stima del danno nell’actio empti non si
dal compratore o l’interesse delle parti. Sul punto, cfr. V. Mannino, Questioni di dirit-to, Milano, 2007, 183 ss., che è cauto, poiché «la metodologia casistica dei prudentes ro-mani impedisce di assegnare all’analisi delle fattispecie trasmesseci una valenza tassati-va». La tesi di Kunkel non è unanimemente accolta: secondo la dottrina maggioritariadella prima metà del secolo scorso la responsabilità per vizi occulti del venditore di buo-na fede e la sua condanna al quanti minoris risalirebbero al periodo giustinianeo (cfr. G.Rossetti, Interdipendenza, cit., 17, in particolare ntt. 27 s. per una rassegna degli auto-ri e delle opere; L. Vacca, Garanzia, cit., 98 nt. 46): il passo sarebbe interpolato (cfr.V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 242). Le recenti revisioni critiche propendo-no per la genuinità del testo (cfr. N. Donadio, Azioni edilizie e interdipendenza delleobbligazioni nell’ ‘emptio venditio’. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazionidelle parti, in La compravendita, II, cit., 462 s. nt. 9; G. Rossetti, Interdipendenza, cit.,21 s. e nt. 36). Per Giulietta Rossetti, la distinzione tra venditor ignorans e sciens, che in-cide sulla liquidazione del danno, è comprensibile «se leggiamo il frammento alla lucedel criterio del bonum et aequum, che è il criterio tecnico, che impone la tutela del-l’equilibrio delle obbligazioni sinallagmatiche nell’iudicium empti ... In altri termini loiudex, utilizzando la duttilità della condemnatio, tipica dell’iudicium bonae fidei, ritienemeritevoli di tutela nell’iudicium empti, alla luce del principio della buona fede, sia l’in-teresse dell’emptor di una res vitiosa ingannato dalla reticenza dolosa del venditor, sial’interesse dell’emptor, che una siffatta res ha acquistato da un venditore, che ignorava inbuona fede l’esistenza del vizio» (47). Anche Fiori si pronuncia per la genuinità del pas-so e del pensiero di Giuliano: poiché «la bona fides va oltre la scientia e diviene parame-tro puramente oggettivo di equilibrio contrattuale», «il venditore deve non solo risarcirel’id quod interest in caso di false dichiarazioni o di scientia, ma anche restituire all’acqui-rente la somma da questi pagata allorché la cosa avesse difetti, per quanto ignoti al ven-ditore. Si nota in ciò un’influenza della tutela edilizia su quella accordata dal pretorenei iudicia bonae fidei: ma la logica sottesa alla innovazione è sempre legata alla centra-lità dell’obligatio ossia – nei contratti a prestazioni corrispettive – dell’equilibrio del si-nallagma» (R. Fiori, ‘Bona fides’, cit., 142 s.; per le argomentazioni a sostegno del-l’interpolazione del brano, cfr. 141 nt. 138, 143 nt. 141). Concordemente, cfr. L. Vac-ca, Garanzia, cit., 99 s. e nt. 100. Per l’evoluzione del ricorso all’actio ex empto per vizidella cosa nei confronti del venditor ignorans, cfr. E. Palermo, Labeone e l’estensione del-la ‘redhibitio’ all’ ‘actio empti’, in RDR, III, 2003, 11.
86 Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., 434.
368 MIRIAM PADOVAN
esaurisce in una mera operazione matematica, nella quale egli sottraeil valore obiettivo del bene al maggior prezzo pagato, poiché viene inconsiderazione pur sempre l’interesse del creditore ad avere l’esattaprestazione dedotta in giudizio e quanto egli sarebbe stato disposto apagare se avesse conosciuto il reale stato della cosa.
Come ha opportunamente osservato Honsell, la conseguenza delcriterio di calcolo suggerito dalla formula è che l’entità della condan-na potrebbe divergere notevolmente grazie al ricorso all’actio empti 87
piuttosto che all’actio aestimatoria.Mentre nella formula dell’actio aestimatoria 88 il giudice è esortato
a condannare alla differenza tra l’obiettiva aestimatio della res viziata eil valore che avrebbe avuto se esente da vizi, dinnanzi all’actio empti ilgiudice ha la facoltà, anzi il dovere, di liquidare l’interesse del com-pratore ad avere nel suo patrimonio la res e ad essere informato pre-ventivamente circa i vizi della cosa89.
Ancora una volta, è l’esatta applicazione del criterio della bona fi-des, connessa alla duttilità dell’id quod interest, a far prospettare que-sto esito del giudizio a Ulpiano e a Giuliano.
Infatti, «indipendentemente dall’inadempimento ‘soggettivo’ delvenditore», la vendita di una res inidonea all’uso «impedisce all’emptorla concreta utilizzabilità del bene, in altri termini pregiudica l’haberelicere della res», conducendo ad uno «squilibrio ‘oggettivo’ tra le pre-stazioni sinallagmatiche delle parti». Il principio della buona fede,
87 Cfr. H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 73 ss.88 C. AQUILIUS IUDEX ESTO. SI PARET HOMINI QUO DE AGITUR
QUEM A. AGERIUS DE N. NEGIDIO EMIT, VITII QUID FUISSE QUOD N. NE-GIDIUS ADVERSUS EDICTUM ILLORUM AEDILIUM NON PRONUNTIAVITNEQUE PLUS QUAM ANNUS EST, CUM EXPERIUNDI POTESTAS FUIT,QUANTO OB ID VITIUM IS HOMO, CUM VENIRET, MINORIS FUIT, TAN-TAM PECUNIAM C. AQUILIUS IUDEX N. NEGIDIUM A. AGERIO CONDEM-NATO; SI NON PARET ABSOLVITO (cfr. D. Mantovani, Le formule, cit., 114 s. n.205 e O. Lenel, Das ‘Edictum’, cit., 300).
89 Le molteplici differenze sussistenti tra l’actio empti e l’actio quanti minoris nonsi manifestano solamente in fase di quantificazione della condanna, ma riguardano an-che il termine entro il quale le azioni sono esperibili, nonché l’ambito di applicazione.Per un’analisi delle due azioni, cfr. C. Bertolini, Appunti didattici di diritto romano,Torino, 1905, 566; H. Honsell, ‘Quod interest’, 73 ss.; fra le ricerche più recenti, v.N. Donadio, La tutela del compratore tra ‘actiones aediliciae’ e ‘actio empti’, Milano,2004; Ead., Garanzia, cit., 67 ntt. 14 s.; Ead., Azioni edilizie, cit., 455-537, in partico-lare 462 nt. 14, 518 ss. e nt. 114.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 369
«non ‘sopportando’ questo squilibrio, non può non provvedere ad eli-minarlo tramite appunto l’utilizzazione dell’azione contrattuale ... neilimiti di quanto serve nel caso di specie a rimettere in equilibrio leobbligazioni interdipendenti» 90.
L’ammontare della condanna muta radicalmente, qualora il ven-ditore sia consapevole del vizio della cosa consegnata91: il suo com-portamento è censurabile, perché contrasta con la bona fides che am-bo le parti devono avere. Perciò, il giudice dapprima accerta il dolodel convenuto (che sarebbe stato tenuto a comunicare al compratoreil reale stato della res), e poi lo condanna all’id quod interest actoris adacquistare travi resistenti e animali sani. Il venditore dovrà rifondereil valore dell’edificio perito e del gregge contagiato, ossia risarcire in-tegralmente il danno, anche indiretto, provato e eziologicamente92
correlato al mancato rispetto dell’oportere ex fide bona.
90 G. Rossetti, Interdipendenza, cit., 49. Cfr., altresì, L. Vacca, Ancora sull’esten-sione, cit., 61 s.; Ead., Garanzia, cit., 297 s. Secondo Letizia Vacca, Giuliano avrebbeintrodotto «la rilevanza, in rapporto a determinati casi concreti, della differenza fra lasituazione in cui si configura un dovere di risarcimento del danno quale conseguenzadella difformità della condotta del debitore dalla condotta richiesta per la conclusione eper l’esecuzione del contratto e la situazione in cui deve essere comunque ripristinatol’equilibrio fra le prestazioni, venuto oggettivamente a mancare, in questo caso a segui-to di un vizio della cosa venduta ignorato senza colpa dal venditore». Giuliano, «utiliz-zando espressamente anche nel caso di vizio della cosa venduta la flessibilità del conte-nuto della condanna ex fide bona, concede sì l’azione contrattuale, ma collega differenticonseguenze al contegno del venditore di buona fede o di mala fede e, andando oltre laconcessione dell’actio empti in funzione di risarcimento del danno nel caso di venditoresciens di cosa viziata, configura l’applicabilità dell’actio empti anche laddove il venditoreignorasse il vizio della cosa, ma solo per la differenza fra il prezzo pagato e il prezzo cheil compratore avrebbe versato se avesse conosciuto il vizio, in funzione cioè analoga al-l’actio quanti minoris», avente lo scopo di ripristinare l’equilibrio voluto dal principio diinterdipendenza delle prestazioni.
91 Cfr. B. Biondi, Lezioni, cit., 141.92 A proposito del nesso causale che deve sussistere tra inadempimento e pregiudi-
zio patrimoniale, Pothier, partendo dalla medesima fattispecie esaminata – D. 19.1.13pr. –, considera tre tipologie di ripercussioni patrimoniali successive all’inadempimen-to, analizzando quali possono essere poste a carico del venditore. Oltre alla morte percontagio del bestiame, si potrebbe verificare la perdita dei raccolti agricoli, a causa dellamancanza di animali sani da utilizzare nei lavori, nonché il dissesto generale del com-pratore, il quale, non guadagnando, entra in insolvenza e subisce l’esecuzione forzata.Poiché la perdita del raccolto potrebbe essere, in parte, dovuta al concorso del fatto delcreditore, che si astiene dal reperire altri animali da lavoro o provvedere in modo alter-nativo al raccolto, il danno risarcibile è proporzionalmente ridotto di ciò che il compra-tore avrebbe potuto evitare. Il fallimento del compratore, invece, non è mai – concludePothier – addebitabile al venditore inadempiente, presupponendo l’intervento di altri
370 MIRIAM PADOVAN
Dal passo esaminato, sarebbe del tutto inopportuno dedurre ungenerale principio di risarcibilità dei pregiudizi indiretti solo in pre-senza di dolo del venditore: conclusione che si rivela inidonea a con-tenere la varietà dei casi prospettabili e che è contraddetta da altre fat-tispecie affrontate dai giuristi. Ancora una volta, l’id quod interest,lungi dal consentire facili astrazioni, si presta a liquidare voci di dan-no eterogenee, a seconda dello specifico oggetto del contratto di com-pravendita e del bilanciamento delle prestazioni prospettato dalle par-ti.
Emblematico, a riguardo, è
Pomp. 9 ad Sab. D. 19.1.6.4: Si vas aliquod mihi vendideris etdixeris certam mensuram capere vel certum pondus habere, ex emptotecum agam, si minus praestes. Sed si vas mihi vendideris ita, ut ad-firmares integrum, si id integrum non sit, etiam id, quod eo nomineperdiderim, praestabis mihi: si vero non id actum sit, ut integrumpraestes, dolum malum dumtaxat praestare te debere. Labeo contraputat et illud solum observandum, ut, nisi in contrarium id actumsit, omnimodo integrum praestari debeat: et est verum. Quod et inlocatis doliis praestandum Sabinum respondisse Minicius refert.
Pomponio, sin dall’incipit di D. 19.1.6, affronta una variegata ca-sistica attinente all’actio ex empto nelle ipotesi di vizi della res e man-canza di qualità dichiarate, contro il venditore sciens e ignorans, ipo-tizzando esiti condannatori non del tutto coincidenti a quelli incon-trati in D. 19.1.13 pr.
Al paragrafo 493, il giurista si sofferma sull’emptio venditio di un
eventi (quali una preesistente difficoltà economica del compratore, mancanza di liqui-dità e di provviste, errate scelte di gestione) che rappresentano le vere cause del dannoeconomico, mentre l’inadempimento del venditore si riduce ad uno fra i molteplicieventi che hanno agevolato la crisi (cfr. R.J. Pothier, Traité des obligations, Orléans,1761, n. 167). Per un commento approfondito agli esempi celebri di Pothier, ai quali siè fatto cenno, cfr. C.A. Cannata, L’inadempimento, cit., 20 ss.
93 Per un commento a Pomp. 9 ad Sab. D. 19.1.6.4, cfr. H. Honsell, ‘Quod in-terest’, cit., 85 s.; L. Vacca, Garanzia, cit., 178 s.; C.A. Cannata, L’inadempimento,cit., 22 e nt. 16. Per la genuinità del testo, v. I. Fargnoli, ‘Culpa in contrahendo’ eazioni contrattuali, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’, I, cit., 468 e nt. 137, 469 (conla disamina delle posizioni di Pomponio e Labeone e la progressiva estensione della re-sponsabilità anche in assenza di dolo in capo al venditore).
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 371
vaso e analizza dapprima il caso in cui il venditore abbia dichiaratocertam mensuram capere vel certum pondus.
Il compratore, scoprendo in seguito che l’oggetto non è rispon-dente alle qualità menzionate dal venditore, agisce ex empto, onde ot-tenere il risarcimento calcolato in base all’id quod interest ad avere unvaso conforme a quello richiesto.
La questione si fa più complessa quando oggetto della vendita siaun vas, non avente particolari dimensioni, peso e fattezze, che, unavolta entrato nel patrimonio del compratore, si scopre essere non in-tegrum.
Il quesito che si pone il giurista riguarda l’esatta quantificazionedella condanna e circoscrive ulteriormente la fattispecie, trattando inun primo momento l’ipotesi in cui l’integrità del vaso sia stata confer-mata dal venditore. In tal caso, il giudice nella liquidazione della con-danna è tenuto a tradurre in danaro anche il pregiudizio che l’acqui-rente ha subìto adibendo l’oggetto alla sua funzione di contenitore. Ilvalore di quanto fuoriuscito dal vaso è un danno economico che ilvenditore deve ristorare a prescindere dalla sua consapevolezza circa lacondizione del recipiente94.
Se, al contrario, le parti non hanno in concreto concluso che ilvaso dovesse trovarsi in perfetto stato, il danno da perdita del liquidoivi riposto è risarcibile, secondo una prima tesi accolta da Pomponio,solo se il venditore abbia venduto nonostante la consapevolezza dellanon integrità (venditor sciens).
Il giudice, aderendo alla soluzione esposta da Pomponio nella pri-ma parte di D. 19.1.6.4, dovrebbe verificare se il venditore abbia di-chiarato l’esistenza di una qualità e, in tal caso, tutti i danni cagionatidall’assenza di questa sarebbero oggetto di stima, secondo il consuetoprincipio dell’id quod interest. Allo stesso risultato il giudice dovrebbepervenire ogni qualvolta, nonostante la conclusione della compraven-dita non sia preceduta da alcuna dichiarazione, il venditore abbia te-
94 A commento di molteplici passi in tema di vizi della res empta, F.M. De Ro-bertis, La disciplina, cit., 624 s., per il quale colui che «ha assicurato avventatamentel’assenza di certi vizi, senza essersi preoccupato di verificarla o per averla mal verificata,risponde per aver trascurato quest’obbligo di verifica» e ciò rientra «nel settore ... ri-comprensivo sia del dolo che della colpa». Per M. Kaser, ‘Periculum locatoris’, in ZSS,LXXIV, 1957, 164, si tratterebbe di un’ipotesi di «Garantiehaftung», che prescinde dal-l’indagine sull’elemento soggettivo in capo al contraente convenuto locatore.
372 MIRIAM PADOVAN
nuto un comportamento doloso e sia rimasto reticente nel consegnareconsapevolmente un vaso non integro.
Di opinione diversa è Labeone, il quale conclude che il venditoredebba in ogni caso prestare un vaso perfetto, a prescindere da unamenzione al riguardo, con la conseguenza che, qualora venga fornitoun recipiente corrotto, sarà risarcibile l’intero danno, anche da disper-sione del liquido, a prescindere dallo stato soggettivo del venditore:soluzione, infine, approvata da Pomponio, che, a chiusura dell’esposi-zione del pensiero labeoniano, pone l’espressione et est verum.
Si badi bene che non si tratta di una responsabilità oggettiva cheLabeone fa gravare sul venditore ignaro, perché presuppone un suocomportamento negligente, consistente nell’assenza di adeguato con-trollo circa l’idoneità dell’oggetto a fungere da contenitore.
L’unica ipotesi in cui dalla compravendita di un vaso non sorgeper il venditore l’obbligazione di prestarlo integro si verifica, per La-beone, quando c’è una pattuizione di esonero, con assoluzione delconvenuto eventualmente chiamato in giudizio dal compratore in-soddisfatto.
Le tesi presentate – quella restrittiva esposta inizialmente da Pom-ponio e quella estensiva accolta da Labeone – non esplicano i loro ef-fetti a livello meramente teorico e dottrinale, ma l’accoglimento diuna o dell’altra ha dirette conseguenze processuali e si manifesta in seded’accertamento dell’oportere ex fide bona e di liquidazione del danno.
Proiettando le argomentazioni dei giuristi in ambito processuale,si ha indirettamente coscienza dell’ampiezza dei poteri di cui è dotatoil giudice privato nei giudizi di buona fede95 e nella stima del dannopatrimoniale.
Si immagini che l’acquirente di un vaso corrotto riponga nellostesso dell’olio e che questo fuoriesca a causa della conformazione delrecipiente. Nella migliore delle ipotesi, il danno sofferto dall’acqui-rente è circoscritto al valore dei liquidi persi e crescerà se l’olio sversa-to abbia imbrattato, guastato e danneggiato gli oggetti adiacenti, adesempio il prezioso mobile, sul quale è riposto il vaso.
Se al momento della conclusione del contratto nulla le parti ab-biano pattuito circa le caratteristiche della res, il giudice che faccia
95 Nella stessa direzione, cfr. B. Biondi, Lezioni, cit., 274.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 373
propria la prima tesi esposta da Pomponio, non ritenendo che dalcontratto consensuale di compravendita sia nata un’obbligazione incapo al venditore di fornire un vas integrum, dovrebbe vagliare lo sta-to soggettivo del venditore e solo se vi è dolo pronuncerà una senten-za di condanna nella cui stima rientreranno i danni da fuoriuscita delliquido.
Se, invece, viene constatata l’ignoranza del venditore, non graveràsu di esso la perdita dell’olio e gli eventuali altri pregiudizi patiti dal-l’acquirente, aventi comunque come prima conditio sine qua non ladazione del vaso imperfetto. Dall’emptio venditio non è sorta l’obbli-gazione di prestare un vaso integro e il venditore non ha agito condolo, né ha espressamente dichiarato l’integrità del vas, pertanto le ul-teriori conseguenze pregiudizievoli non gli sono addebitabili.
Il giudice non opera, però, un mero accertamento di obbligazioni pre-definite, ma valuta di volta in volta a quali prestazioni il convenuto fos-se tenuto in forza del contratto, riempendolo del contenuto discenden-te dalla clausola ex fide bona 96, e potrebbe accogliere la tesi per la qualedall’emptio venditio di un vaso nasce naturalmente l’obbligazione del ven-ditore di dare un oggetto inalterato: a prescindere dallo stato soggettivoe senza bisogno di accertarlo in giudizio, vi sarebbe un inadempimentoogniqualvolta il contenitore non consenta l’uso tipico.
Di fronte alla medesima fonte obbligatoria (l’emptio venditio) e al-lo stesso oggetto (un vas non integro), dall’esperimento vittorioso del-l’actio empti, il compratore sarà o meno risarcito dei danni causatidall’inidoneità del recipiente, in base al concreto accertamento checondurrà il giudice e alla sua vicinanza di pensiero a un orientamentopiuttosto che a un altro.
La possibile discrepanza degli esiti del giudizio di compravendita,con estensione variabile della risarcibilità del danno, si manifesta an-che negli altri giudizi di buona fede (ad esempio, in materia di loca-zione di dolia vitiosa). Proseguendo nella lettura del passo citato – D.19.1.6.4 – in chiusura è ancora Pomponio a riferire il responso di Sa-bino, coerente con il pensiero labeoniano, attinente alla locazione dibotti viziate: quod et in locatis doliis praestandum Sabinum respondisseMinicium refert 97.
96 Cfr. P. Lambrini, Studi sull’azione di dolo, Napoli, 2013, 127.97 Ad approfondire il caso della locazione di botti non integre e la quantificazione
374 MIRIAM PADOVAN
Dalle soluzioni elaborate dai giuristi citati – Labeone, Sabino, Ul-piano – non è possibile dedurre un generale principio di responsabili-tà del venditore per assenza di qualità e presenza di vizi occulti, validoper tutti i contratti di locazione98 e di vendita, tale da assicurare il ri-storo di ogni danno sofferto dal conduttore-acquirente, a prescinderedallo stato soggettivo del convenuto.
Infatti, i tre giureconsulti ipotizzano una conclusione differentequalora muti l’oggetto del contratto.
Se ad essere locato è un fondo, adibito dal conduttore a pascoloper il suo gregge, e alcune pecore, nutrendosi di erbe velenose cresciu-te in esso, si ammalano e periscono, il locatore sciens, convenuto me-diante actio locati, dovrà risarcire l’intero danno cagionato dal suocomportamento doloso. Non solo, per effetto della pronuncia giudi-ziale, il conduttore trova ristoro della parte di canone pagato in ecces-so rispetto a quanto sarebbe stato disposto a versare se avesse cono-sciuto che la vegetazione non era tutta commestibile, ma altresì delleconseguenze provocate dal cattivo adempimento, ottenendo l’equiva-lente del valore degli animali deceduti.
Quando, al contrario, il locatore non è al corrente della velenositàdelle erbe presenti nel terreno, applicando il principio fatto proprioda Ulpiano, Sabino e Labeone in materia di vas e dolia, si dovrebbe
del danno è Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.19. Per la ricca letteratura a commento del passo ul-pianeo, con la disciplina della responsabilità del locator per vizi della cosa, cfr. I. Far-gnoli, ‘Culpa’, cit., 473 e, in particolare, nt. 148. L’ignoranza del locatore sul vizio diconformazione delle giare non è una scusante per Cassio, pertanto al convenuto saran-no addebitati i danni patrimoniali indiretti, provocati dalla rottura delle botti, con suc-cessiva perdita del vino. La ratio è la stessa riscontrata nel responso di Labeone in temadi vendita: è naturale che colui che loca o vende un recipiente sia tenuto a garantirnel’idoneità a contenere del liquido. L’eventuale negligenza del venditore-locatore contra-sta con l’obbligo contrattuale di fornire vasi integri e «l’ignoranza non elimina la colpa.Si deve sapere che le botti non sono guaste e ci si deve all’uopo assicurare prima di con-segnarle» (P. Bonfante, Corso, cit., 433).
98 Per ciò che attiene specificamente ai vizi della cosa locata, secondo Biondi «ledecisioni che troviamo nelle fonti si ispirano non ad alcun principio di carattere genera-le, ... bensì agli elementi che i singoli casi concreti presentano, considerati sempre allastregua della bona fides che sta a base di tutto il rapporto» (B. Biondi, Lezioni, cit., 294s.). A tal proposito, cfr. H. Honsell, ‘Quod interest’, cit., 134 s.; G. Nicosia, La re-sponsabilità del ‘ locator’ per i vizi della cosa locata, in Id., Silloge. Scritti 1956-1996, I,Catania, 1998, 53 ss. (per il quale il testo è sostanzialmente genuino), il cui pensiero èripreso da L. Vacca, Sul rischio del locatore, cit., 322 e 329.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 375
pervenire ad una condanna che, pur in assenza di dolo, non dovrebbetrovare limitazioni.
Il valore del bestiame deceduto, invece, non è risarcibile e lacondanna rimane circoscritta al maggior valore attribuito al fondo,calcolato sempre in termini di id quod interest, rispetto a quello mi-nore al quale il conduttore sarebbe stato disposto a concludere il ne-gozio.
Alla diversità del bene locato corrisponde un fascio variabile diobbligazioni, di comportamenti richiesti ex fide bona e una stima deldanno differente e «la giustificazione della diversità di soluzione va ri-cercata nella peculiarità e quindi diversità delle due fattispecie» 99.
Infatti, in tale materia, «poco valgono i principii astratti se nel ca-so concreto non si esercita un sano criterio nella valutazione dei fatti enell’apprezzamento del nesso causale» 100.
5. Profili problematici nella determinazione dell’interesse del creditorealla luce di C. 7.47.1 pr.-2.
La difficoltà di dare contenuto all’id quod interest, di ricostruire lamodalità di liquidazione del danno effettuata dal giudice privato e diestrapolare dai casi giurisprudenziali dei limiti certi di risarcibilità 101
valevoli per ogni iudicium bonae fidei, non appartiene soltanto allostudioso moderno, il quale non è abituato a trattare con un diritto fi-siologicamente casistico, variabile, non plasmato da dettati normati-vi 102, ma è condivisa dagli stessi giuristi romani, come si coglie dallalettura della costituzione giustinianea del 531, attraverso la qualel’imperatore ha inteso probabilmente porre fine ai molteplici dubbiinterpretativi e applicativi sviluppatisi in passato:
99 G. Nicosia, La responsabilità, cit., 55, la cui tesi è condivisa da L. Vacca, Ga-ranzia, cit., 271 s.
100 P. Bonfante, Corso, cit., 434. Cfr., altresì, C.A. Cannata, L’inadempimento,cit., 23 s., il quale accosta alcune decisioni proposte dai giuristi in materia di locazionee compravendita (ad esempio, D. 19.1.6.4, D. 19.1.13.1-3 e D. 19.2.19.1), che muta-no sensibilmente, esprimendo differenti rationes che giustificano la maggior o minorentità dei danni risarcibili.
101 Cfr. S. Tafaro, C. 7.47.1, cit., 215.102 Si rimanda alle ricordate parole di P. Voci, Risarcimento, cit., 62 s.
376 MIRIAM PADOVAN
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. C. 7.47.1 pr.-2 (a. 531): Cum pro eoquod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, me-lius nobis visum est huiusmodi prolixitatem prout possibile est in angu-stum coartare. 1. Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam ha-bent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibuset omnibus contractibus, quod hoc interest dupli quantitatem minimeexcedere: in aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices, qui cau-sas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod revera inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machina-tionibus et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles rediga-tur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilita-te cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas exi-gi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a legibus certo fi-ne conclusae statuuntur. 2. Et hoc non solum in damno, sed etiam in lu-cro nostra amplectitur constitutio, quia et ex eo veteres quod interest sta-tuerunt: et sit omnibus, secundum quod dictum est, finis antiquaeprolixitatis huius constitutionis recitatio. <d. k. sept. Constantinopoli postconsulatum Lampadii et Orestae VV. CC. a. 531>
Giustiniano riferisce di dubitationes antiquae protrattesi a lungosul concetto di id quod interest. Non viene specificato se vi siano statedispute a livello giurisprudenziale e se l’incertezza dottrinale abbiaavuto ripercussioni in ambito processuale, cagionando pronunce giu-diziali talvolta eccessive, tanto variabili da essere percepite come arbi-trarie.
Il testo della costituzione conferma implicitamente quanto si è giàavuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, ossia che i giu-dizi di buona fede rappresentano l’ambito più esposto a questo ri-schio, poiché – sin dalla fase di accertamento – il giudice gode di am-pi poteri, onde pervenire alla verifica delle obbligazioni sussistenti incapo alle parti.
All’interno di questo scenario variegato e difficilmente controlla-bile ante iudicium, si colloca l’intervento dell’imperatore103, chiaro in-dice della differenza tra l’impostazione casistica classica e la nuovaconcezione giustinianea, che sostituisce alla multiforme «casistica dal-
103 Cfr. R. Volante, ‘Id quod interest’. Il risarcimento in equivalente nel diritto co-mune, Padova, 2012, 9 s.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 377
la quale affiorano non poche divergenze di interpretazione e di solu-zioni» un «procedimento semplificatore ... che praticamente discono-sce la complessa realtà che intende disciplinare: atteggiamento questoche è frutto di una mentalità assolutistica» 104.
Si pone fine per via legislativa alla modalità di liquidazione deldanno patrimoniale, ambito dapprima appannaggio dei giudici priva-ti 105, i quali pervenivano alla stima della condanna modellandola alcaso concreto secondo l’id quod interest, che a tale scopo era stato ela-borato.
La costituzione imperiale prevede che l’interesse dell’attore sia con-tenuto entro il massimale del doppio del valore della prestazione origi-naria inadempiuta e di essa dovranno fare applicazione i giudici in tuttii casi aventi ad oggetto certam qualitatem vel naturam, come ad esempionelle compravendite e nelle locazioni, nonché negli altri contratti.
L’imperatore rivolge, inoltre, un monito ai giudici chiamati a de-cidere fattispecie incerte, ordinando loro di ricercare con rigore in checosa consista realmente il danno (... quod re vera inducitur damnum),affinché non pervengano ad accrescere l’ammontare della condannapotenzialmente all’infinito.
Inserendo le parole di Giustiniano nello scenario storico all’inter-no del quale sono pronunciate, è opportuno rammentare che la varie-tà delle formulae e delle condemnationes – per quel che ci riguarda,quanti ea res est (erit, fuit) e eius ... condemnato – è venuta meno,«ave[ndo] ceduto il passo ad un utilizzo generalizzato dell’id quod in-terest» 106: criterio che, fino a quel momento, è sfuggito a limitazioni,al contrario di quanto è accaduto in tema di poenae (stabilite cum mo-deratione e entro un ammontare predefinito)107.
Alla luce delle considerazioni svolte circa la costruzione formularedell’actio empti con clausola ex fide bona, si può ipotizzare che, men-
104 G.G. Archi, in Corso, I, cit., 42.105 Tra le funzioni pratiche assolte dalla norma, Ratti ravvisa quella di contenere i
poteri dei giudici (cfr. U. Ratti, Il risarcimento, cit., 173).106 F. Procchi, Dall’ ‘ id quod interest’, cit., 496 e nt. 44, il quale evoca gli studi
condotti da Medicus, Kaser e Zimmermann. Cfr. altresì P. Voci, Istituzioni di dirittoromano, Milano, 1954, 412 ss.
107 Focalizza l’attenzione su queste parole Ratti, il quale coglie nell’assunto legisla-tivo giustinianeo una sorta di contaminazione tra la responsabilità civile e penale, una«confusione tra pena e risarcimento»: il risarcimento diventa una sorta di pena (U. Rat-ti, Il risarcimento, cit., 172 s.).
378 MIRIAM PADOVAN
tre il rischio di un cattivo officium iudicis e di una quantificazione deldanno-interesse spropositata è scongiurato, in epoca classica, dallastessa intentio con ex fide bona e condemnatio tendenti all’interesse;dalla padronanza della bona fides (attraverso la quale valutare il daree/o facere oportere) da parte dei giudici privati, chiamati a operare se-condo l’arbitrium del bonus vir; e soprattutto – come ritiene Tafaro–, dal fatto che il giudice fosse scelto dalle parti quale persona fidata eragionevole; in epoca giustinianea, la procedura della cognitio extra or-dinem non consente alle parti un vaglio ex ante sulla preparazione delgiudice, il quale diventa «un [mero] funzionario» 108.
Ciò determina «una crescente preoccupazione per l’operato deigiudici che potevano emettere sentenze senza tener conto del bilan-ciamento tra gli interessi dei litiganti e sempre più spesso si rendeva-no responsabili di arbitrii e collusioni con i creditori». Avviene unadeviazione dell’officium iudicis, che, abusando della discrezionalitàdella quale godeva, aveva dilatato oltre misura la previsione di sommeelevate, a titolo di interesse» 109.
A detta di chi scrive, la preoccupazione di Giustiniano è fondata.Quel criterio, nato per plasmare condanne capaci di aderire perfetta-mente alle esigenze e alle circostanze specifiche della vicenda contrat-tuale esaminata, avrebbe finito per far gravare sul debitore inadem-piente qualsiasi pregiudizio patito dal creditore, pur legato all’ina-dempimento da un labile nesso causale.
Non ci si può esimere dal notare, tuttavia, che l’intervento giusti-nianeo, che avrebbe dovuto costituire un rimedio ai pericoli del siste-ma classico della liquidazione dell’id quod interest, presenta profili didifficile comprensione110, riguardanti sia l’ambito di applicazione del
108 Posto che «la fides bona conferiva discrezionalità ampia al giudicante», «presup-poneva che questi fosse una persona degna: all’uopo nel processo formulare veniva in-contro la scelta del giudice da ambo le parti». Infatti, «nei iudicia bonae fidei e nei con-seguenti rapporti contrattuali non era concepibile una stima del dovuto diversa da quel-lo scaturente dalla valutazione della persona onesta e corretta» (cfr. S. Tafaro, Brevi ri-flessioni, cit., par. IX).
109 Secondo Tafaro, la ratio giustinianea è proprio quella di riportare a correttezzal’operato dei giudici, che, in ambito di iudicium bonae fidei godevano di un grande po-tere, l’arbitrium, «non erano più legati alla richiesta dell’attore e potevano procedere li-beramente all’apprezzamento della lite» (cfr. S. Tafaro, Brevi riflessioni, cit., par. VII;Id., C. 7.47.1, cit., 226 e nt. 23).
110 Perozzi, Ratti e Arangio-Ruiz definiscono la menzionata legge «strana ... di
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 379
limite del doppio (esclusivamente finalizzato alla materia contrattualeo anche all’area extracontrattuale111), sia le reali conseguenze dellostesso e finisce per apparire contraddittorio.
La soluzione non si presta affatto, di per sé, a riportare la stimadel danno entro i canoni della correttezza, della congruità e della con-formità alla vicenda concreta. Al contrario, appare «illogico, ricono-sciuto giusto il dovere di risarcire, mettere limiti artificiali al suo am-montare» 112, poiché la predeterminazione impedisce un accertamentocompleto sul caso e di elaborare una condanna conseguente (quidquid... eius ... condemnato).
Né si coglie, nella previsione giustinianea, un elemento di autenti-ca attenzione al singolo agente113. Un ammontare arbitrariamente pre-
senso molto oscuro. Sembra che l’imperatore voglia alludere a certi contratti, nei quali èdovuta una cosa determinata» (S. Perozzi, Istituzioni, cit., 167); dal significato «oscu-ro» e «presso gli interpreti molto controverso» (U. Ratti, Il risarcimento, cit., 171); un«principio generale ... balordo» (V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., 390).
111 La dottrina maggioritaria confina alle ipotesi di inadempimento contrattualel’ambito di applicazione della norma. Per Ratti, la disposizione vale certamente per gliilleciti contrattuali, non risultando invece «chiaro se e in quali limiti possa applicarsi... al danno extracontrattuale»: ciò «sembrerebbe escluso dalla mancanza di un debitooriginario limitato, tranne che Giustiniano non intendesse considerare nell’actio legisAquiliae come prezzo base, al nostro effetto, la semplice rei aestimatio» (U. Ratti, Ilrisarcimento, cit., 171). Per l’eventuale estensione della disposizione ai quasi contratticfr. F.M. De Robertis, La responsabilità contrattuale nel sistema della grande Compila-zione, I, Bari, 1981, 128 s. Dubbi sull’effettiva applicazione pratica della norma e suicaratteri innovativi sono sollevati da Medicus (cfr. D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit.,288 ss.), Wieling (cfr. H.J. Wieling, Interesse und Privatstrafe vom Mittelalter biszum Bürgerlichen Gesetzbuch, Köln - Wien, 1970, 89 s.), Mommsen (cfr. F. Momm-sen, Zur Lehre, cit., 235 ss.), Zimmermann (cfr. R. Zimmermann, The Law, cit.,828).
112 S. Perozzi, Istituzioni, cit., 167.113 Per Tafaro il limite del doppio è posto a tutela dei contraenti ed è indice del-
l’attenzione all’uomo: come il criterio della buona fede consente di occuparsi del singo-lo agente e delle sue aspettative in base ai criteri di prevedibilità e normalità, così la sti-ma massima nel doppio poneva una «significativa limitazione ‘esterna’ ... che limitaval’ampiezza della discrezionalità [del giudice]»; «spettava alla valutazione del giudicantemodellare la condanna sulle effettive circostanze del contratto, tenendo conto anchedella loro proiezione nella vita del rapporto, ma in ogni caso egli non doveva superare ilduplum» (S. Tafaro, ‘Ius hominum causa constitutum’, cit., 204; Id., Brevi riflessioni,cit., par. VI). Si concorda con l’autore quando sostiene che la misura del doppio ri-sponde alla ratio di non incidere negativamente sulla condizione dei debitori (a tal pro-posito, diffusamente S. Tafaro, C. 7.47.1, cit., 225 e 228, dove individua ulteriori in-terventi legislativi a ciò ispirati, quali, ad esempio, C. 4.32.26.1 e C. 4.32.27.1-2. La«benigna clemenza verso il debitore» potrebbe essere anche finalizzata, secondo Ratti, a
380 MIRIAM PADOVAN
stabilito – pur con tutta probabilità derivante in via analogica da quelloprevisto in altri istituti, come nella stipulatio duplae 114 – non può favo-rire un’analisi del danno re vera e un risarcimento più giusto115.
L’entità finale della condanna, al contrario, consisterà in una sti-ma che solo in parte corrisponde all’accertamento condotto.
D’altronde, l’imperatore «non si preoccupa di trovare soluzionicalate nella realtà dei singoli fenomeni economici e nella struttura deisingoli tipi di negozio» (come, invece, avveniva nel periodo classico),ma statuisce «una soluzione fondata su dati quantitativi e non quali-tativi», tanto che interpreta «come una mera, inutile, subtilitas» ciòche «in realtà era una indispensabile discussione su fattispecie com-plesse e difficilmente riducibili ad elementi semplici» 116.
Ad ogni modo, in fase di modulazione della condanna, pur all’in-terno del limite del doppio, si presenterebbero alcuni dei problemi dideterminazione contenutistica dell’id quod interest – quale, ad esem-
«favorire in qualche modo la conclusione dei contratti, e ... dei debiti contrattuali» (U.Ratti, Il risarcimento, cit., 173).
114 La misura del doppio, per i più, troverebbe origine nella stipulatio duplae, ope-rante nel caso di evizione della res empta. Cfr., a riguardo, la tesi di F. Procchi, Dal-l’ ‘ id quod interest’, cit., 496 e nt. 47; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., 390; S. Tafa-ro, Brevi riflessioni, cit., par. VI e nt. 23. Tafaro affianca alla stipulatio duplae altre fat-tispecie, nelle quali i giuristi della tarda Repubblica e dell’Impero usano ricorrere allamisura del doppio, che è percepita come naturale, se non addirittura scontata. Ciò sa-rebbe confermato, per quanto attiene ai giudizi di buona fede, dal fatto che nella sen-tenza di Giuliano (D. 19.1.43, dedicata al risarcimento del danno per l’evizione di unoschiavo istruito dal compratore per fare l’attore o l’auriga, supra analizzata), Africano(D. 19.1.44) chiosa il pensiero del maestro introducendo il non ultra duplum (cfr. S.Tafaro, C. 7.47.1, cit., 220 ss., 227).
115 Il diritto giustinianeo mirerebbe proprio a introdurre il criterio del «competen-te moderamen», il quale implica che «l’obbligo del risarcimento va determinato, in tesigenerale, in quella misura che sotto i più diversi aspetti possa considerarsi, nel caso con-creto, come un giusto risarcimento» (U. Ratti, Il risarcimento, cit., 169 s.). Specifical’autore che si tratta di una giusta moderazione nei confronti di entrambe le parti: le in-novazioni giustinianee «derivano da un’armonica e coerente concezione dell’obbligo delrisarcimento» entro limiti certi (194).
116 G.G. Archi, Corso, I, cit., 42 s. Il semplicismo che caratterizza gli interventilegislativi di Giustiniano, da un lato, è sintomo del «disprezzo contro gli uomini di leg-ge»; dall’altro, non consente di giungere ad «una soluzione in senso proprio: in sostanzail suo comando si riduce ad una pura esortazione morale, ad un ammonimento che nonha la virtù di semplificare i processi e le fattispecie. E del resto questo semplicismo giu-stinianeo era forse, nel suo difetto di realismo, meno idoneo alla subtilis elaborazionecasistica a favorire un accertamento del danno re vera» (42 s.).
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 381
pio, la rilevanza di talune perdite lamentate dal creditore – analizzatinei precedenti paragrafi 117.
Sebbene non sia chiara la reale portata innovativa e processuale ditale disposizione, importanti indicazioni a riguardo provengono dauno studio condotto da Ratti, in materia di risarcimento del danno inetà giustinianea118.
L’autore si è dapprima chiesto se gli interventi atti a limitare lastima dell’interesse e del danno – di cui abbiamo notizia attraverso lecostituzioni imperiali e le interpolazioni operate dai bizantini alla ca-sistica giurisprudenziale – si esaurissero in innovazioni isolate e super-ficiali o facessero trasparire un nuovo orientamento sostanziale e con-cettuale, propendendo per la seconda soluzione e individuando pro-prio in C. 7.47.1-2 un indizio persuasivo notevole.
Tuttavia, lo studioso, pur definendo come unica «innovazione so-stanziale veramente eccessiva» introdotta da Giustiniano119 proprio il
117 Di opinione diversa sembra essere De Robertis, il quale, nel definire la dispo-sizione giustinianea una «rigida preclusione ... alla estensione del risarcimento», ritieneche non ponga problemi interpretativi e applicativi circa la modalità di calcolo dell’in-teresse del creditore. La base della stima è il «verum rei pretium» e a confermare la suatesi vi sarebbero «il richiamo alla res vera della stessa costituzione», «il riferimento dellimite del doppio al pretium venditionis in D. 19.1.44-45» e la prescrizione normativache il risarcimento dei danni deve «essere limitato alla res in sé e per sé considerata (cir-ca ipsam rem: D. 19.1.21.3)» (F.M. De Robertis, ‘Quanti res est – Id quod interest’,cit., 122 e nt. 42). Ciò, tuttavia, non consente di chiarire come avvenga la quantifica-zione del danno e quali siano i pregiudizi patrimoniali da considerare, pur entro il li-mite del doppio del prezzo d’acquisto della cosa. Si rimanda, inoltre, alle considerazio-ni svolte a commento del passo D. 19.1.21.3, attinenti all’interpretazione dell’espres-sione circa ipsam rem.
118 Cfr. U. Ratti, Il risarcimento, cit., 169 ss.119 Accanto a questa, in epoca giustinianea si introducono altre misure dirette a
contenere il danno risarcibile. Una concerne la prevedibilità del danno: qualora il debi-tore non si sia reso dolosamente inadempiente, potrà essere condannato solo per i dan-ni prevedibili, così che l’entità del risarcimento è direttamente proporzionale al grado dicolpa imputabile al debitore convenuto. Affrontando il caso dello schiavo, ben istruitoe ammaestrato con successo dal nuovo compratore, il quale subisce poi l’evizione, si èvisto che Paolo contiene il danno risarcibile ai miglioramenti e agli investimenti ordina-ri (Paul. 5 quaest. D. 19.1.43). Buona parte della dottrina conclude per l’alterazione deltesto operata dai bizantini, i quali avrebbero utilizzato come criterio di decisione la pre-vedibilità del danno, mentre in epoca classica i giuristi non ne avrebbero fatto menzio-ne (sul punto, si rimanda al terzo paragrafo dedicato all’actio empti per evizione dellacosa). Per Ratti, la limitazione alla prevedibilità è anche giustificata dal fatto che si è «intema di responsabilità per evizione, quindi di responsabilità indipendente da effettivacolpa del venditore, in quanto questi risponde anche se di buona fede, e anche se non
382 MIRIAM PADOVAN
massimale del doppio, precisa che tale assunto vale solo «in teoria»,poiché, scendendo «sul terreno dell’applicazione pratica della nostranorma nel mondo bizantino, non è infondato il supporre che essafosse applicata come un principio derogabile, e in sostanza come uncriterio di decisione» 120.
Il sintomo della cogenza attenuata della statuizione in esame èconfermato, secondo l’autore, dalla presenza, all’interno del Digesto,di talune stime dell’interesse-damnum che finiscono per misconoscereimplicitamente l’esistenza di qualsiasi massimale: a titolo esemplifica-tivo, ricorda che nel passo ulpianeo D. 19.1.13 pr. il venditore di tra-vi tarlate – o di bestiame malato – è chiamato a risarcire il danno in-tegrale provocato al compratore121, qualora abbia dolosamente taciu-to l’esistenza del vizio. Poiché la decisione di Giuliano-Ulpiano non èstata chiosata dai compilatori giustinianei, i quali si astengono dall’in-serire alcun cenno all’opportunità di contenere il risarcimento entrolimiti certi, «queste decisioni, che costituiscono un’evidente condan-na della norma giustinianea, sono state rispettate dai compilatori, edè verosimilmente un consapevole rispetto» 122.
gli si può imputare negligenza alcuna ... l’imprevedibilità del danno, pur non alterandoil nesso causale, sembra in qualche modo attenuare la gravità della condotta del debito-re» (U. Ratti, Il risarcimento, cit., 191 s.). Nella stima del danno – in linea di massima,in età postclassica – si sarebbe dovuto tenere conto anche delle condizioni economichemodeste del venditore: così prevede Africano (il riferimento è ad Afr. 8 quaest. D.19.1.44: cum et forte idem mediocrium facultatium sit: et non ultra duplum periculum su-bire eum oportet, passo che accenna anche al criterio del non ultra duplum di C. 7.47). Atal proposito, cfr. U. Ratti, Il risarcimento, cit., 192, ove si legge che «il criterio dellaimprevedibilità che ... appare nella L. cit. 43 in cui si esclude il risarcimento del dannoin caso di miglioramenti imprevedibili della cosa evitta ... è dettato dai giustinianei conparticolare riferimento all’ipotesi che il venditore responsabile per l’evizione versi inmodeste condizioni economiche».
120 U. Ratti, Il risarcimento, cit., 197, sostiene che «nell’ultimo diritto, la praticacercava spesso di correggere gli inconvenienti e gli eccessi delle norme scritte, naturali escusabili in un’epoca di fermentazione, più che di sistemazione, di nuovi principi»,quindi è ipotizzabile che vi fosse un’applicazione attenuata della disposizione da partedei giudici.
121 Trattasi di Ulp. 32 ad ed. D. 19.1.13 pr., affrontato, all’interno del presentecontributo, nel paragrafo dedicato all’actio empti esperita per vizi occulti della res.
122 U. Ratti, Il risarcimento, cit., 197.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 383
6. Osservazioni conclusive.
Giunti al termine del presente contributo, è possibile individuaretaluni elementi peculiari che caratterizzano il risarcimento del dannopatrimoniale nel giudizio da compera e, altresì, delle prospettive di ri-cerca che più chiaramente consentirebbero di percepire il ruolo svoltodalla bona fides nell’ammontare della condanna.
In primo luogo, si è visto che il criterio in base al quale viene cal-colata la condanna, è l’id quod interest creditoris (D. 19.1.1 pr.), attra-verso il quale il giudice traduce in denaro le ripercussioni patrimonia-li della prestazione inadempiuta.
Pur essendo frequente l’utilizzo di espressioni e verbi che ad essorimandano all’interno del titolo primo del libro diciannovesimo delDigesto, non è presente una sua definizione, né i giuristi provvedonoa circoscrivere qualitativamente e quantitativamente l’interesse giuri-dicamente rilevante, tanto che attraverso la costituzione giustinianeadel 531 (C. 7.47.1 pr.-2) l’imperatore ha cercato di superare i molte-plici problemi applicativi originati da tale criterio, introducendo unammontare massimo alla sua liquidazione.
L’id quod interest sfugge a predeterminazioni ed è stato elaboratoper consentire al giudice di pronunciare una sentenza che sia espres-sione dell’accertamento (demonstratio-intentio) effettuato.
La correlazione tra il dare e/o facere inadempiuto e l’eius ... con-demnato, infatti, non si realizzerebbe se la maggior libertà che caratte-rizza l’organo giudicante nei bonae fidei iudicia nel riempire di conte-nuto l’oportere ex fide bona si esaurisse in questa prima fase e condu-cesse a una condanna dalla stima prefissata nel suo importo, in tuttoo in parte, edittalmente.
Se così fosse, al giudice sarebbe precluso il rispetto dell’ordine for-mulare in tutti i casi in cui l’inadempimento abbia cagionato pregiu-dizi peculiari, componenti di danno nuove, che sembrano sfuggire al-le classificazioni e che, pertanto, si potrebbero considerare atipiche,ma pur meritevoli nel caso specifico di essere risarcite.
La stessa impostazione casistica riceverebbe una battuta d’arresto.A ben vedere, è proprio nei giudizi di buona fede che le plurime cir-costanze fattuali trovano completa valorizzazione apud iudicem. È co-me se ogni giudizio da compera presentasse dei tratti comuni (la for-mula, la legittimazione attiva e passiva, il criterio – astrattamente in-
384 MIRIAM PADOVAN
teso – di quantificazione del danno) e altri unici (i fatti, il contegnodelle parti, la sinallagmaticità delle prestazioni come immaginata eperseguita dai contraenti), sui quali il giudice si sofferma e grazie aiquali elabora la sentenza di condanna.
Un criterio di stima obiettivo ben si presta alle stipulationes certaepecuniae, dove la base di calcolo coincide con il valore della prestazio-ne inadempiuta, ma condurrebbe a esiti irragionevoli se apposto aiiudicia bonae fidei.
La quantificazione oggettiva della res potrebbe, infatti, non essereequivalente all’interesse economico che le parti vi hanno assegnato,così che, rimasta inadempiuta la traditio della res, graverebbe sul com-pratore il valore che supera l’obiettiva aestimatio. Vi sarebbero, da unlato, la vera aestimatio della prestazione, vera perché contingente, insi-ta nell’accordo contrattuale; dall’altro, il prezzo di mercato della stessa,che può coincidere con la prima, ma per lo più tenderà a discostarsi.
L’id quod interest permette, pertanto, di svincolarsi dal rigidomeccanismo che identifica il danno risarcibile con il valore obiettivodella res o con il pretium.
Come sostenuto da autorevole dottrina, i giuristi poco hannoscritto sulla liquidazione del danno, perché avrebbero riconosciutoche si tratta di una quaestio facti, rimessa alla preminente attenzionedel giudice, il solo ad aver piena cognizione del danno patito dall’at-tore. Ogni caso necessita di una valutazione modellata sugli elementigiuridici e fattuali provati in giudizio dalle parti e le esemplificazionidei danni di volta in volta ristorati non possono intendersi comeprincipi generalmente adottabili. La stima elaborata mediante l’idquod interest è applicabile all’unico caso sul quale è plasmata e la ra-gione delle voci risarcite e dei pregiudizi non liquidati si rinviene nelconcreto svolgimento del giudizio.
È pur vero che le fattispecie affrontate dai giuristi e le soluzionitramandateci consentono, a grandi linee, di abbozzare qualitativa-mente la nozione di danno/interesse risarcibile.
Aiutati da D. 46.8.13 pr., si è avuta prova che anche nei giudizidi buona fede trova ristoro tanto ciò che i moderni definiscono perdi-ta subita, quanto il mancato guadagno.
La risposta, tuttavia, non è stata immediata.Invero, si è resa imprescindibile un’analisi sulla genuinità dei testi
richiamati, poiché incombe su alcuni di essi la mano bizantina e la
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 385
nuova concezione giuridica che sfocerà nell’intervento giustinianeo diC. 7.47.1 pr.-2.
Inoltre, influenzati da una certa interpretazione delle espressionihabere rem (D. 19.1.1 pr.) e circa ipsam rem (D. 19.1.21.3), è sem-brato inizialmente che i classici fossero restii a tradurre in condannaqualsiasi danno ulteriore rispetto alla perdita diretta, immediatamentepercepita nel patrimonio dell’acquirente, coincidente con l’oggettodella compravendita.
Tuttavia, provando a ricostruire gli eventi che avevano suggeritoai prudentes di escludere la risarcibilità di taluni pregiudizi, si è avutala conferma che potenzialmente ogni danno cagionato dal comporta-mento del debitore e a lui imputabile avrebbe trovato ristoro all’esitodel iudicium empti, purché il creditore ne avesse fornito rigorosa pro-va e sussistesse una dipendenza eziologica.
È chiaro che la componente del danno più facilmente constatabi-le e che non pone particolari problemi di causalità si identifica conquanto è uscito dal patrimonio del compratore per acquistare la res,ma anche tale voce dovrà essere stimata facendo applicazione dell’idquod interest.
Inoltre, qualora l’attore dia prova del maggior danno sofferto, ilgiudice dovrà necessariamente contemplarlo nella condanna.
Sono stati, poi, analizzati dei passi, nei quali l’acquirente ha subi-to una perdita patrimoniale – in termini di danno emergente, ma an-che di lucro cessante – a seguito dell’evizione della res o della scopertadi vizi occulti.
Originariamente, l’actio empti non forniva tutela al compratoredinnanzi a tali ipotesi e mediante un percorso interpretativo ed esten-sivo della bona fides, i prudentes sono giunti a ritenere che taluni dan-ni dovessero essere valutati al momento della condanna, a prescinderedalla scientia venditoris o da un’espressa dichiarazione, in quanto ilvenditore avrebbe dovuto accertare che taluni eventi non si verificas-sero a discapito del compratore e che taluni vizi non pregiudicasseroil normale utilizzo della res.
In particolare, il venditore ignorans di recipienti non integri è sta-to chiamato a risarcire integralmente i danni patiti dal compratore,poiché la consegna di vasi idonei all’uso è un’obbligazione natural-mente inerente al contratto di compravendita di quel bene ed auto-maticamente originatasi.
386 MIRIAM PADOVAN
In altri casi, in assenza di dolo del venditore, taluni pregiudizinon sono stati resi oggetto di stima pecuniaria, perché del tutto im-prevedibili, aleatori, ed aventi l’effetto di alterare la sinallagmaticitàcontrattuale.
L’essenza dell’id quod interest, ossia la sua dimensione casistica ela sua duttilità, poco si presta al disegno di Giustiniano, intenzionatoad accentrare su di sé il potere di cui disponevano giuristi e giudici.Probabilmente, anche per reagire a un uso distorto ed arbitrario di ta-le criterio, l’imperatore ha definito che l’interesse (ed il danno) nonpotesse essere stimato in una somma superiore al doppio della presta-zione inadempiuta.
Per l’età pregiustinianea, sembra, quindi, imprescindibile, in ma-teria di quantificazione del danno patrimoniale nella sentenza del giu-dice privato nei giudizi di buona fede, mantenere l’impostazione casi-stica, per non tradurre in principi risarcitori assoluti delle soluzionidettate da circostanze fattuali contingenti.
IL DANNO PATRIMONIALE NEL ‘IUDICIUM EMPTI’ 387