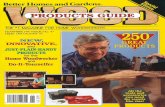Le stagioni del contratto vers 1 nov
Transcript of Le stagioni del contratto vers 1 nov
I VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE E I CODICI DELL’ITALIA UNITAII SessioneLe culture politiche dell’ Italia unita e
l’idea di codice
GUIDO ALPADal codice civile del 1942 ad oggi
1. Premessa e definizione dei confiniDescrivere, interpretare, riassumere le
culture politiche che si sono divise il campodel diritto civile dall’introduzione delcodice ad oggi significa abbracciare settantaanni di attività teoretica, di attivitànormativa , di esperienze e prassi, diinsegnamento e di dibattiti. Cronologicamentesi tratta soltanto di sette decenni, ma inrealtà, se si misura il tempo con glistrumenti del pensiero, se si dà corpo aimutamenti politici, all’alternanza di modellieconomici (dall’ economia prevalentementeagricola e manifatturiera all’economiaindustriale e poi all’economiatecnologicamente evoluta) , ai rivolgimentidella struttura sociale (dalla divisioni inclassi ella formazione di una uniforme classepiccolo borghese, alle nuove povertà e allenuove ricchezze) e si connettono a questi
1
fattori esterni i mutamenti avvenutiall’interno del mondo del diritto - gliindirizzi metodologici, le svolteinterpretative, le battaglie di idee - sitratta di un secolo breve. Non è semplicestabilire se si sia trattata di unaconnessione di eventi in cui il diritto hafinito per registrare gli influssi provenientidall’esterno, quasi la reazione che siproduce in una polla di acqua ferma quando lesi versa dentro del liquido , o piuttosto diuna processo osmotico in cui le strutture, leforme, le tecniche e soprattutto i valori deldiritto si sono adattate ai, o hanno avutoeffetto propulsivo sui fattori economici esociali.
. Un secolo , per riprendere la felice
espressione felice di Eric Hobsbawn, che oggici appare breve e compiuto, intenso ediscontinuo, avido di novità e provvido diidee, ancorato ad un passato che celaval’incertezza sotto lo schermo dell’entusiasmo per la ricostruzione, la voglia diredenzione, la ricostruzione dei valoriannichiliti , soffocati o sommersi dalletargo della dittatura e consacrati neltesto della Costituzione repubblicana.Costituzione incompiuta e forse tradita – sesi vuol condividere la cruda analisi di PieroCalamandrei – e tuttavia portatrice di libertà
2
e di garanzie, di diritti e di doveri,soprattutto di solidarietà e quindi di unità.
Nel corso di questo convegno sarannoapprofondite tutte le tematiche in cui siarticola per convenzione ormai solo accademicail diritto “privato” . Il compito che ci èstato imposto dagli organizzatori (che peraltroringrazio per avermi offerto questa occasione diriflessione) si rivela impervio : disegnarecioè quasi una storia dell’intera materia dallasua nuova codificazione .
In questi ultimi anni si sono succedute molteanalisi degli indirizzi, delle svolte, delleprospettive del diritto privato: analisi che siaffidano sia alle indagini degli orientamentiideologici (Nivarra) oppure alle fonti storiche(Vacca) o alla decifrazione della complessitàdel sistema (Macario e Miletti) o alla vicendadelle libertà e della tutela della persona (chesegnano il diritto privato nella società modernadescritto da Rodotà) o alla collocazione deldiritto civile nell’ambito della evoluzionedelle scienze giuridiche (Ferrajoli, Grossi) oal mutamento delle fonti e alla perdita dirilevanza del codice civile , del dirittostatuale, della sovranità(Lipari, Irti,Gentili), nel travolgente urto dellaglobalizzazione e nell’imperante edomnicomprensiva forza del mercato (Galgano,Macario e Lobuono).Si è ormai consolidato il
3
diritto della post-modernità (Grossi, Scalisi) ,di cui è difficile conservare l’impiantoassiologico (Falzea) e preoccupante decretarnela dissoluzione quasi nichilistica (Irti).
Se si ricollega questo discorso alla formadi codice appaiono del tutto convincenti leparole con cui Pietro Rescigno ha presentato unnuovo, importante trattato composto di moltitomi sul contratto in generale sui contrattispeciali e sulle categorie di contratti ,curato dallo stesso A (. in collaborazione conEnrico Gabrielli XXXXXXXXX<Dobbiamo ritenere che la forma di codice ha lasua attualità, soprattutto nei settori – equello dei contratti è certamente il piùimportante- in cui un regime uniforme è non solopossibile ed auspicabile, ma è tecnicamentesuscettibile di realizzazione>(p.LII).
Ma dobbiamo ora riproporci un problema alquale , vent’anni fa Natalino Irti ( I conquant’annidel codice civile, Atti del convegno di Milano 4-6 giugno 1992,Milano, 1993, t.I,p. 442 ) aveva dato unasoluzione tranquillante: aggiungo alle sueparole solo un punto interrogativo: < ilcodice civile ci appare come la base più stabilidella nostra convivenza>?
A questo interrogativo darò una risposta allafine della relazione.
Avendo già a suo tempo consumato il tentativodi delineare una sorta di disegno storico deldiritto civile compreso tra la codificazione
4
napoleonica e gli albori del nuovo millennio,penso che per aggiungere un ulteriore tasselloal percorso tracciato la scelta più acconciaper assolvere il compito assegnatomi debbaispirarsi a due obiettivi: anziché svolgere undiscorso onnicomprensivo, trattare piuttosto untema più circoscritto, ma non per questo menosignificativo; e anziché affidarsi allecampiture generalizzanti che - per limiti ditempo e di spazio - finirebbero per dare aditoalla enunciazione di assunti apodittici ,studiarsi di porre gli interrogativi piùsollecitanti. In fin dei conti, restringendol’angolo visuale , non si perde di vista loscopo della trattazione, ma si riesce a fare unaricognizione più approfondita della situazioneesistente alla luce del suo passato.
Il settore prescelto è quello delcontratto: non la disciplina delleobbligazioni in generale, anche se laseparazione di questo istituto dalle altrefonti delle obbligazioni è di natura piùpratica che reale; non i singoli contratti,anche se parte generale e parte speciale nonpossono essere separate se non - ancora unvolta – per ragioni di carattere pratico;delcontratto e non del negozio giuridico, anche se ilconnubio contratto-negozio èindissolubile,perché fa parte di una sorta diepopea che ha visto dialogare e configgere tra
5
loro protagonisti insigni del diritto civile,del diritto romano, della storia del dirittoitaliano, del diritto comparato e delle altrepartizioni del diritto che hanno subìto,assimilato, rivisitato l’influsso dellaPandettistica.
2. Le stagioni del diritto privato e le stagioni del contratto
A prima vista le stagioni del contrattoseguono, anziché anticipare, le stagioni deldiritto privato . Il diritto di famiglia èstato rivoluzionato dalla riforma che haintrodotto il divorzio nel 1970, poi dallariforma generale del 1975, poi dalladisciplina dell’aborto, ora dalla disciplinadella procreazione assistita , edell’affidamento condiviso e si è aprta ladiscussione sui patti di famiglia; il dirittodelle successioni è stato riformato solo inparte , e oggi si propone di modificare ladisciplina della successione legittima, deipatti successori, dei patti di famiglia, deltrust; la proprietà (e in modesta parte idiritti reali minori) ha subìto un vero eproprio smembramento non solo nel suo sistemaconcettuale (nel passaggio dalla proprietàalle proprietà, ma anche nella suaframmentazione, nella trasformazione dalladimensione pubblica a quella privata), per nondire poi dell’ impresa, con l’impatto della
6
disciplina della concorrenza e della riformadelle società. Tutti mutamenti che prendevanoatto delle nuove forme di convivenza e deinuovi valori ad esse sottostanti.
Non è stato così per il contratto: o almenoil cambiamento non si è percepito allostesso modo; la trasformazione non è parsacosì evidente perché il testo di codice haretto l’impatto della Costituzione e delcontrollo di legittimità costituzionale e iltesto del codice, nella sua parte generale, èrimasto pressoché inalterato dal 1942 , se sieccettua la soppressione dei riferimenti all’ordine corporativo (art.1371 c.2) e il capoaggiunto e poi soppresso perché riversato nelcodice del consumo a proposito dei contrattidel consumatore (art.1469 bis). Mentrecospicua è stata la modificazione delladisciplina dei singoli contratti, dellatrascrizione, di singoli aspetti del dirittodelle obbligazioni, e così via, innovazionicomunque esterne, nella ripartizione delcodice, alla disciplina generale delcontratto, ma non ad essa estranee.
Si potrebbe obiettare che l’ordinamentogiuridico deve essere considerato nel suocomplesso, e che il suo sviluppo procede inmodo unitario: il che forse dovrebbe essere,ma ad una considerazione realistica delle cose, non è, e così non è stato. I settori dell’ordinamento si sono evoluti, sono cambiati,hanno postulato un intervento a seconda delle
7
esigenze emergenti di volta in volta dallaconvivenza sociale, a seconda dellacongiuntura politica ed economica, a secondadella alterazione e moltiplicazione dellefonti, a seconda delle mode. Sì, anche lemode, le mode culturali, la circolazione delleidee, la trasposizione, il trapianto, ilconfronto con i modelli stranieri, hanno avutoil loro decisivo influsso nella evoluzionedell’ istituto.
E tuttavia, in questo complesso contesto, illibro IV (e la disciplina del contratto, inparticolare) ha resistito alle mutazioni deltempo: e ciò riprendendo l’analisi di AngeloFalzea, svolta come premessa alla terza sessionedel congresso su I cinquant’anni del codice civile (Atti delconvegno di Milano, 4-6 giugno 2002, Milano, 2003, p.202) , per una triplice ragione: perché ilcodice civile non era un codice fascista, ma ilcodice della tradizione scientifica italiana;per il grado di generalità (ma non digenericità) con cui le sue norme sono stateformulate; per i principi generali che essoesprime, tali da superare l’impatto dellaCostituzione, delle leggi speciali e del dirittocomunitario.
Lo spicchio dell’esperienza secolare che mipropongo di illustrare allora non è nétroppo angusto e né troppo scontato, comedimostrano le grandi campiture che si sonotante volte tracciate in occasione di studi
8
celebrativi di maestri del diritto civile odi eventi epocali, della pubblicazione ditrattati o di mise à jour dettate da esigenzescientifiche o editoriali (Rescigno, Breccia,Scalisi, Del Prato,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ed infatti nella storia della disciplinadel contratto dal codice del 1942 ad oggi siriscontrano alcune delle vicende più vivaciche hanno contrassegnato l’evoluzione dellacultura giuridica del Novecento, si passanoin rassegna alcune delle opere più importantidella produzione giuridica, si individuanoluoghi che furono teatro della speculazionepiù alta e della manipolazione più raffinata.
Quel mondo, visto con gli occhi del nuovomillennio e in una prospettiva eurocentrica eglobalizzata , sembra distante non decenni masecoli , appare una esperienza ormaiconsumata, e chi la rivisita percepisce unlinguaggio, concetti e categorie ordinanti,meccanismi tecnici e forme espressive non piùcollimanti con il linguaggio, i concetti, lecategorie, i meccanismi tecnici , le formeespressive che sono propri del dirittocomunitario e del diritto europeo, e tanto
9
meno del diritto globale espresso dalla nuovalex mercatoria.
In altri termini, ci stiamo muovendo tra lequinte di un teatro, tra le sale di un museo,che racchiudono un mondo di valori che sivorrebbe preservare nel tempo, e tuttavia lavita, l’esperienza , i rapporti sembrano averpreso un’altra strada, adattandosi ad altriluoghi, sì che finiscono per riflettere solopallide vestigia di quel mondo ormai passato.
Quel mondo si è costruito lentamente sullabase di vicende che si possono ricostruire, inquesta sede, solo per cenni.
Individuate un po’ arbitrariamente , esseriguardano :
- il consolidamento delle categorieconcettuali riflesse dal codice; le tavolesacrali sono contenute nelle Dottrine generalidel diritto civile di Francesco Santoro-Passarelli e negli Istituti di diritto civile diSalvatore Pugliatti;
- l’opera sistematica di Emilio Betti eRenato Scognamiglio nelle rispettiveconcezioni del Negozio giuridico;
- il passaggio dalla concezione delcontratto come atto volitivo a quello diatto normativo ;
- l’accettazione della etero integrazionerispetto all’autointegrazione;
10
- la oggettivazione del contratto seguitaalla sua commercializzazione,
- l’apporto della comparazione,significativamente descritto nell’operamiliare di Gino Gorla;
- la scoperta delle clausole generali in cuimassimamente si è avvertita l’ansia dirinnovamento dell’interpretazione dellenorme di codice e della loro applicazioneagli atti di autonomia privata;
- la dubbia e comunque debolecostituzionalizzazione del contratto
- la identificazione dei valori e lapreminenza della persona in ogni rapportopubblico e privato (Mengoni);
- l’affermarsi dell’eteronomia, delladominanza dell’interesse pubblico, delcontrollo sociale delle attività private;
- la scoperta della disparità delle particontraenti, del contraente debole, deimezzi negoziali propri della produzione dimassa;
- l’uso alternativo del diritto el’interpretazione ideologica degliistituti del diritto privato;
- la decodificazione e la frammentazionedell’ ordinamento in una massa brulicantedi leggi speciali ( incidenti soprattuttoil contratto, oltre che gli enti nonlucrativi);
- la riscoperta dell’analisi economica deldiritto , la concezione del contratto come
11
operazione economica, come tecnica didistribuzione dei rischi, di controllodelle sopravvenienze
- l’esplosione dei contratti atipici, laloro tipizzazione sociale, la loroparziale normazione;
- la rivisitazione dei dogmi , ilsuperamento delle forme, l’introduzionedelle categorie di giustizia/equità;
- l’erompere del diritto comunitario ,l’ingresso di nuovi termini, nuoviconcetti, nuove concezioni, nuovetecniche , nuovi rimedi;
- l’emergere delle figure di professionistae consumatore, delle nuove classificazionedei contratti, tra contratti deiconsumatorie e contratti d’impresa;
- il consolidarsi del contratto comestrumento privilegiato dal mercato per laallocazione di beni , servizi, capitali;
- l’introduzione dei codici di settore,nuove epifanie della decodificazione;
- l’imporsi di nuove fonti e quindi di nuovimodi di pensare il contratto (i contrattid’impresa, il “terzo contratto” , ilcontratto “amministrato”)
- i nuovi principi comunitari, le nuoveclausole generali, i nuovi attori delmercato: la proporzionalità, lasussidiarietà, la ragionevolezza, latrasparenza, la completezza;
12
- l’incidenza delle tecnologie informatiche,telematiche, biomediche e dei nuovirapporti familiari e sociali
- la globalizzazione e la lex mercatoria eil contratto “alieno” (De Nova)
- l’europeizzazione del contratto el’armonizzazione dei principi , i modelliuniformi, le clausole uniformi, letecniche uniformi di redazione (Lipari,Mazzamuto, Castronovo, Vettori, Roppo,Alpa e Andenas);
- per concludere con la stagione dei dirittifondamentali e dei nuovi limitiall’autonomia privata
.3. Continuità e sistematizzazione (1942-1950)
Nei primi anni del dopoguerra si era discussose procedere ad una nuova codificazione oppureconservare quella vigente con le debitemodificazioni : il dibattito tra Lorenzo Mossa,favorevole ad una moderna concezione del dirittoprivato e Giuseppe Ferri, timoroso di unrifacimento integrale dell’intero edificio chesi sarebbe potuto rivelare tecnicamente pocoaffidabile , si concluse rapidamente a favoredella conservazione. Non si tenne conto, comegià fecero i redattori degli anni Trenta, delCodice italo-francese delle obbligazioni (1927),oggi ormai ignorato dai Colleghi d’Oltralpe epoco evocato anche dagli studiosicontemporanei. Ci si affidò all’interpretazione
13
adeguatrice, all’interpretazione evolutiva,all’interpretazione suppletiva dell’interventolegislativo.
Certamente si registra una continuitàrispetto alla metodologia consolidatasianteriormente al codice del 1942. L’ imperio delformalismo che avevano assistito i codificatoricontinuò a dominare gli interpreti nei primilustri della applicazione del nuovo codice. Puòessere comprensibile che dal 1943 al 1948 sidovessero innanzitutto capire le novità – cheerano molteplici (v. Rescigno, Introduzione al codicecivile, VII ed., Roma-Bari, 2001)- portate dal nuovocodice e la loro organizzazione in sistema e chein pochi anni non si potessero capovolgere gliindirizzi metodologici sperimentati con tantaraffinatezza negli anni Venti e Trenta.Altrettanto comprensibile l’ indifferenza versola Costituzione- che pure avrebbe costituito laprima tavola di valori sui quali il dirittocivile si sarebbe rimodellato due decenni dopo-posto che la concezione diffusa separava ildiritto privato dal diritto pubblico (anche senon mancavano voci di dissenso: v. Pugliatti,
XXXXXXXXXXXXXXXnel quale veniva confinata la Cartacostituzionale e l’autonomia privata tendeva adessere considerata come una riconquista dellalibertà dei privati rispetto ad uno Stato e a dun legislatore totalitario e intrusivo ( sulpunto v. Passerin d’Entreves, Il diritto dei privati,
14
Il negozio giuridico, 1934, e la rievocazione diNatalino Irti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E la mia rievocazione di quella fase dellanostra cultura
XXXXXXXXXXXXXX
4. Primi fermenti culturali (1950-1960)
E tuttavia, già negli anni Cinquanta siavvertono i primi germogli della nuova scienza ,i primi fervori del rinnovamento. Il discorso ètutto interno alla elaborazione teorica deldiritto privato e del diritto contrattuale , inparticolare.
La giurisprudenza non è ancora considerata unafonte del diritto, ma solo la sua applicazionepratica, ed è confinata una sorta diappendice , che come una corolla, circondasbiaditamente il cuore vitale pieno di linfa edi colori costituito dalla scienza giuridica“ufficiale”, cioè della attività culturaleaccademica.
Negli anni Cinquanta il contratto è studiatosoprattutto come “costola” della categoriagenerale del negozio giuridico, e quindi leelaborazioni dottrinali trovano il loro alveonaturale nei commentari al codice civile, postoche il negozio, pur costituendo il substrato diquella normativa e occhieggiando qua e là trauna norma e l’altra, non era stato oggetto dinormazione dettagliata come era avvenuto nel
15
B.G.B. quarant’anni prima. Ma la teorizzazionedel negozio giuridico degli anni Cinquanta non èuna fotocopia o un semplice ammodernamento delleteorie pandettisti che.
Avvalendosi della metodologia inaugurata daAngelo Falzea (Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici,Milano, 1939) Renato Scognamiglio introduce ilnegozio nel novero dei fenomeni giuridici ,considerandolo come concetto empirico, chetrascende le norme di codice , che non siconchiude in una prospettiva strutturale, cheinvece assume una fisionomia prettamentedinamica e quindi si distacca dalla concezionebettiana incentrata sulla fattispecie coneffetti negoziali; una impostazione pragmatica,di autoregolamento di privati interessi, di autoresponsabilità. Una concezione quindi bendistante da quella di volizione soggettiva chesarà riproposta da Giuseppe Stolfi pochi annidopo . Di qui l’interesse ancora oggi suscitatodall’opera, discussa in un prezioso dibattitoorganizzato dal Consiglio nazionale forense (il2 luglio 2008) con la partecipazione di GiuseppeBenedetti, G.B.Ferri,Giuseppe Guarino, NatalinoIrti e Pietro Rescigno (e v. la recensionedella ristampa del 2008, seguita alla secondaedizione del 1969 compitata da E.Quadri,inRiv.dir.civ., 2009, p. 385),
Negli stessi anni in cui veniva ristampata laprima edizione del Contributo alla teoria del negoziogiuridico di Renato Scognamiglio apparivano i duevolumi de Il contratto di Gino Gorla. La
16
prospettiva ideata da Gorla, anticipata nellesue lezioni all’ Università di Alessandriad’Egitto , era un capovolgimento dellacostruzione dogmatica del contratto fino adallora imperante. E’ pur vero che con larivisitazione di Scognamiglio la teoria delnegozio si era di molto avvicinata alla concretavalutazione delle questioni proprie delleanalisi del contratto, ma è anche vero che Gorladiede ingresso ad un nuovo modo di concepirel’esperienza giuridica .
I suoi saggi sul potere della volontà nellapromessa come negozio (1956), sulla causa delladonazione, etc., ne sono una testimonianzaindelebile, anche se le innovazioni non ebberouna accoglienza convinta e corale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gli anni Cinquanta esprimono ancora l’esigenzadi consolidare il nuovo testo codicistico euniformarne l’interpretazione formale. Ma anchedi scoprirne la sua estensione applicativa:Ascarelli si dedica ai rapporti tra inesistenzae nullità, Betti indaga i rapporti contrattualidi fatto (1956), Mengoni la natura dellaresponsabilità contrattuale, Auletta i rapportitra domanda di risoluzione e domanda diadempimento , Satta il rapporto tra volontàprivata e sentenza del giudice.
17
Intenso è il dibattito giurisprudenzialesull’apparenza del diritto e sull’affidamentoragionevole, anche in questo caso coniugandosil’aspetto dogmatico dell’interpretazione conquello pragmatico della applicazione di regolefunzionali al traffico giuridico. Sono gli anniin cui Pietro Rescigno studia l’accollo,Schlesinger l’adempimento del terzo e ladelegazione di pagamento, e grande attenzionericevono i contratti per adesione – di cui ci sichiede se costituiscano un fenomeno sociale ouna categoria giuridica (Genovese, 1959) ; sidà particolare rilievo alle nuove figurecontrattuali codificate come il contrattopreliminare e il contratto per persona danominare. Comincia ad emergere qualche dubbiosulla radicale distinzione tra causa e motivi, esulla irrilevanza delle ragioni che hannoindotto le parti a concludere il contratto,venendo in emersione la figura dellapresupposizione (Martorano, 1959). E si delineala scomposizione tra intento volitivo e intentopratico negli studi sulla simulazione (Ferrara)e sulla rappresentanza (Pugliatti).
Il negozio giuridico tiene ancora testa nellericerche dei giuristi,e non solo tra i cultoridel diritto positivo: Biagio De Giovannipubblica Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico(1958) e Francesco Calasso la sua opera storicainsigne (1960); il filosofo Luigi Bagolini sidedica allo studio della norma tra negozio eparadigma, criticando la posizione kelseniana.
18
Quasi contemporaneamente sono edite da Utet laterza edizione del Digesto (ora Novissimo) e daGiuffré l’ Enciclopedia del diritto. Rosario Nicolò,con la voce Alea, caratterizza il il metodoponderoso e colto di quest’ultima impresaeditoriale. Adempimento (Nicolò,1958) einadempimento (Giorgianni, 1960) sono gliistituti centrali del contratto sui quali siincentra l’attenzione della dottrina, insiemecon l’analisi delle clausole tipiche.
La causa del contratto come funzioneeconomico-sociale teorizzata da Emilio Betti edaccolta uniformemente dalla giurisprudenzacampeggia tra le voci del Novissimo Digesto (1957) ead essa rispondono Giorgianni e Gorla (in temadi consideration) sull’ Enciclopedia del diritto.
5. Esperimenti metodologici (1960-1970)
Gli anni 1960-1961 sembrano segnare iltornante in cui la dottrina, senza abbandonarela teoria del negozio giuridico, si converte astudiare il contratto come categoria generale:proprio in questo frangente , accanto all’operadi Giuseppe Stolfi (Teoria del negozio giuridico,Padova, 1961) che riprende l’augusta tradizionepandettistica ma non se ne sa distaccare , eguarda quindi più al passato che al futuro,pretendendo di proiettarne l’ombra su di unmondo ormai volto alle finalità pragmatiche edefficienti dell’operazione economica compaiono
19
la voce Contratto di Giuseppe Osti (Novissimo Digesto,1957) , la voce Contratto:teoria generale diFrancesco Messineo (Enciclopedia del diritto, 1961), eil volume sui Contratti in genere di RenatoScognamiglio nel Trattato di diritto civilediretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santorio-Passarelli (Milano, 1961).
Nel contempo affiorano le clausole generali:la buona fede e la correttezza, in particolare.Alla buona fede dedica pagine poco convinteSalvatore Romano (Enc.dir. ) mentre ben piùconsistenti sono le considerazioni di Ugo Natoliespresse nella concezione de L’attuazione del rapportoobbligatorio.Appunti dalle lezioni (1961-1962)
Si segnala, in una letteratura “alta” , ilcontributo di Arturo Dalmartello su I contratti delleimprese commerciali (Padova,1962) , che riprende unaprospettiva inaugurata da Enrico Redenti (Deicontratti nella pratica commerciale.Parte Prima. Dei contratti ingenerale, rist., Padova,1933) ma con obiettividiversi: Redenti, con spirito arguto e con pianaesposizione, si studiava di esporre il dirittodei contratti agli operatori economici, alleparti che intendevano concludere un contratto inmodo serio, sapendo che a quella operazionel’ordinamento avrebbe attribuito un significatogiuridico e collegato effetti che sarebberoricaduti nella sfera giuridica dei paciscenti;Redenti operava in un contesto diverso, cioènella vigenza di un ordinamento ancora divisotra codice civile e codice di commercio. Percontro, Dalmartello
20
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE da allora la distinzione è rimasta intatta,
quasi che l’unificazione dei codici e lacommercializzazione del diritto civile nonavesse poi richiuso le acque sopra laseparazione dei due settori: come si vedrà,ancora di recente si è tornati a discutere suicontratti d’impresa, anche se ora si preferiscedistinguere tra contratti conclusi tra impresee contratti conclusi tra imprese e consumatori.
Il negozio giuridico torna all’attenzione inpagine pensose di Betti (Temi, 1963) e nellarimeditazione del negozio fiduciario –a cuiCesare Grassetti e Salvatore Pugliatti avevanodedicato studi miliari negli anni Trenta eQuaranta – proposta da Nicola Lipari (1964)
La dichiarazione è studiata in due diverseprospettive da Piero Schlesinger e da GiorgioGiampiccolo (ad voces, Enciclopedia del diritto, 1964)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E finalmente le clausole generali eromponosulla scena: la buona fede , nella fase dellatrattativa (Benatti, La responsabilità precontrattuale,1963), come regola di comportamento ( Rodotà,Appunti sul principio di buona fede , in Foro pad., 1964, I,1283; Il principio di correttezza e la vigenza dell’art.1175 c.c.,in Banca,borsa,tit.cred., 1965,I,149 ), come criterioorientativo dell’interprete nell’apprezzamentodella responsabilità contrattuale (Bianca,
21
Riv.dir.civ., 1964,I, 478) e della cooperazione delcreditore all’adempimento (Cattaneo, 1964)
L’errore – nel negozio giuridico ( rivisitato daBetti nella voce sul Novissimo del 1965) – vededue concezioni contrapposte: quella di PietroBarcellona e quella di Vittorino Pietrobon(1963). Ma la teoria del negozio è ancorafiorente: Irti, sul negozio parziario, Auricchiosul negozio indiretto , Corrado sul negozio diaccertamento, Schlesinger sull’unità delnegozio, Sacco su contratto e negozio aformazione bilaterale, ne riprendonocriticamente la teoria generale (1965).Pugliatti, forte del suo metodoantiformalistico, raccoglie i suoi Studi sullarappresentanza, Milano, 1965
Il realismo sembra regnare ora nell’accademia:Rodolfo Sacco spiega come il contratto “atipico”non abbi amai fatto ingresso in un’aula ditribunale, atteso che le tecniche diassimilazione, assorbimento e di prevalenzautilizzate dai giudici riducono l’autonomiaprivata negli schemi adusi delle sceltelegislative tipiche (Riv.trim.dir.proc.civ., 1966, 785) eGino Gorla ( Offerta ad incertam personam, Foro it.,1965,I,433) – il quale nel frattempo avevainiziato la sua insuperata teorizzazione dellainterpretazione delle sentenze e delle tecnicheconsigliate per la loro corretta e fruttuosaannotazione – descrive il tramonto dell’
22
incontro dei consensi e la “logica-illogica” delconsensualismo (Riv.dir.civ., 1966,I, 255)
Le clausole generali - che, per riprendere iltitolo di un saggio di Stefano Rodotà, hanno illoro tempo per ogni periodo considerato – sonouno strumento di controllo del comportamentodelle parti, ma anche dell’operazione in sé, edella sua conformità ai valori e ai principidell’ordinamento: la libertà contrattuale non èassoluta e si inizia a discutere di limiti,imposti dall’interesse pubblico e quindi dallacollocazione dell’atto dei privati nel suocontesto normativo (Barcellona, Sui controlli dellalibertà contrattuale ,in Riv.dir.civ., 1965,II, 580).
In questa prospettiva si collocano gli studisu determinati aspetti del diritto contrattualedelle scuole romane di Santoro–Passarelli e diRosario Nicolò : Antonino Cataudella scrive Sulcontenuto del contratto (1966), G.B.Ferri su Causa e tiponella teoria del negozio giuridico (1966), Di Majo,L’esecuzione del contratto (1967), Vitucci, I profili dellaconclusione del contratto (1968) Rodotà, Le fonti diintegrazione del contratto (1969), Bessone , Adempimentoe rischio contrattuale, (1969),Gazzoni, Equità e autonomiaprivata, 1970; Irti, La ripetizione del negozio giuridico(1970), Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale(1970)
La stagione del negozio giuridico – che puredi tanto in tanto si rinverdirà – sembra
23
conchiudersi nella nuova edizione del Contributodi Renato Scognamiglio (1969), con gli studi diGiorgio Cian su Forma solenne e interpretazione delnegozio (1969)
Insomma, dietro l’ordito di un testo rimastopressoché inalterato dal 1942 in trent’anni sicostruisce una trama di tecnica interpretativeche consente di salvaguardare l’autonomiacontrattuale senza però occluderla ai valoriesterni: essi penetrano mediante le clausolegenerali , le fonti di integrazione, i nuovilimiti dettati dal legislatore.
Il rapporto legge-contratto significa ancora(per la parte generale) codicecivile-volontà/dichiarazione dei privati , ma le regole delcodice sono integralmente rivisitate dalladottrina. Non dalla giurisprudenza ,che ne fauna applicazione pedissequa, posto che lalibertà dell’interprete è sempre considerata dalgiudice come ossequio alla lettera della legge.
Vi sono certo eccezioni: Andrea Torrente, ne Ilgiudice e l’interpretazione,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMa siamo distanti mille miglia dalla
discrezionalità che sarebbe stata teorizzata di lì apoco, nei suoi pregi e nei suoi difetti (sulpunto, diffusamente, v. Bessone e Guastini,Materiali per un corso di analisi giurisprudenziale, Padova,1994; Alpa, L’arte di giudicare, Roma-Bari, 1996).
Il decennio degli anni Sessanta registra laripresa economica del Paese, ma anche l’ avviodell’intervento pubblico nell’economia più
24
decisivo e determinante: si parla infatticorrentemente di economia mista, ed il suo perno èdato dall’art. 41 Cost. (specie il secondo e ilterzo comma). La disciplina della concorrenza,nonostante sia stata lumeggiata da TullioAscarelli con tanta acutezza, non ha ancoraattinto il mercato italiano in modo per cosìdire costituzionale. La continuità dello Statofascista , dal punto di vista dellaorganizzazione dell’apparato amministrativo edella concezione del mercato (depurato,naturalmente, dalle venature corporative) è undato di fatto di cui pochi percepiscono larealtà (v. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna,
XXXXXXXNé si può dire che nei primi decenni
l’applicazione della normativa costituzionaleabbia dato frutti succosi: innanzitutto perché irapporti tra privati hanno subìto unacostituzionalizzazione “debole”, e poi perché ilcontratto, in sé e per sé, non è considerato daipiù – direi dalla quasi totalità – l’espressionedella libertà della persona , ma come un mezzodi realizzazione di attività economiche, sicchél’istituto cade nella sfera di applicazionedell’art. 41 secondo comma o eventualmente sottoil terzo comma ( che legittima nazionalizzazionie programmazione), ma rimane impenetrabile daaltri punti di vista.
Mi spiego: non è l’ istituto che consente diper sé la inclusione dei valori costituzionali,ma la sua disciplina e i limiti (costituzionali)
25
alla libertà dei privati che realizzano questoobiettivo. Costituzionalizzare il contrattointendendolo come espressione della personalitàumana avrebbe comportato la sua impenetrabilitàda parte del legislatore speciale e quindil’impossibilità di mantenere in vita lalegislazione vincolistica delle locazioni urbanee dei contratti agrari, le garanzie deilavoratori, e così via. Per contro, incidere sulsuo contenuto, come una forma di controllo diadeguatezza dell’accordo ai valoricostituzionali , non era ancora un obiettivo deiteorici del diritto né dei pratici – avvocati ogiudici che fossero.
La giurisprudenza della Corte costituzionalein materia di contratto in generale è del tuttoasfittica ,e per i contratti speciali è tuttapiegata sull’art.41 Cost. nel senso dellalegittimazione dei poteri limitativi dellegislatore, in materia di prezzi,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La disciplina del contratto divieneemblematica anche per quanti ritengono che ildiritto non debba solo tradurre in terminiformali l’operazione economica, ma si possaspingere fino a promuovere l’economia e irapporti sociali : le trasformazioni subitenella realtà dal principio del consensotraslativo (Bianca, Riflessioni sul principio del consenso
26
traslativo, in Riv.dir.civ., 1969,I, 535) sono un esempiodi come la legge possa introdurre elementi digiustizia anche in una realtà socioeconomicache vorrebbe sottrarsi ad essi: le pagine diMengoni su Forma giuridica e materia economica (in Studiin onore di Asquini, III, Padova, 1965, p. 1077 ss.)teorizzano il riscatto del diritto dall’economia.
Sono sempre gli anni Sessanta a segnare inuovi confini del diritto privato, registrandol’intervento dello Stato che con la legislazionespeciale limita l’autonomia privata al fine diproteggere gli interessi deboli anche attraversole forme giuridiche più tecnicamente raffinate,come il tipo contrattuale (Michele Giorgianni nefarà oggetto di un saggio memorabile concernentei contratti agrari, intitolato Il diritto privato e i suoiattuali confini, 1961; e v. Pinelli, Michele Giorgianni e iconfini del diritto privato, in Riv.crit.dir.priv. 2006).
Il decennio che si racchiude negli anniSessanta è forse quello più rigoglioso nellacreazione di nuovi indirizzi formalistici cheintendono ammodernare il diritto civile, senzaalterarne la sua compattezza sistematica.L’intervento del legislatore limitativodell’autonomia privata non è interpretato comeuna compressione delle libertà individuali ocollettive ma come un sostegno ad esse nellacomposizione degli interessi in gioco. Maproprio per questo servono regole più elastiche,
27
principi e non codici: la prolusione di StefanoRodotà su Ideologie e tecniche del diritto privato (1967)vuol appunto affrancare il diritto civile dalcodice civile.
E Pietro Rescigno propone una rilettura delcodice alla luce delle disposizionicostituzionali:
Giur.it 1968XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La fine degli anni Sessanta e l’inizio deglianni Settanta segnano un’ altra svolta neglistudi del diritto contrattuale, sicché sembradavvero rivolto al passato e non al presente ilpoderoso lavoro di Francesco Messineo, Il contrattoin genere, 1968, in cui il Maestro raccoglie isaggi e le voci via via elaborati nel tempo.Negli anni Settanta è tangibile l’incidenza delsistema economico e delle nuove forme diaggregazione sociale sulla concezione delcontratto e sulle sue molteplici funzioni.
Le forme giuridiche non risolvono più, di persé, i problemi che il giurista deve affrontare.
6. Politica, economia, dimensione sociale del “privato” (1970-1980)
Sono gli anni Settanta a disegnare una nuovasvolta del diritto privato, e con essa anche deldiritto dei contratti. L’interpretazioneideologica del diritto, le formule magiche della
28
scienza giuridica, l’uso alternativo del dirittosono tutte espressioni forti che voglionoproprio sottolineare come il giurista debba – sevuole essere all’altezza della suaresponsabilità sociale – rompere con gli schemidel passato, ridestarsi dal sonno dogmatico,inventare nuovi modi di risolvere il conflittosociale per raggiungere nuove sfere digiustizia.
Francesco Santoro-Passarelli rinnova laconcezione del contratto con acute noteintitolate Variazioni sul contratto (Riv.trim.dir.proc.civ.,1970,1). Muovendo dalla considerazione che ladisciplina del contratto deve essere collocatanel contesto di un sistema retto ad economiamista, il Maestro aggiunge un capitolo alleDottrine generali del diritto civile, perché registral’oggettivazione del contratto avvenuta con lanuova codificazione in quanto “il conflitto tradivergenti volontà dei contraenti va risoltoalla stregua della misura in cui meritano tutelagli interessi in contrasto e , a criteriodiscriminante, s’assume l’idoneità oggettiva delcomportamento del dichiarante ad ingenerare unaffidamento nella controparte” (p.4). Ma glianni Settanta registrano anche un processoevolutivo dettato dalle “trasformazioni impostedal rapido e spesso turbinoso evolversi dellarealtà economica e sociale”, di cui èprotagonista l’ impresa. Il suo potere economicosuscita la contrapposizione degli individui chevengono a contatto con essa, sia nella loro
29
qualità di consumatori sia nella loro qualità dilavoratori. L’A. vede dunque nel comportamentocontrattuale dell’imprenditore l’espressione diun potere normativo che si risolve nellaformulazione di contratti di adesione imposti aiconsumatori e nella redazione di regolamentid’impresa imposti ai lavoratori. L’ordinamentonon legittima integralmente l’esercizio diquesto potere, perché ormai la funzione delcontratto non è più intesa come la realizzazionedi un “qualsiasi serio assetto di interessi trale parti, ma pretende che si tratti di unassetto equo” (p. 8). Le esigenze politichehanno indotto poi lo Stato ad intervenire nelmercato per indirizzare l’autonomia privatasecondo linee di programmazione che si esprimonocon indirizzi vincolanti. Questo programma si èrealizzato mediante il ricorso all’autonomiaprivata, al contratto . Non si può parlare dipubblicizzazione del contratto , né difunzionalizzazione del contratto, ma diadattamento del contratto alle senza che ne siaalterata la sua struttura. Il potere chel’individuo ha perso a livello personale vienetuttavia recuperato a livello collettivo.
L’impiego dei criteri economici invita anche ariflettere sulla opportunità di ricorrere allaresponsabilità oggettiva anziché allaresponsabilità fondata sulla colpa quantoinadempiente è l’imprenditore: ciò sia neirapporti tra imprese, sia – e a maggior ragione– nei rapporti con i consumatori (P.Trimarchi,
30
Sul significato economico dei criteri di responsabilitàcontrattuale, Riv.trim.dir.proc.civ., 1970, 512).<Laresponsabilità contrattuale deve essere regolatatenendo presente l’opportunità di spingerecreditore e debitore ad adottare unacombinazione di misure di diligenza che siaottima dal punto di vista dell’ economiagenerale>(p.514). Il debitore può megliocontrollare il rischio, adottare misure idoneead evitare il danno, ed il criterio del rischioopera meglio del criterio della colpatradizionalmente applicato dai giudici; i costidi funzionamento del criterio della colpa sonosuperiori a quelli del rischio.
Si impone anche una revisione del lessicogiuridico, dal momento che, anche gli esponentidel formalismo giuridico avvertono che, adistanza di trent’anni dalla nuovacodificazione, la definizione di contrattorestituita dal codice non soddisfa né ipostulati di una rigorosa ricostruzionedogmatica dell’istituto né offre gli strumentiper dare risposta a tutti i problemi cheemergono dalla realtà vivente: mutuo consenso econtratti estintivi sono l’esempio utilizzato daLuigi Ferri per contestare il linguaggio delcodice civile (Definizione giuridica e significato dicontratto. La parola come limite all’arbitrarietà dei concettigiuridici, in Giur.it., 1970, IV, 25), ma anche perstoricizzarlo, riprendendo una possibileequiparazione lessicale tra il termine contrattoimpiegato nel codice civile e il termine
31
convention del Code Napoléon e respingendo ogniaffinità con il concetto di contractus provenientedall’esperienza romana , con la quale non si puòistituire alcuna continuità e criticando dunquele tesi degli “attualisti” di cui in quegli annidi era fatto corifeo Giuseppe Grosso (Divagazioni diun romanista sulla dottrina generale del contratto, inRiv.trim.dir.proc.civ.,1963, p. 469 ), in opposizionealla tradizione storicistica del dirittoromano : mi piace ricordare le pagineilluminanti di Pietro Bonfante, Il contratto e i patti,in Riv. dir. comm., 1920, I, 353 (oltre chequelle affascinanti di Riccardo Orestano,Introduzione allo studio storico del diritto romano,Bologna,1987; sulle vicende storiche del patto edel contratto è sempre utile riferirsi aBirocchi, Causa e categoria generale del contratto, Torino,1997 ; ulteriori informazioni in Alpa,Definizionecodicistica di contratto e vinculum iuris, in Materiali per lastoria della cultura giuridica, 1990, p. 152;Birocchi,Notazioni sul contratto, in Quaderni fiorentini, 1990, 637;Brutti, Storiografia e critica del sistema pandettistico, inQuaderni fiorentini, 1979, p.317 ss.).
Anche le riviste giuridiche sembrano volersottolineare questa svolta: ad esempio, il Foroitaliano che, dalla sua fondazione, scandendo levoci del Repertorio secondo lemmi aggreganti diconcetti e termini ordinanti , aveva assegnatoparticolare rilevanza all’endiadi Obbligazioni econtratti , dal 1971 istituisce la nuova voceContratto in genere: il contratto di separa dalla
32
categoria più generale, riceve linfa non solodall’analisi formale, ma penetra nel contestoeconomico e sociale di cui si innerval’ordinamento. Si registra altresì l’espansionedegli studi sul contratto, con una ricchezza dicontributi, note, saggi, monografie del tuttoinusitata, quasi a dimostrare che di fronte allavarietà di situazioni create dai rapportisociali non solo le regole della responsabilitàcivile sono chiamate a farvi fronte ma anchequelle fondate su di una base negoziale,rimanendo apparentemente ferme le regole suidiritti reali, e, una volta riformate, quellesulla famiglia e sulle successioni. Una simileesplosione di fenomeni culturali si riscontrasoltanto in un altro settore, quello dellapersona, in cui lo status, l’identità, i valoriintrinseci, le modalità di essere e di vivere insocietà divengono uno dei punti di attrazionedella scienza giuridica.
A Catania il fenomeno economico-sociale dellacontrattazione di massa, ormai imponente in unPaese che sta attraversando un rimarchevolesviluppo commerciale e industriale , e quindiabbisogna di strumenti giuridici adeguati allatutela degli interessi in conflitto, si celebrail convegno che innova una stagionestraordinaria. I giuristi non sono insensibiliai rivolgimenti sociali, al mutamento dellamentalità, alle nuove esigenze che emergono
33
dalla società civile: si comincia dal contrattoe , appunto, dalla tutela del contraente debole(Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole-Atti della tavola rotonda tenuta presso l’ Istituto di diritto privatodell’ Università di Catania, 17-18 maggio 1969, Milano,1970), ma si prosegue con la famiglia, con laproprietà, con la responsabilità civile e in uncontesto globale con il nuovo diritto privato (Il diritto privato nella società moderna, a cura di S.Rodotà,Bologna, 1971; P.Barcellona, Diritto privato e processoeconomico, Napoli,1973), con nuove tecniche diinsegnamento (Diritto privato. Una ricerca perl’insegnamento, a cura di N.Lipari, Bari, 1974), edi analisi arricchite dalla prospettivaeconomica del diritto .
<Oltre che sui modi di rendere più efficientela macchina giudiziaria i giuristi comincianoad interrogarsi sul significato attuale delproprio ruolo e sul valore degli strumenti (lenorme) a cui sono addetti: in particolarevengono in discussione sia l’ideologia del ceto,sia la funzione di legittimazione del poteresolitamente svolta o assegnata alla scienzagiuridica> (Barcellona, L’uso alternativo deldiritto.I.Scienza giuridica e analisi marxista, Roma-Bari,1973). Temi che sono trattati con straordinarioimpegno intellettuale , con varietà di vedute eampiezza di discussione nell’incontro di studiosvoltosi a Catania il 15-17 maggio 1972. Non ènecessario ricodificare, non è necessariolegiferare, è sufficiente saper vedere ereinterpretare il codice sulla base di valori
34
condivisi tendenti alla giustizia sociale. Leregole del contratto sono per così dire“smascherate” là dove predicano una eguaglianzagiuridica che non corrisponde alla eguaglianzadi fatto;l’uso del diritto privato come dirittocomune viene smascherato come impiego deldiritto privato per favorire i privati operatoridi fronte alla pubblica Amministrazione(Galgano, ivi,p.140). L’impiego dellainterpretazione costituzionale delle regole puòessere utile anche se non dirimente, perché ilrapporto di scambio tra parte forte e partedebole del contratto deve essere corretto inaltro modo (Di Majo,ivi, 173).Ma lo studio delletecniche giuridiche in una nuova prospettiva checonsenta il riscatto delle classi socialidisagiate investe tutte le istituzioni deldiritto privato (Lipari, p.37 ss.; e poi Dirittoprivato. Una ricerca per l’insegnamento,Roma-Bari, 1973 ).
Sono anni di grande fermento intellettuale ,ricostruiti con cura nel corso del convegnopalermitano del 7-8 luglio 2006 (Gli anni Settanta deldiritto privato, a cura di Luca Nivarra, Milano, 2008)sotto il profilo del contesto politico, degliistituti del diritto civile e dei “soggettiantagonisti” (i lavoratori, le donne, iconsumatori, i locatari, i giudici). Sono glianni in cui si promuovono riviste impegnate comePolitica del diritto, Quaderni fiorentini per la storia della scienzagiuridica, Democrazia e diritto, ed altre ancora.
Si tende ad edificare un nuovo dirittoprivato, Il diritto privato nella società moderna, come
35
recita il titolo del volume di Stefano Rodotà(Bologna, 1971); un’esperienza culturalerivisitata nel seminario in onore dello stessoRodotà dell’ ottobre 2004, i cui atti sonopubblicati con il medesimo titolo del volumeinnovativo( a cura di Vincenzo Roppo e mia,Napoli, 2005); e si tende ad utilizzare glistrumenti del diritto privato per realizzare ilcontrollo sociale (Il controllo sociale delle attività private,Genova, 1972, Bologna, 1973, a cura diS.Rodotà).
Il contratto e le tipologie societariecostituiscono gli strumenti dell’economiacapitalistica: Galgano scrive appunto Le istituzionidell'economia capitalistica. Società per azioni. Stato e classisociali,(Bologna, 1974) suscitando un ampiodibattito (anche sulla rivista «Sociologia deldiritto», nn. 1 e 2, 1975) e Le istituzionidell’economia di transizione (Bologna,1978).
Ormai la concezione del contratto,l’interpretazione delle regole codicistiche, laloro applicazione giurisprudenziale fuoriesconoprepotentemente dal nesso costrittivodell’esegesi formalistica e dalla dogmaticaconcettosa: questo indirizzo, preparato daglistudi della fine degli anni Sessanta , siafferma senza tema: Giorgianni parla di Crisi delcontratto nella società contemporanea (Riv.dir.agr.,1972,I,3819).
In questo contesto non poteva che deflagrarela categoria del negozio giuridico.
36
Categorie giuridiche e rapporti sociali è appuntol’insegna del rinnovamento e del pensierocritico fondato sulle ideologie sottostanti allecostruzioni della Pandettistica e poi alleelaborazioni dei suoi epigoni( a cura di CesareSalvi, Milano, 1978): la vicenda storica delnegozio giuridico nella nostra cultura, ancorchéla figura non sia stata codificata, è tuttapropria della identità italiana, di matricefrancese nella struttura e di matrice germanicanella concettualizzazione. Più reciso ilgiudizio di Galgano , che ne parla in termini didetrito paleo-capitalistico (in Categorie giuridiche,cit., p. 59 ss.) e de Il problema del negozio giuridico,in Riv trim dir proc civ 1976, 449.
Di qui, di fronte alla scarnificazionedell’istituto , la riflessione più serena ,sdrammatizzante, pragmatica di Ugo Natoli (Indifesa del negozio giuridico, ivi, p.261) e di PietroRescigno (Appunti sull’autonomia negoziale, ivi,p.120), il quale peraltro sottolinea come nelcontesto del conflitto di classe di fineOttocento l’ideologia borghese espressa dalcodice civile tedesco e dalla dottrinapandettistica non trovò nel negozio giuridico lasua più significativa identificazione , quantopiuttosto nelle forme societarie , nei titoli dicredito e nella disciplina della proprietàintellettuale . Anzi, nella sostituzione delcontratto o del rapporto al negozio l’A. vededelinearsi una serie di pericoli , la riduzionedella libertà ad aree che non potrebbero essere
37
coperte dal contratto al sacrificio di interessiche meriterebbero al contrario di esserepromossi. In altri termini, il problema delnegozio giuridico – se di problema di tratta –si risolve nel suo significato storico.
In quel torno d’anni la riflessione sulcontratto è stimolata anche dalla nuovacodificazione civile introdotta dalla RepubblicaDemocratica Tedesca (ZGB), le cui disposizionisul contratto sono commentate da Giorgio De Novae Vincenzo Roppo, e da Pietro Rescigno, chesottolinea come un Paese socialista come laGermania Democratica non aveva sdegnato diavvalersi del negozio giuridico nella disciplinadei rapporti tra privati (Appunti, cit.)
L’ingresso scoperto, massiccio, determinatodelle ideologie, e soprattutto della ideologiamarxista assolve ad una sorta di funzionetaumaturgica. Si percepisce ormaicollettivamente che il diritto non è solo uncomplesso di comandi, che la norma giuridica nonè solo un precetto da analizzare lessicalmente eda tradurre in un ordine concettuale, ma èscelta politica, e quindi racchiude giudizi divalore: giudizi che guidano il legislatore, ilgiudice, l’amministratore. I diritti e gliinteressi appartengono a categorie di individuiche per la prima volta vengono eretti aprotagonisti del mondo giuridico: le donne, ilavoratori, i consumatori, i minori, e così via.<Dal soggetto di diritti alla persona>, dalla
38
fattispecie all’ individuo, dal diritto formaleal diritto “carnale” , un aggettivo che haabbandonato il suo genitore ed è ormai entratanell’uso linguistico dei giuristi (Paolo Grossi,acura di Guido Alpa, Roma-Bari, 2011). Ilgiurista in tutti i suoi ruoli, di legislatore,di giudice, di avvocato, di interprete media iconflitti sociali e si rifiuta di legittimare ilsacrificio dei portatori di interessi deboli (LaTorre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, SoveriaMannelli, 2002).
Ma non si tratta solo di un’ immersione nellainterpretazione ideologica. Gli anni Settantavedono rinnovarsi gli studi sul contrattoeminentemente nel metodo. Ne è prova lastraordinaria ricchezza del volume di RodolfoSacco ( Il contratto, nel Tratt. Vassalli, Torino, 1975,recensito compiutamente da Cian, in Riv.dir.civ.,1977,II,446 ) che, semplificato per un verso eampliato per taluni aspetti con lacollaborazione di Giorgio De Nova vienepubblicato nel Tratt. Di dir.priv. Rescigno, Torino, 1984( e v. la mia recensione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Più che rifarsi ai sistemi dottrinali da cuisono scaturite le disposizioni del codice civilesul contratto Sacco si rivolge all’esperienzastorica, a quella comparatistica eall’esperienza pratica, cioè alla applicazioneeffettiva che quelle disposizioni hanno avuto da
39
parte dei giudici. Il contratto viene intesocome un vincolo acquisito volontariamente madissociando l’assunzione dell’obbligazionedall’acquisto del corrispondente diritto dicredito. Ne nasce una originale trattazione delsistema di conclusione del contratto, unampliamento del numero dei vizi dovuto allacontaminazione tra volontà e comportamento,tradizionalmente distinti, una estensione delconcetto di contratto volto a raccogliere unaserie di fattispecie negoziali nelle quali sicombinano la manifestazione di volontà di unaparte con una corrispondente dichiarazione,oppure un rifiuto, oppure l’esecuzione, e cosìvia. L’attenzione per il principio di atipicitàcorretto dalla affannosa riconduzione di ognicontratto ad un tipo legale da parte del giudiceindica come il metodo giusrealistico di Saccosveli tutte le operazioni, meglio , lemanipolazioni, cui è costretto l’interpretequando deve colmare la distanza tra il testo delcodice e la complessa realtà del dirittovivente.
Nel decennio che corre tra il 1970 e il 1980 sisviluppa anche l’analisi critica del diritto privato,in ripetute occasioni congressuali, esoprattutto con la fondazione di nuove riviste acui già si è fatto cenno (Politica del diritto,Democrazia e diritto, Rivista critica di diritto privato, ilQuadrimestre ) che hanno un taglio dichiaratamenteantidogmatico , aperto alle intersezioni con le
40
altre scienze, sensibili alle istanze economico-sociali, attente ai mutamenti interni e allesollecitazioni che provengono dagli altriordinamenti.
La comparazione si sviluppa in piùdirettrici: analisi di orientamenti, modelli,istituti; importazione di tecniche negoziali edi prassi redazionali; trapianti di regole e disoluzioni. La traduzione di saggi e libri aprela cultura giuridica italiana ad esperienze datempo trascurate, diverse da quell usuali, lafrancese , certamente meno raffinata e profonda,e la tedesca , più elaborata e solida (dallaquale finalmente si affranca).
E’ in questo contesto che si colgono i fruttidel lavoro svolto a Genova sulla basedell’insegnamento di Pietro Trimarchi , StefanoRodotà, Giovanni Tarello. La rivisitazione dellacategoria del contratto muove dalla suaconsiderazione come programma economico delle parti,esposto ai rischi – all’ incertezza della realtà– che ne possono sconvolgere la “basenegoziale”. I contributi di Mario Bessone ( apartire da Adempimento e rischio contrattuale, Milano,1969) e poi di Vincenzo Roppo e miei (raccoltiin Rischio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1982)insieme con gli altri collaboratori della Scuolalanciano nuove sfide alla ricerca di nuoviorizzonti nella concezione del contratto , cuilentamente si adegua la giurisprudenza inmateria di inadempimento, di presupposizione, diinterpretazione, di integrazione. Alcuni di quei
41
saggi appaiono attuali anche agli occhi delgiurista odierno, dedicati come sono all’ equitàcontrattuale (Bessone e Roppo, Equità interpretativa ed“economia” del contratto.Osservazioni sull’art. 1371 del codicecivile, in Giur.it.,1974,IV, 248) alla causa (La causa neisuoi profili attuali.Materiali per una discussione, ora inRischio contrattuale, cit.) come strumento dicontrollo della meritevolezza del contratto e disufficienza dello scambio, all’interpretazioneunitaria del contratto (Alpa,……).
L’interpretazione giuridica si allea allainterpretazione economica, non tanto persottoporre l’operazione conclusa dai privatialle drastiche regole del mercato, quantopiuttosto per rendere compatibili le esigenze digiustizia interne al contratto con le esigenzesociali . L’analisi dei fenomeni recati dallasocietà di massa – la contrattazioneasimmetrica, la diffusione di prodottidifettosi, la pubblicità commerciale, i rischiambientali – sono esaminati alla luce dellecategorie giuridiche codicistiche piegate anuove tecniche interpretative. Al metodogiuseconomico si affianca quello comparatistico,con la capillare informazione sulle novitàprovenienti dal’esperienza anglo-americana,troppo a lungo emarginata dalla culturagiuridica tradizionale. Ma il rapporto strettocon il diritto vivente induce tutti icollaboratori della Scuola genovese apartecipare ad un enorme lavoro di annotazionedelle sentenze, per saggiare da un lato
42
l’utilità delle tesi proposte e dall’altro perverificare nella quotidiana amministrazionedella giustizia la rispondenza dei testinormativi ai problemi posti da una societàsempre più complessa.
I “réportages” della letteratura anglo-americana, affiancati da traduzione di libri esaggi (di Kessler, Horwitz, Friedman,Markesinis, Gilmore, Feinman, Atiyah, Posner,etc.),disseminati sulle riviste o raccolti inantologie fanno germogliare nuove idee sulcontrollo delle condizioni generali dicontratto, sulla concezione della causaconfrontata con la consideration (di cui Gilmore,ne La morte del contratto, trad. a cura di A. Fusaro,Milano, aveva descritto la profonda ,secolare trasformazione) , sugli altri elementiessenziali del contratto (in particolarel’oggetto), sulle forme di conclusione delrapporto, sulle tecniche di clausolazione,sull’uso delle clausole generali come buona fedee correttezza da parte dei giudici a finioccultamente correttivi dell’operazioneeconomica (e v. ora D’Angelo, La buona fede …..
L’attenzione alle tecniche di applicazione deldiritto da parte dei giudici si riversa nellecollane di casi e materiali commentati :l’intersecarsi di dottrina e giurisprudenzadimostra come i due mondi, quello accademico equello magistratuale, possano non solo conviverema dialogare in modo proficuo, alla ricerca
43
della attualità senza indulgere a tentazioniiconoclastiche.
Ma non è solo un complesso di innovazionimetodologiche l’indirizzo che spira da Genova:esso che investe l’intera concezione delcontratto, indagato complessivamente – e forseper la prima volta – anche sotto il profilodelle sue molteplici funzioni e non più soltantocome categoria generale (v. Il contratto in generale,voll…..a cura mia e di Mario Bessone): ilcontratto nelle attività d’impresa, il contrattocome strumento di organizzazione societaria, ilcontratto come strumento di distribuzione dibeni e servizi ai consumatori, il contratto cometecnica di comunicazione informatica, ilcontratto come strumenti di trasferimento dellaproprietà e degli altri diritti reali, ilcontratto come tecnica di dissociazione tra latitolarità e gestione dei beni , il contrattocome tecnica di sanzione, il contratto comestrumenti di investimenti finanziari, ilcontratto come strumento di garanzia, ilcontratto come strumento di risoluzione deiconflitti (Alpa, ivi, t.I, Torino,1991, p. 59ss.; questa poliedricità dell’ istituto è oramessa in chiara luce dal quinto tomo del Trattatosul contratto curato da Vincenzo Roppo, Milano, ……
E’ un invito – anche coraggioso, se posso dire– a non chiudersi nella interpretazione formaledegli istituti, a non esaurire la ricerca entroi confini dell’astratta logica formalistica, anon sopravvalutare le mode di pensiero
44
ideologicamente connotate, e a sfruttare lepotenzialità di adattamento dell’ istituto el’elasticità delle regole ( secondol’insegnamento di Twining, Come fare cose con regole……………… ) per essere all’altezza dellaconcorrenza dei modelli stranieri , in tutte leloro componenti, dottrinali, giudiziali,professionali .
Ma negli anni Settanta cominciano adavvertirsi le crepe del sistema: non solo ilsistema concettuale, ma, più pericolosamente,del sistema giuridico : il quale appunto dasistema diviene ordinamento pluralistico. Simoltiplicano gli intereventi legislativi neisettori speciali , si attua l’autonomiaregionale che implica anche autonomi legislativaed inizia un’ avventura che si espande fino alambire gli istituti del diritto privato e a farsorgere molti interrogativi sulla ammissibilitàdi un diritto privato regionale (Galgano, Vitucci,Alpa). Il codice civile perde la sua posizionemonopolitistica, il suo ruolo di tessutoconnettivo delle regole e di fattore ordinantedei rapporti tra privati.
7. La decodificazione e le forme della modernità (1980-1990)
L’analisi fenomenologica, accompagnatadall’istanza metodologica di verificare ilrecupero del sistema in un mondo che sembravaandare in frantumi suggerisce a Natalino Irti la
45
pubblicazione di una raccolta di saggi , scrittiverso la fine degli anni Settanta, che vengonoracchiusi in un titolo trasgressivo: L’età delladecodificazione. La perdita di centralità del codicecivile rispetto alle leggi speciali, la nascitadi “micro-sistemi”, gli statuti dei gruppipongono al’Autore e quindi alla comunità deicivilisti il dubbio sulla salvezza del codicecivile, condannato ad assolvere una funzioneresiduale in un complesso normativo ormaipolicentrico. Il passaggio dal mono al poli-sistema, con il superamento del libro sacraleche appariva l’unico fondamentodell’ordinamento giuridico della societàliberale , trasforma il giurista in un tecnicodei micro-sistemi, travolge i criteri dicatalogazione delle fonti, travolge i criteri diinterpretazione, relegando principi generali eanalogia sul fondo di una piatta esegesi , evede erompere la dimensione politicanell’applicazione delle regole del dirittocivile. E’ la situazione diametralmente oppostaa quella che auspicava Filippo Vassallidefinendo l’ “extrastatualità” del dirittocivile (sul punto v. ora G.B.Ferri, La “cultura” delcontratto e le strutture del mercato, in Riv.dir.comm.,1997,I, 843 ss.)
La normativa speciale investe soprattutto ilcontratto, là dove questo involge interessisocialmente rilevanti ( ad es., la locazione, i
46
contratti agrari) o economicamente prevalenti(ad es. i contratti bancari edell’intermediazione finanziaria). Il fenomenodella decodificazione – che ha attratto ,affascinato e convinto i giuristi di qua e di làdell’Oceano – avrebbe dovuto ricomporsi , masotto altre forme, solo vent’anni dopo (v. orala quinta edizione dell’opera, pubblicata sempreper i tipi di Giuffré a Milano nel 1999). Unaricomposizione all’insegna della pluralità deilivelli delle fonti.
Non sarebbe cambiato l’afflusso di leggi,leggine,decreti delegati e regolamenti, volti asostituire nel numero ma non nella perfezionetecnica le norme sfoltite dal processo di“delegificazione”; sarebbe cambiata la lorotecnica aggregativa, con l’avvento dei codici disettore e di nuove fonti (come le leggiordinarie scritte per principi e destinate adessere poi tradotte in norme di dettagliomediante regolamenti ).
A quarant’anni dal codice civile si avvertedunque l’esigenza di fare il punto dellasituazione, ripensare l’idea di codice e dicomprendere la sua adeguatezza alle nuoveesigenze economiche e sociali. Il tema proiettalunghe ombre sulla discussione interna allascienza civilistica : la Rivista critica di diritto privatoorganizza nel 1985
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX47
Ma l’economia ferve, ed incalza il giurista:alla metà degli anni Ottanta si moltiplical’interesse per i contratti atipici,per leoperazioni più diffuse che non hanno (ancora)una disciplina codicistica o di legge speciale :leasing, factoring, lettere di patronage, jointventures,engineering, financial futures,garanzie a prima richiesta, fideiussioneominibus, sponsorizzazione, know how,contrattituristici, lettere di intenti, lettere dipatronage, contratti preliminari con effettianticipati ,ed altri tipi sociali sonoaltrettante punte di emersione di una realtà inpiena evoluzione che chiede forme giuridicheordinanti e certezza dei rapporti, senzatuttavia il sacrificio della creatività.
Le clausole generali e i limiti all’autonomiaprivata dettati da norme imperative ripropongonoil problema, da un lato, della discrezionalitàdell’interprete, e dall’altro, della osservanzadel principio di legalità
L’ incidenza dell’interesse pubblico nellanegoziazione privata (per riprendere il titolodi un saggio di Pietro Perlingieri in Rass.dir.civ.,1986, 933) può esprimere compiutamente ladimensione nella quale la pattuizione privata sicolloca nel contesto dell’ordinamento.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Di qui due operazioni ormai diffuse econsapevolmente compiute: l’ equilibrio
48
all’interno del contratto, il contemperamento diinteressi tra istanze e aspettative delle partie controllo sociale
Contratto e impresa
In questo torno d’anni si radica l’idea cheal contratto si deve pensare come allo strumentomigliore per la realizzazione di finalitàeconomiche , e che il contratto debba quindirendersi la “scatola magica” per soddisfare leiniziative delle imprese, sempre peròsalvaguardando i principi espressi dallacostituzione economica. Il “manifesto” fondativodella rivista Contratto e impresa, diretta daFrancesco Galgano, poi affiancata da Contratto eimpresa.Europa, diretta da Marino Bin, recitaappunto:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I dialoghi con la giurisprudenzaVisintini
8. Segue. La rivisitazione dei dogmi e il “problema” delnegozio giuridico
La rivisitazione dei dogmi è in pienaattività: il negozio giuridico continua a
49
concentrare l’attenzione dei civilisti; d’altraparte è la cateogria ordinante per eccellenzanell’ambito dei rapporti obbligatori. FrancescoGalgano pubblica il volume sul Negozio giuridico(1988) che in realtà, è un volume sul contratto,a cui l’A. antepone le sue considerazioni sullacategoria del negozio, di cui documenta ilcrepuscolo (Contr. e impresa, 1987,733) , ma nellostesso tempo G.B.Ferri ne rivendica lalegittimità concettuale e l’utilità pratica, nelsegno della libertà contrattuale (Il negozio giuridicotra libertà e norma, Rimini, 1987, con mia recensionesu Contr.e impresa, 1987,752; e v. Patti, Il negoziogiuridico:è vera crisi?, in Riv.dir.civ., 1987,I, 487)
La vicenda del negozio giuridico, vistanell’arco di un settantennio, sembra quasidipingere in modo lacerante la pressione dellastoria e delle categorie dogmatiche su di unascienza civilistica che cerca di liberarsene,senza però convincersi fino in fondo della suainutilità, quasi che il negozio rappresentasseun cordone ombelicale che lega indissolubilmenteil civilista alle sue radici. Di anno in anno,nonostante i convegni e le riflessioni comuni,il tema ritorna in tutta la sua complessità, maanche il suo fascino intellettuale: è un leit motivche percorre talvolta in modo sotterraneo altravolta in modo prorompente le ricerchecollaterali a quelle dedicate ai temi diattualità. Dai corsi degli studi la nozione e laillustrazione dell’istituto sono banditi, salveeccezioni marginali (v. Ferri , Emilio Betti e la
50
teoria generale del negozio giuridico, in Rass. Dir.civ ,1992 , p.715).
E’ cambiata però la prospettiva: se ne parlaper ricollocare l’istituto nella sua dimensioneattuale (v. Scalisi, Il negozio giuridico tra scienza ediritto positivo. Teoria, manifestazione, astrazione, inefficacia,Milano, 1998), o con propositi ricostruttividella storia della cultura giuridica (G.B.Ferri,Il negozio giuridico, 2° ed., Padova, 2004),o perillustrare i concetti giuridici in mododiacronico: la categoria del negozio èconnaturale alla cultura dei civilisti, efinanche supera, per l’attenzione che le sidedica, quella dei giuristi tedeschi, cheavrebbero ben altra ragione di coltivarla,essendo essa codificata nel B.G.B. e maisoppressa (P. Cappellini, Storie di concetti giuridici,Torino, 2010) o come metafora (“del nulla”:Galgano, Le insidie del linguaggio giuridico.Saggio sullemetafore del diritto, Bologna, 2010,p. 105 ) o a finirievocativi (Irti, Il negozio giuridico come categoriastoriografica, Quaderni fiorentini, 1990, p.557; ID:, Delritorno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di VittorioScialoja), Riv.dir.civ., 2011,425); se ne parla comeconcetto, come espressione del principio divolontà e quindi di libertà, come categoriauniversale accolta in molti ordinamenti in modoesplicito ed in altri presente in modo menoevidente ma pur sempre logicamente efunzionalmente utilizzata (R.Sacco, La partegenerale del diritto civile.1.Il Fatto,l’Atto,ilNegozio, con lacollaborazione di Paola Cisiano, Torino,
51
2005,p.273 ss.). E tuttavia la Teoria generale delnegozio giuridico di Emilio Betti viene ripropostanel 1994 a cura di uno dei suoi allievi,Giuliano Crifò, Napoli, 1994; il negoziogiuridico continua a costituire un “problema”(Franzoni, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1995, 409) , unasorta di giogo sotto il quale si deve passare,anche se poi ci se ne può liberare.
Chi oggi si pone il problema – senza averpaura di parlarne (Spada, Chi ha paura del negoziogiuridico?,in Riv.dir.comm.,2007,I, p.518) – potrebbespingere la sua curiosità a rivisitare iclassici (Irti, Del ritorno ai classici(e del negozio giuridiconel pensiero di Vittorio Scialoja), in Riv.dir.civ., 2011,I,425ss.) , a considerare la sua traduzioneconcettuale sia nelle versioni linguistiche incui è stato tradotto il B.G.B. – in inglese, conjuridical act oppure con legal transaction, in francese,meno correttamente, con acte juridique – oppure adeffettuare una ricerca sulla sua rilevanza nellinguaggio giurisprudenziale in Italia dallafine dell’ Ottocento ai giorni nostri.
A questo riguardo è appena il caso disegnalare che non ne risulta una applicazionegiurisprudenziale fino agli anni Venti, unascarsa applicazione negli anni Trenta(nonostante la poderosa opera di Scialoja (Negozigiuridici, prima ed. litografata in forma didispense ad uso degli studenti apparsa nel
vedesse la sua quarta ristampa nel 1938), eduna applicazione più diffusa negli anni Quarantae poi di lì fino ai giorni nostri, senza però la
52
consapevolezza dogmatica e la finezza tecnicache questo monumento storico richiederebbe. Enonostante la devozione mistica di cui è - abuon diritto – circondato ormai quasi tutti imanuali di Istituzioni di diritto privato nehanno abbandonato l’illustrazione.
Se invece se ne dovesse ancora fare unalettura non storiografica, ma ideologica, sidovrebbe osservare che quando fu introdotto inItalia ad opera di Tullio Serafini e, appunto,di Vittorio Scialoja (e con il corredo delletraduzioni dei volumi dei Pandettisti di diversaformazione ed indirizzo culturale) a questacategoria non arrise una immediata fortuna. Mala critica che ad esso si mosse, già da partedegli appartenenti al gruppo dei “socialistidella cattedra” coinvolgeva anche il contratto.Perché anche la disciplina - generale edastratta – del contratto non poteva che esporsialle critiche di quanti in esso vedevano lostrumento di oppressione dei lavoratori, deiconsumatori, delle parti socialmente deboli. Mipiace ricordare a questo proposito non tanto lecritiche di Enrico Cimbali , di Cesare Vivante odi Biagio Brugi, ma le note molto discrete delgenovese Pietro Cogliolo, che, nella sua Filosofiadel diritto privato , per i tipi di Barbera (che, sisa, era la collezione di libri tascabili piùdiffusa ), osservava come il contratto sia sìstrumento di libertà, ma il contratto assolva aduna funzione sociale , ed i limiti sociali imposti dalloStato (a tutela del lavoro dei fanciulli, delle
53
donne, nelle miniere, etc.) possono crescere neltempo per contenere il potere dei <capitalisti,società anonime grandiose e forti> che >pongonoin essere i fatti, che interessano le questionisociali , sotto forma di contratti> (p. 230della terza ed., Firenze, 1936). Cogliolo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A questa riflessione occorre aggiungere duechiose.
La prima è suggerita dalle pagine diHattenhauer, il quale, nel IV capitolo del suoprezioso libro sui concetti giuridicifondamentali (Grundbegriffe des Buergerlichen Rechts,Monaco, 1982) dedicato al negozio giuridicospiega come la concezione pandettistica degliatti privati sia nata sulla base di unaconcezione kantiana di libertà e poi sia statacorretta oggettivando la volontà soggettiva indichiarazione, e poi si sia trasformata ,degenerandosi, in mero rapporto istituito pereffetto dell’ordine dello Stato , in ossequioalla ideologia nazista, la quale aveva favoritoanche l’ immersione nelle clausole generali e lateorizzazione della vincolatività del semplicecontatto sociale, sì che la difesa dellacategoria del negozio giuridico negli anni delnazismo acquistava non solo un significatodogmatico ma era anche un modo per difendere lalibertà della persona, privata della suaidentità per via della massificazione imposta
54
dal regime e schiacciata al punto da perdere lasua dignità. Sì che, cambiando il contesto, ilnegozio giuridico, da strumento dell’ideologiaborghese, diviene strumento di affrancamentodalle politiche liberticide. Ed è appena il casodi sottolineare che invece, da noi, salve rareeccezioni, la rivisitazione della concezionepandettistica di negozio rimane rinchiusa trale solide pareti della dogmatica civilistica eromanistica.
La seconda riguarda l’uso del diritto romano,che come si sa, in Italia viene ideologicamentepiegato a sostenere il regime ( si pensi agliArcana imperii di De Francisci) , e quindi lateorizzazione del negozio celebra lariscoperta delle radici romanistiche del dirittocivile; si tende così a “nobilitare” la scienzagiuridica civilistica anche a costo di compieremanipolazioni del tutto antistoriche; mentre inGermania, come scriveva Koschaker, era maturatoun orientamento opposto, il diritto romano eraconsiderato come antitetico al diritto moderno,cioè al diritto emergente dal popolo, e lasconfitta del diritto romano era la metaforadell’ isolamento di quel Paese – e della suacultura giuridica - dal resto d’ Europa e daglistessi valori della società occidentale.
9. Nuovi modi di concepire il contratto
55
Sacco e De Nova pubblicano una nuova edizionedel volume sul contratto del Trattato diretto daPietro Rescigno
Alpa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVettori
La revisione concettuale, l’evoluzioneinterpretativa, la discussione sui risultatidell’esperienza ha accompagnato la storia delcontratto in questo secolo breve.
I confini dell’autonomia negoziale, lafunzione della causa, il ruolo dellapresupposizione, il rigore della forma hannocalamitato l’attenzione
Quanto all’autonomia, la libertà di scelta deltipo , l’identificazione del tipo sociale e lavalutazione di vantaggi e svantaggi dellacodificazione o inclusione dei tipi in unoschema legislativo si sono rivelate qualiinterrogativi più frequenti, soprattutto conriguardo al leasing, che sia per gli operatoriprivati sia per le imprese consente di ottenereil godimento di beni mobili (strumenti,utensili, veicoli, etc.) e di beni immobili coninvestimenti modesti e con l’opzionedell’acquisto finale. Il leasing è stato ilvolano delle piccole e medie imprese, ma ancheil rimedio a cui si sono rivolte le grandiimprese per ottenere liquidità o per ripianare i
56
debiti. Così come il factoring – poi divenutomodello legislativo denominato < cessione deicrediti d’impresa> - è un mezzo per realizzaerele ragioni creditorie ad un prezzo accettabile,consentendo all’impresa di recuperare risorse dainvestire nuovamente nella sua attività. Ilfranchising, anch’esso convertito da formulameramente negoziale a modello legislativo, hainnovato gli strumenti di distribuzione dei benie dei servizi, e così il know how. Riprendevigore il negozio fiduciario – anticaesercitazione dei Maestri del diritto civile, daGiuseppe Messina, a Francesco Ferrara, a TullioAscarelli, a Cesare Grassetti, a SalvatorePugliatti, perché l’ordinamento deve esserepiegato alle esigenze dell’economia ma anchealle esigenze dei singoli che intendonoeffettuare legittimamente e per la realizzazionedi interessi meritevoli di tutela lacostituzione di patrimoni separati (AA.VV. Fiduciatrast mandato e agency Milano, 1991).
Allo stesso modo, le complesse operazionifinanziarie che sul contratto fanno affidamento– superando per legge persino i principi digioco e scommessa e implicando alee anormali –sono state il mezzo per ammodernare il mercatofinanziario , e talvolta proprio una ragionedella sua crisi.
La convenienza fiscale dell’operazioneeconomica ha indotto la fantasia dei giuristi amoltiplicare i negozi e a combinarli tra loro ,dando luogo alla figura del collegamento
57
negoziale, già apparsa sulle soglie dellacodificazione e poi corroboratasi nel corsodegli anni recenti. Qui il formalismo non èprevalso, sì che nel collegamento si è potutovedere un meccanismo in cui individuare unacausa per il negozio principale , che a suavolta costituisce la ragione giustificativa deinegozi accessori.
Il lavoro più complesso ha riguardatol’adempimento e l’esecuzione del contrattoconsiderati nella prospettiva delladistribuzione dei rischi . Di qui ilconsolidamento della presupposizione, cometecnica di risoluzione in caso di mancatasussistenza originaria o di sopravvenuta carenzadelle circostanze considerate dalle parti allabase del loro accordo ( Galgano, in Contr e impr.1989, 32).
La rivisitazione dei dogmi investe ancheprincipi che si credevano ormaiindissolubilmente legati alla codificazione ealla prassi contrattuale, come quello dellalibertà delle forme. Ancora una volta è NatalinoIrti che lancia la sfida con il suo saggio Idolalibertatis del 1985 (e con altri saggi raccolti nelvolume di Studi sul formalismo negoziale, Napoli, 1997),a cui risponde Pietro Perlingieri, Forma dei negozie formalismo degli interpreti, Napoli, 1987.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Viene anche in gioco il ruolo della “partegenerale” rispetto alla “parte speciale” della
58
disciplina dei contratti. Se ne è già accennatoa proposito del fenomeno della elefantiasi dellalegislazione speciale, a scapito della coerenzasistematica del codice civile. Ora ci si chiedecome si debba intendere – in un nuovo contestoeconomico-sociale – la parte generale: comeancora dominante la scena, o come elementoancillare alla disciplina dei singolicontratti ; e più dogmaticamente, le regole sulcontratto in generale richiedono di essereriviste alla luce della esplosione dei contrattiatipici?
Parte generale e parti speciali De Nova, Contrimpr. 1988, 327
GiorgianniVitucci Contr impr 1988,804
Il problema si porrà in altra prospettiva conla introduzione dei codici di settore, dalmomento che in essi confluiscono regole chepotrebbero essere collocate nel corpo del codicecivile, oppure che sono state estrapolate dalcodice civile, oppure che in altre esperienzehanno ricevuto collocazione nei codici civili.Di questo si dirà tra poco, a proposito dellaevoluzione del contratto negli anni Novanta.
10. Contratto , status, mercato, e rivoluzione delle fonti(1990-2000)
59
I contratti d’impresaI contratti d’impresa Buonocore et alii,
1993,e 1995 riv dir civ oppo rdc 1995 i 62Dal contratto allo statusI rimedi recesso e ris nei conrr de nova
milano 1994 Di Majo
I principi generali
I primi cinquant’anni del codice civile
La centralità del codice civile (Falzea, neI cinquant’anni del codice civile, Atti del convegno diMilano 4-6 giugno 1992, t.I, Milano, 1993, p.204) viene rivendicata nell’ambito dellecelebrazioni dei cinquant’anni di vita di questalegge ordinante dei rapporti civili. Ciò cheemerge, soprattutto, è il rapporto tra le regolescritte (innovative, rispetto ai modelliottocenteschi) e le regole operazionali : una tecnicache si affida sia alla dottrina sia allagiurisprudenza, oltre che alle prassi, perricostruire la categoria “contratto” in terminigiusrealistici (Sacco, ivi, p. 205 ss). Siregistrano le sue trasformazioni – dalla“fattispecie primogenita” al contratto mediantedichiarazione, al contratto-negozio, al rapportodi fatto , all’apparenza, cioè ai fenomenilegislativamente non previsti ma emersi
60
attraverso l’interpretazione e l’applicazionedelle norme di codice. E si pone in luce tuttociò che è emerso al di fuori del codice, etuttavia ha inciso sulla disciplina delcontratto: le regole del mercato e dellaconcorrenza (Irti, ivi, p. 439) e la tutela delcredito (Schelsinger, ivi, p. 253) ; ma ancheciò che si è esteso al contratto dalle regoleraccolte nella parte dedicata a disciplinare leobbligazioni (Mengoni, ivi, p. 239) e deicontratti tipici (De Nova, ivi, p. 217). Sidiscutono le innovazioni che connotano ladisciplina in modo più significativo – la“publicizzazione” del contratto ,l’integrazione, le condizioni generali(Patti,ivi, 759) .
Ma il contratto è visto soprattutto cometecnica di regolamentazione dei rapporti tra iprivati , mentre l’analisi del contratto cometecnica di disciplina dei rapporti tra i privatie le pubbliche Amministrazioni, e finanche deirapporti tra pubbliche Amministrazioni èaffidata (salve rare eccezioni : Moscarini, ai cultori del diritto pubblico. Tra tutti è ilcaso di ricordare la categoria dei contratti adevidenza pubblica ideata da Massimo Severo GianniniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La rivoluzione delle fonti
Oggi, che siamo in piena fase ditransizione, ed abbiamo tutti percepito la
61
fallacia della architettura kelseniana, sembraagevole tracciare una nuova illustrazione dellefonti del diritto (Lipari,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXE quindi è operazione più semplcie adattarealle nuove fonti anche la disciplina delcontratto (Vettori,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ma ci sono voluti anni per smuoverel’impalcatura al tempo stesso concettuale edogmatica con cui si assorbiva nella fattispecie“contratto” ogni fenomeno negoziale. Si èdescritto questa vicenda come una “tenaglia” cheschiaccia, comprime, sgretola la solidacrisalide nel quale si voleva proteggere lalibertà contrattuale : dall’alto il dirittosovranazionale, dal basso il diritto regionale(Irti,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La svolta si è registrata con la riscopertadella Costituzione, e dei suoi valori, dopo iprimi esperimenti tentati degli anni Sessanta.
La costituzioneGiur it 1993 1, 1, 2129Alpa li bcontr e tut cost riv crit 1995 35
dimajo ivi 5Mengoni autonomia privata e costituzione bbtc
1997 1,1
62
La gir costituzionale e la giur delle cortiordinarie
Seminario cnf
La “costituzionalizzazione” del contratto ,nonostante gli auspici di molti civilisti, nonsi è mai compiuta. Anche di recente,nell’esaminare il processo di formazione della“costituzione economica”, sulla base dellalettura dell’art.41 Cost. nelle diverse epocheche hanno contraddistinto la giurisprudenzadella Corte di legittimità e l’evolvere delladottrina costituzionalistica Massimo Lucianipone in luce il collegamento tra l’art. 41 el’art.3, non coinvolge nel discorso l’art.2. Lalibertà economica è vista dunque come unaespressione delle libertà individuali, daesercitare secondo i canoni della concorrenza edella utilità sociale e quindi in una dimensionecollettiva , ma non tale da incidere sulle forme diespressione della persona (Unità nazionale e strutturaeconomica. La prospettiva della Costituzionerepubblicana,Relazione al Convegno annuale AIC,Torino 27-29 ottobre 2011,§6 del datt.).
In altri termini, come si accennava all’inizioe come si dirà anche tra poco, un conto è lavalutazione dei diritti fondamentali che sonocoinvolti nell’operazione contrattuale, altroconto è la possibilità di concludere in sé e persé quell’operazione. In questo secondo aspettonon si può scorgere la via per giungere allaprotezione costituzionale del contratto. Anche
63
di recente Pietro Rescigno lo ha ribadito inmodo netto, chiamando a confronto il modellotedesco , ma per sottolinearne le differenze conil modello italiano. Né si può giungere a quelrisultato considerando il contratto come ilmomento fondativo della libertà di associazionee la libertà matrimoniale. Così come il dispostodell’art. 41 Cost funziona come limite allalibertà contrattuale , piuttosto che non comesuo sostegno.
Diversa è invece la problematica dellaDrittwirkung delle norme costituzionali airapporti tra privati, ma di questo si parleràtra poco (Rescigno, Premessa, al Trattatocit.,p. XLIII ss.).
Il diritto privato regionale
I rapporti tra codice civile e dirittoregionale non sono stati oggetto di ampiodibattito: il discorso , avviato come si è dettonegli anni Settanta, è stato ripreso da alcunistudiosi (Benedetti, L’attenzione si è concentrata sullagiurisprudenza costituzionale, ma non si hanotizia di ricerche specifiche in materia .Eppure l’intervento delle Regioni, sia sullaorganizzazione degli enti privati e pubblici,
64
sia sulle modalità di erogazione dei servizi, èstato intenso e pervasivo. Questa è una lacunache deve essere colmata, perché, nonostante ilsignificato del sintagma “ordinamento civile”che riserva allo Stato ogni intervento normativonel settore (non più materia ma ambito) lalegislazione regionale continua ad esseretumultuosa.
Il diritto comunitario
Il valore fondamentale che stava alla base delTrattato istitutivo è la libertà economica, coni suoi riflessi nella disciplina dellaconcorrenza, nella edificazione del mercatounico ed integrato, articolato nei quattropilastri della libertà di circolazione dellepersone, dei beni, dei capitali e servizi. Comesi sa, questi valori si sono poi via viaarricchiti con l’espandersi delle competenzedell’ Unione europea. Non è il caso qui diripercorrere le fasi di contatto, connessione,conflitto potenziale, gerarchia, tral’ordinamento comunitario e l’ordinamentonazionale. E’ una storia complessa, costruitapoliticamente, socialmente, economicamente e -per i giuristi – in modo irreversibile etotalizzante. Perché il diritto comunitario nonè solo un ordinamento in sé, è anche uno deifattori propulsivi del diritto europeo, ed unodei fattori propulsivi del diritto interno. Nonsi tratta solo di regole, ma di idee e valori,
65
di modelli, di termini, in somma di una nuovalingua che i giuristi hanno dovuto imparare intutte le sue declinazioni.
Il settore del contratto ne è stato investitoin modo molto incisivo. Sia sotto il profilo deisettori di competenza specifica dell’ Unioneeuropea, sia sotto il profilo della disciplinadi categorie contrattuali , dei tipicontrattuali, delle modalità di conclusione delcontratto, dello status delle particontrattuali, e di tutto l’universo propriodella cultura giuridica , composto com’è ditermini tecnici, di concetti, di principi, diclausole generali, di canoni interpretativi.
Il fatto che gran parte delle regole destinatea disciplinare taluni tipi contrattuali e taluneregole di natura generale derivinodall’attuazione di direttive o dall’applicazionediretta di regolamenti, o dalle sentenze dellaCorte di Giustizia rende più complessa ladecifrazione della situazione. Ma l’applicazionedel diritto comunitario ha influito anche sullaevoluzione del diritto interno di competenzaesclusivamente nazionale, perché si è creata unaosmosi tra i due settori, così come si è creatoun universo culturale nel quale, pursalvaguardandosi le diversità, la circolazionedelle idee, dei modelli, dei tipi ha subìto unaforte accelerazione.
Prima ancora che comparissero i progetti diarmonizzazione delle regole sul contratto ingenerale - i PECL – e certo prima che si
66
potesse pensare ad una sorta di “codice civileeuropero” come il Draft Common Frame ofReference con i suoi libri dedicati ai principi,al contratto, alle obbligazioni, si era giàformato un diritto contrattuale europeo,denominato per l’appunto existing contract law.
I suoi caratteri essenziali sono descritti neimanuali, nei saggi e financo nei trattatidedicati al diritto privato europeo (di cui leopere di Lipari, Perlingieri, Castronovo eMazzamuto , Bessone e Tizzano, a cui vorreiaggiungere anche l’ opera sui i Fondamenti di MadsAndenas e mia sono in qualche modo le primeespressioni) . Le definizioni dei contraenti –professionisti, consumatori, piccole-medieimprese – i principi cui si debbono attenere icontraenti ( ad es., proporzionalità,ragionevolezza, buona fede) , le modalità diconclusione dell’accordo e così via sono soloframmenti di un intero comparto di un nuovomondo nel quale il contratto viene concepito inun nuovo modo.
Tra tutti gli interventi in materia credo cheil più sconvolgente sia stato quello sulleclausole abusive, la cui disciplina dapprimaintrodotta con la direttiva n.13 del 1993 eattuata con legge comunitaria del 1996, inseritanel codice civile agli artt. 1469 bis e ss.,viene poi traslata nel Codice del consumo del2005.
La direttiva è stata preceduta e accompagnatada molteplici iniziative, da progettati
67
interventi legislativi, da una amplissimaletteratura , sia rivolta a valutarne l’impattonella realtà socio-economica, sia rivolta aconsiderare , ponendoli a confronto, i metodi diapplicazione delle direttive negli altriordinamenti dell’ Unione, sia a valutarel’effetto sull’ordinamento interno già provvistodi regole sulle condizioni generali dicontratto e sui contratti di adesione . Ladirettiva, con le sue disposizioni ripartite indivieti, in valutazioni di potenziale abusività,e con la introduzione di regole di buona fedevolte non tanto a commisurare il comportamentodei contraenti ma il contenuto delle clausole “nonnegoziale”, e, di più, volte a commisurare l’equilibrio tra le posizioni giuridiche delleparti ha davvero avuto l’effetto di legal irritantpropnosticato da Gunther Teubner . Soprattuttoha espresso alcuni modi di concepire ilcontratto , poi accentuati nei loro profiligiuridici dalle direttive introdottesuccessivamente successive , nonché dalleproposte di armonizzazione delle regole generalie dai primi atti normativi che di recente sonostati approvati - mi riferisco alla direttivasui diritti dei consumatori, del 10 ottobre 2011(in corso di pubblicazione sulla G.U.C.E.) e alRegolamento sulle vendite ai consumatori ……………,in cui il contratto viene visto come un accordodi scambio, tra parti che dovrebbero essereposte su di un piano di parità, e quindi ,quando rivestano uno status particolare ( quello
68
di consumatore o di piccola e media impresa)richiedono un supplemento di informazioni , chesono elencate come altrettanti obblighi daosservare nella fase anteriore alla conclusionedel contratto.
Commento al d.lgs.15.1.1992,n. 50 a cura dilipari nuove leggi civ 1993, 176
I contratti dei consumatori Alpa, doc giustizia 19931049
Zeno, Gi 1993 iv 57 1994 commenti cl abusive
I codici di settoreI contratti amministrati eteronomia e autonomia
Il contratto pubblicoIl contratto internazionale De Nova sui
principi unidroit contratti 1994 bonell dircommi nt. 1994 567
69
La rivoluzione informatica e i suoi riflessisulla contrattazione
1987
La rivoluzione biologica
L’ordine giuridico del mercatoLa lex mercatoria e il diritto senza Stato
11. Il tornante del nuovo millennio (2000-2010): ilcontratto tra postmodernità e complessità
Codici?Ricodificazione irti patti etcil nuovo BGB
, Scienza e insegnamento del dirittotradizione civilistica e complessità del
sistema
seminari di perlingieri
Roppo, galgano mazzamuto vettori
Il nuovo diritto dei contratti crotone 2004
70
12.Il contratto , l’individuo e la collettività .I dirittifondamentali, la solidarietà, la cooperazione, l’ equità
Ormai non si può più pretendere di ricondurretutto a sistema, anche se non è necessarioabbandonarsi a tentazioni nichilistiche. Icodici di un tempo hanno vissuto in gloria, oggisi propone una nuova codificazione concepitacome un nuovo modo di aggregare regole diautonomia privata. I tentativi consumati inambito accademico e poi ripresi in ambitocomunitario sono in corso.
Il codice civile ha retto tutto il secolo, epuò ancora reggere se adeguatamenteinterpretato. D’altra parte, quali sono i nuovivalori?
I diritti fondamentali, la solidarietà, lacooperazione, l’equità
Siamo distanti anni luce dal dibattito oggi incorso nella cultura giuridica francese o inquella anglo-americana, nel senso che il nostrotempo ha superato il loro, le nostre stagioni sisono moltiplicate molto di più delle loro, macorriamo un doppio rischio: che quellastraordinaria esperienza sia conchiusa in sé,rimanendo compressa entro i confini nazionali,visto che siamo più inclini ad importare che nonad esportare le idee, i modelli, le stesse“mode” che si radicano e ramificano all’estero;che l’affermarsi del contratto globalizzato,
71
tecnicamente perfetto e (in apparenza) neutraledal punto di vista ideologico e dei valori cheracchiude soppianti, attraverso lecodificazioni di settore, l’applicazione deiprincipi internazionali, la giurisprudenzaarbitrale, il contratto costruito sullefondamenta del codice del 1942. Quellefondamenta corrono il rischio di diventareceneri, e il contratto del codice anch’esso unmonumento storico come è accaduto per il negoziogiuridico .
Nell’avvicendarsi di queste stagioni, nelsovrapporsi delle epoche, nella vita paralleladi indirizzi interpretativi, si delineano anchenuove metodologie che affiancano all’analisiformale l’analisi sociologica, quellaantropologica, quella letteraria. Si affermanonuove clausole generali, prima tra tutte l’abusodi potere contrattuale. Si affermano nuoveclassificazioni (B2C, B2B, , “terzo contratto”).Si introducono nuovi principi, come latrasparenza intesa come tecnica di negoziazionemediante l’adempimento di obblighi informativiprecontrattuali, nuovi adempimenti documentali,come i modelli imposti dalle direttivecomunitarie. Si congegnano nuovi rimedi , qualila rinegoziazione e la revisione del contratto,la nullità di protezione, la rilevanza deicomportamenti che ridonda in vizi del contratto.E pertanto si assegnano nuovi compiti al
72
giudice, espandendosi perciò i confini delcontrollo giudiziale degli atti di autonomiaprivata
Meno labile, nei suoi confini, rispetto allaresponsabilità civile, ma molto più vitale dellaproprietà, il contratto ha conosciuto dunquetante stagioni ed una costante , attentarivisitazione da parte della dottrina e dellagiurisprudenza, si è arricchito delle prassinegoziali dovute al contributo deiprofessionisti, e le norme di codice hannosuperato il “secolo breve” senza richiederequella ricodificazione attuata in altri Paesi,come in Germania, o in corso di espletamento,come in Francia
Patti di famiglia, patti successori
Nuovi rimedi
Le clausole generali: rivisitazione e innovazione Abuso di potere contrattuale(abuso del diritto Patti, Salvi, Gambaro,
BrecciaPagliantini, Abuso del diritto e buona fede nei contratti,
Torino, 2010
73
D’amico, libertà di scelta del tipocontrattuale e frode alla legge, milano 1993
Equità galgano, ci 1993 419Clausola penaleRagionevolezzaTrasparenza
Le persistenzeLa persistenza dei dogmi il negozio come
concetto, come paradigma, come scrigno dellatradizione
L’ incidenza del diritto comunitario e l’ armonizzazione deldiritto dei contratti
L’impatto del diritto comunitario sugliistituti del diritto civile è stato oggetto diuna ampia ed approfondita discussione al IVConvegno nazionale della S.I.S.D.I.C. (Capri,16-18 apirle 2009, i cui atti sono statipubblicati con il titolo Diritto comunitario e sisteminazionali:pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti,Napoli, 2010). Già il titolo del convegno , cheriprende peraltro temi da tempo coltivati dalsuo organizzatore, Pietro Perlingieri
XXXXXXXXXXXXXXXXXindica la complessità del problema: l’incidenzache la introduzione di nuove fonti normative,come i regolamenti (in particolare, Roma I eRoma II) e le direttive, (sui diritti dei
74
consumatori, sui pagamenti e così via) , lacircolazione di nuovi modelli , nuovecategorie , concetti e termini dispiega suldiritto interno e quindi sugli istituti checostituiscono la trama del diritto civile. Suiconcetti in particolare si è attiratal’attenzione, sì che una sessione è statadedicata alla “riconcettualizzazione del dirittodei contratti” che si accompagna allariconcettualizzazione del diritto dell’impresa.
A questo proposito è importante sottolinearecome nel diritto comunitario – e quindi nellefonti che o direttamente o indirettamenteincidono sugli ordinamenti nazionali - ladistinzione tra diritto civile e dirittocommerciale, e tra fonti di codice civile e dicodice di commercio, conservata ancor oggi inmolti ordinamenti continentali, a cominciaredall’esperienza francese, da quella tedesca e daquella spagnola, e superata in altre (come nellanostra e in quella olandese) , non si siaradicata; di più, che il linguaggio e leprospettive ermeneutiche del diritto comunitariosono fortemente influenzate da categorieeconomiche e aziendalistiche, sicché da un latoè molto complicata l’impresa di inscriverequesto intero armamentario nelle categorieusuali consegnate dalla tradizione , ancorchériviste e ammodernate , dall’altro è faticoso,per il giurista nazionale, ancor più secontinentale, dover trattare termini, concetti,principi nuovi ( v. in particolare Busnelli,
75
ivi, 573; Scalisi, ivi, p. 87, Gentili, ivi, p.163;) a cominciare dai soggetti ,individualmenteconsiderati o come componenti di aggregazionicollettive (Conte, ivi, 239) , dagli elementiessenziali del contratto , quali l’ accordo eil consenso (Addis, 273), non la forma ma ilprocedimento contrattuale (Cesaro, ivi, p. 305)alla “causa”, inclusa tra virgolette perchéintesa come razionalità economica piuttosto checome ragione dello scambio e come scopo delcontratto (Navarretta, 323) o comunquerecuperata sotto le specie dell’ oggetto (Alpa,Causa e contratto. Profili attuali, in Vacca (cur.), Causae contratto nella prospettiva storico-comparatistica, Torino,1997, p. 279) , al vincolo contrattuale e allasua integrazione o al suo scioglimento medianterecesso (Padovini, Atti, op.ult.cit. , 343),alle invalidità (Polidori, p. 351) . Per nonparlare delle nuove clausole generali, quali laragionevolezza (Del Prato, ivi, p. 187; Alpa,ivi, p. 661) e l ‘abuso del diritto (Alvisi,ivi, 359; ma v. già Sacco, L’abuso della libertàcontrattuale, in AA.VV. L’abuso del diritto, Padova, 1997,217 )
La convergenza dei modelli nazionali el’armonizzazione in materia di contratti deiconsumatori e i progetti di un codice civileeuropeo
i tentativi di codificazione europea76
Pavia, 1992Posch, jus 1993 117ZimmermannSchwartz rcrit dp 1996 427
Convegno della bocconiSeminari del consiglio Seminari della acivit
Il contratto nei progetti di uno strumentocomunitario : le nuove clausole generali,
la concezione sinallagmatica, la scomparsadella causa, il riequilibrio contrattuale,l’informazione precontrattuale e la trasparenza,i rimedi
i contratti asimmetrici :B2C,B2B
12. Il contratto nell’epoca della crisi globale13.la specializzazioneContr e impresaI contrattiRev des contratsERCLawERBLEuropa e diritto privato
77
La collettività internazionaleil contratto nel diritto internazionale, il
contratto alieno
Dalla lex mercatoria alle regole dellaglobalizzazione
Galgano, Marrella
Iudica, Globalizzazione e diritto, in Contr eimpresa, 2008, 869
Si deve ancora alle iniziative congressualidella S.I.S.D.I.C. la riflessione più recente suL’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile (atti delV congegno nazionale , Capri, 25-27 marzo 2010,Napoli, 2011) in cui si è dibattuto soprattuttosui nuovi confini della sovranità (Gentili, ivi,p.7) del ruolo dei diritti fondamentali(Busnelli, ivi, 43) del dialogo tra le corti econtrolli dell’autonomia privata (Donato,ivi,295; Nuzzo, ivi, 431).
In materia di contratti internazionali si deveall’ Istituto per la uniformazione del diritto (UNIDROIT) il progetto più compiuto di elaborareun testo accettato dai giuristi di tutto ilmondo, sia appartenenti all’area di civil law,sia a quella di common law, sia a quellainformata alla sharìa in materia di contrattidel commercio internazionale (Bonell, anInternational Restatement of Contract Law. The Unidroit
78
Principles of International Commercial Contracts, Ardsley.N.Y., 2005). Il progetto, avviato decenni fa,ha trovato una prima realizzazione nel 1994, èstato integrato nel 2004 e poi nel 2010 (UnidroitPrinciples of International Contracts 2010, Roma,2010).
L’importanza dell’iniziativa , nellaconfigurazione dell’istituto del contratto, ètriplice: la traslazione in enunciazioniscritte predisposte in forma di “codice” (iredattori preferiscono che si parli direstatement) delle prassi della lex mercatoria ;la inclusione di principi comuni che innovanola concezione del contratto; la proposta di unmodello a cui si sono ispirati i Principles ofEuropean Contract Law e, a cascata, il DraftCommon Frame of Reference, il Feasibility Text,il Regolamento sulla vendita
XXXXXXXXX Certo , dal punto di vista della finezzadogmatica e della precisazione terminologica ,si può pensare che il testo non sia sempre inlinea con il rigore della cultura civilisticaitaliana, ma si deve apprezzare non solol’enorme sforzo di sintesi ma anche la chiarezzadel dettato. In più – e questo lo si deve almerito e alla lungimiranza dei suoi redattori –non si tratta, come si potrebbe quasinaturalmente immaginare, di un testo che sistudia di imporre i valori dell’economia delgrande capitale, dei “mercanti del diritto” (perriprendere la fortunata quanto ingiustificataespressione di Dezelay) , o dei commercianti
79
tels quels. Al contrario, la fiducia sulla qualesi deve fondare il contratto in ambitointernazionale (art.1.3, pacta sunt servanda)è taleda esigere il rispetto della buona fede e del fairdealing, in cui è incluso anche il divieto diabuso del diritto (art.1.7., op.cit.,p.20) , siimpone la cooperazione tra le parti (art.5.1.3.,op.cit.,p.149), si dà ingresso al controllodella gross disparity tra le parti che dà luogo adannullamento del contratto(art.3.2.7.,op.cit.,p.108 ), si consente larinegoziazione e l’adettamento del contratto daparte del giudice in caso di hardship (art.6.2.1.,op.cit.,p.212) e così via.
Appare persino superfluo sottolineare comequesti principi siano stati enfatizzati dallanostra dottrina che si è occupata dei contrattid’impresa, dei rapporti tra le partiimprenditoriali di diverso potere contrattuale,di conservazione del contratto attraverso la suarinegoziazione, oltre che delle clausolegenerali di cui si è detto.In sintesi, anche l’autonomia contrattuale, chepure è sempre stata uno dei vessilli del liberocommercio , non è senza limiti in un ordinamentoche si sottrae alla legge nazionale e si affidaa principi universalmente (o convenzionalmente)riconosciuti .
Il timore, espresso anche da recente daqualche commentatore, è che l’applicazione (nondi questi principi, ma) in generale di regolesovranazionali, possa sottrarre le parti al
80
rispetto di regole di elementare correttezza edi favorire i più forti, specie se il veicoloper realizzare questo scopo è l’arbitratointernazionale. I lodi internazionali sonoinfatti difficilmente sindacabili , attesi ilimitati poteri dei giudici nazionaliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clausola compromissoria, clausola diconciliazione , arbitrato irrituale: ilcontratto come strumento di “giustizia privata”
La clausola arbitraleLa clausola di conciliazioneL’arbitrato irrituale
Eteronomia/ autonomia:il conflitto tra l’intervento legislativo ela libertà dei privati
Il controllo giudiziale
Come si è anticipato, la giurisprudenza haaccompagnato l’evoluzione della concezione delcontratto, e della sua applicazione, in tuttiquesti decenni, seguendo gran parte deisuggerimenti offerti dalla dottrina. Leinnovazioni non hanno registrato una perfettacoincidenza: si registra un andamentodiacronico, in parte perché la modificazione
81
degli orientamenti è dovuta alla mediazionedella cultura forense, poiché il giudice deveper l’appunto giudicare iuxta alligata et probata, enon può prescindere dalle domande formulatedalle parti. Spetta quindi all’avvocatoprospettare le nuove tesi, e la cultura forenseche si esprime nel processo è tendenzialmentetradizionale e conformista, e normalmente piùlenta ad aggiornarsi e a modularsi secondo lenuove esigenze di quanto non lo sia, invece, ladottrina accademica. Diverso è il discorso sullacultura forense stragiudiziale, che invecesembra, per certi aspetti , sopravanzare oanticipare la dottrina accademica.
Sul controllo giudiziale del contratto laletteratura è cospicua. Oltre ai commentari alcodice civile e alle raccolte di giurisprudenzaannotata, si devono segnalare le opere che sisono preoccupate di individuare i leading cases .Ad alcune, nate in ambito genovese, si è fattocenno; particolarmente significative sono leraccolte di Dogliotti e Figone,
il volume curato da Caringella e Cicia, Lesentenze storiche del Diritto Civile, Roma, s.d. (ma 2008),l’ Antologia di leading cases a cura di Alpa e Sbisà,Padova, 2001 a cui vorrei aggiungere Iprecedenti
XXXXXXXXXXXXXX
Le prassi
82
Le riviste di settore
Quesiti finali
il codice ha retto, ma reggerà? È una tavolacombinatoria di valori, rispecchia quelliattuali? È in linea con il FT? Dobbiamointegrarlo correggerlo o lo teniamo così?
Visto dall’alto dei sette decenni le regole
sul contratto, come disegnate dal codicecivile, sono notevolmente mutate nel lorosignificato, così come è mutata la definizionedell’istituto nei suoi profili generali. Lageneralità delle espressioni normative, laelasticità dei principi, la capacità diadeguamento delle tecniche ermeneuticheconsentono però di conservarlo, di annoverarlotra le “persistenze” della nostra culturagiuridica, e di confermarne la vitalità.
Posso allora concludere con le parole delMaestro più volte ricordato: <in definitiva, ilcontratto, nelle sue inesauste e inesauribilipossibilità di adattamento, sembra eterno, come
83
è eterna la necessità di un’intesa tra gliuomini>.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________----------
:
84