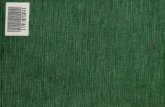Pasciuta "Homines aut liberi sunt aut servi". Riflessione giuridica e interventi normativi sulla...
Transcript of Pasciuta "Homines aut liberi sunt aut servi". Riflessione giuridica e interventi normativi sulla...
INCONTRI MEDITERRANEINUMERO MONOGRAFICO - XVII - I-2I2OO8
Schiavitù religione e libertà
nel Meditenaneo
ftamedioevo ed età moderna
a cura dí
Giovanna Fiume
LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE
Homines uut liheri ,ruril (tLtl ,\('rvi: rillcssionc
giuridica e interventi normativi
servile fra medioevo ed età moderna
sulla condizione
BEATRICE PASCIUTA
<Et quidem sllmma divisio de iure personarum haec est, qttod omnes ho-
mines aut liberi sunt aut servi>>r: la summa divisio che Gaio pone a fondamen-
to clel diritto delle persone nel I libro delle sue Istituzioni costituisce una delle
tappe fondative del concetto di schiavitù nel diritto romano classico2.
La differenza fra esseri appartenenti, fìsicamente, alla medesima catego-
ria viene fondata sul izs: è una differenza de iure,immateriale eppure assolu-
tamente clefinita e molto piùr concreta della presunta appartenenza degli ltorni'
nes alla medesima specie animale.
Qtresta operazione di costruzione logica di categorie organizzative degli
assetti sociali può essere assunta a paradigma dell'operare giuridico: il giuri-
sta recepisce istanze provenienti dalla società ,le organizzafonnalizzandole in
categorie clel diritto e le restituisce, per così dire, alla società stessa, la quale a
sua volta si baserà su di esse per dare vita a nuovi rapporti sociali3.
ora per quanto riguarda il problema della schiavitù,la differenza essen-
ziale,maggiormente rilevante dal punto di vista del giurista, consiste proprio
nella posizione assunta da liberi e servi nei confronti del irrs: i primi - i liberi
- sono soggetti di diritto, i secondi - i servi - ne sono oggetti.La condizione di schiavitù assimila il servo alla res,lo sottopone al diritto
,r Questo testo è 1a dproduzione feclele della relazione tenLrta al Convegno <Schiavitù e conversioni
r-eligiose nel Mediterraneo di età medievale o moderna" (Pderno,2l-23 nraggio 2007);l'apparato
di note è pertanto limítato alle citazioni e alle indicazioni bibliografiche essenziali a lomire un
orientamento sul tema.
I Gaio, Instittrtiones, 1.9.
2 Il tema della schiavitù è uno dei più consolidati nclla storiografìa giuridica romanistica. Per
tutti cfr. le inclicazioni generali fornite da G. Franciosi, Sc hiavitii (dir. ntmano) in Enciclopedict
del diritro, Milano, Giuffrè, 1958-2007, ad t'ocem.
3 A. M. Hesptrnha, Introduzione allct sktria det cliritto europeo,Bologna, Il Mulino,2OO3,p'29.
48 INCONIRI MEDITERRANEI INCONTRI MEDITERRANEI 49
ttlhrrr"rr, ,'rttil,lr,,t, tttt'tt.ttlt ttrttttt'tlttt rtll,t",tr,lr tttttt \ttttlt
Ir,r trt, '1t", tt' t rl t l.t ttr\lt tttt
rli proprir'l:r r'lo grri vtr rluinrli rrorr soll;urlo tlt'll:r lrlrcrlrt,;xrrrcrttlolo rtclllt lolttletlisporrilrilillr tlt'l srro lllrtlrorrt' ,,tkrrrritris in st'rvos vilitt' rrt't istlrrc lxllcstatctltt.SSC,,'r rrrir irnclrc tlt'llir cirplrcilir gitu'itliclr cltc irt rtllirtrt itttitlisi ò cottnessa e
rlt:lclrttittir lrt tltrirlitir rli ttottur, tli 1tcr.srtntr.l'ir lilx,rtus cornc è rroto è irrfhtti il rec;uisito indispensabile per poter ave-
rc cirlracitir giuriclica: chi non ha libertas non può essere titolare di diritti sog-
gcttivi e, se uon ha tliritti soggettivi, è assimilato ad una res; è oggetfo di do-tttittiturt e come la res è sottoposto alle forme tradizionali di alienazione, qualil ;r t' i nd i cctt io, la ma nc i p atio e pi ù tardi l' emp t io -v endit io .
E tuttavia, è innegabile che anche per il diritto romano classico lo schiavoIrir alcune qualità che lo differenziano dalla res: al servo vengono riconosciuteIrlcune specifìcità che sono inevitabilmente connesse con la sua intrinseca qua-
lità "Íìsica" di uomo.Il fondamento giuridico della condizione del servus,neltliritto romano classico, è infatti una "quasi" assimilazione alla res, che con-scnte, ovviamente, una notevole dose di flessibilità.
Innanzitutto egli può mutare la propria condizione e acquistare la qualità ditromo libero mediante lamanumissio. Del resto, anche I'uomo che nasce liberopuò perdere il suo s/a/us originario nel momento in cui viene preso prigionierorlal nemico, subendo la capitis deminutio maxima; soltanto attraverso il riscat-ro clalla prigionia e al suo ritorno in patria egli potrà riacquistare la titolaritàrli tutti i rapporti giuridici, ad eccezione di quelli che impongono continuità inrrtto quali ad esempio il matrimonio o ancora il possesso. La libertà dunque è
run requisito che ha una duplice connotazione: può essere originario ma si può
rurche acquisire e/o perdere e in questa 'mobilità'del concetto, in questa sua
contingenza, risiede proprio uno dei punti nodali dell'idea stessa di schiavitù.La sumnta divisio gaiana viene ripresa ed inserita in due luoghi della com-
lrilazione giustinianea - Inst., 1.3 e D., 1 .5.3. - che diventano le sedes mate-
riae dell'interpretazione del concetto di schiavitù da parte della scienza giuri-rlica medievale, oggetto specifico di questo intervento.
Come è noto I'attività dei giuristi a partire dal XII secolo si fbnda su un la-
voro di interpretazione creativa del diritto romano-giustinianeo; una intetpre-tazione cioè clie basandosi sull'autorevolezzadel diritto romano lo supera con-
l'erendogli nuova efficacia ed adattandolo quindi alle esigenze - assolutamen-te differenti - della società del tempos. Attraverso I'imponente opera esegetìca
condotta sulle fonti giustinianee, si crea dunque una civiltà giuridica nuova,
îocalizzafa su un diritto generale e comllnque applicabile in via sussidiaria - ilcosiddetto itts comntune - le cui fonti normative principali sono il diritto giusti-
a Gaio, Instittttiones, 1.52.s P. Grossi,L'r,,rdine g,iuridico rnedievale,Roma-Bari, Lalerza,2}O6,p.l64 e ss.
niilìco c il rlililto cluronico, r su lrrir pl rrrrrlrl;r tlr rlrritti p:rtlicolitli i r'ositltle tliiuru pntprio - llltxlolti scllot'iltlrnt:rtlc tllri sirtgoli olrlinlttttcttli girlritlici.
Relativamente alla condiz,iorrcr giulitlictr rlcl sclvo, llr t'illcssiottc rlci girrlisticivilisti, artefìci del ins conutruilL', si rnuovc essertzialrnettte su due f'rottti: tuttlpiù generale volto all'individuazione delle caratteristiche giuricliche cli questit
figura, I'altro, più specifico, relativo alla capacità processuale del servo.Ora, quello della definizione del diritto delle persone è un ambito che pre-
senta già da tempo innumerevoli aspetti contraddittori, che rendono assai ar-dua, per i giuristi medievali, I'assunzione pedissequa della defìnizione gaiana.La summa divisio degli uomini nelle due categorie di liberi e servi resta cefta-mente il punto di paftenza ma le limitazioni a questa divisione così netta sonodi varia natura e sono tali da porre agli interpreti medievali non pochi proble-mi di armonizzazione logica delle fonti.
Innanzitutto la divisione contrasta con il principio dell'uguaglianza di tut-ti gli uomini sancita dal ius naturale: Isidoro da Siviglia, che, come è noto, èuna delle fonti più conosciute dalla prima scienza giuridica medievale, avevaaffermato che <<Ius naturale est commune omnium nationum [...] ut viri et fe-mine coniunctio,liberomm successio et educatio, communis omnium posses-
sio et omnium Llnam libertatem>>ó: il passo, che fra I'altro riecheggiava un'af-fermazione di Ulpiano <<cum iure naturali omnes liberi nascerentur>>7, veni-vattllizzato già da uno dei primi giuristi bolognesi, Pepo, nel famoso placitolombardo come argomentazione giuridica, ma forse anche e soprattutto poli-tica, per richiedere la pena di morle nei confronti di un uomo libero accusatodi aver ucciso un seryo8.
E per la verità quello dell'uguaglianza originaria - iure nature - è un te-ma caro ai primi glossatori bolognesi; i quali comunque si sforzeranno di ar-monizzare questo principio con il suo opposto, con la considerazione cioè chesecondo il diritto positivo gli uomini non sono tutti uguali.
L'armonizzazione dei due principi opposti verrà tentata dai glossatori -specie da quelli di prima e di seconda generazione - sulla scofia del dettatogiustinianeo, con I'aggiunta di quel 'buon senso', derivante in gran parte dalleinfluenze della canonistica. Tipico esempio di questa reinterpretazione - mes-
so in luce da Ennio Cortese - è la riflessione derivante dal passo ulpianeo sul-la manumissio: se per il giurista romano la manumissio del servo era una da-tio libertatise, per Irnerio - che glossava il passo del Digesto -la manumissio
6 Isidoro, Ert*m. 5.4.1; il passo è citato da E. Cortese, Il diritîo nella storia ntedíettale, Roma, Ilcigno, 1995, vol. II, p. 40, n. 86.1 D.,1.1.4.8 Cofese, Il diritto nella storia medievale, cit., p. 39 e ss.
e D.. 1.1.4.
50 INCONIRI MEDITERRANEI INCONTRI MEDITERRANEI
n()il ('f it |nltl(tli(, iltit utìlt tt',tli!tttitt,l:r tcsltlttrloil("( r(x"rlr Urlir r;rrirlilir llllltll'lt-Ir., irrrrirlir, t'lrt', pcl tlirlir t'orr lt' lllrlolc tlcl srro lrllir'vo llttlglttrr c poi cort lìogc-r ro, t' s<lltlrtlo rrirscoslir, vclitlit rlitllit cotttliziottt: sct vilc"'.
l;r tesi tlrrrttprc cltc lit lilrcÍà, pcr liplcrttlelc la glttssa irneriana ad Ul-piln<l, .,rurn ò urr cpralcosa chc si cliì al servo, rrìít un diritto che è in lui e
thc u lui si restituisce'>rr ben si coniuga con le istanze che in quello stesso
lrclirrcltr plovenivzrrro clalle sistematizzazioni della prima canonistica: la qua-
It'. conrc vedremo, puntava decisamente a dimostrare I'equivalenza fra di-rit(o rraturale e diritto divino e quindi, nel caso specifico della servitù, a di-nì()strîre che, almeno secondo il diritto divino, gli uomini godono tutti del-Lr rnedesima liberlà.
Vi era ancora un'altra questione fondamentale, che poneva ai glossatorirrorr pochi problemi nell'interpretazione e nell'adattamento del corpus gilu-
stirrianeo alla realtà dei loro tempi, quella legata ai vari livelli di gradua-zione della libertà personale. La constatazione dell'esistenza di situazionit'hc postulano tutte la graduabilità del regime della libertà personale era inslliclente contrasto con la assolutezza della prospettiva costruita dal dirittor1)rììÍìno, che fondava la divisione fra gli uomini esclusivamente sul posses-
s() o meno di un determinato ed unico requisito, ossia lalibertas. La mol-tcplicità di situazioni personali, comparse sulla scena già da alcuni secoli,spingeva adesso i giuristi ad interrogarsi proprio sulle incongruenze che ilrcgime del diritto delle persone, modellato sulla struttura gaiana, inevita-bilrnente poneva.
Secondo I'opinione che si affetma nella riflessione giuridica già a pani-lc dal XII secolo, la peggiore condizione di servitù è quella degli adscrip-ri<'ii; essi sono soggetti non liberi - perché possono essere venduti insiemerrlla tera - e non schiavi - perché il rapporto di dipendenza, giltrridicamente,rr<ln è nei confronti di una persona ma della teffa stessa; in buona sostanza lat'orrdizione dell'adscripticius configura una doppia dipendenza, nei confron-ti della terra e del padrone della terra, che è padrone anche di quelli che lalrrvorano: Rogerio, nelle Questiones super Institutis, afferma esplicitamentechc i servi della gleba <<infìmam servitutem pati potius dicendi>>r2.
L,a riflessione sullo status degli adscripticii vaniflcava nella sostanza lasttntnla divisio gaiana, in quanto poneva sulla scena il problema di sogget-
ti che partecipavano della condizione di servi e di liberi insieme, un tertium
''' Cortese,l/ diritto nella storia rnediettale, cit.,p.4O e ss.
,, <<Non ut aliud detur, sed ius quod in eo habetur ei restituitur>; il passo è citato da Cortese,1/,liritto nella storia medievctle, cit.,p.4O,n.87; la traduzione inserita nel testo è nostra.
': R. Conte, Servi ntedievali. Dinamiche del dirino cotnune, Roma, Viella, 1996,p.46.
51
,q('/ltl.t sttl clttltlc si sitt('l)l)('(()rt('('nlr:rlir lir rrllr',,.,rorrt'rl,'ll:r plrrrrlr rlollrirur t'ivilistica a partire tla lrltclior'. Mrr llr Ilt'ssrlrrlrtrr tlt'l rr'r'rrrrt' rlcllc lilrcltir pcr
sonali mostrava la suzt colnlllcssilà girrritlit'lr in:unlrito l)t1)ccsriuitlc. Qrri, irr-fatti, maggiormente ernergevarìo le corrtrirrltlizioni lì'ir i principi gcnerlli e leinnumerevoli sfumature poste dalla prassi dci tr-itrulrali c clalla casistica gitr-diziana; il tereno del processo costringeva la dottrina ad affiontare e a ri-solvere con nuove soluzioni, spesso circoscritte e apparentemente limitate alcaso specifico, il contrasto altrimenti insanabile determinato dalla sostanzialeinade guatez za delle schemati zzazioni di matrice romani stica.
Il principio generale vietava al servo di stare in giudizio. L'impossibili-tà era per così dire oggettiva: secondo la dottrina, anche la più risalente, ilprocesso era per antonomasia actus personarutn e poiché il sewo, semprein via di definizione generale, non possedeva lo status giuridico di perso-na questo rendeva logicamente impossibile che egli intervenisse come par-te nel processol4. E dunque, ancora nel XIV secolo, Cino da Pistoia potevaaffermare seccamente che il servo sta in giudizio non come parte ma corneres,non come soggetto ma come oggetto dell'azione processualers; e, primadi lui, Guglielmo Durante nello Speculum iudiciale aveva affermato, sullascofia del Codex giustinianeo che <<servus [...] non potest pro se vel pro alioagere in civili vel criminali callsa>>16.
E tuttavia, se questo era il principio generale,la medesima dottrina era al-trettanto concorde nel prevedere alcune specialissime eccezioni, solitamente
13 Conte, Servi medievali., cit.,p.37 e ss.; sul punto cfr. inoltre C.E. Tavilla, Homo alterius,. Irapporti di dípendenla persornle nella dottrintt del duecento. Il trattatoDehominicits di Martinoda Fano, Napoli, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, 1993; F. Panero,Servi e rustici. Ricerche per uno storía della servitit, del ,servaggi.ct e della líbera dipendenT,arurale nel I' Italia medíevale,Yercelli, Società storica vercellese, 1 990.la Il concetto del processo come actlts personarutn è consolidato nella dottrina giuridica sindai primi glossatori e dagli ordinesi iudiciarii della fine del XII secolo. Per un quadro delleprincipali tematiche procedurali cfr. i saggi di K.V/. Nòn. ora inseriti in Id.. Iudicium est actustrium personartrm. Beitrrige zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa, Leinen, 1993, KeipVerlag; L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius: Begriff und Liîeraturgattung,Ius commune, Sonderheft 19, Frankfurt, 1984; Ead., Ordines iudiciarii cutd libelli de ordineiudiciorum (from the Middle oJ tlrc Twelfth to the end of the Fi.fteenth Century),tn Typologíe desSources du Moyen Ag,e Occidental A-III.1, Turnhout, 1994, Fasc. 63.rs ..Servus non potest esse in iudicio, ut sit pars iudicii, id est ut iudicium substantietur in eo,sed potest esse ut res super qua litigatur", Cyni Pistorensis, In Codicem et ulíquot titulos prirníPandeclorum tomi, id est, digesti veîeris doctissinm Comnrentaria, Francoforti ad Moenum,l57B (rist. an., Torino, 1964), De iudic'iís,1. I,f .129r.16 Wiflelmi Durantis, Speculum iudiciule, Basileae 1574 (rist. an.,Aalen, 1975) t. l,p. 169,*2.17.
52 INCONTRI MEDI-IERRANEI INCONIRI MEDITERRANEI
r,lrrr.rl,':rrrtlr't'.,st'tllr p:rsst rlcl ('rxlttt'llttt\ltttrirrr('{r'' Sctotttlol)rrl'lrlttc,il scr-
\. lr.l('vlr irviur/.:u(' rrrir srrlrplit:r :rl pirrtlicr',l)('r :i('() Pt't tl strrl llittlt'tltìcrn c ittt-.,rr.r lx)l('vlt :rllrilllrrt' irr t'ollt';:i lrrllillrrli ()ll()Hcnci, t'orttlxlsli citÈ soltanto da
,,|\|()((()lt'sollolirrcirrcc'lre in(lu('sl()r'lrsol'lttltilllrtrltlcl scrvo,ctlsìstruttu-r.rt( r. :l t :rnrltcrizzirvil c()tììc iu'l)ilrirl() tlt irtrc; o ciò asstltììe un rilievo particola-r(. l(.nuto t onlo clre lir slcssl tkltll'irrl. rclalivarìrerlte alla condizione rJi un'altrar .rtt'1,111.ii, l)iu'lic()lirrc, (luclliì 1èrtttttittile, iìfl'ermava che di regola le donne non
t,i, ..,ono rrrtri irll.ri(rlrc c chL' tuttavia qllando per la loro Specifica posizione di
l,,u lr( ( )llu'c pl'c:itigio o pe r consuetudine locale questa prerogativa sia loro con-'.r'rrtrl:r, (ìssc arbitrer'tìltlto /.)ft/ honrt et equo e non de iurete.
lr rrrrcolir. altra signifìcativa eccezione rispetto alla regola dell'assimilazio-rr, lr:r st'rvo e rcJ, efa il caso in cui il Servo fosse convenuto civiliter vel crimi-uttlrtt,t . t;rri valevano le medesime regole dell'azione intrapresa contro l'uomoIrl,r'ro, slrlvo che, avverte Durante, il libello doveva essere rivolto in persona
,lt'ntitti'. l'azione quindi si esercitava nei confronti del padrone che in questo
' ,r',. r icporì(leva dell'operato di un soggetto di sua proprietà20.
Lrr c'onrplessità della materia e la sua intrinseca contraddittorietà vengono,rll rontrrtc clalla scienza giuridica civilistica con il ricorso ad una casistica det-
r.rl,lrrrtrr che pone di volta in volta le innumerevoli eccezioni alla regola, rive-l.rrr,lo llr sostanziale impossibilità di fissare uno Schema unico e coerente in re-
l.rrrorr('al regime giuridico delle persone.(.)ue sta intrinseca contraddittorietà, tuttavia, emerge assai più chiaramente
rrrI I;r rloltrina giuridica canonistica.ll ;rrrrrto cli partenza, fìssato da Graziano îel Decretum, è il celeberrimo
1r;r:,:;o tli Agostino nel quale si afferma che per diritto divino omnia sunt com-ttrrtrtitt rtttrnibus e quindi, in nome del diritto divino, non si può rivendicare lapro;rrictlì di nessuna cosa, servi compresi; tuttavia, continuaAgostino,la pro-
1,r rr.trr rle lle cose e dei servi è rivendicabile secondo il diritto Llmallo, quel di-r rn, t'ioò che è creato dai sovrani per volere di Dio2t.
' I r:r lt: costituzioni deI Codex giustinianeo citate da Durante per argomentare le circostanze in,lr lirrcll()lageneralenondovevaessereosservata,CJ.3.l.6,CJ. 1.19.1,CJ.9.41.1,CJ.8.5.1,I I t.l().11.
' \\r I )uluntis, Speculwn ittclicirtle, cit., t. I, p. 896.
' ' \V I )rrllntis, Speculwn iudiciale, cit., t. I, p. 104.
" \V I)rrrantis, Speculun iudicíale, cit., t. I, p. 169.
, .l)ivinum ius in scripturis divinis habemus, humanum in legibus regum. Unde quisque
1,,, ,1;1q[,t, quod possiclet? Nonne iure humano? Nam iure divino "Domini est terra et plenitudo
, rrr:r". I,luperes et divites de uno limo fecit, et pauperes et divites una teffa supportat. Iure ergo
Irrlrr:rrìo dicitur: hec villa mea est, hec domus mea est, hic servus meus est. lura autem humana
rilr.r ilìtPcratorum sunt: quare? Quia ipsa iura humana per imperatores et reges seculi Deus
, I r',t r r lrui I generi humano >>, Decre tunt, D. 8, c.l.
53
Itt c;ucsto cottttttlrirt ;lossi:rrrro rrrrlivrrlrr:rn' il rrotlo ( r'ltlt'irl(' rlt'llir lillt'ssiorrt'catìonistica sulla cttlttliziottc scrvilc: rrrtir rnctlesirììir niìlura ccl rrno slcsso tlilit-to - la legge di Dio - ma una altrettanto lìrrrclata c legittirna dill'crcnza clcttatadal diritto umano, che, in ultima analisi, è ugualmente voluto dzr Dio.
Il diritto canonico ha evidentemente un problema di coerenza, di armoniz-zazione fra il precetto appartenente al supremo diritto, ius divinum naturale,secondo il quale gli uomini nascolto uguali e tutto appartiene solo a Dio, e ildiritto umano che - sia in ambito civile che in ambito canonico - prevede e di-sciplina la diseguaglianzafra liberi e non liberi.
Questa duplice e contemporanea coesistenza di due piani opposti, che de-vono tuttavia essere continuamente concordati tra loro, crea, nello specifico,una molteplicità di situazioni contraddittorie che di volta in volta i giuristi ri-solvono con soluzioni alquanto artificiose. Esemplificativo, a questo proposi-to, è il confronto fra due passi del Decretum di Graziano22 che palesano la dif-ficoltà ad armonizzare due principi diametralmente opposti.
Nel Decreto di Graziano, sulla scorta dell'omonima raccolta di Ivo di Char-tres23, veniva riportata una decretale di Gregorio Magno nella quale si affer-mava che se i serui ebrei o pagani al servizio di padroni della stessa religionesi fossero convertiti al cristianesimo avrebbero dovuto essere sciolti dal vin-colo della servitù e riacquistare la libertà; ciò in nome del principio che è bla-sfemo che un cristiano stia a servizio di un ebreo2a. Questo principio, peraltro,era anche proprio del diritto civile in quanto già nel Codex giustinianeo il pos-sesso di un servo cristiano da parle di ebrei, pagani o eretici veniva conside-rato un reatozs. Di contro, ai cristiani che servono ebrei o saraceni doveva es-sere comminatala scomunica; analoga punizione spettava, secondo Lln cano-ne del Concilio Lateranense III del 1179, inserito nel Liber Exîra26, ai cristia-ni che vendevano agli infedeli merci proibite - armi, ma anche materie primeper fabbricarle, ferro e legname, innanzitutto - e a coloro che, pur essendo cri-stiani, goveflravano le navi corsare e saracene: se catturati avrebbero dovutoessere ridotti in schiavitù. I-a schiavitù dunque è strettamente correlata all'ap-partenenza religiosal e sempre con maggiore evidenza diviene qrnsi un corol-lario della formidabile arma della scomunica che la Chiesa, a partire dalla ri-forma gregoriana, aveva sempre più perfezionato.
22D.54,c. 15 e D. 54,c.22.ts Iv o, D e cre tum, lll,lO6.2a <Nefas est quem Christus Dominus sanguinis sui effusione redemit blasphemum Christianereli gionis in vinculis tenere>> De cr., D.54, c.l9.
'?s CJ.1.10.1 e inoltre CJ.l.3.54.8; CJ.1.3.54.9: CJ.l.3.54.10.26 x.5.6.6.
54 INCONIRI MEDITERRANEì
t] I)ecr.,D.54,c.22.
INCONTRI MEDNERRANEI 55
fr!,,'f.rlt j.rl r'r\r,l/t\\ittr.t:,ttf.rrtttt'titt"t'''*i"""",,,t,' ,t',t,,,t,tt,',,'',,tt,t,l t.rtrtth\lttrtt
M:r il tltrlttlro t'osl tlt'liltt';tlo vit'ttt' lltttlottrl:tttlr'ttlt't rrttlt;ttltlt'llo tl:t tttt ltlltolrrogotlt.l l)t.trt'lorli (illrzilrrro,tk'rlicitlo:tll;trotttltzt,rttt'tlt't '-t'rvrtlt'llclrlrlrltzit't.rlt.i r16rlrsteli,tli sclvi t'r'islilrrti,r'ior',itl ,'l'rvt/to tlr t'rtli rcligiosir/. lrt tlttt'slrl
,.lrso llr risposf tr tlcl tlir itlo clrrrorrictr ttr'lllt rk'lrnrzrottt' tlt'lllt t'otltttt(itzittttt' girrr i
tlit tr llrollctrtlc rlccisirrrrcrìtc l)ct' l'irtlcsiottt' rrl tlir lllo rrrttltll(), ll'ltscttrattcltl i lllirr-t.ipi rrnivclsirli tlcl tlilitto rratrrralc:. l,'ltbllc o il ttttlttltctl irl'l'crtttlt itt cllte.sttl ca-,,o il rlirilto canorric<l - lìotì poss()no clarc la Iiltcltà itl scrvo clell'abbaziit tl tlcl
rrrerrirster6. rrealtche se cluesti rnanif'esti lzt voltllttà di prendere iv<lti; e inlzrtti
soltirrrto il padr<lne ha cliritto cli liberare il suo servo e non si può alienare ttnit
('osit tìon propria; quindi poiché il servo non appartiene all'abate ma all'abba-
zil, cgli non può essere liberato dal vincolo della servitù, neanche da colui cltc
l,t() t(ntpore detiene all'interno dell'istituzione religiosa la massima autoritit.
La qualità personale, legata all'appartenenza religiosa, diventa allora di-sr'r'irninante per I'access o allo status servile: chi non era cristiano e si cOltver-
tc ucclr,rista l; libertà, ma chi era cristiano, e servo della Chiesa stessa, non pttt\
rrtutíìre la propria condizione, per evidenti ostacoli di tipo giuspositivo.
Le armonizzazioni fra diritto divino e diritto umano sono evidentemertlc
lrrlicose e particolarmente cavillose. E se le prime fonti del diritto della Chie-
sit avevano risolto il problema, come abbiamo visto, separando nettzrmente lit
slcr-a del diritto umano da quella del diritto divino e riprendendo corl coererìz,il
il rlcttato gelasiano dell'utraque lex,ladottrina canonistica piùt matura avvertc
I'insuflficienza di questo tipo di argomentazione e la sua assoluta contracltlit-
torietiì. Questo fa sì che la riflessione dei giuristi canonisti, ma anche la slcssrt
rrolrnazione pontificia a partire dal XIII secolo in poi, cambi ptogressivlrttctt-
tc utteggiamento nei confronti del problema della defìnizione giuridica tlcl se:t'
vs, facendo sempre più ricorso all'argomentazione del peccato e all'iclcntif icl-zigne della schiavitù come punizione, orientando la Chiesa a pref'erire clccisit-
rììeltte la condizione servile di appartenenti ad altre religioni e ad incoraggiitt'tr
in ogni modo le affrancazioni di schiavi cristiani o di battezzati.
Ma re le categorie generali previste dal ius commune ruotavalìo itllorrttl itl
lir rielaborazione di quelle di matrice giustinianea, ben diverstt errt la silttitzio
ne degli iura propria.A mo' cli premessa occoffe puntualizzare che la legislaziottt: tli itt.s 1tt ttltritttrr ,
il cliritto positivo dei cosiddetti ordinamenti particolari, dispoltc sctttplt' stt si
trrazioni specifìche, e tralascia quanto già previsto dal ius cotttttttttt(. Orrr. rrcl
caso specifico della problematica legata alla condizione scrvilc, vrt ttotltlo t'ltt'
cssa è una di quelle maggiormenfe caratteizzate da un localisltro ttttt'tlllllivtr
rumpiamente variegato; questo evidentemente in ragione del fatto cltc, irl tli lrt
clelle schernatizzitzittni gerrcrali crl lrslrirllc, ll rcaltir clcl lcgirrrc girrlitlico tlcllt:persone, e la graduazione delle libertà individtrali, em esseltziallrrcntc utìî rc-altà che si fondava sulla consuetrrdine e che pertanto si pleserrtirvir olll'crnorkrcomplessa e articolata.
In vinù di questa considerazione la schematizzazione che qui ci imponiamoci porta dunque ad occuparci della situazione del regnum Sicilie, affiontando-la prevalentemente dal punto di vista della normazione regia. È una prospetti-va che non ha owiamente pretese di esaustività ma che è tuttavia strumentaleper evidenziare gli ambiti di intervento di una normazione positiva su un qua-dro consuetudinario ben consolidato.
La normazione del regno di Sicilia relativa ai servi - più o meno presentein maniera inintenotta dalle Assise di Ruggero II fino alle Prammatiche cin-quecentesche2s - si concentra prevalentemente e in misura sempre più marca-ta sulla schiavitù di tipo "etnico" e quindi sulle differenze di status fra sarace-ni e cristiani e segna, come elemento caratteristico, la connessione fra appar-tenenza religiosa e condizione servile.
La legislazione più organica che riguarda la condizione servile è quella,ben nota, di Federico III emanata a Messina nel 13102e.
Si tratta di un corpus di disposizioni legate dal tema della conversione re-ligiosa degli infedeli, in cui, in ossequio alla dottrina ormai prevalente,la con-dizione servile rappresenta il corollario indispensabile dell'appartenenza re-ligiosa.
Innanzitutto,le norme favoriscono la conversione dei servi musulmani. Ilcapitolo di aperlura è introdotto da un preambolo solenne nel quale il sovra-no afferma che la necessità di compiere azioni significative a favore della fe-de cattolica è la condizione indispensabile <ut Christi nomen, quo vocamur etdicimur Christiani in vanum assumpsisse non videamun>30; pertanto si stabi-lisce, come nonna generale del regno, che il saraceno, sia libero che servo, ilquale voglia battezzarsi deve poterlo fare. Ciò ha un'ovvia rilevanza giuridicaproprio nei riguardi della condizione del servo e della sua connotazione comeres di proprietà di un dominus; la norma prescrive infatti che il signore dovràconsentire al seruo dibattezzarsi e lo dovrà aiutare; nel caso in cui invece tenti
28 M. Gaudioso, kt schiavitit domestica in Sicilia dopo i Normanni, Carania, s.e., 1926 (rist.an. Catania, Maimone , 1992),p.25 e ss. Sulla schiavitù nel Mediterraneo cfr., inoltre, i recentisaggi raccolti nel volume /,a schiavitu nel Medíterraneo,a cura di G. Fiume, "Quaderni Storici",n.107,2001.2e Federico III, capitoli 59-75 in Capitula regni Siciliae a cura di F. Testa, Panormi, Ii{l ,vol.I, p.76 e ss.; sulla legislazione del 1310 cfr. B. Pasciuta , Placet regie naiestaîi . Itinerari dellanormazione nel tardo medíoevo sicíliano,Torino, Giappichelli,2005, pp. 116-117.30 Federico IlI, cap. 59,rn Capitula regni Siciliae cit.,p.76.
56 INCONIRI MEDITERRANEI INCONTR] MEDITERRANEI 57
tlllt\\ttttlt t:tlttl.llttl, tttlttt'tt!'tttittrtttlltt \ttll'tl.ttttlt ttttlt \ttltlt
Ir,t tu, ,lt' ttt' , rl tttt n, \lt t tttt
rlr osllrt'ollrllo srrlrillr llr t'olrtlirnrtir irtl ttrt lrtttto tli t':tttt't't't'il st't'vo. bttllczzttltt,rr:rt'rlrrislclir ltr Iibclttr. Llr llclrir trllli((ivlr, irrolttt'. slnr cottìrttitrlrllr a (tttti coltlr<l
clrc irrrpc:rlirirnrro irr tprirlsiirsi rtttttkr il bitllcsittto tlci scrvi sal"acelìi.
l.'inlcrvcnlo nolrnutivo. ncl suo cornplcsso, tcttclc at delineare una nuovar'ontliziouc del servo corìvertito, sulla scorta sia dei principi già presenti nel('tulct'giustinianeo e nella tradiziclne interpretativa del ius conlnililrc sia so-
l)nrtlutt() della dottlina derivante dalle Lettere di San Paolo; i testi paolini, in-l:rtri vengono piùr volte citati e talvolta inseriti nei capitoli quasi a costituir-rrt' I'csclusivo dettato normativo. Il cap. 60 è imperniato tutto sulla Lettera diI'rurlo a Filemone, il cui testo viene parafrasato e costituisce il disposto stesso
tlt'lla uorma: ..Suscipe illum iam non ut servum sed ut fratrem carissimum inI krnrino et in came>>3r.
ll precetto paolino del servo uomo e fratello del padrone è qui assunto co-rnc parametro giuridico per il trattamento dello schiavo che si sia conveftito e
clrc abbia ricevuto il battesimo. E tuttavia lo svolgimento complessivo del pen-
sicnr di San Paolo, e il suo sviluppo specialmente nella prima Lettera ai Co-rinzi32, ribadiva la necessità di un cambiamento che fosse interiore e non so-
r irrlc. Ciò rendeva possibile, da parte del legislatore, I'assunzione del tema delr;t'r'vo-fratello, inteso per lo più nella sua accezione squisitamente teorica; uti-lizzlndo un'altra citazione paolina - questa volta inserita integralmente nellanonìra - Federico disciplinava il comportamento reale che avrebbero dovutol('ncre i servi che avessero ricevuto il battesimo. <<Quicumqlle sunt sub iugo,sclvi dominos suos omni honore dignos arbitrentur, ne nomen domini et doc-trirra blasphemetur. Qui autem fideles habent dominos, non contemnant. quiaIlrrtres sunt, sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii par-ticipes sunt>>: il passo della I Epistola a Timoteo33 erattilizzato come giusti-f reirzione al mantenimento dello status servile previsto dal legislatore ancherrcl caso di servi che si fossero conveftiti alla fede cattolica, i quali avrebberorlovnto rimanere nella condizione servile e servire il loro padrone ferventius
'' f icclerico IIl, cap. 6O,in Capitula regni Siciliae cit.,p.77.ll testo della Lettera di San Paolo a
I ilcmone(15-17)recitava<Forsitanenimideodiscessitadhoram,utaeternumillumreciperes,r:uìì rìon ut servum sed plus servo, carissimum fratrern, maxime mihi, quanto autem magis tibict in carne et in Domino>,
'r " ljnusquisque, in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat. Servus vocatus es? Non sit tibi, rrnrc; sed et si potes liber fieri, magis utere! Qui enim in Domino vocatus est servus, libertusL sl I)onrini; similiter, qui liber vocatus est, servus est Christi! Pretio empti estis! Nolite Iìerist'rvi hominum. Unusquisque, in quo vocatus est, fratres, in hoc maneat apud Deum > Ep. ad.( 'rtrinrh.l,7,20-24.
" l:p od Thimot.l,6.l-2.
llr '!llr' t I'rlìr llrl,l
(tt(lu( (l(t'()tirr,r'''r . Qrrcslir tntritrrizzlrziorrc rrcr r:r1r;rot'l i lllt sctvi crtttvetliti t'1xt
droni veniva ultcriot'nrcutc: rlclinittr rrrctlilrrrlt' lrr lrtt'st't iziortc tli alcLrrti oltblighiche i padroni clovevano avere rrci crlrrlìrrnli tlci loro sclvi: lir tttolivltziottc ct'tt
ancora una volta evidentemelrte ispirata dalla clottrina cattolica e tuttitvia il stttl
trfilizzo in una norrna generale e vincolante,la sua giuridicizzazione, dava al
precetto un sapore del tutto differente; i padroni dovevano attenersi ad un co-
dice compoftamentale che prevedeva il rispetto del servo, il divieto di malver-sazioni fisiche3s, il divieto di induzione alla prostituzione36 e perfino il divietodi appellare i servi neofiti, inclusi gli ebrei convertiti, con alcune ingiurie - ad
esempio, ca nes renegatos - solitamente riservate secundum nsum loquendi agliebrei e in generale ai non cristiani3T. Questi obblighi compoftamentali veniva-no giustificati con I'assunto che i padroni <licet sint domini servorum suorum,
tamen suorum membrorum domini non existunt>>3s e ancora che i neofiti, anche
se servi, dovessero essere trattati caritate lraterna ac humana [. '.1 benignita-tée,e venivano imposti con la minaccia di severe sanzioni che andavano dallacarcerazione del dominus alla immediata liberazione del servo.
Infine un trattamento parlicolare è riservato ai servi greci de romania: per
costoro il regime della schiavitù è mitigato dalla comune matrice religiosa che
porta il legislatore a prevedere ad esempio il consenso del servo alla sua ven-
dita a persona suspectaq o la immediata restituzione della libertà a coloro che,
avendo giiì servito per sette anni, decideranno di abiurare I'eresia e ritornarenella fede cattolicaar.
Ovviamente questa "vmanizzazione" del servo cristiano, e del neofita inpafiicolare, impone ai giuristi che operano sulle notme del Regnum una ulte-riore riflessione circa la effettiva assimilazione del servo alla res.In particola-re, il divieto di maltrattamenti espressamente previsto dal cap. 62 ela possi-
bilità per il servo maltrattato di chiedere di esser venduto - nonché la possibi-lità che il servo greco de rontania rifiuti di esprimere il proprio consenso alla
3a Federico III, cap. 6l ,in Capitula regni Sicilíae, cit., p.77 .
3s Si vietava di "vulneribus ac flagellibus afficere, aut aliquod mernbrum illis inciderc. val
devastare, in facie, vel in fronte signare, aut in ea aliquatenus insaevire" (Federico lll,cap.62,in C apitLtla re gni S icil iae cit., p. 77).36 Federico III, cap. 7l,in Capitula rcgni Siciliae cit., p. 81.
37 Federico III, cap. 63,in Cqtitukt regni Siciliae cit., p. 78.38 Federico III, cap. 62,in Capitula regni Siciliae cif .,p.77.3e Federico III, cap. 63,in Cupitula regni Siciliue cit., p. 78.a0 Federico III, cap. "73, in C a pitu La rc gn i S i c i I iu e cit., p. 82.a' Federico III, cap. 72,in Capitulu ragni Siciliue cit., p. 81.
5R INCONTRI MEDITERRANEI INCONIRI MEDITERRANEI 59
l',t ttt,,lt,', t,',,l , r,t ttt,rl, t tt,r
stllt vt'tttlillt (()ttltltsl:t ttt lìtitttt('tit t'vltlt'ttlt't ott ll illlli( tlìl() tll tlitillrt (()llltlll('- già lol rrrlrlitt,alo lrt'l ( \xlit t' giuslirrilrrrt'o r'lrr' rtt ',rtuto l)u() ('\ri('t'c cttstl'cl-to ir vcntlclc t'(tìt,\'tt(un. Nci ('ottttttcrtlltti rti ('rtltilrrlrt tt'.qtri ,\icilitu', r'cclatti dal
giurista llalcrnritalro Mulio Mrrtrr irgli irrizi tlt'l XVll sccoloar, il problelna del-la congrrritlì tritil dorrtittirlrr srrl scrvo c i lirrriti posti clul legislatore all'eserci-zio di cluella potestiì etììcrgc con cviclcnte rilevartza. Commentando il capito-Io 62, Mutzr nota infìrtti che la prescrizione del divieto di maltrattare Lln servo,c la conseguente liberazione clello stesso in caso di comprovate sevizie o an-
cora la vendita coatta ad altro dominus,contrasta con il principio di tradizioneromanistica espresso nel Codice giustinianeoa3: secondo Muta <<quamvis ne-
rìro cogatur vendere rem suam, fallit tamen in servis male tractatist>4. Analo-giìmente le prescrizioni del divieto di vendita del servo cristiano, contro la sua
vtrlontà, a persona suspecta rappresentano una violazione - in senso contrario
- del medesimo principio: <<prope principium quod potest cogi dominus quan-rloque ex causa vendere suum servum, ita e converso potest aliquando prohi-bcri vendere personis infidelibus et minus honesti, et vidi in facto renuisse ali-(plos secus vendi non simpliciter sed certis personis>4s
La specialità della condizione del servo modifica dunque alcuni presup-posti del diritto civile, ma ha ovviamente rilevanza anche nell'ambito del di-ritto penale.
Esernplifìcazione di una casistica assai variegata e complessa è il com-rrrcnto di Muta al capitolo n. 166 di Alfonso circa la punizione dello stupro, e
lrr clifferenza di trattamento tra stupro con o senza rapimento e violenza6. Quiil giurista, sulla scorta di una tradizione intelpretativa ben consolidata, affron-trr il problema della violenza carnale commessa ai danni di una serva, fattispe-cic non considerata dalla norma alfonsinaaT. Muta dopo aver defìnito il reatotli stupro, quello di rapimento, e il concetto stesso di violenza, sottolinea chelo stupro con mpimento è un crimine talmente odioso da essere punito anche',(' commesso da un cristiano a danno di una donna ebrea. E tuttavia egli pone,1ui la differenzafra donne libere e sele: Muta intende la notma soltanto ri-Icr ita alle donne libere, anche se ebree; <intelligo primo hoc capitr.rlum proce-
' M MLrta. Capítulorum Regni Sicilíae regaliuntque cotrstiîuîionwn divorum regunr Federicí eî
l" rr i rlilucidationum...,Panormt ,16O5-1627: sul giurista e sulla sua opera cfr. B. Pasciuta , PlaceÍt, t'tt ntdicstati. Iti.nerari della nonrn.zione nel tardo medioevo sici.liano, cit., p. 93 e ss.
,' ( t 6.30.16.
" M. Mrrta, Ctrpitttlorwn, cit., vol. 2,p.207,$2.' lr r. 1r1.r. 217-218.
' ,,\ ll r rrrso V, cap. 166 ,in Capitula regni Sícíliae cit., pp. 261-262.
' l\1 Muta, Capitulorttm, cit., vol.4, pp. 374 e ss.
TIlleÈtrlcd I'drclillB
dere in stupro vel raptu fìrcto et corrrnrisso in libernrrr rrrulielern el idco irr an-cillas non habet loctrm>4. Ma se lo strrpro è cornrnesso con violerrza nllurn ilreo sia punito anche se la vittima è una serva perchè cprando il reato è clupli-ce e parlicolarmente efferato allora si ha la parilicazione: <par rrtio violnrrtissclavas et liberas>>ae; owiamente la fattispecie appare estremamente comples.sa poiché in questo caso si prevede esclnsivamente un processo accusatorio econ la ulteriore aggravante che per iniziare I'azione giudiziaria I'accusa clo-vrà esser presentata dal dominus, dal padrone della serva e non da tn quilibetde populo, ma, nonostante queste palesi limitazioni, la posizione della scien-za giuidica sembra orientarsi decisamente verso la costruzione di un modellogiuridico del diritto delle persone differente da quello tracciato nella tradizio-ne del diritto romano classico.
L'assimilazione del servo alla res elanetta divisione degli uomini in libe-ri e servi si rivela un presupposto teorico difficilmente sostenibile ad oltran-za.La dottrina quindi, e su di lei la legislazione di ius proprium, si impegna a
delineare un quadro giuridico particolareggiato e marcatamente casistico nelquale la specialissima condizione del seryo si colloca in una posizione inter-media fra persona e res,partecipando di entrambi ma finendo con I'assumereconnotati giuridici specifici e assolutamente suoi propri.
a Ivi, p. 376, $8.ae Ivi.
60 INCONIRI MEDITERRANEI













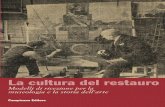

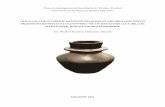
![Quaternionic root systems and subgroups of the Aut(F[sub 4])](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63253551584e51a9ab0b749a/quaternionic-root-systems-and-subgroups-of-the-autfsub-4.jpg)