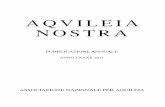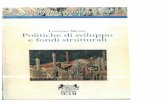Area II, saggio 5 in Aquileia, fondi ex Cossar - Missione archeologica 2013
Transcript of Area II, saggio 5 in Aquileia, fondi ex Cossar - Missione archeologica 2013
Aquileia - Fondi ex Cossarmissione archeologica 2013
DIPARTIMENTODEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIADELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA
Contributi di:S. Berto, J. Bonetto, V. Centola, S. Dilaria, D. Dobreva, G. Furlan, A.R. Ghiotto, E. Madrigali, C. Previato, A. Stella, S. Zago
Rilievi di:S. Berto, T. Luongo Progettazione e layout:P. Kirschner, A.R. Ghiotto
DIPARTIMENTODEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIADELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA
Piazza Capitaniato 735139 PADOVA +39 049 8274591/4587fax +39 049 8274613 www.beniculturali.unipd.it [email protected] [email protected]
La ricerca è �inanziata da Arcus S.p.A., Fondazione Aquileia, MIUR e Università degli Studi di Padova, Progetto di Ateneo 2012 “Conoscenza, tutela e valorizzazione. Le ricerche nei fondi ex Cossar di Aquileia come modello innovativo di approccio alle aree archeologiche complesse” (responsabile scienti�ico A. R. Ghiotto; codice progetto GHIOPRAT12).
In copertina: strutture produttive nell’area II, saggio 4 - calco di gemma a soggetto dionisiaco (IG 562481).
ISBN: 9788890842436
Aquileia - Fondi ex CossarMissione archeologica 2013
a cura di Jacopo Bonetto e Andrea Raffaele Ghiotto
Padova 2014
5
Sommario
Premessa Jacopo Bonetto,Andrea Raffaele Ghiotto
p. 7
Area II, saggio 1 Emanuele Madrigali p. 15
Area II, saggio 2 Caterina Previato p. 19
Area II, saggio 3 Caterina Previato p. 23
Area II, saggio 4 Vanessa Centola p. 29
Area II, saggio 5 Caterina Previato p. 37
Area III, saggio 1 - Ambiente 11 Caterina Previato p. 47
Area III, saggio 2 Simone Berto, Simone Dilaria, Guido Furlan, Sabrina Zago
p. 53
Area III, saggio 3 Andrea Raffaele Ghiotto,Emanuele Madrigali
p. 63
Area III, saggio 4 Jacopo Bonetto p. 71
Verso uno studio del paesaggio economico aquileiese. Sintesi dei dati relativi ai ritrovamenti ceramici della campagna 2013
Diana Dobreva p. 77
I rinvenimenti monetali Andrea Stella p. 93
7
Premessa
Dal 20 maggio al 19 luglio 2013, seguita da due settimane di ulteriori verifiche condotte nel mese di settembre, si è svolta la quinta campagna di ricerche archeologiche presso i fondi ex Cossar di Aquileia, conferiti in gestione alla Fondazione Aquileia. Le indagini sono state coordinate e condotte sul campo dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, in co-direzione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia.Le attività sono state dirette da chi scrive, con la collaborazione di Simone Berto, Vanessa Centola, Diana Dobreva, Guido Furlan, Tiziana Luongo, Emanuele Madrigali, Caterina Previato e Andrea Stella. A queste, scandite in tre turni di tre settimane, hanno partecipato nel complesso oltre 30 studenti, specializzandi, borsisti, dottorandi e assegnisti delle Università di Padova, Udine e Brno.Le indagini hanno riguardato due diverse aree di scavo, ubicate all’interno della grande domus che occupa il settore centrale dell’area archeologica. L’abitazione fu parzialmente indagata, a più riprese, durante il secolo scorso, per diventare poi oggetto delle nuove ricerche avviate nella campagna 2009. La prima delle due aree (area II) si estende nel settore centrale e orientale della casa; la seconda (area III) si trova invece nel settore occidentale, acquisito nel 2010 dalla Fondazione Aquileia e sino ad allora mai indagato dal punto di vista archeologico, se si fa eccezione per una lunga trincea esplorativa aperta da Giovanni Battista Brusin nel 1941 (“Aquileia Nostra”, XII, coll. 26-27).Gli scavi nell’area II hanno interessato innanzitutto l’esteso settore sud-est dell’edificio abitativo (saggio 4), in continuità con le indagini avviate nella campagna 2012. Lo scavo ha consentito sia di mettere in luce le tracce di una complessa e articolata sequenza di attività produttive svolte all’interno di un ambiente affacciato sul tratto stradale che fiancheggia il lato est della casa, sia di documentare i resti, seppur estremamente lacunosi, del cordolo di un sottostante e più antico asse viario con il medesimo orientamento nord-sud. Tale settore offre quindi molteplici spunti di interesse non solo per quanto concerne le vicende dell’edificio domestico, ma anche in relazione ad altri aspetti legati all’archeologia della produzione e alla viabilità urbana aquileiese.Nella stessa area II un secondo contesto di particolare rilevanza è stato riconosciuto nel settore settentrionale della casa (saggio 5), al fine di stabilire i limiti dell’edificio domestico in corrispondenza di uno spazio scoperto, già posto in luce lo scorso secolo, la cui lettura appariva però di difficile soluzione. Altri tre sondaggi, molto più contenuti dal punto di vista spaziale, ma di sicuro interesse per la ricostruzione delle fasi di sviluppo planimetrico dell’edificio, hanno interessato poi il settore orientale della casa (saggio 1), quello meridionale (saggio 3) e quello della corte centrale (saggio 2).Vari sondaggi hanno riguardato anche l’opposto settore occidentale dell’abitazione (area III). Le indagini in quest’area, condotte a partire dal 2010, stanno permettendo di comprendere nella loro interezza la planimetria, l’articolazione e i percorsi interni dell’edificio domestico. Ciò riveste un eccezionale interesse scientifico, poiché è questa la
8
prima volta in cui ad Aquileia viene posto in luce e affrontato sistematicamente lo studio di una casa di età romana nel suo complesso.In corrispondenza del settore centrale dell’area III, le indagini archeologiche degli anni scorsi hanno evidenziato l’esistenza di un originario nucleo abitativo caratterizzato da un impianto planimetrico riferibile alla tipologia domestica “ad atrio”, ampiamente diffusa in ambito romano in età repubblicana e alto imperiale, ma sinora mai attestata con sicurezza ad Aquileia.In questo contesto è stato affrontato lo scavo della supposta bottega affiancata all’ingresso della casa (saggio 3), contraddistinta da una complessa sequenza stratigrafica, e sono state condotte alcune verifiche puntuali all’interno dell’atrio e di un secondo spazio attiguo all’ingresso (saggio 2), nonché lungo l’asse stradale nord-sud dal quale si accedeva all’abitazione (saggio 4). Sempre nell’area III, è stata portata a termine l’indagine all’interno di un ambiente già parzialmente scavato lo scorso secolo (saggio 1), individuando una serrata sequenza di piani pavimentali sovrapposti e le successive tracce di un’interessante frequentazione tardo antica legata allo svolgimento di attività metallurgiche.Come di consueto, in parallelo alle indagini di scavo sono stati effettuati e costantemente aggiornati i rilievi planimetrici e strutturali mediante l’utilizzo di una stazione totale.Le ricerche sul campo sono state affiancate dalle operazioni di ripulitura, catalogazione,
classificazione e studio dei reperti ceramici, vitrei e metallici, nonché dalla classificazione dei rinvenimenti monetali presentati nel lavoro che chiude questa relazione.Infine, come da tempo avviene, si sono svolti vari incontri di programmazione tra i responsabili delle ricerche archeologiche e il gruppo di architetti dell’Università IUAV di Venezia incaricati di redigere, su mandato della Fondazione Aquileia, il progetto definitivo di copertura dell’edificio domestico e delle opere di generale valorizzazione dell’area.
Jacopo Bonetto, Andrea Raffaele Ghiotto
Domus dei Fondi ex Cossar. Immagine zenitale dell’area di scavo (Foto LTS, luglio 2011).
9
Gruppo di lavoro
Direttori di scavoJacopo BonettoAndrea Raffaele Ghiotto
Responsabili di scavoVanessa CentolaGuido FurlanEmanuele MadrigaliCaterina Previato
Responsabili dello studio dei repertiDiana DobrevaAndrea Stella
Rilevatori e disegnatoriSimone BertoTiziana Luongo
Operatori di scavoChiara AndreattaVirginia AvogaroGiovanni BettiAlessandro BiselloVittoria CancianiElisa CastellaccioMargherita ColomboMarianna ColussoBeatrice De FaveriValeria De Scarpis Di VianinoSimone DilariaGiulia FiorattoRosa FirettoChiara Gasparini
Tobia GirottoMarco GottardoLucia JiranovaEster LunardonNicolò MaresoFrancesco MasieroIrene MissagliaAlessandro PiazzaIsabella PiovesanLaura PizzolAnna RiccatoMichela RuzzanteElia SaviatestaGaia SinigagliaMartina Trivini BelliniSabrina ZagoValentina Zanus Fortes
37
Area II, saggio 5
Il saggio 5 si colloca nell’angolo nord-occidentale dell’area II, all’interno dell’area demaniale già indagata e valorizzata nel corso del XX secolo, in prossimità del vecchio limite di proprietà smantellato nel 2010. L’area di scavo, che presenta una pianta ad “L” e si estende per circa 32 mq, è posta a nord-ovest del grande oecus noto per il mosaico della pesca, al confine tra la domus di Tito Macro e la casa settentrionale dei fondi ex Cossar. La scelta di aprire un saggio di scavo in questo punto è nata dalla necessità di acquisire dati funzionali a definire il reale limite tra i due edifici, così da poter fornire adeguate informazioni planimetriche agli architetti incaricati della valorizzazione del sito, e trova motivazione nel fatto che si tratta di uno spazio privo di estesi piani pavimentali, mai indagato nel corso degli scavi precedenti e solo parzialmente interessato dagli interventi di restauro del secolo scorso1. All’inizio della campagna 2013, l’area di scavo risultava coperta da tappeto erboso. In alcuni punti erano presenti delle lastre lapidee disposte di piatto (1503) e dei blocchi lapidei a forma di parallelepipedo, la cui quota sommitale appariva nettamente superiore a quella delle lastre (1504 e 1505). Nell’area erano inoltre presenti due lacerti musivi ricollocati su soletta di cemento nel secolo scorso, e in particolare un lacerto di mosaico monocromo nero (1507) presso l’angolo sud-orientale, a ridosso del muro nord dell’oecus e parzialmente inglobato nel muro ovest dell’ambiente adiacente, e un lacerto di mosaico monocromo bianco (1506), situato circa al centro del saggio.L’area di scavo è delimitata ad ovest da una struttura muraria (5052) con orientamento nord-sud, e dalla relativa fossa di spoglio (-3111), a sud dal grande oecus situato circa al centro della domus, ad est da un grande ambiente pavimentato con tessellato policromo figurato e a nord da uno spazio identificabile in un corridoio porticato, di cui si conservano parte del braccio nord (sviluppato in direzione est-ovest) e parte del braccio est2.
Lo scavo
Completata la rimozione del livello humotico superficiale esteso su tutta l’area di scavo (1500), è emersa la seguente situazione. Nel settore orientale, tra il limite nord del saggio, il muro moderno 1513, il mosaico cementato 1506 e il mosaico 1507, affiorava un livello a matrice argillosa di colore giallastro, depurato e ricco di ghiaia (1511). A sud del mosaico cementato 1506 era visibile parte della sua preparazione in malta gialla (1509) e, più a sud, uno strato di colore
1 Questo spazio è stato a lungo attribuito alla domus centrale dei fondi ex Cossar, cioè alla domus di Tito Macro. A questo proposito si veda da ultimo Atria longa II 2012, scheda n. 20, pp. 78-80 e relativa planimetria.2 I pavimenti dei tre ambienti posti a nord, est e sud dell’area di scavo sono stati ricollocati su soletta di cemento nel corso degli interventi di restauro del secolo scorso.
38
marrone scuro, ricco di frammenti ceramici e laterizi (1510) e un livello caratterizzato dalla presenza di grumi di malta (1512). Nell’angolo sud-ovest del saggio emergeva una canaletta in pietra (1502), che si estendeva verso est fino alle lastre 1503. Ad ovest della canaletta, a ridosso del muro 5052, erano presenti invece un livello a matrice sabbio-argillosa di colore giallastro (1508), esteso per circa 2 m in direzione nord-sud e, più a nord, un lacerto del mosaico del corridoio porticato (1514) e la rispettiva preparazione in malta di calce compatta con inclusi piccoli ciottoli (1518). In prossimità del limite nord del saggio si distingueva invece uno strato marrone a matrice humotica (1517) spesso circa 20 cm e, nella fascia compresa tra il portico e il mosaico 1506, un livello scuro ricco di inclusi (1526).
Il settore orientale
Nel settore orientale si è proceduto quindi alla rimozione dello strato 1512, sottile livello marrone con grumi di malta, e dello strato 1510, di colore marrone scuro, contenente abbondanti frammenti ceramici e laterizi, tra cui un discreto numero di cubetti di cotto. L’asportazione di tali livelli ha permesso di riportare alla luce un esteso lacerto della preparazione pavimentale 1509, costituita da malta giallastra con inclusi laterizi e un minuscolo lacerto del pavimento che poggiava su di essa (1521) (Fig. 1). Si tratta di un tessellato monocromo bianco con fascia nera, cui si può attribuire anche il lacerto cementato visibile poco più a nord, ricollocato nel corso degli interventi di restauro del Novecento (1506). La presenza della fascia di bordura nera risulta di particolare importanza in quanto indica che ci troviamo in prossimità del limite occidentale del mosaico.Dove la preparazione 1509 non si conserva è emerso invece il sottostante livello di preparazione, costituito da frammenti di laterizi disposti di piatto (1524). Verso est, a circa m 1,45 di distanza dal muro 1513, la preparazione 1509 termina in modo regolare, e il suo margine presenta andamento rettilineo nord-sud. È ipotizzabile quindi che questo fosse l’originario limite orientale del pavimento ad essa sovrapposto. A conferma di ciò sta il fatto che il lacerto musivo 1506 conserva traccia, sullo stesso allineamento, di una fascia nera che segnava probabilmente il bordo del mosaico. Sulla base della posizione delle fasce di tessere nere che ci indicano quali erano i limiti est ed ovest del mosaico, possiamo affermare che in questo punto il tessellato aveva una larghezza di circa m 1.Più ad ovest, tra il corridoio porticato a nord, il mosaico 1506 ad est e la canaletta 1501 a sud, sotto lo strato 1517 è stato riportato alla luce un altro lacerto della preparazione 1509. In quest’area la preparazione 1509 è apparsa in uno stato di conservazione piuttosto lacunoso. Di essa si conserva l’originario limite nord, con andamento rettilineo est-ovest, mentre essa risulta tagliata verso ovest e ampiamente scassata verso sud, dove è intaccata da una buca (-1522), riempita da un livello marrone scuro ricco di inclusi (1523). La rimozione di 1523 ha permesso di verificare che la canaletta 1501 poggia sopra la preparazione 1509, ed è quindi successiva alla distruzione del mosaico a questa sovrapposto.È stato quindi rimosso lo strato 1526, riempimento di un taglio con andamento est-ovest
(-1528) in prossimità del limite nord del saggio3. Nella sua porzione occidentale il limite sud del taglio coincideva con il limite nord della preparazione 1509. Più ad est, la fossa tagliava invece il livello 1511 e gli strati ad esso sottoposti. La rimozione del riempimento 1526 ha permesso di mettere in luce la fronte orientale di un muro in mattoni con andamento nord-sud (1530), situato sotto il muro moderno 1513, che ne ricalca l’andamento.È stato quindi rimosso lo strato 1511, sotto cui sono emersi un livello di malta biancastra (1533), molto lacunoso, localizzato nell’angolo nord-est del saggio, una “macchia” di malta bianca con andamento sub-circolare (1535) in prossimità del mosaico 1507 e uno strato di ghiaia (1536), visibile a ridosso del muro 1513 e in prossimità della preparazione 1509. Tutti questi strati, subito rimossi, coprivano un livello a matrice argillosa ricco di frustoli carboniosi (1537). È stato quindi asportato lo strato 1537, spesso circa 10 cm e con pochi inclusi, e sotto di esso è emerso un livello sabbio-argilloso di colore verdastro, molto depurato (1563), tagliato in prossimità dell’angolo nord-orientale del saggio da una fossa con andamento est-ovest (-1564), riempita da un livello a matrice argillosa, di colore grigio verdastro (1565). Si è quindi scavata la fossa -1564, che si approfondiva per circa 80 cm. La rimozione del suo riempimento (1565), ha permesso di mettere in luce un altro tratto del muro 1530, posto sotto il muro moderno 1513. La struttura 1530 è costituita da mattoni sovrapposti di piatto nella porzione nord, e da scapoli lapidei legati da malta di calce nella sua porzione meridionale, e si arresta a circa m 1,5 di distanza dall’angolo nord-est del saggio. Non è chiaro se la parte in mattoni sia un rifacimento connesso agli interventi di restauro del Novecento.
3 Il taglio presentava profondità costante, tranne in un punto subito ad est del mosaico 1506, dove si approfondiva per circa 70 cm.
Fig. 1. Il lacerto di mosaico presente al centro della corte (1521).
39
Il settore occidentale
Nel settore occidentale del saggio è stato rimosso lo strato 1508, livello giallastro molto friabile, ricco di frammenti laterizi e grumi di malta, esteso lungo la fronte orientale del muro 5052. Sotto 1508 sono stati riportati in luce uno strato giallo, compatto (1519), posto in quota con la risega del muro 5052 e, più a sud, un sottile livello a matrice sabbiosa di colore rosato (1520), entrambi tagliati dalla fossa di spoglio -3111. Si è proceduto quindi con lo scavo della fossa -3111, spoglio del muro 5052, attraverso la rimozione del suo riempimento (3112), livello di colore marrone scuro, ricco di scapoli lapidei e laterizi e frammenti ceramici. Sotto 3112 è emerso un secondo livello di riempimento (1525), di colore grigio scuro con abbondanti grumi di calce. Completato lo scavo della fossa -3111, è stata rimossa l’US 1519, strato giallo a matrice sabbiosa ricco di inclusi. La rimozione di 1519 ha messo in luce un ulteriore lacerto della preparazione 1518, uno strato marrone ricco di frammenti laterizi (1532) e, più a sud, uno strato grigio chiaro a matrice sabbiosa (1529) e uno strato grigio scuro ricco di frustoli carboniosi (1527), visibile in prossimità della canaletta 1501. È stato quindi asportato il livello 1527; sotto di esso è emerso uno strato grigio ricco di frammenti di intonaco e grumi di malta (1531).Sono stati quindi scavati i livelli 1532, 1531, strato grigio ricco di grumi di malta e, più a sud, 1529, sottile livello grigio a matrice argillosa. Sotto 1531 è stato così individuato uno strato argilloso giallastro molto depurato (1534) che, per quanto visibile in sezione, si estende sotto la preparazione 1518 e appare del tutto simile allo strato 1537, messo in luce nella fascia orientale del saggio. Si può quindi ipotizzare che la sequenza stratigrafica individuata lungo il muro 1513 costituisca l’insieme dei livelli di preparazione di una fascia musiva analoga a quella presente lungo il lato nord della corte. Lo strato 1534 era tagliato da uno scasso di forma irregolare (-1539), riempito da un livello a matrice sabbiosa, ricco di grumi di malta e da frammenti della preparazione 1509 (1538). La rimozione di 1538 ha permesso di verificare come effettivamente la preparazione 1509 sia rotta in questo punto, e pertanto non è possibile stabilire quanto essa si estendesse verso ovest.Si è proceduto quindi a svuotare la canaletta 1501 dal suo riempimento (1502), strato grigio scuro piuttosto friabile contenente frammenti ceramici, frammenti di vetro, ossa e pochi frammenti laterizi. È stata così rimessa in luce la canaletta, costruita con elementi di varia natura e dimensioni, molti dei quali di reimpiego (Fig. 2). Le spallette della struttura sono composte da blocchetti di arenaria, calcare e frammenti di mattoni di varie forme e dimensioni, legati da malta di calce. Il fondo, che presenta una leggera pendenza da ovest verso est, è costituito da lastre lapidee e laterizi. La parte superiore della canaletta non si conserva, ma la posizione di una delle lastre 1503 ha fatto ipotizzare che esse fungessero da copertura del condotto. Per provare tale ipotesi è stata rimossa una delle lastre, ed è stato così possibile verificare che effettivamente esse costituivano la copertura del condotto. La canaletta termina circa 30 cm ad ovest del blocco 1505, mentre verso ovest appare tagliata dalla fossa di spoglio -3111, per cui non è chiaro quanto essa si estendesse in questa direzione e quale fosse il suo rapporto con il muro 5052.
Si è deciso quindi di rimuovere uno dei blocchi lapidei presenti circa al centro del saggio (1505). Al di sotto è stato individuato uno strato marrone scuro, quasi nero (1546), analogo all’US 1523 già scavata più a nord, che copriva una buca circolare (-1547), tagliata nella preparazione 1509 e riempita da uno strato di colore marrone (1548). La buca, caratterizzata da pareti verticali e notevole profondità, si trova a poca distanza dall’estremità orientale della canaletta 1501.
L’allargamento sud
Si è deciso quindi di allargare il saggio di circa 1 m a sud della canaletta 1501; un ulteriore allargamento (m 1 x 2) è stato effettuato a sud delle lastre 1503, fino a raggiungere il limite meridionale del saggio, per verificare l’estensione della preparazione 1509 verso sud.Nell’allargamento sud la rimozione dell’humus (1500) ha permesso di riportare alla luce un altro lacerto del mosaico 1521 e della sua preparazione (1509). Anche in questo punto il mosaico conserva parte della fascia nera presente in prossimità del limite occidentale del pavimento e già individuata più a nord. Non è stato possibile definire il limite meridionale della preparazione 1509 in quanto essa è risultata scassata da una fossa moderna realizzata probabilmente per la posa del tombino in cemento qui presente. Lo scavo si è quindi arrestato su questi livelli.A sud della canaletta 1501 invece al di sotto dell’humus (1500) sono stati individuati un lacerto di preparazione pavimentale in malta giallastra, molto friabile e di ridotto spessore (1541) coperto da un sottile livello a matrice sabbiosa (1542), e uno strato di colore scuro, quasi nero (1543), riempimento di uno scasso (-1544) esteso in direzione est-ovest. È stato quindi asportato lo strato 1543.Più ad est è stato individuato invece uno strato grigio ricco di grumi di malta e di argilla
Fig. 2. La canaletta 1501.
40
gialla, frammenti laterizi e ceramici e frammenti di intonaco (1549), che si estende verso est oltre i limiti del saggio, sotto le lastre 1503. Si è deciso quindi di rimuovere altre due lastre di pietra (1503) situate circa al centro del saggio, e si è verificato che esse poggiavano su uno strato scuro, quasi nero (1550), del tutto simile allo strato 1546 individuato sotto il blocco 1505. Sotto 1550 è emerso invece un livello, denominato 1551, che è stato successivamente uguagliato a 1549. Si è proceduto quindi con la rimozione dello strato 1549=1551, strato di notevole spessore (circa 40 cm), particolarmente ricco di inclusi, soprattutto frammenti ceramici e laterizi. Lo strato 1549=1551 costituiva il riempimento di una grande fossa (-1552) situata circa al centro della corte e tagliata nella preparazione 1509, di cui sono stati individuati i limiti nord ed est. La posizione, al centro dello spazio scoperto, e la morfologia fanno ipotizzare che si tratti di una vasca ornamentale poi riempita e defunzionalizzata prima della posa delle lastre 1503.Nel riempimento (1549=1551) sono stati ritrovati molti frammenti di anfora, perlopiù pareti, e alcuni colli (Fig. 3).Dopo aver svuotato tre piccole buche di palo tagliate nella preparazione 1541 (-1553; -1555; -1557), si è deciso quindi di rimuovere la preparazione 1541, caratterizzata da uno spessore di circa 5 cm e costituita da malta gialla molto sabbiosa mista a frammenti di intonaco e frammenti ceramici. Sotto 1541 è emerso uno strato di colore marrone
grigiastro a matrice sabbio-argillosa (1559), subito rimosso. Nello strato 1559 sono stati ritrovati frammenti ceramici e laterizi, frammenti di intonaco, tessere musive e qualche frammento di vetro. Sotto 1559 è stato messo in luce quindi un livello friabile, ricco di inclusi ceramici e frammenti di intonaco (1560), del tutto analogo agli strati 1549 e 1551. È stato quindi asportato anche lo strato 1560, entro cui sono stati rinvenuti numerosi cubetti di cotto e frammenti di mattoni, tegole e tubuli. Sotto lo strato 1549=1551=1560 è stato individuato un secondo livello di riempimento (1561), simile per inclusi al livello soprastante ma di colore più grigio. Lo strato, spesso circa 40 cm, era caratterizzato dalla presenza di un’ingente quantità di frammenti di anfore. Al suo interno sono state ritrovate anche due monete e una lucerna integra. A causa della risalita dell’acqua di falda è stato purtroppo necessario interrompere lo scavo della fossa -1552, che prosegue verso sud e verso ovest oltre i limiti del saggio.
Conclusioni e prima interpretazione
Dalla lettura simultanea dei dati raccolti nel corso della campagna 2013 e degli indizi forniti dai pavimenti degli ambienti circostanti l’area di scavo appare evidente l’esistenza di almeno due fasi edilizie (Figg. 4-5).
Fig. 3. Frammenti di anfore dal riempimento della vasca al centro della corte.
Fig. 4. Foto generale dell’area di scavo alla fine della campagna 2013, vista da nord.
42
Alla prima fase si possono attribuire il corridoio, pavimentato con tessellato monocromo nero con punteggiato regolare di tessere bianche, e il relativo portico, visibile a nord e in parte anche ad est del saggio. Del portico resta, in prossimità dell’angolo nord-orientale, la parte inferiore di una colonna in laterizi (diametro m 0,45), conservata in alzato solo per pochi decimetri, che poggiava su un plinto quadrangolare in calcare (1515). A distanze regolari dovevano trovarsi altre colonne, di cui purtroppo non resta traccia. Lo spazio tra le colonne era decorato con soglie musive con motivi geometrici di vario tipo. Il corridoio porticato si affacciava su uno spazio scoperto, evidentemente una corte, coincidente circa con l’area di scavo.Il peristilio circondava la corte sui lati nord ed est, ma era evidentemente assente sul lato sud, in quanto anche ipotizzando un braccio meridionale con dimensioni minori rispetto a quelle del braccio nord, la sua presenza avrebbe ridotto lo spazio scoperto ad un’area ridottissima4. La probabile assenza del braccio meridionale permette di ipotizzare che la corte afferisca alla casa settentrionale e non alla domus di Tito Macro. Sembrerebbe infatti inspiegabile il fatto che l’accesso allo spazio scoperto da un ambiente della domus fosse privo di copertura.Già in questa fase lo spazio della corte, delimitato dal portico, era almeno in parte pavimentato, come testimonia la fascia di mosaico monocromo nero visibile in prossimità del limite nord del saggio, a sud delle colonne, e l’analogo lacerto musivo presente nell’angolo sud-orientale dell’area di scavo (1507). La contemporaneità tra il tessellato del portico e la fascia musiva nera è provata dal fatto che, come verificato nel corso dello scavo, essi condividono la stessa preparazione pavimentale (1518). La fascia nera, larga circa m 1, viene quindi a costituire una sorta di “corridoio” che corre lungo il colonnato, all’interno della corte.Forse già in questa fase viene realizzata un’ulteriore fascia musiva, concentrica rispetto a quella nera, di colore bianco e larga circa m 1 (almeno sul lato orientale), di cui sono stati individuati la preparazione (1509) e due lacerti (1521), e a cui appartiene anche il mosaico cementato visibile in prossimità del limite nord del saggio (1506).La fascia musiva bianca circonda una grande fossa (-1552) profonda almeno cm 50, di cui sono stati individuati i limiti nord ed est, che taglia i livelli di argilla sottoposti alla preparazione 1509. Sebbene le reali dimensioni della fossa e la sua morfologia restino ignote, il fatto che essa si trovi circa al centro della corte e che presenti contorni regolari fa ipotizzare che si tratti di una vasca ornamentale posta a decorare lo spazio scoperto. Purtroppo a causa della risalita dell’acqua di falda non è stato possibile raggiungere il fondo della struttura, che in origine era probabilmente rivestito. A causa della presenza del tombino moderno che ha profondamente disturbato la stratigrafia antica inoltre, non è stato possibile verificare quanto la vasca si estendesse in direzione sud: non si può escludere che essa raggiungesse il muro di confine tra le due domus. In una fase successiva, collocabile intorno alla metà del IV secolo (325-375 d.C.), la corte subisce un totale riassetto (cfr. infra il contributo di D. Dobreva). La vasca viene colmata
4 Non disponiamo purtroppo di informazioni circa il lato ovest, esterno all’area di scavo. Corti colon-nate solo su tre lati sono attestate in Cisalpina (cfr. Bonini 2012, pp. 56-57).
con vari livelli di riempimento caratterizzati da una fitta presenza di frammenti di anfore. Sopra i riempimenti della vasca e sopra ciò che resta del mosaico bianco 1521 e della sua preparazione (1509) viene costruita una canaletta con andamento est-ovest (1501). L’area della corte viene pavimentata con lastre di arenaria di forma perlopiù rettangolare (1503), che poggiano su uno strato di colore scuro, quasi nero (1546 = 1550), che va a livellare e regolarizzare la superficie dello spazio scoperto5. Ad una fase non precisabile in termini di cronologia assoluta, ma forse intermedia tra le due individuate nel corso dello scavo della corte, risalgono le modifiche apportate agli ambienti circostanti, indagati nel secolo scorso e per i quali purtroppo non si dispone di dati stratigrafici6. Il braccio est del corridoio porticato viene defunzionalizzato e in parte obliterato da un nuovo grande ambiente di soggiorno pavimentato con un tessellato figurato, oggi visibile ad est dell’area di scavo. Il braccio settentrionale viene ridotto di dimensioni verso est a causa della costruzione del muro 5052, oggi visibile al limite ovest del saggio.Sebbene allo stato attuale lo studio dei materiali provenienti dai diversi contesti sia ancora ad uno stadio preliminare e non sia quindi possibile proporre datazioni puntuali per le diverse fasi edilizie, i materiali contenuti nel riempimento della vasca confermano, ancora una volta e anche per questo settore della domus, una lunga continuità di vita, fino almeno al IV secolo d.C.7.
Caterina Previato
5 In questo il contesto esaminato ben si inquadra nel panorama aquileiese, dove l’abitudine di lastri-care le corti delle domus trova diffusione a partire dal IV secolo d.C. (cfr. Ghedini, Novello 2009, p. 116).6 Allo stato attuale non disponiamo purtroppo di elementi che ci permettano di mettere in relazione i due spazi, e di stabilirne una cronologia, almeno relativa. L’ambiente di rappresentanza ad ovest della corte infatti, così come gli altri ambienti circostanti, è stato indagato nel secolo scorso e poi ricollocato su soletta di cemento, senza che i dati di scavo fossero pubblicati.7 A proposito dei materiali rinvenuti nel riempimento della vasca, cfr. infra il contributo di D. Do-breva.
43
Bibliografia
Atria longa II 2012 = Atria longa patescunt: le forme dell’abitare nella Cisalpina romana. II. Schede, a cura di F. Ghedini e M. Annibaletto, Roma.
Bonini P. 2012, Aree scoperte, in Atria longa patescunt. Le forme dell’abitare nella Cisalpina romana. I. Saggi, a cura di F. Ghedini e M. Annibaletto, Roma, pp. 45-69.
Ghedini F., Novello M. 2009, L’edilizia residenziale, in Moenibus et portu celeberrima. Aquileia, storia di una città, a cura di F. Ghedini, M. Bueno e M. Novello, Roma, pp. 111-125.